Articolo 52
(Esonero parziale dei contributi previdenziali
a carico dei lavoratori dipendenti)
L’articolo 52 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.
Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.538 euro.
In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Inoltre, tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero in questione, come anticipato, è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Successivamente la suddetta percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali (art. 20 del D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.
La relazione tecnica stima gli oneri conseguenti per la finanza pubblica in 3.521 milioni di euro per il 2023 e in 799 milioni di euro per il 2024, ovvero, in termini di indebitamento netto, in 4.185 milioni di euro nel 2023 e in 135 milioni di euro nel 2024.
Articolo 53
(Disposizioni in materia di pensione anticipata)
Il comma 1 dell’articolo 53 introduce, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata pensione anticipata flessibile - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge - come possibilità alternativa - alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi dall'ambito i soggetti di cui al capoverso 10 del presente comma 1. Per il trattamento riconosciuto in base alla fattispecie in esame sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo (capoverso 1), sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione (capoversi 2 e da 4 a 7) e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro (capoverso 3). Il successivo comma 2 specifica che i trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base ad altri istituti.
Il comma 3 abroga la disciplina istitutiva di un fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi.
Come accennato, la novella di cui al comma 1 introduce, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata pensione anticipata flessibile - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge - come possibilità alternativa - alle fattispecie per le quali, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente, ferma restando l'applicazione delle norme previste dalla novella in esame (capoverso 1 del citato comma 1).
La nuova fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi dall'applicazione (capoverso 10) il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche summenzionate sono cumulabili secondo la disciplina richiamata che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche (capoverso 2); resta fermo, come nella suddetta disciplina richiamata, che il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti e che esso è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto. Resta implicitamente fermo che, per i soggetti la cui pensione sia interamente determinata secondo il sistema contributivo, il cumulo (sempre di periodi assicurativi non coincidenti) è disciplinato dall'articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, e successive modificazioni.
Per il trattamento riconosciuto in base alla nuova fattispecie sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro. Sono in ogni caso fatte salve le normative che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento (capoverso 8) - fermo restando che, come detto, la fattispecie sperimentale ha carattere aggiuntivo rispetto alle altre fattispecie di riconoscimento del diritto alla pensione anticipata (per ciascuna delle quali resta applicabile la rispettiva disciplina) -.
Come disposizione specifica sui criteri di calcolo, si prevede (capoverso 1) che il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale sia riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo, pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto - tempo per tempo - nel regime generale INPS; la successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia - quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni (salvi casi specifici) -.
Il trattamento liquidato in base alla fattispecie sperimentale, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde - per i redditi da lavoro autonomo occasionale - a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.
I termini dilatori per la decorrenza del trattamento riconosciuto in base alla fattispecie sperimentale sono i seguenti (capoversi 2 e da 4 a 6) - per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, cfr. infra -:
-
i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dal 1° aprile 2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dal 1° agosto 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;
-
i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ovvero, se dipendenti pubblici, dal settimo mese successivo - e in ogni caso non prima della suddetta data del 1° agosto 2023 -, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.
Ai dipendenti pubblici si applicano i termini temporali ad essi relativi anche qualora siano o siano stati iscritti presso più di una gestione pensionistica (capoverso 2).
Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023 (capoverso 7).
Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla fattispecie sperimentale in esame non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento (lettera d) del capoverso 6); la norma garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari in genere, come detto, a 67 anni).
Il capoverso 9 del presente comma 1 esclude che i requisiti posti per la fattispecie sperimentale in esame possono essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori: degli accordi cosiddetti di isopensione - di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni; degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali - di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 -, ferma restando, ai sensi della novella di cui al successivo comma 2 del presente articolo 53, la possibilità che la regolamentazione del fondo preveda uno specifica forma di assegno straordinario con riferimento ai requisiti di cui alla fattispecie sperimentale; dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione, disciplinata dall'articolo 41, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.
Riguardo al capoverso 10, cfr. supra.
La summenzionata novella di cui al comma 2 del presente articolo 53 specifica altresì che i termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie sperimentale di cui al comma 1 decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Il successivo comma 3 abroga la disciplina istitutiva di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi (si ricorda che il decreto ministeriale attuativo di tale normativa non è stato emanato).
Articolo 54
(Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa)
L’articolo 54 prevede la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria - di cui al precedente articolo 53, comma 1 - relativa alla cosiddetta quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della presente legge, la definizione delle modalità attuative della norma in esame.
La norma specifica che la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà è in ogni caso successiva alla data del medesimo esercizio ed esclude che la decorrenza in oggetto possa essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente. A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si faccia riferimento al momento di maturazione dei requisiti per il pensionamento ovvero al momento in cui il trattamento pensionistico avrebbe avuto decorrenza (dopo il decorso dei termini dilatori, previsti da alcune discipline pensionistiche, tra le quali quella - posta dalla novella di cui al citato articolo 53, comma 1 - sulla suddetta quota 103).
La norma in oggetto - che, come detto, demanda le relative modalità attuative ad un decreto ministeriale - non specifica se l'opzione possa essere revocata.
Articolo 55
(Ape sociale)
L’articolo 55 novella la disciplina dell’APE sociale – consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni – prorogandone l’applicazione in via sperimentale a tutto il 2023.
In dettaglio, le disposizioni in commento, con una modifica all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce l’APE sociale (cfr. infra il box a fine scheda) ne prorogano l’applicazione di un anno, fino al 31 dicembre 2023.
Inoltre, viene confermata anche per il 2023 la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2, annesso alla legge di bilancio 2022, ulteriori rispetto a quelle già individuate dall’elenco di cui all’allegato C) alla l. 232/2016, di accedere all’Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).
Il medesimo articolo 55, comma 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l'accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023.
Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.
Il richiamato comma 165 stabilisce per i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell’istituto nel corso dell'anno 2018 un termine di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l’accesso all’istituto e l’eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.
Infine, la norma incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame, di 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’Ape sociale in virtù della proroga disposta per il 2023.
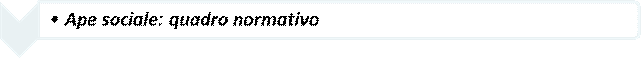
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2021 - termine da ultimo prorogato dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 91-93, L. 234/2021) - l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.
In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati
[19]
) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Si segnala che con L. 234/2021, è stato stabilito che per gli operai edili
[20]
, per i ceramisti
[21]
e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
[22]
il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni);
È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.
Inoltre:
§
per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);
§
per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;
L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:
§
mancata cessazione dell'attività lavorativa;
§
titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
§
soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
§
soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
§
soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
§
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.
L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.
Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.
Articolo 56
(Opzione donna)
L’articolo 56 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti. Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a cinquantotto anni.
L’articolo 56, al comma 1, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 (“opzione donna”) e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
§
assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
§
abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
§
siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.
Come indicato nella Relazione illustrativa, viene confermato il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12 del D.L. n. 78/2010 (richiamato dall’articolo 16 del D.L. n. 4/2019), che comporta il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi un numero di mesi dalla data di maturazione dei requisiti pari a diciotto per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, richiamato dall’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, in forza del quale, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.
In sede di prima applicazione, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
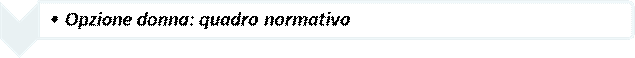
L'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico per il quale era inizialmente previsto l'adeguamento all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.
Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.
L'articolo 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010).
Successivamente, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
Il suddetto termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 336, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e, da ultimo, al 31 dicembre 2021, dall’articolo 1, comma 94, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Articolo 57
(Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli)
L’articolo 57 reca disposizioni in merito all’introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell’imprenditoria in agricoltura.
In primo luogo, in alternativa all’esonero previsto dalla normativa vigente per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, viene introdotto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli domestici) effettuate nel 2023. Tale esonero si applica anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Vengono altresì estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023 gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni e viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente.
Esonero contributivo per assunzioni effettuate nel 2023 (commi 1, 2, 3 e 6)
L’articolo 57, comma 1 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 6); esso è riconosciuto:
§
per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
§
in alternativa all’esonero previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza (comma 3).
Il richiamato art. 8 del D.L. 4/2019, istitutivo del Rdc, ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.
La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del reddito di cittadinanza e, comunque, non inferiore a cinque mesi; nel caso il beneficio del Rdc sia stato rinnovato, la durata dell'esonero è pari a cinque mensilità. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.
Qualora l'assunzione consegua ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è riconosciuta per metà al datore di lavoro e per metà all'ente di formazione. In tal caso, la durata minima dell'incentivo è pari a sei, anziché cinque, mensilità. Se l'assunzione ha luogo con la mediazione di un'agenziale per il lavoro, il 20 per cento dell'incentivo è decurtato al datore di lavoro e riconosciuto alla medesima agenzia.
Si valuti l’opportunità di specificare la compatibilità o meno con analoghi esoneri previsti dalla normativa vigente.
Il comma 2 prevede che l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale.
La Relazione tecnica allegata al disegno di legge ipotizza l’assunzione di 30.000 percettori di Rdc con un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro, con conseguenti effetti per la finanza pubblica negativi per 60 milioni di euro nel 2022 e 37 milioni di euro nel 2024. Nel 2025 ipotizza effetti positivi per 14 milioni di euro e per il 2026 un saldo negativo per 10 milioni di euro.
Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (commi 4 e 6)
L’articolo in esame estende, al comma 4, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020, che a tal fine aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall’articolo 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017.
Sulla base di quanto detto, l’esonero in questione, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 6), è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, in luogo del trentesimo anno richiesto dalla normativa a regime, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa:
§
nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, in luogo dei valori previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua;
§
per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
§
ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa (in luogo dei 6 richiesti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).
L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica:
§
ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;
§
alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
§
alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento previsto dall’articolo 1, comma 108 della legge n. 205/2017.
La relazione tecnica ipotizza una platea complessiva di potenziali beneficiari per il 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a 78.000 apprendisti. Stima i maggiori oneri per la finanza pubblica in 319,3 milioni di euro nel 2023, in 663,9 milioni di euro nel 2024, in 566,2 milioni di euro nel 2025, in 337,7 milioni di euro nel 2026, in 9,6 milioni di euro nel 2027, in 56,6 milioni di euro nel 2028, in 12,1 milioni di euro nel 2029 e in 0,7 milioni di euro nel 2029.
Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (commi 5 e 6)
L’articolo in esame estende al comma 5 alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, che a tal fine aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.
Con riferimento all’esonero oggetto dell’estensione temporale in commento, si ricorda che la Circ. INPS n. 32 del 2021 specifica che esso spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Sulla base di quanto detto, l’esonero in questione, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 6), è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa a regime) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
§
donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
§
donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
Ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016. Si ricorda che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
§
donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
§
donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
In considerazione del fatto che l’articolo in esame richiama espressamente il solo comma 16 dell’articolo 1 della L. 178/2020 e non anche il successivo comma 17, si valuti l’opportunità di specificare se la condizione ivi prevista, che subordinava la fruizione dello sgravio in esame per il biennio 2021-2022 al fatto che le assunzioni comportassero un incremento occupazionale netto, si applichi anche alle medesime assunzioni effettuate nel 2023.
La Relazione tecnica ipotizza una platea complessiva di potenziali beneficiari per il 2023 pari a 80.000 lavoratrici. Gli oneri per la finanza pubblica sono stimati in 62,1 milioni di euro nel 2023 e 84,7 milioni di euro nel 2024 e 15,7 milioni di euro nel 2015. Nel 2026 sono previsti effetti positivi per 15,7 milioni di euro; nel 2026, 2027 e 2028 effetti nuovamente negativi rispettivamente per 11,4 milioni di euro, 2,5 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.
Decontribuzione giovani imprenditori agricoli (comma 7)
Il presente articolo, infine, proroga al comma 7 dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con età inferiore a quarant'anni.
La disposizione modifica a tal fine l'articolo l, comma 503, della L. 160/2019 il quale specifica altresì che l’esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La Relazione tecnica ipotizza una platea complessiva di 10.000 nuovi iscritti e stima effetti di finanza pubblica negativi per 9 milioni di euro nel 2023, 27,9 milioni di euro nel 2024, 15,7 milioni di euro nel 2025, nonché effetti positivi per 1 milione di euro nel 2026 e oneri per 1 milione di euro nel 2027.
Articolo 58
(Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo)
Il comma 1 dell’articolo 58 reca, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale in materia in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); tali norme transitorie prevedono una perequazione in termini più restrittivi - rispetto a quella posta dalla disciplina a regime - per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS e confermano, per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al suddetto quadruplo, il relativo criterio vigente a regime. Il successivo comma 2 prevede - in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica - un incremento transitorio - con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024 - per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e a 2,7 punti per l'anno 2024; la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento (fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica).
Più in particolare, il comma 1 prevede che, per gli anni 2023 e 2024, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici si applichi nei seguenti termini:
-
per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore (nella misura lorda) a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS, la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita (riguardo a tale base di calcolo, cfr. anche infra);
-
per gli altri casi, la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 80 a 35 punti percentuali, in relazione a determinate classi di importo del complesso dei trattamenti. Il valore percentuale è in ogni caso riconosciuto nella misura immediatamente superiore a quella spettante per la relativa classe, fino a concorrenza dell'importo che deriva dall'applicazione del medesimo valore percentuale superiore sull'importo massimo della classe per la quale è attribuita tale percentuale superiore.
Si ricorda che, nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.
In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale - si basano sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest'ultimo anno sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore - definitivamente accertato con il suddetto decreto - della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo. Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente.
Le percentuali di perequazione delle norme a regime - norme che, come detto, sono oggetto di deroga transitoria da parte del presente comma 1 per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo - possono essere più di una per ogni soggetto, in relazione a fasce di importo del complesso dei trattamenti, mentre la disciplina transitoria di cui al comma 1 prevede l'applicazione di una percentuale unica per il soggetto (ferma restando l'articolazione delle percentuali nei casi specifici summenzionati).
In base alla disciplina generale, la perequazione è riconosciuta: nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo (sempre lordo) dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS; nelle misure - ferma restando la deroga transitoria di cui al presente comma 1 - del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo e del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
Riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia di perequazione automatica, si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre 2020-9 novembre 2020, facendo riferimento anche a precedenti sentenze della stessa Corte, ha rilevato che il carattere parziale, per alcuni trattamenti pensionistici, della rivalutazione al costo della vita non costituisce, di per sé, una violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (principio di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione) e che, nella valutazione del rispetto o meno (da parte di normative che presentino il suddetto effetto) di tale principio, sono fondamentali "la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo" nonché la sussistenza di una "motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative".
Come accennato, il comma 2 del presente articolo 58 prevede - in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica - un incremento transitorio ed eccezionale - con riferimento alle sole mensilità (ivi inclusa la tredicesima) relative agli anni 2023 e 2024 - per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia (nella misura lorda) pari o inferiore al suddetto trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e a 2,7 punti per l'anno 2024; la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica. Resta altresì fermo che quest'ultima si applica sui valori al netto dell'incremento transitorio medesimo.
L'incremento si commisura - nei termini suddetti - in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore (1° gennaio 2023) della presente legge di bilancio.
Considerato che nella disciplina della perequazione automatica si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima, si valuti l'opportunità di chiarire se per l'incremento transitorio ed eccezionale in esame si faccia riferimento allo stesso criterio oppure al valore minimo dell'anno medesimo di applicazione dell'incremento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio opera le quantificazioni finanziarie sulla base del secondo criterio suddetto, in quanto essa fa riferimento al valore provvisorio per il 2023 del trattamento minimo, nonché, implicitamente, al successivo eventuale conguaglio e ai valori relativi al 2024.
Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l'incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione dell'incremento medesimo sul suddetto minimo.
Inoltre, l'incremento transitorio non rileva ai fini del computo dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Il comma 2 in esame specifica che l'incremento transitorio è disposto al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'aumento del tasso di inflazione.
Articolo 59
(Disposizioni di riordino delle misure
di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)
L’articolo 59 prevede che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di otto mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età.
Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. La decadenza interviene sempre nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.
Inoltre, si richiede ai comuni l’impiego di tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.
Si prevede, poi, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.
Infine, si dispone l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.
Per effetto di tali misure, è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza. È, invece, incrementato, di 9 milioni di euro nel 2023 e di oltre 700 milioni di euro l’anno dal 2024, lo stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Le ulteriori risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza, come rideterminate sulla base di quanto stabilito in Sezione II della legge di bilancio, confluiscono in un capitolo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”.
L’articolo 59 prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto e della pensione di cittadinanza dal 2024, nell’ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.
Il comma 1 prevede che, dal 1° gennaio 2023, la misura del reddito di cittadinanza sia riconosciuta nel limite massimo di otto mensilità. Si rammenta, a tal proposito, che attualmente il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi, rinnovabile, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un mese.
Il comma 2 precisa che la riduzione del periodo massimo di fruizione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del d.P.C.M n. 159 del 2013
[40]
), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare. L'indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti. Viene considerato disabile ai fini della dichiarazione ISEE chi soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato 3 al d.P.C.M n. 159 del 2013. In particolare, il decreto differenzia le persone con disabilità media dalle persone con disabilità grave e dai non autosufficienti. Inoltre, i disabili e le persone non autosufficienti, presentando l’ISEE socio sanitario, hanno diritto ad ottenere prestazioni sociali agevolate, assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali, e prestazioni di natura residenziale. L'ISEE socio sanitario è infatti utile per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, e l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio.
Il comma 3 prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i diciotto e i sessantacinque anni, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, debbano essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
Tale obbligo di frequenza a corsi di formazione e riqualificazione è previsto dalla norma in commento per “i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4” del D.L. n. 4/2019. Il medesimo articolo 4 già condiziona, al comma 1, l’erogazione del reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni (…) nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale”. Il successivo comma 2 precisa che sono tenuti agli obblighi previsti dal medesimo articolo “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale” che tenga conto “delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato”. Esclude, inoltre, dai medesimi obblighi “i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità”. Il successivo comma 3 precisa che “possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza”, nonché i lavoratori il cui reddito da lavoro corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (pari a 690 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, 1.380 euro per i lavoratori a tempo determinato).
Il comma 4 prevede, alla lettera c), che i medesimi beneficiari decadano, con i propri nuclei familiari, dal diritto al reddito di cittadinanza qualora non accettino la prima offerta di lavoro congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (attualmente, invece, la decadenza interviene se non viene accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima offerta congrua a seguito del rinnovo del beneficio).
L'offerta è giudicata congrua, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 4/2019, nonché dell'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015 a cui rinvia e delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 10 aprile 2018, se:
§
essa è coerente con le esperienze e le competenze maturate (il criterio si applica in modo meno stringente dopo sei e dodici mesi);
§
la sede di lavoro è localizzata entro:
-
ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, se si tratta di prima offerta;
-
ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta o, salvo non siano presenti figli minori nel nucleo familiare, di prima offerta ricevuta dopo il rinnovo del beneficio;
-
entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, sia che si tratti di prima che di seconda offerta.
§
la retribuzione è:
-
superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro;
-
non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
§
il rapporto di lavoro è:
-
a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi;
-
a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.
La lettera a) del comma 4 prevede una deroga alla norma secondo cui, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente dei componenti il nucleo familiare durante l'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. In particolare, si prevede che il maggior reddito da lavoro percepito svolgendo lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico (e pertanto non determina alla sua riduzione), entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Pertanto, sono comunicati all’INPS, ai fini della decurtazione dell’importo spettante, solo i redditi eccedenti tale limite massimo, con riferimento alla parte eccedente.
Il comma 4, alla lettera b), dispone che i comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, e non più almeno un terzo di essi, nell’ambito dei progetti utili alla collettività.
Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 15 del D.L. n. 4/2019, salvo i casi di esclusione dagli obblighi di cui al medesimo articolo (vedi supra), i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione a titolo gratuito un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore a otto e non superiore a sedici ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.
La pubblicazione Progetti utili alla collettività (PUC): spunti per la progettazione. Esperienze nei Comuni italiani , del febbraio 2020, ha fornito una prima panoramica delle esperienze e delle buone prassi realizzate su tutto il territorio nazionale, attraverso forme di volontariato, cittadinanza attiva, lavoro protetto ed altro, attuate nei Comuni anche con l'apporto di Enti Pubblici e di Soggetti del Terzo Settore. Attualmente, l'elenco dei PUC attivati dai Comuni (Catalogo PUC) è disponibile nella sezione dedicata della pagina web GEPI - Piattaforma per la gestione del Patto per l'inclusione sociale (lo strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei Comuni rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza).
Il comma 5 prevede che dal 1° gennaio 2024 siano abrogate le disposizioni del D.L. n. 4/2019 che disciplinano il reddito e la pensione di cittadinanza, istituti di cui, dunque, si prevede l’abolizione dal 2024.
Il comma 5 si limita ad abrogare le disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019. Si ricorda che tale istituto è richiamato da altre disposizioni, quali l’articolo 25, comma 1, let. d-bis) del D.Lgs. n. 150/2015, introdotte con legge n. 234/2021, in materia di offerta di lavoro congrua.
Il comma 6 prevede che, per effetto delle precedenti disposizioni, l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 12 del D.L. n. 4/2019 per l’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza sia ridotta di 743 milioni di euro per il 2023.
Il D.L. n. 4/2019 prevedeva, inizialmente, all’articolo 12, per gli anni 2023 e seguenti, un’autorizzazione di spesa di 7.245,9 milioni di euro annui. Successivamente, la medesima autorizzazione di spesa è stata incrementata di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 371, L. n. 178/2020). Con legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 73, legge n. 234/2021), la medesima autorizzazione di spesa è stata ulteriormente incrementata di 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029
Il comma 7 dispone, invece, l’incremento dello stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, per 9 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l’anno dal 2029.
In merito alle modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 65. Per un approfondimento della disciplina vigente alla data di presentazione del disegno di legge in esame, si rinvia alla sezione ad essa dedicata del dossier di inizio legislatura.
Infine, il comma 8 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un capitolo denominato “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell’autorizzazione di spesa prevista dalle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza, rideterminate al netto delle risorse destinate al rafforzamento dell’assegno unico e universale e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della legge di bilancio.
Articolo 61
(Rifinanziamento del fondo sociale
per occupazione e formazione e relativi utilizzi)
L’articolo 61 reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
I suddetti interventi concernono: lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva.
Nel dettaglio, il suddetto incremento del Fondo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 1), viene disposto per finanziare le seguenti misure.
Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (comma 2)
La norma in esame stanzia per il 2023 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, incrementato dal comma 1, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti – rispettivamente, dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e dall’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.
Ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.
Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 (ripartite con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016) e di 117 mln per il 2017 (ripartite con il decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017).
Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2022, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l’impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:
§
per il 2018 e 2019 è stato consentito l’impiego delle risorse residue stanziate per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
§
per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln di euro, ripartiti con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019 (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
§
per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln di euro, ripartiti con il DM 5 marzo 2020 (art. 1, co. 491, L. 160/2019);
§
per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln di euro, ripartiti con il DM n. 18 del 16 aprile 2021 (art. 1, co. 289, L. 178/2020);
§
per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln di euro, ripartiti con il DM n. 5 del 9 marzo 2022 (art. 1, co. 127, L. 234/2021).
Indennità per i lavoratori del settore della pesca (comma 3)
Per l’erogazione, anche per il 2023, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziate risorse pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 1.
La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Si ricorda che la misura in oggetto è stata rifinanziata più volte, da ultimo dall’art. 1, co. 123 e 124, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che ha stanziato risorse pari a 19 mln di euro per il 2022 (di cui 12 mln per il riconoscimento dell’indennità legata al fermo pesca obbligatorio e 7 mln per quella connessa al fermo pesca non obbligatorio).
Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 4)
La disposizione in commento rifinanzia anche per il 2023, nella misura di 10 milioni di euro - a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 1 - le misure di sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015.
La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.
In base al combinato disposto del richiamato art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, le citate misure di sostegno al reddito consistono nell’erogazione di un’indennità in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.
Si ricorda che la misura di cui al presente articolo è stata rifinanziata più volte, da ultimo, per il 2022, dall’art. 1, co. 125, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) nel limite di spesa di 20 mln di euro.
Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA (comma 5)
Viene altresì prorogato per il 2023 - nel limite di spesa di 19 mln di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 1 - l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.
Il richiamato art. 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 nel limite di spesa di 24 milioni di euro (art. 1, co. 1167, della L. 205/2017), per il 2019 nel limite di spesa di 35 milioni di euro (art. 1, co. 248, della L. 145/2018), per il 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 11-quater, co. 1, del D.L. 162/2019), per il 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 9 del D.L. 41/2021) e per il 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 1, co. 128, L. 234/2021).
Proroga CIGS per cessazione di attività (comma 6)
La disposizione in commento proroga per 2023 - nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 1 - la possibilità (attualmente prevista sino al 2022) per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’articolo 44 del D.L. 109/2018.
La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dal richiamato articolo 44 del D.L. 109/2018 (vedi infra) in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.
In particolare l’autorizzazione è concessa:
§
qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
-
risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
-
sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
-
siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;
§
per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
§
anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;
§
subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.
In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.
Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 – come modificato da ultimo dal D.L. 162/2019 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziate ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn. 124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020.
Infine, il trattamento in oggetto è stato prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 1, co. 278, L. 178/2020) nel limite di spesa, rispettivamente, di 200 e di 50 milioni di euro.
Articolo 62
(Emolumento accessorio una tantum)
L’articolo 62 incrementa di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tale incremento è volto all’erogazione, esclusivamente nel medesimo 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità, sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse.
Preliminarmente, si ricorda che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 sono attualmente pari a 310 milioni di euro per il 2022 e a 500 milioni a decorrere dal 2023 (art. 1, co. 609, L. 234/2021). Con il suddetto incremento, tali oneri vengono portati, per il solo 2023, a 1,5 miliardi di euro.
Come anticipato, l’incremento disposto dall’articolo in commento è destinato all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Pertanto, tale emolumento, come specificato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, nonché delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di morte di quest’ultimo (comma 1).
Le relative somme saranno ripartite, nel 2023, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023 (comma 4).
Il suddetto importo - comprensivo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) -concorre a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lett. e) della legge n. 196 del 2009 (comma 2).
Infine, si dispone che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1 sono posti a carico dei rispettivi bilanci e sono destinati alla medesima finalità (comma 3).
Articolo 64
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)
L’articolo 64 è volto a estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, innanzi tutto elevando da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso anche da parte degli utilizzatori con più di cinque, fino a dieci, lavoratori a tempo indeterminato.
Nel settore agricolo, si rimuove il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per prestazioni rese da soggetti iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e si consente l’acquisizione di prestazioni occasionali anche in relazione alle attività agricole di carattere stagionale, per un periodo non superiore a 45 giorni l’anno.
L’articolo 64, attraverso modifiche puntuali all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali.
Al comma 1, lettera a), è elevato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
Al comma 1, lettera d), è rimosso il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato da cinque a dieci. Attualmente, infatti, il divieto interessa gli utilizzatori con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Tale soglia è elevata a dieci dalla disposizione in esame. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.
Si rammenta che il testo vigente dell’articolo 54-bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017 consente ai medesimi operatori del settore del turismo di ricorrervi anche in deroga al limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato a condizione che alle proprie dipendenze abbiano fino a otto lavoratori (a tempo indeterminato o determinato) e purché le prestazioni siano rese dai seguenti soggetti: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Al comma 1, lettera b), si ammette il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. In tal caso, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16, laddove prevede che, nel settore agricolo, il compenso minimo sia pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 1, lettera d), sopprime la lettera b) dell’articolo 54-bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017 che vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo a meno che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Al comma 1, lettera c), è conseguentemente abrogata la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 8-bis del D.L. n. 50/2017 che obbliga, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Articolo 66
(Congedo parentale)
L’articolo 66 prevede, con riferimento alla madre lavoratrice dipendente e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento -, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; la relativa aliquota (commisurata sulla retribuzione) viene elevata dal trenta all'ottanta per cento. L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.
La novella di cui all'articolo 66 concerne l'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
Il citato comma 1 riconosce il trattamento economico - pari, come accennato, al trenta per cento della retribuzione e costituito da un'indennità corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro - per i seguenti periodi di congedo parentale, salvi i casi di periodo più ampio in relazione al reddito individuale o all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata: per tre mesi per ciascun genitore - tale diritto non è trasferibile all'altro genitore -; per un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori; per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore o l'affidamento del minore sia esclusivo di un genitore.
La novella in esame inserisce la norma sul suddetto elevamento nel primo periodo del citato articolo 34, comma 1, del testo unico, periodo concernente la quota di tre mesi di congedo usufruibile da ciascun genitore. Si valuti l'opportunità di inserire una novella di coordinamento nel terzo periodo dello stesso articolo 34, comma 1, periodo relativo ai nove mesi di congedo parentale a cui ha diritto il genitore unico o titolare dell'affidamento esclusivo, al fine di fare salva esplicitamente - nell'ambito della formulazione sull'aliquota del trenta per cento - l'ipotesi di elevamento in oggetto.
Articolo 107, comma 1
(Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste)
L’articolo 107, comma 1, incrementa di 2 milioni di euro (annui), a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
Il riferimento di tale disposizione è al Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Si rammenta che il citato art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
La norma istitutiva del suddetto fondo rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati la determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse stanziate.
Con riguardo al 2022, il D.P.C.M. 19 maggio 2022, all’articolo 7, ha previsto l’erogazione, entro il limite massimo di spesa di 350 mila euro, di un contributo di maternità fino a un massimo di dodici mesi di importo pari a mille euro ciascuna alle atlete che ne facessero richiesta al Dipartimento per lo sport. Erano ammesse alla misura le atlete non appartenenti a gruppi sportivi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità, con reddito da altra attività fino a 15 mila euro lordi, che avessero svolto nella stagione sportiva in corso o prevedente un’attività sportiva agonistica. Inoltre, era posto come requisito l’aver partecipato negli ultimi cinque anni ad una competizione europea o internazionale oppure l’aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali o, infine, l’aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.
Da ultimo, si segnala che l’articolo 107, comma 4 del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rinvia – aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all’incremento disposto, per il 2022, dall’art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022 del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
Articolo 134, comma 21
(Sisma Italia Centrale 2016)
L’articolo 134 reca una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. In particolare sono previste: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 1 e 2); disposizioni in materia di personale (commi 3, 4, 20 e 21) e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 5); un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (comma 6); disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale (commi 7, 8, 10-14); disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani (comma 9) e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione (commi 17 e 18); agevolazioni per le utenze (commi 15 e 16); esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 19).
Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.
Stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione (comma 21)
Il comma 21 consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione, prevista dal D.L. 104/2022 all’art. 57, del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.
Il riparto delle risorse è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all’esaurimento del fondo istituito dal citato art. 57 del D.L. 104/2017, tra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di riapertura del termine, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
Si rammenta che l’art. 57, comma 3 del D.L. 104/2020, oggetto delle modificazioni previste dal comma 21 in esame, stabilisce che le regioni, gli enti locali e gli Enti parco nazionali possano assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 con le procedure, i termini e le modalità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Quest’ultima disposizione consente, in particolare, alle amministrazioni, in coerenza con il proprio piano triennale dei fabbisogni: a) fino al 31 dicembre 2023, l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio dopo il 28 agosto 2015 presso la medesima amministrazione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, reclutato con contratto a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbia maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; tale ultimo requisito, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, può essere maturato anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri; b) fino al 31 dicembre 2024, lo svolgimento di procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale titolare, dopo il 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile, con almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Per concorrere agli oneri derivanti da tali assunzioni, il D.L. n. 104/2020 ha istituito, all’art. 57, comma 3-bis, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 31 milioni di euro nel 2021 e a 83 milioni di euro annui dal 2022.
Si ricorda che, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, l’articolo 57, comma 3 del D.L. 104/2020 consente la riserva di una quota fino al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti interessati dagli eventi sismici a favore del personale con contratto a tempo determinato che abbia lavorato presso le medesime amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni alla data del 31 dicembre 2021, mentre l’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, richiamato dalla norma speciale, ora prevede, in generale, la possibilità di riservare fino al 50 per cento dei posti disponibili ai lavoratori che abbiano maturato il medesimo requisito di anzianità al 31 dicembre 2024 (termine da ultimo prorogato dall’articolo 3, comma 4-bis del D.L. 36/2022).
Si valuti pertanto l’opportunità di chiarire quale dei due termini si applica in caso di riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione.
Articolo 153, comma 12
(Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)
Il comma 12 dell'articolo 153 riduce il limite di spesa entro il quale, per i lavoratori cosiddetti precoci, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio afferma che la riduzione è disposta in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.
Come accennato, il comma 12 riduce il limite di spesa entro il quale è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto - pari attualmente a 41 anni di contribuzione - il diritto al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. La riduzione è pari a 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024 e 120 milioni annui a decorrere dal 2025. Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni; il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda.
Come detto, la relazione tecnica afferma che la riduzione del limite di spesa è disposta in base agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.
Articolo 153, commi 15-17
(Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato)
L’articolo 153, commi da 15 a 17 istituisce un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
Dal 2024, almeno l’80 per cento di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e la eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie, mentre per il solo 2023 le medesime risorse potranno essere impiegate anche solo per tale ultima finalità.
L’istituzione del predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è posta dalle presenti disposizioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del DPCM del 4 novembre 2022, che consente al disegno di legge di bilancio 2023-2025 di assegnare risorse, da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, ai Ministeri che conseguiranno i seguenti obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto previsti dal citato decreto:
| DESCRIZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE
|
2023
|
2024
|
2025
|
| Ministero dell’economia e delle finanze
di cui Presidenza del consiglio dei ministri
|
419,0
19,3
|
620,1
29,0
|
775,1
36,3
|
| Ministero dello sviluppo economico
|
12,7
|
19,4
|
24,3
|
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali
|
9,8
|
15,0
|
18,8
|
| Ministero della giustizia
|
49,0
|
77,2
|
96,5
|
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
|
49,2
|
76,0
|
94,9
|
| Ministero dell’istruzione
|
28,3
|
39,4
|
49,2
|
| Ministero dell’interno
|
52,8
|
85,2
|
106,5
|
| Ministero della transizione ecologica
|
3,8
|
5,2
|
6,5
|
| Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
|
80,8
|
122,4
|
153,0
|
| Ministero dell’università e della ricerca
|
7,2
|
10,8
|
13,5
|
| Ministero della difesa
|
55,6
|
85,9
|
107,3
|
| Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
|
7,2
|
10,1
|
12,6
|
| Ministero della cultura
|
13,8
|
19,7
|
24,6
|
| Ministero della salute
|
7,6
|
11,2
|
14,0
|
| Ministero del turismo
|
3,2
|
2,5
|
3,1
|
| Totale complessivo
|
800,0
|
1.200,0
|
1.500,0
|
Su richiesta delle amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (a cui possono successivamente essere apportate le opportune variazioni) - da adottare entro il 2 marzo 2023 (ossia 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023-2025) – si provvederà alla ripartizione del Fondo in oggetto e ad autorizzare le unità di personale assumibili. Il Fondo dovrà essere destinato (comma 15):
§
a partire dal 2024, almeno per l’80 per cento al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area dei “Funzionari” prevista dal C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto delle disposizioni che regolano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di posti vacanti in organico (art. 30 D.Lgs. 165/2001) e l’immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi (art. 4 del D.L. 101/2013);
§
per l’eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione. Per il solo 2023 i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per il conferimento di tali incarichi (comma 17).
A valere sul Fondo in oggetto, viene autorizzata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il 2023, di 1.562.500 euro per il 2024 e di 1.875.000 euro a decorrere dal 2025 a favore della Presidenza del consiglio dei ministri e di ciascun Ministero (comma 16).
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).
Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.
Le previsioni contenute nella Sezione II:
-
sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
-
evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
-
riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra.
Le unità di voto parlamentare
Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.
L’unità di voto deve indicare:
§
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§
le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Nell’ambito di ciascuna unità di voto, le spese sono classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante in:
§
oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§
fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§
spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La c.d. flessibilità di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai fattori legislativi – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a)
la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;
b)
il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a)
missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b)
programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
c)
unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (Tomo III del ddl).
Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, con i seguenti Allegati:
?
Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
?
Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
?
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
?
Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
?
Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).
Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:
?
la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, le norme autorizzatorie che lo finanziano; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
?
per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;
?
un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.
L’articolo 158 autorizza del disegno di legge di bilancio 2023 (comma 1) l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Il comma 2 reca altresì l’autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi nn. 149 del 2015 (di semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro) e 150 del 2015 (di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive).
L’articolo 156 del disegno di legge di bilancio 2023, invece, autorizza (comma 1) l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2023, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze comprende anche, alla Missione 23 Fondi da ripartire, relativa anche alla spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche
2.1 Le spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2023-2025
Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spese finali, in termini di competenza, pari a 179.692,6 milioni di euro nel 2023, a 184.505,6 milioni di euro per il 2024 e a 186.337,6 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue.
Spese finali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel ddl di bilancio per il triennio 2023-2025
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
|
Legge di Bilancio 2022
|
Previsioni
|
| Ddl di bilancio 2023
|
Diff.
bil 2023/
bil 2022
|
Ddl di bilancio 2024
|
Ddl di bilancio 2025
|
| Spese correnti
|
162.449
|
179.632,4
|
+17.183,4
|
184.447,1
|
186.279,1
|
| Spese in c/capitale
|
63,8
|
60,2
|
-3,6
|
58,5
|
58,5
|
| SPESE FINALI
|
162.512,8
|
179.692,6
|
+17.179,8
|
184.505,6
|
186.337,6
|
| Spese MINISTERO in % spese finali STATO
|
20
|
20,6
|
|
23
|
23,1
|
Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 dispone dunque per il Ministero del lavoro un incremento nelle spese finali nel 2023 pari, in termini assoluti, a circa 17.179,8 milioni di euro (+10,6%), ascrivibile ad un aumento delle spese correnti pari, in termini assoluti, a 17.183,4 milioni di euro e ad una diminuzione delle spese in conto capitale pari, in termini assoluti, a 3,6 milioni di euro.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero del lavoro autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2023, in misura pari al 20,6% della spesa finale del bilancio statale, percentuale leggermente in aumento rispetto al 20% dell’esercizio precedente.
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 180.274,4 milioni di euro nel 2023, a 184.505,6 milioni di euro nel 2024 e a 186.333,1 milioni di euro nel 2025.
2.1.1 Le spese per l’anno 2023
Lo stato di previsione del Ministero del lavoro (Tabella 4) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 176.574,2 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 3.118,4 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:
Spese finali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - anno 2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
|
2022
|
2023
|
| Legge di Bilancio
|
previsioni assestate
|
BLV
|
Modifiche Sez. II
|
Ddl bilancio Sez II
|
effetti Sez. I
|
DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II
|
| Spese correnti
|
162.449
|
166.213
|
176.514
|
-9,8
|
176.504,2
|
3.128,2
|
179.632,4
|
| Spese in c/capitale
|
63,8
|
63,8
|
60,2
|
-
|
60,2
|
-
|
60,2
|
| SPESE FINALI
|
162.512,8
|
166.276,8
|
176.574,2
|
-9,8
|
176.564,4
|
3.128,2
|
179.692,6
|
In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un decremento della spesa pari a 9,8 milioni di euro, solo dal lato delle spese correnti, ascrivibile al programma 32.2 Indirizzo politico della Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: si tratta dell’effetto di rifinanziamenti e definanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che saranno illustrati di seguito in un’apposita tabella.
Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 179.692,6 milioni per il 2023.
2.1.2 Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2023 per Missioni/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2023 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2022.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione.
Si ricorda altresì che per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vi sono alcuni cambiamenti nella collocazione degli stanziamenti di bilancio tra le unità di voto per una più puntuale attribuzione delle risorse ai competenti centri di responsabilità amministrativa in conseguenza della riorganizzazione del dicastero avvenuta nel 2021. Si tratta, in particolare, delle risorse da destinare all’INAIL a titolo di contributo statale a fronte della riduzione dei premi e dei contributi dovuti dalle imprese per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che nel 2023 passano dal programma 25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali della missione Politiche previdenziali (azione 25.3.7 “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione”) al programma 26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della missione Politiche per il lavoro (azione 26.11.3 “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”). Inoltre, dal programma 26.11 passano al programma 25.3 la parte delle risorse destinate alle pensioni di inabilità corrisposte dall’INPS ai lavoratori affetti da malattie absesto-correlate e le risorse del Fondo per i lavoratori che hanno subito l’esposizione alle polveri dell’amianto che nel 2023 si collocano nell’azione 25.3.14 “Sostegno alle gestioni previdenziali” (mentre nel 2022 erano collocate nell’azione 26.11.3 “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
|
|
Missione/Programma
|
2022
|
2023
|
| Legge di Bilancio
|
Assest.
|
BLV
|
Modifiche sez. II
|
DDL bilancio
Sez. II
|
Effetti Sez. I
|
Dlb integrato sez I+Sez II
|
| Rimodul
a.23 c. 3 lett a)
|
Variazioni
a.23 c. 3 lett b)
|
| 1
|
Politiche per il lavoro (26)
|
17.846
|
17.658,3
|
18.501
|
-
|
-
|
18.501
|
263,8
|
18.764,8
|
| 1.1
|
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
|
14.925,8
|
14.710,1
|
15.472,3
|
-
|
-
|
15.472,3
|
250
|
15.722,3
|
| 1.2
|
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
|
32,6
|
33,8
|
33,7
|
-
|
-
|
33,7
|
-
|
33,7
|
| 1.3
|
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
|
67,9
|
68,3
|
119
|
-
|
-
|
119
|
-
|
119
|
| 1.4
|
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
|
382
|
385
|
412,3
|
-
|
-
|
412,3
|
-
|
412,3
|
| 1.5
|
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
|
1.069,7
|
1.069,9
|
1.037,1
|
-
|
-
|
1.037,1
|
-
|
1.037,1
|
| 1.6
|
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)
|
47,1
|
47,2
|
49,1
|
-
|
-
|
49,1
|
-
|
49,1
|
| 1.7
|
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)
|
1.320,9
|
1.344
|
1.377,5
|
-
|
-
|
1.377,5
|
13,8
|
1.391,3
|
| 2
|
Politiche previdenziali (25)
|
95.507
|
93.391,5
|
98.289,8
|
-
|
-
|
98.289,8
|
3.136,2
|
101.426
|
| 2.1
|
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
|
95.507
|
93.391,5
|
98.289,8
|
-
|
-
|
98.289,8
|
3.136,2
|
101.426
|
| 3
|
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
|
49.060
|
55.129
|
59.692
|
-
|
-
|
59.692
|
-271,8
|
59.420,2
|
| 3.1
|
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
|
106,3
|
111,2
|
104,3
|
-
|
-
|
104,3
|
-
|
104,3
|
| 3.2
|
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
|
48.953,7
|
55.017,8
|
59.587,7
|
-
|
-
|
59.587,7
|
-271,8
|
59.315,9
|
| 4
|
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
|
12,8
|
14
|
13
|
-
|
-
|
13
|
-
|
13
|
| 4.1
|
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
|
12,8
|
14
|
13
|
-
|
-
|
13
|
-
|
13
|
| 5
|
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
|
87
|
84
|
78,4
|
-
|
-9,8
|
68,6
|
-
|
68,6
|
| 5.1
|
Indirizzo politico (32.2)
|
66,5
|
62
|
59,7
|
-
|
-9,8
|
49,9
|
-
|
49,9
|
| 5.2
|
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
|
20,5
|
22
|
18,7
|
-
|
-
|
18,7
|
-
|
18,7
|
|
|
SPESE FINALI MINISTERO
|
162.512,8
|
166.276,8
|
176.574,2
|
-
|
-9,8
|
176.564,4
|
3.128,2
|
179.692,6
|
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
La spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su 5 missioni, di cui quelle di maggior rilievo per il lavoro sono la Missione 26 Politiche per il lavoro e la Missione 25 Politiche previdenziali.
La Missione 26 Politiche per il lavoro rappresenta circa il 10,4% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (18.501 milioni di euro) la Missione 26 registra un incremento complessivo di 263,8 mln di euro a seguito degli interventi in Sezione I, determinato da un incremento del Programma Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) e del nuovo Programma Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11). In tali Programmi si registra infatti:
§
un incremento, pari a 250 milioni di euro, delle somme destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230) (art. 61 della Sez. I);
§
un incremento, pari a 13,8 milioni di euro, delle somme da trasferire all'Inail a titolo di rimborso degli oneri derivanti dalla riduzione, riconosciuta per incentivare il trattenimento in servizio, dei contributi a carico dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione (quota 103) (cap. 4344) (art. 54 della Sez. I).
Si segnala che lo stato di previsione del Ministero del lavoro prevede un incremento maggiore delle suddette somme nel 2024, pari a 24,7 mln di euro, e un incremento più contenuto delle medesime somme nel 2025, pari a 8,5 mln di euro.
La Missione 25 rappresenta circa il 56,4% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente la Missione 25, Politiche previdenziali, ed il suo unico Programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3), registra un incremento a seguito degli interventi in Sezione I pari a 3.136,2 milioni di euro.
Per tale Missione lo stato di previsione del Ministero del lavoro prevede un decremento nel biennio successivo pari a -3.010,5 mln di euro nel 2024 e a -5.377 mln di euro nel 2025.
Il suddetto incremento per il 2023 è ascrivibile in particolar modo ad un incremento degli oneri relativi agli interventi in materia previdenziale, pari a 4.987 mln di euro, che tiene conto delle variazioni operate in attuazione dell’art. 20 del D.L. 115/2022, che ha previsto un esonero del 2% sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (cap. 4367).
Sul medesimo Programma 25.3 si registrano poi i seguenti incrementi e decrementi rispetto alla dotazione a legislazione vigente:
§
+ 64 mln per somme da trasferire all’INPS in relazione all’Ape sociale (cap. 4328) (art. 55 della Sez. I);
§
+ 552,4 mln per oneri derivanti da pensionamenti anticipati (cap. 4354) (artt. 53 e 56 della Sez. I);
§
+ 450,4 mln per agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (cap. 4364) (artt. 52 e 57 della Sez. I);
§
+ 210 mln per la rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici (cap. 4356) (art. 58 della Sez. I);
§
-3.127,6 mln per somme da trasferire all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (-700 mln su cap. 2539 e -2.427,6 su cap. 4339);
La Missione 24 rappresenta circa il 33% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle famiglie e del sociale discendenti da disposizioni contenute nella Sezione I si ricorda l’incremento delle risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico (cap. 3620 nel Programma 24.12) ad opera del disposto congiunto degli artt. 65, comma 2 (incremento di 345,2 milioni di euro per il 2023; di 457,9 mln di euro per il 2024; di 473,1 mln di euro per il 2025 fino ad arrivare, nel 2029, ad un incremento annuo strutturale di 489,2 mln di euro) e 59, comma 7 (incremento di 9 mln di euro nel 2023; di 708,8 mln di euro nel 2024; di 717,2 mln di euro nel 2025, fino ad arrivare ad un incremento strutturale annuo di 740,8 mln di euro dal 2029), del provvedimento in esame. Pertanto le risorse da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico nel triennio di interesse risultano pari a: 18.583,6 mln di euro (a legislazione vigente 18.229,4 euro) nel 2023; 19.868.600,0 mln di euro (a legislazione vigente 18.701.900,0) nel 2024; 20.112.500,0 (a legislazione vigente 18.922.200,0) nel 2025.
Per quanto concerne il Reddito di cittadinanza, a seguito di quanto previsto dall’art. 59 della Sezione I, vi è un decremento del relativo Fondo di 743 mln di euro (a cui seguirà, nel biennio 2024-2025, con il decremento per 8.784,9 mln di euro per ciascuno di tali anni, il suo azzeramento) (cap. 2781). Per contro, sono indicate in misura pari a 7.076,10 mln di euro per l’anno 2024 ed a 7.076,70 mln di euro per l’anno 2025 le risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva (cap. 3552) istituito dal citato art. 59.
2.2 Le spese del Ministero dell’economia e delle finanze
In relazione allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), la Missione 23 Fondi da ripartire, relativa anche alla spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche, presenta un incremento delle risorse conseguenti alle misure riportate nella Sezione II per 3.952,4 milioni di euro.
(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)
| MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
|
Missione/Programma
|
2022
|
2023
|
| Legge di Bilancio
|
Assest.
|
BLV
|
Modifiche sez. II
|
DDL bilancio
Sez. II
|
Effetti Sez. I
|
Dlb integrato sez I+Sez II
|
| Rimodul
a.23 c. 3 lett a)
|
Variazioni
a.23 c. 3 lett b)
|
| 23
|
Fondi da ripartire (33)
|
19.532,1
|
16.122,9
|
18.034,9
|
-
|
3.872,5
|
21.907,4
|
-1.956
|
19.951,4
|
| 23.1
|
Fondi da assegnare (33.1)
|
13.431,9
|
11.895,8
|
12.536,6
|
-
|
3.952,4
|
16.489,1
|
-2.220,7
|
14.268,4
|
In particolare, all’interno del Programma “Fondi da assegnare”:
§
l’azione “Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche” prevede uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 980,8 mln di euro per il 2023, 1.136,6 mln per il 2024 e 1.302,5 per il 2025.
All’interno di tale azione si segnala il cap. 3054 su cui è allocato il Fondo da ripartire per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per analisi, valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa, istituito dall’art. 153, co. 15-17, della Sez. I con una dotazione di 20 mln di euro per il 2023, 25 mln per il 2024 e 30 mln per il 2025;
§
l’azione “Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale” prevede uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 3.873,5 mln di euro per il 2023, 2.872,4 mln per il 2024 e 3.322,1 per il 2025.
All’interno di tale azione si segnala il cap. 3027, fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia, su cui è allocato un miliardo di euro per la corresponsione di un’indennità una tantum ai dipendenti pubblici, ex art. 62 della Sez. I.

![]() @SR_Studi
@SR_Studi
![]() @SR_Bilancio
@SR_Bilancio

![]() @CD_lavoro
@CD_lavoro