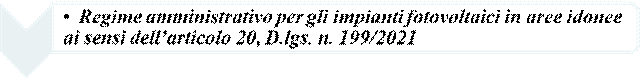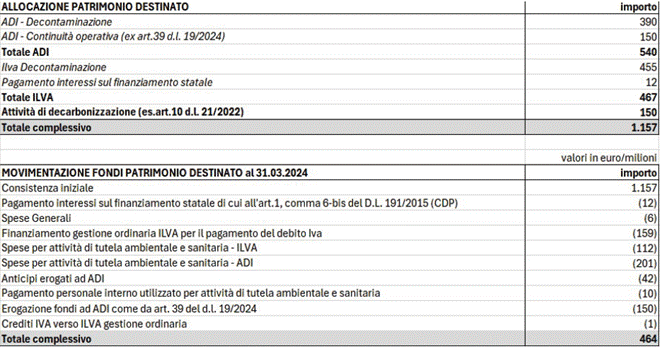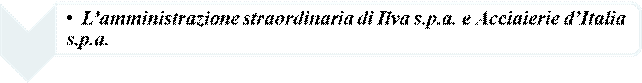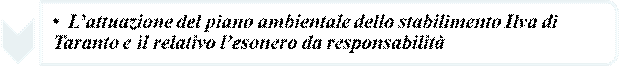Capo I – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati
Articolo 1, commi da 1 a 6 e 8
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
L’articolo 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina, garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, il settore vitivinicolo, il settore florovivaistico, la pesca e l'acquacoltura. Il comma 2 prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023. In particolare, viene prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA. I commi 3 e 4 prevedono l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. I criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni.
Con le modifiche approvate dal Senato, sono stati aggiunti i commi da 4-bis a 4-quater, con il fine di contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole (del settore olivicolo - oleario, di quello agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino), attraverso lo stanziamento di 15 milioni di euro.
Il comma 5 prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. Il comma 5-bis, inserito per effetto delle modifiche approvate dal Senato, prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione. Il comma 6 prevede, infine, la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis.
L’articolo 1, comma 1, del decreto in esame espone gli obiettivi specifici degli interventi urgenti di cui ai successivi commi, volti in via generale a contenere la crisi congiunturale originata dal conflitto russo-ucraino:
§
garantire l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria,
§
garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico (questi ultimi due settori inclusi per effetto delle modifiche adottate dal Senato) e a quello della pesca e dell’acquacoltura.
Il comma 2 prevede una moratoria su mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio.
Tali imprese, in particolare, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
Oltre alla riduzione significativa del volume d’affari, la norma fissa un’ulteriore condizione per l’accesso alla moratoria, per la quale le imprese beneficiare non devono presentare, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, esposizioni debitorie classificate come “esposizioni creditizie deteriorate”, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Per le imprese che soddisfano i requisiti suddetti, il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.
La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, o dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sui finanziamenti oggetto della moratoria è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.
Il comma 2 chiarisce, infine, che le relative disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni relative agli aiuti di importo limitato.
Con una modifica apportata dal Senato, il comma 2-bis amplia la platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l’ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB.
Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Tale comma ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Il fondo ha l’obiettivo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.
A seguito delle modifiche approvate dal Senato, la novella in esame integra:
§
fra gli obiettivi del fondo il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell’acquacoltura;
§
fra gli interventi finanziabili dal fondo quelli destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati, ai sensi dell’articolo 43 del TUB, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
L’articolo 43 del TUB regola il credito agrario, che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali, e il credito peschereccio, che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali. Le attività connesse o collaterali sono l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR con la deliberazione del 22 aprile 1995. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca, equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata.
Il comma 4, modificato dal Senato, stabilisce che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, i decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge di bilancio 2023, vengano modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3.
I criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare sono stati definiti con il D.M. 9 agosto 2023, che sarà, dunque, necessario modificare per garantirne la coerenza con la novella in esame.
La norma primaria specifica inoltre che, ai fini della definizione dei criteri per l’assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, è necessario tenere conto dell’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti. La modifica delle norme attuative dovrà inoltre prevedere che l’erogazione delle somme sia gestita dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Conseguentemente, per rispondere all’esigenza di copertura finanziaria delle nuove iniziative incluse nel perimetro d’azione del Fondo per la sovranità alimentare, la relativa dotazione viene incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.
A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, sono stati aggiunti i commi da 4-bis a 4-quater, con il fine di contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo - oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. In particolare, il comma 4-bis, attraverso uno stanziamento di 5 milioni per ciascuno dei settori indicati con riferimento al 2024, estende la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine, contratti dalle relative Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori. Tali contributi sono concessi tramite l'ISMEA.
Il comma 4-ter demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma.
Con il comma 4-quater sono individuati gli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, per i quali si provvede:
§
quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, che restano acquisite all'erario;
§
quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, che restano acquisite all'erario;
§
quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, che restano acquisite all'erario.
Il comma 5 stabilisce che il decreto di cui all’articolo 1, comma 129 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), con cui sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, può destinare le risorse del relativo Fondo, nel limite complessivo di 32 milioni di euro:
§
ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, nonché
§
ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.
Il citato articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 reca norme finalizzate a superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali. A tali fini, la norma ha istituito nello stato di previsione del MASAF un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo.
In attuazione di quanto disposto dal comma 129 dell’unico articolo della legge di bilancio 2021 sono stati adottati, per le filiere zootecniche, il D.M. 6 agosto 2021, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il Decreto 11 agosto 2021, il Decreto 31 marzo 2022 e il D.M. 13 novembre 2023, per i produttori ortofrutticoli, il D.M. 8 novembre 2021 e il D.M. 13 novembre 2023, per la filiera olivicola, il D.M. 23 novembre 2021, per la filiera vitivinicola, il Decreto 23 marzo 2022, per il settore del riso, il Decreto 16 settembre 2022, per le imprese florovivaistiche, il D.M. 19 ottobre 2022, per le imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, il D.M. 23 dicembre 2022 e, per la filiera agroalimentare il D.M. 5 settembre 2023.
Il comma 5-bis, inserito per effetto delle modifiche approvate dal Senato, prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo e nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi, nonché il limite del contributo per singolo intervento, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Ai relativi oneri si provvede, ai sensi del comma 5-ter dell’articolo in esame, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il comma 6 dell’articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.
La finalità dell’intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di a garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
Con la novella in esame, modificata dal Senato, viene, in primo luogo, posticipato di un anno (rispetto alla norma in vigore) il termine originariamente previsto, per cui i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono prorogati di due anni (uno in più di quanto già previsto a legislazione vigente) senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge.
Inoltre, vengono inclusi nell’ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui all'articolo 38-bis del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.
La legge finanziaria del 2005, all’articolo 1, comma 421, prevede che, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle entrate, salve alcune eccezioni, possa emanare un apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.
Ai sensi del comma 422, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.
Il comma 423, infine, specifica che la competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.
L’articolo 1, della legge di bilancio 2022 prevede, al comma 31, che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri in materia di accertamento e controlli previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ai sensi del comma 32, con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero.
Il comma 33 specifica che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Inoltre, il comma 34 stabilisce che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
Ai sensi del comma 35, le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Il comma 8 reca la copertura degli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca e dell’acquacoltura – settore inserito in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame al Senato - fino al 31 dicembre 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura di cui all’articolo 16-bis, del decreto-legge n. 124 del 2023, introdotto dal decreto in esame (vedi infra) anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato a cura dell’Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.
Articolo 1, commi 7 e 9
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.
Nello specifico il comma 7, lettera a), dispone la soppressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124.
Si rammenta che il sopracitato articolo 16 ha introdotto, per l’anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che rispettino determinati requisiti. In particolare, possono beneficiare della predetta agevolazione le imprese che abbiano effettuato investimenti diretti all’acquisto di beni strumentali, quali nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
L’ultimo periodo del comma 1 del suddetto articolo 16 riconosceva alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, limitatamente all’acquisto di beni strumentali, un credito d’imposta secondo quanto disposto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
La relazione illustrativa chiarisce che in fase di attuazione della misura è risultato evidente alle Amministrazioni coinvolte come il comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, pur prescrivendo l’applicazione della misura anche al settore dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, operando solamente un generico rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, non consentiva, a differenza degli altri settori, di adempiere tout court agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione Europea, difettando degli elementi essenziali necessari. A differenza degli altri settori industriali, infatti, per i quali è fatto espresso rinvio, dai successivi commi dell’articolo 16, alle norme applicabili del Reg. UE 651/2014 (GBER), non vi è alcun riferimento normativo specifico per i settori agricolo, forestale e della pesca, né vengono ulteriormente precisate le modalità di attuazione in tali settori, che godono di una specificità normativa. Come si legge al comma 6, inoltre, risulta l’esclusiva competenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’adozione del relativo decreto attuativo della misura, per tutti i settori. La relazione illustrativa ricorda come l’incentivo fiscale previsto dall’articolo 16 si pone in continuità con le misure del credito di imposta Mezzogiorno e Zes previste negli anni precedenti, dapprima con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Tale circostanza, nonché il contenuto specifico dell’attuale articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, in relazione alle disposizioni della normativa aiuti di Stato applicabile ai sensi del GBER, ha consentito l’immediato adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea per gli altri settori di attività. Per il settore agricolo, forestale e della pesca, invece, stante l’assenza di una disposizione specifica in materia ed in base alla normativa aiuti di Stato applicabile al settore agricoltura, non si può prescindere dall’effetto di incentivazione richiesto ai sensi del punto (25) dell’Aber (Reg. (UE) 2022/2472) che espressamente prevede che “Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l’effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell’ambito di tali regimi sono concessi automaticamente. La suddetta condizione specifica implica che i regimi in questione debbano essere stati adottati prima dell’avvio delle attività o dei lavori relativi all’attività o al progetto sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l’attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell’effetto di incentivazione dei regimi di aiuto subentrati a regimi precedenti, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario.”. Pertanto, ai fini dell’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché per consentire l’attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, si è ritenuto necessario specificare in una norma ad hoc l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 16, con una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca.
Il comma 7 dell’articolo in commento, alla lettera b), introduce, con specifico riguardo alle imprese sopracitate, una nuova agevolazione fiscale, in parte analoga a quella prevista dalla norma abrogata.
In merito, il comma 1 del summenzionato articolo 16-bis introdotto dalla richiamata disposizione concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
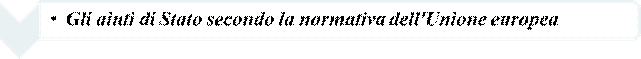
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno.
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea gli aiuti di Stato che abbiano intenzione di concedere, con esclusione di quelli coperti da una esenzione generale per categoria oppure quelli di minore importanza, ossia con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis").
In particolare, il paragrafo 3 dell’articolo 107 stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
Per un approfondimento in materia di aiuti di Stato si fa rinvio al relativo Tema web sul sito della Camera dei deputati.
Il comma 2 del medesimo articolo individua gli investimenti agevolabili con la predetta misura fiscale. Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro.
A tal proposito, il nuovo regime prevede alcune particolarità rispetto a quello già disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge, 19 settembre 2023, n. 124:
§
sono presi in considerazione gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 (nel vigente comma 4, per i soli investimenti immobiliari, sono previsti i seguenti termini: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024);
§
viene introdotta l’esclusione dall’agevolazione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro (200 mila euro nel vigente comma 4).
Infine, il comma 3 dello stesso articolo 16-bis prevede che le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, siano definiti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 9 individua la copertura finanziaria delle disposizioni stabilendo che agli oneri di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124.
Articolo 1, comma 9-bis
(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)
L’articolo 1, comma 9-bis, introdotto dal Senato, modifica le disposizioni in materia di genetica agraria recate dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 39 del 2023 (decreto “Siccità”, convertito dalla legge n. 68 del 2023), che ha ammesso l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo.
Con le modifiche in argomento viene specificato che lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati riguarda il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché, come già previsto dalla norma originaria, di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, è consentito previa autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.
Viene inoltre posticipato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale è consentita la sperimentazione sulla base dell’autorizzazione soggetta, alle disposizioni di cui al citato articolo 9-bis, del decreto Siccità.
Per cisgenesi si intendono le tecniche genomiche finalizzate all'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.
Per mutagenesi sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo stesso, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.
Le disposizioni in esame aggiornano la normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) che è ferma, rispettivamente, al 2001 (direttiva 2001/18/CE) e al 2003 (decreto legislativo n. 224 del 2003). La scienza ha, infatti,
sviluppato tecniche che hanno superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell’organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques – NGT) alle quali l’articolo in esame fa riferimento sono la tecnica dell’editing del genoma mediante mutagenesi sito-specifica, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata editing genomico) e la cisgenesi.
La prima permette una precisa modifica del DNA senza l’introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nucleasi sito-specifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sito-specifica di tipo 2 (SDN-2). Per effettuare l’editing genomico si usano proteine della classe delle nucleasi, ovvero enzimi che tagliano il DNA, e brevi sequenze di RNA, le quali guidano la nucleasi in un preciso punto desiderato del genoma, con la possibile conseguenza dell’inattivazione di un gene o dell’introduzione nella sua sequenza di modifiche già presenti in natura. In ambedue i casi, le mutazioni ottenute sono
equivalenti a mutazioni che possono avvenire spontaneamente. La normale biodiversità all’interno di una specie coltivata è dovuta a tali mutazioni. La tecnologia di editing genomico più nota è denominata “CRISPR/Cas9”, perché utilizza la proteina Cas9, ed è stata sviluppata nel 2012 da due ricercatrici, la francese Emmanuelle Charpentier e la statunitense Jennifer Doudna, una scoperta che è valsa loro il Premio Nobel per la chimica nel 2020. Le tecniche di editing genomico CRISPR/Cas9 sono state definite le “forbici genetiche che hanno inaugurato una nuova era per le scienze della vita”. Infatti, mediante l’editing genomico si può introdurre in una varietà coltivata una qualsiasi mutazione favorevole che sia stata identificata in un’altra varietà, in individui selvatici o in specie affini, senza introdurre nuovi geni e soprattutto evitando le “tradizionali” lunghe pratiche di incrocio e di re-incrocio: l’unica mutazione introdotta è quella che si desidera ottenere.
Per cisgenesi, si intende l’inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione.
Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all’incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l’editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.
Si ricorda che la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM; che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350
che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l’ambiente nel caso di emissione deliberata nell’ambiente di OGM per scopi diversi dall’immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III bis del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”.
Secondo quanto preannunciato dalla Commissione europea, un nuovo quadro giuridico dell’UE per le piante ottenute mediante mutagenesi e cisgenesi mirate e per gli alimenti e i mangimi da esse ottenuti avrebbe dovuto essere presentato nel secondo trimestre 2023.
L’iniziativa dovrebbe basarsi sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio dell’UE alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16) il quale ha rilevato come l’attuale legislazione dell’Unione in materia di OGM non sia più adatta a queste tecnologie innovative. Per approfondimenti, si veda la pagina web “Legislazione per le piante prodotte con alcune nuove tecniche genomiche” della Commissione europea.
L’emissione deliberata nell'ambiente di un “organismo” prodotto mediante cisgenesi e mutagenesi, da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita autorizzazione. Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede che la richiesta di autorizzazione sia notificata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in qualità di Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). Con riferimento alla terminologia utilizzata nella direttiva e, conseguentemente, nel decreto legislativo che vi ha dato attuazione, si segnala che la traduzione della locuzione inglese “deliberate release into the environment of genetically modified organisms” con quella italiana appena richiamata (in particolare per quanto concerne il termine “emissione”) potrebbe essere oggetto di valutazione e revisione. Il termine “emissione” infatti fa riferimento alla diffusione, all’emanazione, all’irradiamento, al fuoriuscire di un liquido o di un gas. La disciplina in oggetto, viceversa, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento piuttosto all’immissione sperimentale e controllata nell’ambiente di uno specifico organismo prodotto con tecniche di editing genomico nell’ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.
Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 5, comma 2 lettera a) del medesimo decreto legislativo, il MASE trasmette copia della notifica al Ministero della salute e al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Copia della notifica viene inoltre trasmessa all’ISPRA, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo. L’ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell’ISPRA, il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell’esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.
Nell’ambito della citata istruttoria preliminare, il MASE è tenuto a verificare la conformità formale della notifica alle previsioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 e il pagamento delle tariffe previste dall'articolo 33 del medesimo decreto, richiedendo, se del caso, il completamento della documentazione al notificante.
I compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione affidati all’ISPRA sono quelli di: a) verificare che il contenuto della notifica e delle informazioni trasmesse sia conforme alle previsioni del decreto legislativo; b) esaminare qualsiasi osservazione sulla notifica eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico; c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente; d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 del decreto legislativo e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che europei; f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo n. 224 del 2003.
Il comma 3 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede che per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l’emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell’ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.
I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:
§
la disapplicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 lettera c) e dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003; e
§
l’applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, in conformità alle prescrizioni stabilite dal D.M. 19 gennaio 2005 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 8.
Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l’attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).
Il comma 7 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 1, comma 9-ter
(Differimento termini presentazione documentazione agevolazioni fiscali attività agricole)
La norma prevede uno slittamento dei termini previsti per presentare la documentazione necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (per gasolio nella misura del 22 per cento dell’aliquota normale, esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente, per la benzine nella misura del 49 per cento dell’aliquota normale) nonché di quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche accisa nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale). Tali agevolazioni si applicano, previa denaturazione alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli e sono riconosciute:
§
agli esercenti le attività svolte in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
§
alle cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti sopra citati, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
§
alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
§
ai consorzi di bonifica e di irrigazione;
§
alle imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.
Nello specifico si prevede che, al fine di garantire ai sopra citati soggetti (indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454) l'accesso a tutte le funzionalità del sistema "Carta dell'uso dei suoli" i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo decreto sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto.
Sul punto si ricorda che l’articolo 2, comma 3, stabilisce che per usufruire delle agevolazioni sopra descritte, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato «ufficio regionale o provinciale», competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:
a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti.
Mentre il comma 6 dell'articolo 6 stabilisce che entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.
Si ricorda inoltre che la Carta dell’uso dei Suoli è il risultato di un processo di evoluzione del sistema GIS che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha avviato da tempo per migliorare la qualità dei propri strumenti geografici e di monitoraggio territoriale con l’obiettivo di completare il Sistema Informativo Territoriale (SIT) per l’acquisizione dei dati del territorio. In merito alla Carta dell’uso dei Suoli, nella relazione illustrativa all’articolo 32 del decreto legge 75 del 2023 si osservava che questo strumento, innovativo, renderà possibile una sensibile riduzione (stimata in oltre l’80 per cento) delle rettifiche da parte della Commissione UE in ordine alle infrazioni nelle dichiarazioni presentate dagli agricoltori per la concessione delle misure di sostegno.
La norma infine fa salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Articolo 1, comma 9-quater
(Abrogazione di disposizioni in materia di riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli)
L’articolo 1, comma 9-quater, introdotto dal Senato, dispone l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 (convertito dalla legge n. 34 del 2022). La disposizione oggetto di abrogazione introduce misure volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
A tale riguardo si segnala che il disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di florovivaismo” (A.S. 1048, approvato definitivamente dal Parlamento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento della redazione della presente scheda) indica al Governo la necessità di prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico (articolo 2, comma 1, lett. l)).
L’articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, al comma 1, stabilisce che il Ministro della transizione ecologica, - di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico - al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego, predispone un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.
Il comma 2 del medesimo art. 11-bis descrive le finalità che devono essere perseguite dal decreto in parola:
a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;
c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;
d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;
e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;
g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;
l) incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;
n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee ad incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;
q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;
r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.
Il comma 3 prevede che il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità di raccordo delle finalità indicate nella presente disposizione con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
Con riferimento al PNRR si ricorda che nell'ambito della Missione 2, sono previste risorse nell'ambito della Componente 2 -Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito di intervento 1 "Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile", in relazione allo sviluppo dell'agro-voltaico, per circa 1,1miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro.
Il comma 4 prevede che il Piano è attuato con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1-bis
(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento
“Dedicata a te”)
L’articolo 1-bis - introdotto durante l’esame al Senato – introduce il comma 2-bis all’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 che prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. “Carta dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.
L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, inserisce il comma 2-bis all’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (LB 2024), prevedendo un rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell’assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul Fondo di cui al comma 2, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico.
In proposito si ricorda che il comma 2 ha previsto, tra l’altro, l’incremento di 600 milioni di euro delle risorse del richiamato Fondo già istituito presso il MASAF - Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con l’articolo 1, comma 450, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e che finanziava la cd. “Social card”, ora carta “Dedicata a te”.
In data 24 giugno 2024 è stato pubblicato il D.M. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste del 4 giugno 2024 con cui sono stati individuati i beneficiari e i requisiti per l’erogazione della Carta dedicata a te. Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, ripartisce le risorse del Fondo dedicato istituito con la L. 197/2022 (L. di bilancio per il 2023) e incrementato di 600 mln di euro per il 2024 dall’articolo 1, comma 4 della L. 213/2023 (L. di Bilancio per il 2024). I beneficiari della misura sono i nuclei familiari, residenti in Italia, iscritti nell’anagrafe comunale, con un ISEE non superiore ai 15 mila euro annui, che non siano destinatari di altre misure di sostegno. L’importo di 500 euro per nucleo familiare è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti o, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 450 della citata legge di bilancio 2023 aveva previsto l’istituzione nello stato di previsione del MASAF, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante. Il decreto MASAF 18 aprile 2023 ha poi definito i criteri per l’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dal sopra richiamato complesso di norme della legge di Bilancio per il 2023
[2]
per la cd. “Social card” istituita dal MASAF per l’acquisto di beni di prima necessità. Il base al citato decreto, il numero complessivo di carte assegnabili era pari a 1.300.000 unità, con un contributo entro il limite pro-capite di circa 76 euro.
Successivamente, l’articolo 2, commi 1-3 del DL 131/2023 (cd. Energia) ha disposto il riconoscimento di un ulteriore contributo di complessivi 100 milioni ai beneficiari della cd. Social Card, come misura di sostegno al potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, portando la dotazione iniziale del Fondo da 500 a 600 milioni di euro.
La norma prevede inoltre che il MASAF, a valere sulle risorse del medesimo fondo, venga autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni di euro all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) al fine di provvedere alla successiva erogazione ai Comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute.
Si prevede che l’ANCI deve fornire al richiamato Ministero idonea rendicontazione delle somme erogate.
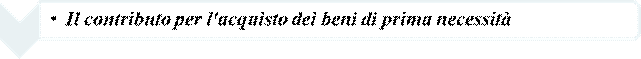
Il contributo per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità, previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, co. 450-451-bis, Legge n. 197/2022, come modificata dal D.L. n. 13/2023 - L. n. 41/2023) è un trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo famigliare, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le stesse carte elettroniche sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, per spese relative ai soli beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari.
I beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:
§
iscrizione di tutti i componenti del nucleo famigliare all’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
§
titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.
In taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (decreto MASAF 18 aprile 2023) avessero incluso titolari di: a) Reddito di cittadinanza; b) Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Viene precluso inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) e dell’Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell’Indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
L’individuazione dei beneficiari è operata dall’INPS che inviano ai comuni l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all’allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, secondo i seguenti criteri di priorità decrescente:
1.
nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
2.
nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
3.
nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
Il numero complessivo delle carte assegnabili è pari a 1.300.000, con carattere nominativo e operatività a partire dal mese di luglio 2023. Le carte sono ritirate dai beneficiari dei contributi presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza del beneficio, se non sia stato effettuato il primo pagamento entro il 15 settembre 2023.
L’assegnazione del numero delle carte per ciascun comune è effettuata in base ai seguenti criteri:
§
una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
§
una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
Il comma della citata legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede peraltro che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l’erogazione del contributo l’utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione.
Articolo 1-ter
(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)
L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A tale riguardo vengono apportate alcune puntuali modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023.
In particolare le modifiche apportate al decreto-legge sopra citato consentono di includere nel meccanismo dei ristori anche i danni subiti alle produzioni agricole a seguito di frane verificatesi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
A tal fine l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che è il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di danno ricevute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
L’articolo in esame stabilisce, quindi, che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le risorse a sostegno degli interventi di ristoro sopra richiamati.
L’articolo in commento prevede, da ultimo, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni sopra descritte per un ammontare massimo di 8 milioni di euro per l’anno 2024.
Articolo 2
(Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo)
Il comma 1 dell’articolo 2 prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 – allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 –. La misura della riduzione temporanea in oggetto è pari al 68 per cento; tale aliquota viene determinata mediante il richiamo della riduzione, a carattere permanente, prevista per le cosiddette altre zone agricole svantaggiate (diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati). Il successivo comma 2 provvede alla stima (modificata dal Senato) degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 e alla relativa copertura.
Le novelle di cui al comma 3 concernono gli elenchi nominativi, curati dall’INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. In primo luogo, si reintroduce l’istituto dell’elenco nominativo trimestrale di variazioni, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall’INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall’elenco nominativo annuale; inoltre, si prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2024, di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione adottati dall’INPS a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati secondo le forme già previste dalla disciplina. Il comma 4 reca le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle novelle di cui al comma 3.
Come accennato, la riduzione contributiva transitoria di cui al comma 1 viene determinata mediante il richiamo della misura della riduzione, a carattere permanente, prevista per le cosiddette altre zone agricole svantaggiate – diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati –; si ricorda che per questi due ambiti territoriali la misura della riduzione, di natura permanente, è pari, rispettivamente, al 68 per cento e al 75 per cento.
Il comma 2 valuta in 67,45 milioni di euro – 83,7 milioni di euro nel testo originario, così modificato dal Senato – per ciascuno degli anni 2024 e 2025 gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, in termini di minori entrate, inerenti ai premi e contributi suddetti; la riduzione della stima dell’onere approvata dal Senato è dovuta (come emerge dai lavori parlamentari presso la 5a Commissione del Senato) alla considerazione che lo sgravio contributivo concerne le sole aliquote a carico del datore di lavoro (ivi comprese quelle relative ai premi INAIL) e non si applica all’aliquota a carico del dipendente. Alla copertura finanziaria dell’onere in oggetto si provvede:
§
mediante riduzione, nella suddetta misura di 67,45 milioni per l’anno 2024, del limite di spesa relativo al beneficio economico inerente all’istituto del Supporto per la formazione e il lavoro (lettera a) del comma 2). Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che, sulla base degli esiti del monitoraggio già svolto e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica, la suddetta riduzione non compromette il riconoscimento del beneficio economico agli interessati;
§
mediante riduzione, nella suddetta misura di 67,45 milioni per l’anno 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera b) del comma 2).
Le novelle di cui al comma 3 concernono gli elenchi nominativi, curati dall’INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. In primo luogo, si reintroduce – rispetto alla soppressione operata nel luglio 2020 –l’istituto dell’elenco nominativo trimestrale di variazioni, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione (quindi, di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative) adottati dall’INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall’elenco nominativo annuale, il quale è compilato in base alle dichiarazioni dei datori di lavoro. La novella prevede che gli elenchi trimestrali di variazione siano pubblicati dall’INPS sul proprio sito internet istituzionale secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso (come già previsto per gli elenchi annuali).
La pubblicità dei provvedimenti di variazione mediante i relativi elenchi trimestrali integra quella costituita dalle comunicazioni individuali dei medesimi provvedimenti ai lavoratori interessati, comunicazioni già previste dalla disciplina e confermate dalle novelle in esame. Tale disciplina richiede che ogni provvedimento di variazione (rispetto all’elenco annuale) sia notificato ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
Le novelle di cui al comma 3, inoltre, autorizzano l’INPS alla pubblicazione, entro il 31 dicembre 2024, di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione (rispetto all’elenco annuale) adottati dall’INPS a decorrere dal suddetto mese di luglio 2020 e non validamente notificati secondo le summenzionate forme di comunicazione individuale. L’elenco straordinario in oggetto è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’INPS secondo le specifiche tecniche stabilite dallo stesso Istituto.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che il ripristino degli elenchi trimestrali di variazione appare necessario in considerazione dell’insufficienza del livello di conoscibilità connesso alle sole comunicazioni individuali nonché in relazione all’esigenza di consentire alle organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli (particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento).
Il comma 4 specifica che l’INPS provvede all’attuazione delle novelle di cui al comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (la limitazione al comma 3 del richiamo è stata esplicitata dal Senato, mentre il testo originario faceva riferimento all’intero articolo).
Articolo 2-bis, commi 1-4
(Ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche)
I commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis – articolo inserito dal Senato – recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.
Il comma 1 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto; l’estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni di attività lavorativa comprese nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024; nei suddetti termini si estende dunque (limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali) l’applicabilità dell’istituto, prevista dalla disciplina vigente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell’attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concesso in base all’estensione transitoria in esame, il medesimo comma 1 stabilisce l’esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l’equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – dal contratto individuale.
Il comma 2 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l’applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l’anno 2024.
I commi 3 e 4 provvedono alla copertura finanziaria per gli oneri corrispondenti ai limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2.
Riguardo al suddetto riconoscimento transitorio dei trattamenti di CISOA per riduzioni alla metà della durata della giornata lavorativa, il comma 1 fa riferimento alla finalità di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali.
La nozione, al fine in esame, di intemperie stagionali è stata oggetto da ultimo, in relazione alle temperature elevate, del messaggio dell’INPS n. 2729 del 20 luglio 2023.
Si ricorda che, con riferimento ad una precedente e analoga norma transitoria, posta per il periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023, la circolare dell’INPS n. 73 del 3 agosto 2023 ha confermato la formulazione letterale, posta anche dal presente comma 1, facendo riferimento esclusivo alle ipotesi di riduzione pari esattamente alla metà dell’orario giornaliero (contrattualmente previsto).
Come accennato, il comma 1 ammette i trattamenti in esame – nell’ambito del periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024 e purché le riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa siano pari a metà e fondate sulla causale delle intemperie stagionali – in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – da parte del contratto individuale. Più in particolare: la deroga summenzionata (di cui al comma 1) concerne la norma – posta dalla disciplina sul trattamento di CISOA – che prevede un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la suddetta norma di equiparazione (di cui al medesimo comma 1) concerne l’applicazione del requisito (al fine di ulteriori interventi a titolo di CISOA) secondo il quale il contratto individuale (a tempo indeterminato) deve contemplare lo svolgimento di almeno 181 giornate lavorative annue (presso lo stesso datore).
Per i trattamenti di CISOA concessi in base al regime speciale di cui al presente comma 1, è posto (dal medesimo comma) un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024; l’INPS provvede al monitoraggio degli oneri finanziari in oggetto e non accoglie le domande che comportino, anche in via prospettica, il superamento del suddetto limite.
I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono concessi direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga alla procedura di cui all’articolo 14 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (la quale prevede, per i trattamenti in oggetto, la previa deliberazione di una commissione, costituita presso ogni sede dell’INPS).
Il comma 2 del presente articolo 2-bis reca, come detto, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l’applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l’anno 2024.
Le imprese oggetto della deroga di cui al presente comma 2 – le quali, quindi, per il profilo in oggetto, rientrano in via transitoria nella disciplina già prevista a regime per le imprese degli altri settori – sono: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. In base alla deroga transitoria, anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente non evitabili – non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata; questi ultimi prevedrebbero che: dopo la fruizione di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione sia stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Riguardo al suddetto limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, l’INPS provvede, ai sensi del presente comma 2, al monitoraggio degli oneri finanziari in oggetto e non accoglie le domande che comportino, anche in via prospettica, il superamento del limite.
Si ricorda che l’esclusione dei periodi in oggetto dal computo dei suddetti limiti di durata determina anche il beneficio che i medesimi periodi non rilevano – per quanto riguarda l’applicazione degli stessi limiti – nel caso di domanda di un eventuale ulteriore periodo di trattamento.
Si ricorda altresì che, al fine in esame, la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell’INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”. L’applicazione di tali criteri in relazione alle temperature elevate è oggetto, da ultimo, del citato messaggio dell’INPS n. 2729 del 20 luglio 2023.
Riguardo alla deroga temporanea in esame, il comma 2 fa riferimento alla finalità di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali.
Il medesimo comma 2, per i trattamenti derivanti dall’applicazione della suddetta deroga transitoria, conferma esplicitamente il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
Il successivo comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell’onere corrispondente al summenzionato limite di spesa di cui al comma 1, disponendo la riduzione, nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria dell’onere corrispondente al limite di spesa di cui al comma 2, disponendo la riduzione, nella misura di 11 milioni di euro per l’anno 2024, del suddetto Fondo sociale per occupazione e formazione.
Articolo 2-bis, comma 5
(Ammortizzatori sociali in aree di crisi industriale)
Il comma 5 dell’articolo 2-bis – articolo inserito dal Senato – prevede, in primo luogo, un’integrazione del finanziamento relativo alla possibilità di riconoscimento, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nel corso dell’anno 2024, relativi a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti dalla disciplina generale di tale trattamento; l’integrazione finanziaria in oggetto fa riferimento in particolare a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata. Tale integrazione è disposta con la determinazione di un limite di spesa pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2024. Per la copertura finanziaria dell’onere corrispondente a tale limite, si dispone la riduzione, nell’identico importo di 7,5 milioni per l’anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma, inoltre, consente che le risorse finanziarie corrispondenti al suddetto limite di spesa siano utilizzate per il finanziamento della proroga, nell’anno 2024, di trattamenti di mobilità in deroga in favore di soggetti già operanti, come lavoratori dipendenti, in aree di crisi industriale complessa.
Come accennato, il presente intervento di integrazione finanziaria relativo a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga fa riferimento in particolare a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata. Le aree di crisi industriali richiamate dalla norma sono quelle corrispondenti ai Sistemi locali del lavoro di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture.
Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, l’intervento in deroga è riconosciuto previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza dei rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, e sulla base della presentazione, da parte dell’impresa, di un piano di recupero occupazionale; quest’ultimo deve prevedere appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e intesi alla rioccupazione dei lavoratori.
Le risorse finanziarie di cui al citato articolo 44, comma 11-bis, come successivamente integrate e come ripartite tra le regioni con i decreti ministeriali, possono – ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 – essere destinate dalle regioni medesime – nei limiti delle quote non utilizzate per i summenzionati trattamenti straordinari in deroga – al riconoscimento, senza soluzione di continuità, di trattamenti di mobilità in deroga, per i soggetti già operanti, come lavoratori dipendenti, in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1º gennaio 2017 risultassero beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga; tale possibilità è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (quest’ultimo deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Come accennato, l’integrazione finanziaria di cui al comma 5 in esame può essere utilizzata, nell’anno 2024, anche per i suddetti trattamenti di mobilità in deroga.
Si valuti l’opportunità di chiarire se quest’ultima possibilità di utilizzo sia subordinata alla sussistenza di una quota – nell’ambito delle risorse relative al limite di spesa di 7,5 milioni – non utilizzata per i summenzionati trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga.
Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 1, comma 170, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha stanziato per gli interventi di cui ai citati articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148 del 2015 e all’articolo 53-ter del D.L. n. 50 del 2017 un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024.
Articolo 2-ter
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro - controlli)
L’articolo 2-ter, introdotto dal Senato, al comma 1, modifica l’art. 7, comma 2 del D.L. 48/2023, rafforzando l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare. A tal fine, si prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL - oltre, come previsto dalla normativa vigente, al personale ispettivo dell’INL e alla Guardia di finanza - ha accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS.
I commi 2 e 3 autorizzano l’Inps e l’Inail, per l’anno 2024, ad assumere, rispettivamente, 403 e 111 nuove unità da inquadrare nel ruolo dei funzionari impiegati in attività di vigilanza, nei limiti dell’economie prescritte dall’art. 31, comma 12, del D.L. n. 19/2024.
Il comma 4, invece, disciplina le modalità attraverso cui deve svolgersi la procedura di selezione pubblica volta all’assunzione del suddetto personale.
Il comma 1 del presente articolo, come accennato, innova l’articolo 7, comma 2, del D.L. 48 del 2023.
A tal riguardo, si ricorda che il predetto decreto legge ha riformato la materia degli strumenti di politica attiva volti al reinserimento nel mondo di lavoro ed all’inclusione sociale.
In particolare, l’articolo 7 disciplina le modalità ed i soggetti incaricati di compiere le attività di controllo e di vigilanza sulla corretta percezione dell’Assegno di inclusione da parte dei soggetti beneficiari.
La suddetta norma consente alle autorità competenti di accedere alle informazioni ed alle banche dati gestite dall’Inps, sia in forma analitica che aggregata, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulle circostanze che comportano la decadenza dal beneficio ADI, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale.
Ciò premesso, la novella introdotta dal comma 1 dell’articolo 2-ter consente di ricorrere alle informazioni ed alle banche dati trattate dall’Inps anche per rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.
Inoltre, sempre il comma 1, estende la platea delle autorità competenti che possono accedere alle informazioni detenute dall’Inps, aggiungendo al personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ed alla Guardia di finanza, anche il personale ispettivo del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro di cui all’articolo 6 del d.lgs. 149 del 14 settembre 2015.
Si ricorda che il richiamato art. 6 istituisce, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il suddetto Comando dei Carabinieri presso la sede di Roma dell’INL. In particolare, la norma affida al direttore dell'Ispettorato la definizione di linee di condotta e di programmi ispettivi periodici volti ad orientare l’attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l'Ispettorato (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs. 149/2015).
Si segnala che non è stato specificato il comma dell’articolo 6 del d.lgs. 149/2015 che disciplina l’istituzione del «Comando carabinieri per la tutela del lavoro». A tal proposito, si valuti l’opportunità di inserire dopo le parole “ai sensi dell’articolo 6” le parole “comma 4”.
I commi 2 e 3 dell’articolo 2-ter autorizzano l’Inps e l’Inail, per l’anno 2024, ad assumere con contratto a tempo indeterminato, rispettivamente, n. 403 e n. 111 nuove unità di personale all’interno del proprio organico.
Innanzitutto, occorre osservare come le amministrazioni vengano autorizzate direttamente dalla stessa norma di rango primario ad assumere nuovo personale, derogando a quanto previsto in via generale dall’articolo 35, comma 4 del d.lgs. 165/2001 (cd. t.u.p.i.).
A tal proposito, la norma appena richiamata stabilisce che le P.A. siano autorizzate ad indire nuove procedure concorsuali mediante d.p.c.m. Nello specifico la disposizione prescrive che “le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (…). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”.
Le nuove risorse saranno inquadrate all’interno dei ruoli dei funzionari, con mansioni di ispettori di vigilanza.
Si specifica, inoltre, che le assunzioni previste avvengano senza previo esperimento della procedura di cui all’art. 30, comma 2-bis.
Si ricorda che quest’ultima disposizione prevede espressamente che “le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (…)”.
Nello specifico, il richiamato comma 1 dell’art. 30 che disciplina le cd. procedure di mobilità volontaria, consente alle amministrazioni di “ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti (…) appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”.
I commi 2 e 3 stabiliscono, inoltre, che le nuove assunzioni sono disposte nell’ambito e nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023.
A tal riguardo, le disposizioni richiamano l’articolo 31, comma 12, D.L. 19 del 2 marzo 2024, il quale detta una disciplina dettagliata circa il budget assunzionale da stanziare per il personale ispettivo da incardinare presso Inps e Inail.
Innanzitutto, la disposizione appena ricordata ha novellato il d.lgs. 149/2015, abrogando sia la previsione dell’attribuzione, in via esclusiva, all’INL delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale, sia l’inquadramento del personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Ente.
Sempre il comma 12 precisa che per far fronte alle nuove assunzioni Inps ed Inail utilizzano “le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017”. Tali risorse rappresentano il cd. budget assunzionale.
Peraltro, il comma 12 fornisce anche il criterio sulla base del quale è parametrata la consistenza numerica dell’organico del personale ispettivo dell’Inps e dell’Inail. Nello specifico si prevede che “le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni (…)”.
Infine, il comma 4 dell’articolo 2-ter regola le modalità di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica mediante cui assumere il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Secondo la lettera della norma, l’Inps e l’Inail sono autorizzati a bandire, per l’anno 2024, una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale.
È prevista la facoltà per i due Enti di stabilire l’utilizzo di tecnologie digitali per l’effettuazione delle prove, nonché la facoltà di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (cd. RIPAM), di cui all’art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001.
Ogni candidato può concorrere per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle presenti nel bando.
Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a bando, le P.a. possono ricorrere allo scorrimento delle altre graduatorie regionali per coprire i posti rimasti vacanti, fermo restando l’esperimento del previo interpello e l’assenso dei candidati interessati.
Il bando, con riferimento ai titoli valutabili, può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi, garantendo, comunque, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge.
Articolo 2-quater
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e lavoro - Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura)
L’articolo 2-quater – introdotto dal Senato - prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, avente le finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura. Alla sua costituzione concorrono i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’INL, l’AGEA e l’ISTAT. Il Sistema costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le richiamate amministrazioni centrali e le regioni, che mettono a disposizioni le informazioni e i dati disponibili di interesse (comma 1).
La disposizione precisa, infine, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).
Deve preliminarmente osservarsi che la disposizione in commento presenta contenuto sostanzialmente identico all’articolo 1 del disegno di legge recante “Diposizioni in materia di lavoro” (collegato alla manovra di finanza pubblica) (A.C. 1532-bis).
Si ricorda, al proposito, che tale provvedimento è in corso di esame in sede referente presso la XI Commissione Lavoro della Camera.
Passando ad esaminare i contenuti propri della disposizione in titolo, si osserva che essa reca, al comma 1, una novella all’articolo 25-quater del decreto legge n. 119 del 2018, introducendo, in particolare, il comma 5-bis.
Ai sensi di tale nuovo comma, si dispone l’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura. Il Sistema è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Giova ricordare che nella relazione tecnica allegata alla disposizione in commento – analogamente a quanto già sottolineato nella relazione illustrativa allegata al richiamato articolo 1 del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro” - si specifica che l’istituzione di Sistema in commento si inserisce nell’ambito dell’attuazione al Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.
Tale Piano pone, infatti, tra le priorità trasversali, lo sviluppo di un sistema informativo per la programmazione degli interventi e per il monitoraggio del mercato agricolo.
Sono quindi delineate le finalità specifiche del Sistema, che consistono nel:
§
consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato;
§
favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo;
§
incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura.
Merita rammentare che l’articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, recita così testualmente:
“1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo". Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie”.
Si fa presente che le disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento del Tavolo Caporalato sono contenute nel Decreto Interministeriale del 4 luglio 2019, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della giustizia e dell'interno.
Il Decreto Interministeriale del 17 giugno 2022 ha prorogato la durata del Tavolo, inizialmente previsto per un triennio sino al mese di settembre 2022, sino al 3 settembre 2025 e ha aggiornato anche il decreto interministeriale del 4 luglio 2019 di organizzazione e funzionamento del Tavolo.
Come specificato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le attività del Tavolo Caporalato sono supportate dal Ministero medesimo - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - mediante una Segreteria costituita nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, gestito dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.
La programmazione delle principali azioni, concordata tra tutti i partecipanti al Tavolo, è stata raccolta nel “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)”, approvato dal Tavolo il 20 febbraio 2020 e rispetto al quale è stata sancita l’intesa da parte della Conferenza Unificata delle Regioni il 21 maggio 2020.
Si segnala, infine, che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 58 del 6 aprile 2023 - con il quale si è proceduto all’aggiornamento del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, adottato, a sua volta, con DM n. 221 del 2022 - ha previsto che tale Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso operi in sinergia con il richiamato Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e ne contribuisca all’implementazione delle azioni prioritarie, con particolare riferimento a quelle volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di politiche attive del lavoro.
Concorrono alla costituzione del Sistema: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Si valuti l’opportunità di prevedere che alla costituzione del Sistema concorrano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerato che trattasi di materia riconducibile alla “tutela e sicurezza sul lavoro”, materia rientrante nella competenza legislativa concorrente, e anche che le stesse regioni e province autonome concorrono alla formazione e all’aggiornamento del Sistema, come espressamente previsto nell’ultimo periodo del nuovo comma 5-bis.
Si segnala, peraltro, che nel medesimo Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito ai sensi del richiamato articolo 25-quater, comma 1, del dl 119 del 2018, vi sono, tra gli altri, rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La disposizione in commento specifica, altresì, che il Sistema rappresenta uno strumento di condivisione di informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni.
Si valuti l’opportunità di indicare le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione del fatto che anch’esse – parimenti alle amministrazioni centrali e alle regioni - concorrono alla formazione e all’aggiornamento dell’istituendo Sistema.
Tale condivisione di informazioni - come specificato nella medesima norma in commento - persegue anche la più ampia finalità di contrastare il lavoro sommerso in generale.
Si valuti l’opportunità di specificare tale finalità, con riferimento, in particolare, alla locuzione “lavoro sommerso in generale”.
Il Sistema è quindi alimentato in virtù dei dati messi a disposizione dalle richiamate amministrazioni centrali e dalle regioni.
In particolare:
§
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati relativi ai rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro che riguardano il mercato del lavoro agricolo;
§
il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l’anagrafe delle aziende agricole, i dati sulla loro situazione economica e il calendario delle colture;
§
il Ministero dell’interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro;
§
l’INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
§
l’INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole;
§
l’INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
§
l’ISTAT mette a disposizione i dati concernenti le imprese agricole attive;
§
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione i dati dei trasporti e degli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.
Ai sensi del comma 2, dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si dispone, infine, che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle medesime disposizioni, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nella relazione tecnica allegata - analogamente a quanto precisato nella relazione tecnica riferita all’articolo 1 del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro” - si specifica che alla disposizione in commento può darsi attuazione, ricorrendo alle risorse già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si specifica inoltre che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata già predisposta l’infrastruttura per l’implementazione di tutte le componenti del Sistema istituendo, necessarie per gestire il ciclo di vita del processo di integrazione dei dati, tramite i servizi di interoperabilità.
Nella medesima relazione tecnica, si precisa infine - con riferimento all’individuazione della fonte di copertura - che la disposizione non ha nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto “le attività necessarie per la gestione della piattaforma gravano sui contratti di sviluppo dei sistemi informatici ministeriali, la cui spesa è imputata alle risorse stanziate ordinariamente sulla Missione 26, programma 12, capitolo 7821, dello stato di previsione della spesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Articolo 2-quinquies
(Disposizioni in materia di appalti in agricoltura e istituzione di una relativa banca dati)
L’articolo 2-quinquies – inserito dal Senato – prevede, in primo luogo, l’istituzione, presso l’INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un’impresa agricola. Nell’ambito di tale banca dati, l’INPS rilascia un’attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale. Per l’ipotesi di stipulazione – o di esecuzione – di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria e l’esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l’ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all’esecuzione del contratto di appalto. Dall’ambito del presente articolo sono esclusi i contratti di appalto rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.
Riguardo alla finalità delle norme in oggetto, il comma 1 fa riferimento al rafforzamento dei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo. Ai sensi del medesimo comma, l’accesso ai contenuti, sia in forma analitica che aggregata, della banca dati in oggetto è consentito al personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.
Le imprese per le quali si prevede l’iscrizione, in forma singola o associata, nella suddetta banca dati sono, ai sensi del comma 2 del presente articolo, quelle appartenenti alle seguenti tipologie: imprese non agricole, singole ed associate, con riferimento ai propri lavoratori eventualmente addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta; imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, la definizione dei seguenti elementi, al fine dei rilasci delle suddette attestazioni di conformità alle imprese richiedenti l’iscrizione nella banca dati: i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto; la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti; le informazioni relative alle imprese in oggetto già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche; le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della suddetta documentazione (per l’esecuzione di tali operazioni si prevede la possibilità di avvalersi anche delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste); i requisiti della suddetta polizza fideiussoria assicurativa.
Il medesimo comma 3 prevede che, all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, l'INPS rilasci una attestazione di conformità all'impresa richiedente l’iscrizione nella suddetta banca dati.
In base al complesso della presente disciplina, la banca dati sembra riguardare la qualificazione degli appaltatori interessati e non anche i singoli contratti di appalto. Si valuti l’opportunità di un chiarimento al riguardo, considerata la denominazione adoperata di banca dati degli appalti in agricoltura. Si consideri altresì l’opportunità di chiarire se i requisiti di qualificazione possano essere previsti dal decreto ministeriale in termini articolati, in relazione a diverse tipologie di appalto.
Il comma 4 richiede che le imprese rientranti nelle suddette tipologie di cui al comma 2 stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all’esecuzione del contratto di appalto. Riguardo alla garanzia in esame, si ricorda che, in base alla disciplina generale in materia di appalti di opere o di servizi, il committente è responsabile in solido dei pagamenti in oggetto da parte degli appaltatori e dei subappaltatori.
Il comma 5 prevede, per il caso di contratto di appalto nel settore agricolo concluso senza la stipulazione della suddetta polizza oppure concluso – o eseguito – da un’impresa priva dell’attestazione di conformità di cui al comma 3, una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico sia del committente sia dell’appaltatore; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 5.000 e 15.000 euro; è esclusa l’applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. L’irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all’articolo 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni. Si consideri l’opportunità di valutare la congruità del riferimento temporale alla notifica dell’illecito, considerato che essa può essere antecedente rispetto all’irrogazione (della sanzione), la quale costituisce, testualmente, la causa ostativa dell’iscrizione o della permanenza nella Rete per un anno.
Il comma 6 reca le clausole di invarianza finanziaria, con riferimento all’attuazione del presente articolo da parte dell’INPS.
Il comma 7 specifica che dall’ambito del presente articolo sono esclusi i contratti di appalto rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.
Articolo 3, commi da 1 a 5, da 6 a 8, 8-ter e 8-quater
(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)
L’articolo 3, modificato dal Senato, prevede misure di sostegno per le imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. La dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori” viene incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”.
L’articolo in esame incrementa, inoltre, la dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Nel corso dell’esame al Senato, inoltre, sono stati introdotti i due commi aggiuntivi 8-ter e 8-quater recanti misure di aiuto in favore delle imprese agricole con sede operativa in Sicilia che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024.
L’articolo 3, comma 1, del decreto in esame consente di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, le imprese agricole che:
§
nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato “moria del kiwi”, dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni,
§
non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.
L’Actinidia è un genere di piante della famiglia dilleniacee, originarie dell’Asia: sono alberi, arbusti, spesso liane, con foglie semplici sparse od opposte e fiori in corimbi; la specie più diffusa in Italia è l’Actinidia chinensis, da cui si ottengono i frutti comunemente noti col nome di kiwi.
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi.
A sostegno delle imprese agricole il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha previsto, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge n. 38 del 2003, una serie di interventi finanziari, tra i quali, quelli volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva. L’articolo 5 del citato decreto legislativo, in particolare, stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato;
c) proroga delle operazioni di credito agrario;
d) agevolazioni previdenziali.
Il comma 4, del quale la disciplina in esame prevede espressamente la deroga, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.
Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che la ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni sia effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
Il successivo comma 3 specifica che la ripartizione delle somme da assegnare è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 4, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della “moria del kiwi”.
Il comma 4, modificato dal Senato con la previsione di stanziamenti sensibilmente più elevati rispetto a quelli originariamente previsti dal testo del decreto, incrementa di 44 milioni per l’anno 2024 la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, n. 102, dei quali 4 milioni di euro, per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi di cui al comma 1 e 40 milioni di euro per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 104 del 2023.
Tale norma ha consentito alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004
Agli oneri derivanti dall’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, complessivamente quantificati in 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a)
quanto all'importo di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (esposto in tabella B della legge di bilancio 2024-2026);
b)
quanto all'importo di 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui alla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) articolo 1, comma 499 (recante disposizioni in materia di “distretti del cibo”) che restano acquisite all'erario;
c)
quanto all'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato ad interventi per fronteggiare situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024).
Ai sensi del comma 5, la dotazione del medesimo Fondo per la gestione delle emergenze viene ridotta di un ulteriore milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all’articolo 1, comma 433, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Per effetto delle modifiche approvate dal Senato il fondo è stato incrementato di un ulteriore milione mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all'erario.
Il comma 6 incrementa, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, istituito dall’articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), è incrementata. L’incremento è finalizzato a consentire l’operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.
Alla copertura degli oneri per il rifinanziamento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 225, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (“Decreto crescita”).
Il comma 515 dell’unico articolo della legge di bilancio 2022 ha istituito, nello stato di previsione del MASAF, il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi per lo sviluppo rurale relativi a strumenti per la gestione del rischio di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115. La dotazione finanziaria per l'anno 2022 era stata destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al successivo comma 517. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004, n. 102. La dotazione del Fondo è stata rideterminata dagli articoli 19, comma 3, e 20, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, dalla legge n. 51 del 2022 e, successivamente, l'articolo 1, comma 302, della legge 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Le disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo sono state adottate con il D.M. 30 dicembre 2022.
Il comma 7 incrementa di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della legge n. 160 del 2019.
La citata norma, al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole ha istituito, nello stato di previsione del MASAF, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le disposizioni attuative del Fondo sono state adottate con il D.M. 6 aprile 2020. Le commissioni uniche nazionali (CUN) sono state istituite in forza del citato articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015 e del D.M. 31 marzo 2017, n. 72 che ha dato attuazione regolamentare alla norma di rango primario. Le CUN:
-
sono costituite, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, dai delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione;
-
determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;
-
hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge n. 272 del 1913, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera;
-
operano con il supporto della società di gestione “Borsa merci telematica italiana ScpA”.
Il comma 8 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 7, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del MASAF.
Nel corso dell’esame al Senato sono stati introdotti i due commi aggiuntivi 8-ter e 8-quater recanti misure di aiuto in favore delle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024. Si prevede (comma 8-bis) che tali imprese, ove non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possano accedere agli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori) in deroga all'articolo 5, comma 4 (vedi sopra). Per quanto concerne la procedura per l’accesso ai benefici, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, e ai commi 2 e 3 del presente articolo 3. Anche riguardo al beneficio in oggetto, è posta la condizione della verifica del nesso di causalità tra l’evento siccitoso e i danni riportati. Viene posto il limite di spesa di 15 milioni di euro. A tal fine, il comma 8-ter dispone l’incremento di 15 milioni per il 2024 del medesimo Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori. A copertura del relativo onere si prevede la corrispondente riduzione del già menzionato Fondo destinato ad interventi per fronteggiare situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024).
Articolo 3, commi da 5-bis a 5-quater
(Epidemia dell’insetto Ips typographus)
I commi in esame, inseriti nel corso dell’esame al Senato, rideterminano la dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, consentendo alle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia l’utilizzo del fondo altresì per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.
Le disposizioni in esame, approvate dal Senato, modificano, tra l’altro, l'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) inserendo il nuovo comma 855-bis.
I commi da 846 a 855 sono volti a sostenere l'individuazione di misure di intervento per i territori coinvolti dall’epidemia dell'insetto Ips typographus (Bostrico dell’abete rosso), al fine di ridurre gli effetti degli attacchi in fase epidemica nelle regioni alpine, fra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si sono rese necessarie misure aggiuntive oltre a quelle previste nel decreto legislativo n. 195 del 2021, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione della legislazione europea.
In particolare, il comma 855 della legge di bilancio 2022 ha istituito nello stato di previsione del MASAF un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e per la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia.
Il nuovo comma 855-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 consente alle regioni e province autonome l’utilizzo del fondo altresì per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.
Allo stesso tempo, si ridetermina la dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Alla relativa copertura si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.
In base al comma 847 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione (prevista dal successivo comma 850) da parte dei proprietari pubblici e privati, dei conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, quale titolo abilitativo al taglio delle piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.
Il comma 848 prevede che le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di contrasto alla diffusione del bostrico (come individuate dal comma 846), in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni abbandonati per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria (terreni silenti).
Il comma 849 prevede l'applicazione, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, delle misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto legge n. 77 del 2021, fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848.
 Il comma 850 prevede che i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
Il comma 850 prevede che i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
Il comma 851 prevede che, salvi gli interventi sostitutivi delle Regioni in caso di prolungata inerzia dei proprietari dei terreni silenti (come previsto dal comma 848), al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano autocertificazioni, rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.
Ai sensi del comma 852, fermo restando il potere dei proprietari o dei conduttori e detentori di boschi minacciati dal bostrico di procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, secondo quanto previsto dal comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di contenimento della diffusione del bostrico disciplinate dai commi da 846 a 855, i soggetti prima richiamati provvedono, mediante le procedure per i contratti sotto soglia (articolo 36 del codice dei contratti pubblici) e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (articolo 63 del codice dei contratti pubblici), anche non espletate contestualmente, alla previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici (cioè mediante controllo delle autocertificazioni presentate dagli affidatari). Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.
Il comma 853 consente che, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di contenimento della diffusione del bostrico disciplinati dai commi da 846 a 855, i soggetti individuati dal comma 850 (cioè i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico) possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
Il comma 854 dispone che, nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività disciplinate dai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 (cioè i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico) possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del codice dei contratti pubblici, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, dello stesso codice, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Articolo 3, comma 8-bis
(Xylella fastidiosa)
L’articolo 3, comma 8-bis - introdotto durante l’esame al Senato - al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture.
La disposizione in esame, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per attuare misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture.
I criteri e le modalità di attuazione della misura sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del D. Lgs. n. 228/2001 in materia di interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.
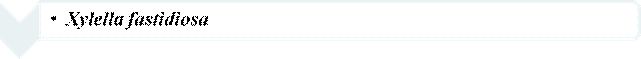
Tra gli organismi nocivi che da anni infestano le piante di ulivo si ricorda, in particolare, il batterio della Xylella fastidiosa, che ha fortemente colpito la filiera olivicolo-olearia della Puglia, specie, del Salento. Sin dal suo manifestarsi, nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati.
Lo strumento principale con cui il legislatore ha finanziato la ricostruzione del paesaggio e l'indennizzo alle imprese danneggiate è stato il Fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal patogeno della Xylella fastidiosa– di cui all'articolo 8-quater del D.L. 27/2019 - dotato di risorse pari a 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e adottato con il decreto ministeriale 6 marzo 2020.
Inoltre, con il decreto 1 settembre 2022 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa (25 milioni di euro).
Infine, con il decreto 13 settembre 2022 sono stabiliti criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici (5 milioni di euro).
Altre misure per il contenimento della Xylella sono:
·
al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto, in materia di incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo (articolo 65, decreto-legge n.1/2012) (art. 15, comma 1-novies, D.L. n. 198/2022);
·
per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento (decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni), e conseguentemente di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate (articolo 8-ter, comma 2-bis D.L. n. 27/2019 e successivamente articolo 13, comma 2, D.L. n. 215/2023).
Con ordinanza n. 3 del 26 maggio 2023 sono state definite le aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana, da cui risulta che vi è un nuovo focolaio di Xylella fastidiosa nella regione Lazio e dei nuovi ritrovamenti di piante infette da Xylella fastidiosa nelle aree demarcate delle regioni Puglia e Toscana. Con il D.M. 22 maggio 2023 è stato quindi abrogato il precedente decreto 6 giugno 2019, che definiva le aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa.
Infine con il D.M. 31 gennaio 2024 è stato modificato il regime degli aiuti di Stato relativi al ristoro dei danni causati da infezioni di Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia nel corso dell'anno 2018.
Attività della Commissione XIII (Agricoltura)
Si segnala che in data 12 aprile 2023 la Commissione ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia. Per i relativi approfondimenti si possono consultare il programma dell'indagine e le audizioni svolte.
Articolo 3-bis
(Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli)
L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell’Unione europea - e lo schedario viticolo.
La disposizione dispone circa il collegamento tra:
-
i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli).
L’art. 147, par. 2, citato, pone in capo ai soggetti che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo (in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i commercianti) la tenuta di registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
-
lo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”).
L’art. 8 della legge n. 238 citata prevede l’istituzione di uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del suddetto regolamento (UE) n. 1308/2013. Entro il 1º marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo sulla base delle risultanze dello schedario medesimo. Lo schedario viticolo è gestito dalle regioni, secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.
Si prevede che tale collegamento sia realizzato attraverso la digitalizzazione degli adempimenti connessi ai registri e allo schedario.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione delle modalità attuative della disposizione in esame, sentite le Organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola. Il termine per l’emanazione del suddetto decreto è di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n. 63.
Articolo 4
(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)
L’articolo 4, comma 1, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di “costo di produzione” e “costo medio di produzione”; viene specificato, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.
Con una modifica inserita dal Senato, si autorizza l’ICQRF a chiedere agli acquirenti tutte le informazioni necessarie, con l’acquisizione di documenti contabili relativi alle attività di vendita, per facilitare indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate.
Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. I commi 2 e 3 prevedono lo stanziamento di fondi a favore dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il potenziamento dei sistemi informatici (comma 2) più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento dei sistemi informatici (comma 3).
L’articolo 4, comma 1, del decreto in esame reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021.
Con la direttiva (UE) 2019/633 il legislatore europeo è intervenuto per disciplinare le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Il decreto legislativo n. 198 del 2021, oggetto delle modifiche in esame, ha dato attuazione, in Italia, a tale direttiva.
Nelle premesse dell’atto europeo si osserva che, nell'ambito della filiera agricolo-alimentare sono comuni gli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari; tali squilibri comportano pratiche commerciali sleali nel momento in cui i partner commerciali più grandi cercano di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un’operazione di vendita. Tali pratiche possono discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, imponendo un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un partner alla sua controparte, oppure imponendo un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei partner commerciali. Alcune pratiche possono essere manifestatamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano. Da tali considerazioni è sorta la necessità di introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurne la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola.
Il suddetto decreto legislativo n. 198 del 2021 si applica ai rapporti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguiti da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti (sono esclusi, quindi, i contratti dei consumatori). I prodotti agroalimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto sono tutti quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).
L’articolo 2 del decreto legislativo reca le definizioni, tra cui quella di “prodotti agricoli e alimentari deperibili”, “accordo quadro”, “contratti di cessione” e “fatturato”.
L’articolo 3 reca i principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che devono, in primo luogo, essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. Essi sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento. La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. La norma fa salve, inoltre, le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Gli articoli 4 e 5 individuano le pratiche sleali vietate. Tra queste, si ricordano:
- l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore ai a 30 giorni;
- la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni relative alla frequenza, al metodo, al luogo ai tempi o al volume della fornitura di un contratto di cessione di prodotti; la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari dal fornitore;
- l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa la vendita a prezzi manifestamente inferiori ai costi di produzione;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di vendita, di acquisto o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di certi prodotti nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento di prodotti.
Il successivo articolo 8 individua nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) l'Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del richiamato decreto legislativo, mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) rimane competente nei casi in cui le attività di accertamento e repressione riguardino pratiche rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.
L’articolo 10 del decreto legislativo reca le sanzioni per la violazione delle relative disposizioni.
Tutto ciò premesso, la novella in esame modifica in primo luogo le definizioni recate dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2021, aggiungendo le definizioni di “costo di produzione” e di “costo medio di produzione”. In particolare, per “costo medio di produzione”, si intende il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base della metodologia elaborata dallo stesso e comunicata al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (nuova lettera o-bis del comma 1); per “costo di produzione”, si intende il costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell’area di riferimento (nuova lettera o-ter del comma 1).
In secondo luogo viene modificato l’articolo 3, comma 1, aggiungendo ai principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, infine, la specificazione relativa al fatto che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. La medesima precisazione viene inserita nel comma 5, a proposito delle condizioni contrattuali relative ai prezzi definite nell’ambito di contratti quadro.
Dopo il comma 6 dell’articolo 3, vengono inoltre inseriti 3 ulteriori commi ad integrazione della disciplina dei principi ed elementi essenziali dei contratti di gestione.
Il nuovo comma 6-bis stabilisce che nelle convenzioni e nei regolamenti, che disciplinano il funzionamento e l’organizzazione dei mercati all’ingrosso dei prodotti agroalimentari, è inserito l’obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
Il comma 6-ter impone ai titolari e i gestori dei mercati all’ingrosso dei prodotti agroalimentari che vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, di inoltrare tempestiva denuncia all’ICQRF, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 198 del 2021, n. 198.
Il successivo 6-quater dispone che la violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all’interno dei mercati all’ingrosso, costituisca ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.
Ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 198 sono apportate con l’inserimento, durante l’esame al Senato, della lettera d-bis). Tale novella prevede che, nello svolgimento delle sue attività, l’ICQRF chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare con l’acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi, al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate.
Le modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021 riguardano, infine, l’articolo 10 (sanzioni) nel quale, dopo il comma 12, è inserito un nuovo comma 12-bis che consente, in deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689 del 1981, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di ingiunzione, di procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del cinquanta per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito.
In relazione all’illecito di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero la violazione dell’obbligo di stipula per iscritto del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti ceduti, il nuovo comma 12-bis chiarisce che costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell’illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente.
In relazione all’illecito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero in relazione all'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell’illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest’ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell’intero importo convenuto nel contratto di cessione.
Il comma 2 dell’articolo in esame assegna all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell’Istituto per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 198 del 2021.
Il comma 3 assegna all’ISMEA ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell’Istituto.
Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.
Si segnala che, con riferimento al medesimo oggetto dell’articolo in esame, la Camera dei deputati ha approvato il 9 aprile 2024 il disegno di legge A.C. 851 recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. L’atto è stato trasmesso al Senato in data 10 aprile 2024 e annunciato nella seduta n. 177 del 10 aprile 2024. L’A.S. 1096 è stato assegnato alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente l'11 aprile 2024 e il relativo esame non risulta ancora avviato.
Articolo 4-bis
(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)
L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, ridefinisce - apportando alcune modifiche ai commi 139-142 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) - gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende, elencate nel comma 139 della predetta legge di bilancio 2021, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.
Il comma 140 così emendato indica i termini per ottemperare all’obbligo di registrazione, mentre il comma 141 demanda al MASAF l’emanazione di uno o più decreti per disciplinare le modalità di applicazione della normativa.
Infine, il comma 142, a seguito della sostituzione disposta dalla lettera d) dell’articolo in esame, disciplina le sanzioni e indica il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MASAF quale autorità competente.
Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame, inserita durante l’esame al Senato, opera alcune modificazioni all'articolo 1 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sostituendo i commi 139-142.
Il comma 139, così emendato, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, e dato il fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 39 TFUE, impone alle aziende agricole, alle cooperative, ai consorzi, alle imprese commerciali, alle imprese di importazione e alle imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate.
La comunicazione avviene attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Inoltre, tale onere si impone ai soggetti suddetti solo se la quantità del singolo cereale è superiore a:
a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;
c) 80 tonnellate annue per il mais;
d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
f) 30 tonnellate per l'avena;
g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.
L’ultimo periodo del così novellato comma 139 specifica che sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati, nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.
Si ricorda che l’articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ex articolo 33 del TCE, indica le finalità della politica agricola comune (PAC), individuandole nelle seguenti:
a)
incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
b)
assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
c)
stabilizzare i mercati;
d)
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e)
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
Inoltre, è specificato che nell’elaborazione della PAC, posti anche i metodi speciali che la stessa può implicare, si dovrà considerare:
a)
il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;
b)
la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;
c)
il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.
Il comma 140 della legge di bilancio 2021, nella nuova formulazione, stabilisce che le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, o anche importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico sopra disciplinato entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Inoltre, il comma 141, cosi come riformulato, dispone che le modalità applicative dei commi 139 a 142 della L. n. 178/2020 sono stabilite con uno o più decreti del MASAF, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della novella.
Infine, il comma 142 della legge di bilancio 2021, riformato ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del D. L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023, a decorrere dal 1º marzo 2025, ai soggetti che, pur essendovi obbligati, non hanno provveduto alla comunicazione, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 500 a euro 2.000.
Inoltre, si stabilisce che a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, stabilite con i decreti del MASAF, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000. L’ultimo periodo designa come autorità competente allo svolgimento dei controlli, e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.
Si ricorda che l’articolo 15, comma 3-ter del D. L. n. 198/2022, dispone che il termine per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, comma 142, della L. n. 178 del 2020 è prorogato al 1° gennaio 2025.
In particolare, è modificato il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1 della L. n. 178 del 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, che prevedeva l’applicazione delle sanzioni a partire dal primo gennaio 2024.
Il comma 2 precisa, infine, che dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si specifica che le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 4-ter
(Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)
L’articolo in esame, approvato dal Senato, modifica una serie di atti normativi nell’intento di rafforzare le sanzioni per le condotte violative di norme in materia alimentare.
In primo luogo, viene modificato il decreto legislativo n. 190 del 2006, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare. All’articolo 2 del citato decreto, che disciplina la violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, dopo il comma 1 è aggiunto il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale, se le violazioni dei citati obblighi sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, le relative sanzioni amministrative sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.
In base alla citata raccomandazione, la definizione di grandi imprese si ricava per differenza rispetto a quella di PMI recata dall’articolo 1: si tratta di imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle medie imprese ricadono invece le imprese che occupano meno di 250 ma più di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di euro ma inferiori, rispettivamente, a 50 e a 43 milioni.
Il comma 2 modifica gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 103 del 2016, che disciplinano, nell’ambito delle disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti, rispettivamente, l’identificazione delle partite di olio d’oliva e le sanzioni per piccoli e grandi quantitativi.
La lettera a) inserisce all'articolo 8, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis che inasprisce le sanzioni per la violazione degli obblighi volti a garantire l’identificabilità delle partite di olio, anche in questo caso aumentandole nei casi in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa (vedi supra) e, in particolare, di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.
La lettera b) modifica il successivo articolo 9 specificando che la riduzione della sanzione applicabile nel caso in cui la violazione riguardi piccoli quantitativi (non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive), non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (vedi supra).
Il comma 3 reca modifiche decreto legislativo n. 297 del 2004, recante disposizioni sanzionatorie emanate in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. L’articolo 2 del citato decreto prevede, al comma 2, che, fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpi, imiti, o evochi una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio sia sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Il comma 3 integra tali disposizioni specificando che, nel caso in cui le violazioni siano commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (vedi supra), le sanzioni amministrative indicate nel periodo che precede sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.
Il medesimo aumento viene previsto ai sensi del comma 4, che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2017, per le sanzioni applicabili ai casi di mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, per cui se tali violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, le conseguenti sanzioni amministrative sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.
Articolo 5
(Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra)
L’articolo 5, comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato –limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse – secondo quanto precisato dal Senato – le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Il comma 2 – la cui formulazione è stata sostituita dal Senato – pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.
L’articolo in commento, al comma 1, modificato dal Senato, integra l’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, direttiva 2018/2001 (c.d. direttiva RED II), il quale, ai commi 1-7 reca la procedura per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e, al comma 8, indica, nelle more del procedimento di individuazione delle aree idonee (procedimento allo stato non ancora concluso), alcune aree da considerarsi idonee ai fini dell’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.
Segnatamente, il comma 1 dell’articolo qui in esame inserisce nell’articolo 20 un nuovo comma 1-bis, il quale delimita l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato soppresso il richiamo – ai fini dell’individuazione degli impianti fotovoltaici a terra – all’articolo 6-bis, lettera b), del D.lgs. n. 28/2011. Ne consegue che la limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole disposta dal comma 1 qui in esame ha ora una portata più generale, riguardando tutti gli impianti di tale categoria e non più solo quelli di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del D.lgs. n. 28/2011, richiamo normativo ora soppresso.
L’articolo 6-bis, comma 1, alinea e lett. b) del D.lgs. n. 28/2011 dispone che non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 4 del medesimo articolo 6) gli interventi su impianti fotovoltaici a terra e le modifiche dei progetti autorizzati, inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, che comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. L’area occupata dagli impianti e dalle opere connesse non deve subire un incremento. Non rileva comunque la potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento.
Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 5 qui in esame prevede che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui sopra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente in talune delle aree, attualmente qualificate ex lege come idonee dal comma 8 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, nelle more della procedura atta a individuarle. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
·
nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte di cui lettera a) del comma 8, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata. Si supera dunque quanto previsto dalla medesima lettera a) che invece in via generale consente una variazione della superficie dell’area occupata non superiore al 20 percento;
·
nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento di cui alla lettera c) del comma 8, ivi incluse – secondo quanto precisato dal Senato – le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
·
nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, sì come stabilito dalla lett. c-bis) del comma 8;
·
nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, poste le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC, a norma dalla lett. c-bis.1) del comma 8;
·
nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (c-ter) n. 2 del comma 8);
·
nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (c-ter) n. 3 del comma 8).
I vincoli di cui al primo periodo del comma 1 appena analizzato non si applicano ai progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER).
Il D.Lgs. n. 199/2021, di recepimento della direttiva 2018/2001/UE, sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, c.d. direttiva RED II, nel Titolo IV, Capo I (articoli 30-33) disciplina configurazioni per l’autoconsumo diffuso di energia elettrica da fonti rinnovabili – meglio dette Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile o CACER - e il relativo sistema incentivante (articolo 8).
Nell’ambito delle configurazioni di autoconsumo diffuso, particolare rilievo assumono le Comunità energetiche rinnovabili (CER), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 31 del decreto legislativo, citato nel testo della norma qui in commento.
Ai sensi dell’articolo 31, citato nel testo, i clienti finali, inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché nel rispetto dei seguenti requisiti:
·
l’obiettivo principale della comunità non deve essere quello di realizzare profitti finanziari, bensì quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano. Anche per le imprese, dunque, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
·
la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a soggetti quali a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali facenti parte del conto economico consolidato della PA incluse nell’apposito elenco divulgato dall’ISTAT, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell’energia;
·
per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla CER non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
·
la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti sopra indicati (articolo 31, comma 1);
Rimane fermo che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili direttamente interconnessi alla sua utenza, ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione degli impianti a FER che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità. Inoltre, l’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito, o per la condivisione con i membri della comunità, mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
I membri della comunità possono ricorrere anche a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.
L’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 8, del D.lgs., sui quali vedi infra e alla valorizzazione dell’energia autoconsumata in sede di determinazione delle componenti tariffarie da parte di ARERA (cfr. articolo 32, co. 3, lett. a)).
La comunità può, inoltre, produrre altre forme di energia da FER finalizzate all’utilizzo da parte dei membri. Può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità (articolo 30, comma 2).
Per approfondimenti si rinvia alla pagina web “Le comunità energetiche in pillole“ al sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il primo periodo del comma 1 appena analizzato non si applica, altresì, in caso di progetti attuativi delle “altre misure” di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
La disposizione richiama testualmente le “altre misure di investimento”.
Si valuti l’opportunità di specificare a cosa faccia riferimento il riferimento alle “altre” misure, posto che la disposizione richiama solo la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili (articolo 31 del D.lgs. 199/2021) e non misure di investimento del PNRR/PNC/altri progetti collegati.
Ai fini di una chiara identificazione degli ambiti di esclusione, si valuti, altresì, l’opportunità di indicare specificamente quali siano gli investimenti del PNRR e del PNC, nonché i progetti connessi, cui la medesima fa riferimento.
Quanto ai progetti attuativi delle misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e dal relativo Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), dei ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, si rinvia alle schede di approfondimento del Servizio Studi.
Si indicano, in questa sede, posta l’assenza di alcun richiamo a specifici investimenti del PNRR operato nella norma, i più rilevanti per attinenza alla materia qui in esame:
·
Investimento M2C2 I 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo” a favore delle CER e dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
·
Investimento M2C1-I.2.2 Parco Agrisolare;
·
Investimento M7C1 I.16.1 Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI.
Per una descrizione analitica, si rinvia alle tabelle di approfondimento dal Servizio Studi.
Il comma 2, sostituito dal Senato, dispone che la limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole – inserita dal comma 1 dell’articolo qui in esame nell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo del D.lgs. n. 199/2021 – non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione qui in commento, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
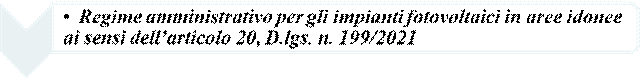
Il D.lgs. n. 199/2021 reca, all’articolo 20, una disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (prevedendo poi, all’articolo 22, alcune semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati
[52]
).
In particolare, il comma 1 dell’articolo 20 rinvia ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di principi e criteri omogenei per l’individuazione, con successive leggi regionali, delle superfici e delle aree idonee e non all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER) aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il PNIEC – nella sua versione aggiornata, inviata il 30 giugno 2024 alle Istituzioni europee – evidenzia che a inizio giugno 2024 è stato raggiunto un accordo tra Stato e regioni sullo schema di decreto ministeriale recante i criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, delle aree idonee (il c.d. “decreto aree idonee” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024). Il decreto definisce i criteri per minimizzare l’impatto ambientale delle nuove installazioni, definire la massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie dagli impianti già installati e dai nuovi impianti, e individuare le superfici tecnicamente disponibili, dando priorità alle aree edificate, alle aree industriali dismesse, alle aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
L’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, al fine di accelerare l’installazione di impianti a FER nelle more del procedimento di individuazione da parte delle regioni delle aree idonee, ha comunque indicato alcune aree da considerarsi idonee ai fini dell’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.
Dicasi che l’indicazione delle aree idonee di cui comma 8 acquisisce rilievo anche ai fini della successiva definizione delle aree idonee con il procedimento di cui al comma 1 e ss. dell’articolo 20, giacché lo stesso comma 1, come modificato dall’articolo 47, comma 1, lett. 0b) del D.L. n. 13/2023, prevede che i decreti recanti i criteri per l’individuazione delle aree idonee dovranno tener conto anche delle aree definite idonee ai sensi del successivo comma 8.
Il comma 8 dell’articolo 20 è stato oggetto di ripetute modifiche, finalizzate ad estendere il più il novero delle aree idonee nelle more ex lege.
Il comma 8 dell’articolo 20, nella sua formulazione attuale, prevede che siano idonee:
·
lett. a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Detto limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1), del medesimo comma 8. Tale numero 1), tuttavia, non pare indicare un limite alla variazione dell’area occupata, perché richiama “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”.
·
lett. b) le aree dei siti oggetto di bonifica;
·
lett. c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
·
lett. c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
·
lett. c-bis. 1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC;
·
lett. c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli a tutela dei beni culturali (Parte II, D.lgs. n. 42/2004), le seguenti aree:
1)
le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere
2)
le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3)
le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
·
lett. c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere da a) a c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali o paesaggistici, incluse le zone gravate da usi civici, né che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004, ovvero sottoposti a tutela in quanto immobili ed aree di notevole interesse pubblico. A tale specifico fine, la fascia di rispetto è di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici rispetto ai predetti beni. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.
Come sopra si desume, l’elenco delle aree idonee ex lege di cui al comma 8 dell’articolo 20 considera varie aree agricole su cui ricadono impianti fotovoltaici.
Articolo 5, comma 2-bis
(Concessione del diritto di superficie per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)
L’articolo 5-comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare il comma in questione prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non può essere inferiore a sei anni.
Si stabilisce, inoltre che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione.
La disposizione prevede inoltre che qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni.
Da ultimo il comma in questione precisa che tale disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d’urgenza in esame.
Articolo 5, commi 2-ter e 2-quater
(Trattamento fiscale produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra)
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5, inseriti dal Senato, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.
Il comma 2-ter, inserito dal Senato, prevede, attraverso l’aggiunta del comma 423-bis all'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari.
In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere l’opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260.000 kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25% (si veda la sintesi del comma 423 più avanti).
Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra prevedono pannelli fotovoltaici fissati al suolo tramite strutture in alluminio o in acciaio direzionate verso il sole. A seconda degli spazi disponibili e delle necessità, le strutture portanti degli impianti fotovoltaici a terra possono essere dotate di un unico palo o di due. Il funzionamento è simile a quello degli impianti tradizionali montati sui tetti. Anche in questo caso, infatti, le componenti principali sono costituite da pannelli fotovoltaici composti principalmente da celle in silicio monocristallino o policristallino che assorbono la luce solare e, grazie all’effetto fotovoltaico, ne trasformano l’energia in corrente continua. Nel caso del fotovoltaico a terra, i pannelli possono essere orientati e posizionati al meglio per catturare la maggiore quantità possibile di energia solare, non dovendo dipendere dalla conformazione del tetto; l’inverter, una componente che ha il ruolo di convertire la corrente continua proveniente dai pannelli in corrente alternata, utilizzabile sotto forma di elettricità negli edifici e vendibile se immessa nella rete elettrica; un eventuale sistema di accumulo composto da batterie che consentono di immagazzinare l’energia e utilizzarla in un secondo momento.
La normativa riguardante gli impianti fotovoltaici a terra, diversamente da quanto previsto per gli impianti su tetto, non contempla procedure di semplificazione per quanto concerne l’installazione.
Ai sensi del comma 423 della legge finanziaria 2006, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Il comma 2-quater precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.
Articolo 5-bis
(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva
agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)
L’articolo 5-bis, inserito dal Senato, contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.
Il comma 1 estende la portata applicativa della norma che prevede un regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. Il regime viene ora riconosciuto a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero a coloro che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.
Il comma 2 reca disposizioni volte a chiarire la definizione, all’interno del D.M. 224/2023 relativo alle garanzie di origine (GO), di biometano autoconsumato (prodotto da impianti incentivati) ai fini dell’applicazione delle specifiche disposizioni sulle relative GO ivi previste.
L’articolo, comma 1 modifica l’articolo 24, comma 8 del D.lgs. n. 28/2011. Tale norma ha demandato ad ARERA la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas e biomassa, in esercizio alla data del 28 luglio 2023, che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui sopra.
Il comma 1 interviene su tale previsione, estendendone la portata e riconoscendo il suddetto beneficio non più “a coloro che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027” ma a coloro i cui regimi incentivanti siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.
La modifica viene esplicitamente finalizzata a garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché a garantire il sostegno alle filiere produttive agricole.
Segnatamente, l’articolo 24, comma 8 del D.lgs. n. 28/2011- come sostituito dall’articolo 3-ter, del D.L. n. 57/2023 - prevede la definizione da parte dell’ARERA, entro il 24 gennaio 2024 (180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, avventa il 28 luglio 2023), di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione di energia elettrica da impianti - in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione, dunque, in esercizio al 28 luglio 2023 - alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime incentivante di cui sopra. La norma indica i seguenti criteri per la definizione di prezzi minimi garantiti o delle integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico:
§
i prezzi minimi garantiti, o le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e un funzionamento efficiente dell’impianto;
§
i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell’impianto;
§
gli impianti rispettano i requisiti di sostenibilità cui all’articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021;
§
il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi sull’utilizzo energetico delle stesse.
Il D.L. n. 181/2023, articolo 5, comma 3-bis, ha disposto che il riferimento agli impianti alimentati a biomassa di cui al citato comma 8 dell’articolo 24 del D.lgs. n. 28/2011, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
In attuazione delle suddette norme, ARERA ha adottato la delibera 9 aprile 2024 132/2024/R/eel.
| D.lgs. 28/2011
|
| Testo vigente articolo 24, comma 8
|
Testo articolo 24, comma 8 risultante da modifica ex art. 5-bis D.L. 63/2024
|
| 8.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente dell’impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell’impianto;
c)gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all’utilizzo energetico delle stesse.
|
8.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente dell’impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell’impianto;
c)gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all’utilizzo energetico delle stesse.
|
Il comma 2 interviene sul D.M. 224/2023 relativo alle garanzie di origine (GO) da fonti rinnovabili, e specificamente, reca disposizioni volte a chiarire cosa si intenda, all’interno del medesimo decreto, per biometano autoconsumato ai fini dell’applicazione delle specifiche norme previste.
In particolare, l’articolo 11, comma 5 del D.M. 224/2023 dispone, alla lettera a), che le GO emesse per la produzione di biometano da impianti di produzione incentivati, se riferite a biometano autoconsumato, sono contestualmente annullate e, conseguentemente, ai fini della valorizzazione della tariffa premio (prevista dal meccanismo di incentivazione) per la medesima quantità di biometano il prezzo medio mensile delle GO è nullo.
Il comma 2 qui in esame, ai fini dell’attuazione della disposizione suddetta, prevede che per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell’ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d’origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall’applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.
Rimangono ferme le disposizioni del D.M. relative ferme alle GO per la produzione del biometano impiegate nel settore “altri usi” (di cui all’articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto, cfr. infra, ricostruzione normativa).
La norma viene esplicitamente finalizzata a favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare.
Il D.M. 14 luglio 2023, n. 224, ha dato attuazione all’articolo 46 del D.lgs. n. 199/ 2021, in materia di garanzie di origine (GO) dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (cd. decreto GO). Per quanto qui specificamente interessa, l’articolo 11 reca disposizioni specifiche per la certificazione della produzione di biometano.
Ai sensi del comma 5, le GO emesse per la produzione di biometano da impianti di produzione incentivati:
a)
se riferite a biometano autoconsumato, sono contestualmente annullate e, conseguentemente, ai fini della valorizzazione della tariffa premio (prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera v) del D.M. 15 settembre 2022) per la medesima quantità di biometano il prezzo medio mensile delle GO è nullo;
b)
su indicazione del produttore, possono essere emesse direttamente all’acquirente con cui ha sottoscritto un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le GO sono contestualmente annullate.
c)
se impiegate nel settore trasporti possono essere annullate solo per l’utilizzo nel territorio italiano e dai seguenti soggetti: i. imprese di vendita di gas naturale per il settore trasporti; ii. gestori o titolari di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti;
d)
se impiegate nel settore altri usi possono essere annullate solo nel territorio italiano dalle società di vendita di gas naturale, che dovranno indicare, in fase di annullamento, almeno: i. le informazioni sul cliente finale beneficiario dell’annullamento delle GO; ii.la tipologia di utilizzo del biometano nel settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo, ad esempio: processi industriali, riscaldamento e/o raffrescamento, cogenerazione.
Articolo 6, comma 1 - SOPPRESSO
(Tipologia dei rischi di protezione civile. Epizoozie)
L’articolo 6, comma 1, risulta soppresso a seguito di una modifica approvata dal Senato. Tale comma inserisce il riferimento alle epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell’ambito del rischio “igienico-sanitario”, incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l’azione del Servizio nazionale della protezione civile.
Il comma 1 modifica l’articolo 16, comma 2, del Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Tale comma 2 elenca i rischi in relazione ai quali può esplicarsi l’azione del Servizio nazionale della protezione civile, ferme restando le competenze e le attività dei soggetti competenti nelle medesime materie. Il medesimo comma individua le seguenti tipologie di rischio: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario (ivi incluse, dispone la novella, le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali) e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
Si ricorda che il termine “epizoozia” dovrà intendersi la diffusione di una malattia infettiva, in un territorio più o meno esteso, a un gran numero di animali della stessa specie o di specie diverse, ed eventualmente anche all’uomo.
Secondo la relazione illustrativa la modifica presenta un “carattere descrittivo, più che precettivo”, in quanto “a legislazione vigente, il ventaglio delle tipologie di rischio che prevedono il coinvolgimento del Servizio nazionale di protezione civile già abbraccia le suddette epizoozie”.
La relazione tecnica evidenzia che il comma in esame, di natura ordinamentale e non comportante oneri finanziari, introduce una specificazione “rivolta a chiarire che nella più ampia categoria delle emergenze di carattere igienico sanitario sono comprese anche le epizoozie”.
Il comma 1 del medesimo articolo 16 del Codice di protezione civile individua le tipologie dei rischi di protezione civile e dispone che l'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge n. 353 del 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).
Si rammenta che l’art. 18 del regolamento di organizzazione del Ministero della salute (d.P.C.m. 30 ottobre 2023, n. 196) attribuisce al Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) le attività di coordinamento e di vigilanza, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della Salute, in tema di salute animale, farmaci veterinari e benessere degli animali. Nell'ambito del medesimo Dipartimento operano il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (art. 5 del decreto legislativo n. 136 del 2022) e la Direzione generale della salute animale, le cui competenze sono disciplinate dall’art. 21 del citato d.P.C.m. n. 196.
Si rammenta, altresì, che il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (d.P.C.m. 16 ottobre 2023, n. 178) attribuisce al Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale funzioni inerenti alla gestione di forme di aiuto alle imprese agricole e zootecniche colpite da epizoozie e per la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi connessi alle malattie epizootiche.
Articolo 6, comma 2
(Utilizzo del Fondo per la biosicurezza)
L’articolo 6, comma 2, rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.
Nel dettaglio, la disposizione in commento rifinanzia, con gli stanziamenti sopra indicati, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all’articolo 26 del D.L. n. 4/2022. Tale disposizione è finalizzata a contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, ad incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.
Si ricorda che l’articolo 26 del D.L. n. 4/2022, al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, ha istituito due fondi denominati, rispettivamente, Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado.
Il D.M. 29 aprile 2022 ha ripartito il finanziamento di 15 milioni di euro tra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Nella ripartizione delle risorse è stato assegnato un maggior peso alla consistenza del patrimonio suinicolo delle singole regioni, rispetto alla tipologia di allevamento.
E’ prevista, inoltre, la clausola di copertura finanziaria che prevede che agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in complessivi 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
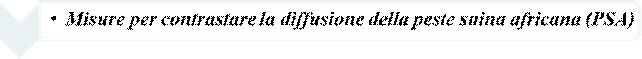
Tra le misure più incisive per contrastare la diffusione della PSA si ricorda il D.L.n. 9/2022 - e successive modifiche – emanato al fine di eradicare la malattia, prevenire la sua diffusione nei suini da allevamento, assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Il provvedimento in questione ha previsto la figura di un Commissario straordinario, supportato da tre sub-commissari, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere.
Il Commissario straordinario – dott. Vincenzo Caputo nominato con DPCM 25 febbraio 2023 - ha elaborato un Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (2023-2028), che persegue l'obiettivo della rimozione annuale tra il 70% e l'80% della popolazione presente, stimata approssimativamente tra 1 e 1.5 milioni di capi, in un arco temporale limitato dai 3 ai 5 anni.
Il Piano contempla anche attività di installazione e manutenzione delle recinzioni e barriere per frazionare il territorio e proteggere le aree interessate dall'infezione.
È, inoltre, previsto l'allestimento di attrezzature per la verifica della popolazione degli ungulati (droni ed altri sistemi similari), sistemi di cattura, mezzi speciali e servizi per la rimozione di carcasse in aree impervie.
Si ricorda, infine, che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati:
§
in data 25 gennaio 2023 ha svolto l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021;
§
in data 20 giugno 2023 ha approvato la risoluzione n. 8-00016 sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale;
§
in data 28 giugno 2023 ha svolto l'audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per della malattia;
§
in data 19 febbraio 2024 ha svolto l'audizione del Generale di Brigata Raffaele Covetti, Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, in merito alla catena di controlli sui prodotti alimentari importati posta in essere in relazione al diffondersi della peste suina.
Articolo 6, comma 2-bis
(Disposizioni sul prelievo di cinghiali)
L’articolo 6, comma 2-bis, introdotto durante l’esame al Senato, consente, sino al 31 dicembre 2028 la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.
La disposizione in esame, al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste suina africana (PSA) consente sino al 31 dicembre 2028 la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi come ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere [previsti al punto 2.3), lettera b) del decreto del MASE 13 giugno 2023], nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.
Si ricorda che l’attuale Piano Straordinario - di cui all’articolo 2, comma 2,lettera b) del D.L. n. 9/2022 – è emanato dal Commissario straordinario alla PSA, ha valenza sull’intero territorio nazionale, esclusa l’intera regione Sardegna, ed è riferito al quinquennio 2023-2028. L’obiettivo generale del Piano è la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.
Articolo 6, comma 3
(Poteri del Commissario straordinario e concorso delle Forze armate nel contrasto alla peste suina africana)
L’articolo 6, comma 3, con una modifica introdotta dal Senato definisce i poteri del Commissario straordinario istituito dalla legge n.9 del 2022. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all’attuazione delle misure per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.
Con una modifica proposta dal Senato, la norma chiarisce per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. La norma stabilisce anche che il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione
Sempre nel corso dell’esame al Senato, è stato previsto che per la messa in opera di recinzioni e altre strutture temporanee necessarie al contenimento dell’epidemia, il Commissario operi anche in zone indenni adiacenti alla zona infetta, ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali.
La norma in esame, aggiungendo il comma 9-quater, all’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, estende poi anche ai sub-commissari l’autorizzazione ad adottare i provvedimenti contingibili che lo stesso articolo 2 del decreto legge (al comma 6) attribuisce al Commissario.
Per disciplinare il concorso delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all’azione di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, la norma in esame introduce un nuovo articolo, il 2-bis, al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
Il comma 1, del nuovo articolo 2-bis, prevede che i piani di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all’articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario sono attuati anche con il concorso del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l’utilizzo di idoneo equipaggiamento.
Si ricorda che l’art.89 del codice dell’ordinamento militare definisce come segue i compiti delle Forze armate:
- compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
- le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
- le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.
Il comma 2 del nuovo art.2 bis autorizza un contingente massimo di 177 unità di personale delle Forze armate a svolgere il servizio in questione, per un periodo non superiore a dodici mesi. I relativi oneri (riferiti a personale e funzionamento), nel limite massimo di euro 2.000.000 per l’anno 2024 e di euro 1.000.000 per l’anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario. A tale personale possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinarie, oltre i limiti massimi di legge, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.
Il comma 3 del nuovo art. 2 bis, al fine di consentire l’assolvimento dei compiti assegnati, la norma prevede l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare non appartenente all’Arma dei carabinieri (che hanno già tale qualifica). I militari possono procedere alla identificazione di persone al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l’attività. Sono espressamente escluse tutte le funzioni spettanti alla polizia giudiziaria. Ai fini dell’identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri.
Il comma 4, del nuovo articolo 2-bis, prevede la possibilità, per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione, di utilizzare le armi in dotazione, ove compatibili con il servizio.
Il comma 5, del nuovo articolo 2-bis, stabilisce che ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli obblighi del datore di lavoro sono a carico del Commissario straordinario.
Con una modifica nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il comma 6, del nuovo articolo 2-bis, che nella formulazione originaria prevedeva che il Commissario straordinario o i sub-commissari potessero È stata anche soppressa la relativa copertura finanziaria, indicata dal comma 7.
Il comma 8, del nuovo articolo 2-bis, intervenendo su un diverso aspetto, autorizza il Commissario straordinario a integrare, entro il 15 giugno 2024, la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare d’urgenza. Con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari, anche rispetto all’attuazione della pianificazione commissariale.
Articolo 6, comma 3-bis
(Prelievo selettivo del cinghiale)
L’articolo 6, comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina degli strumenti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 13 della legge n. 157 del 1992, stabilendo che per l’attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa) è consentito l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l’esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 185 del 1990.
Nel dettaglio la disposizione in commento interviene, inserendo il nuovo comma 2-ter nell’articolo 13 della legge n. 157 del 1992, e specificando che nell’ambito del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa) è consentito l’utilizzo di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna - ad esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento - ai sensi dell’art. 2 della legge n. 185 del 1990.
Si ricorda, che il sopra richiamato articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 descrive, ai commi 1 e 2, i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria specificando le caratteristiche dei singoli strumenti idonei per l’esercizio dell’'attività venatoria. In particolare, è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. Il successivo comma 3 specifica che i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dai cacciatori e non lasciati sul luogo di caccia.
L’art. 2 della legge n. 185 del 1990 definisce i “materiali di armamento” quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. La stessa disposizione specifica che i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
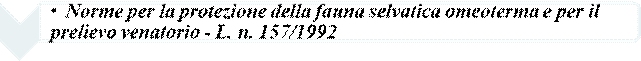
In estrema sintesi la legge riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne prevede la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
Nel corso della attuale legislatura il provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi modificativi ed integrativi, si segnalano al riguardo quelli apportati dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha interamente sostituito l'articolo 19 in materia di controllo della fauna selvatica e che ha aggiunto l'articolo 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
Inoltre, ulteriori modifiche hanno riguardato:
§
l'articolo 18 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria (articolo 11-bis, D.L. n. 104/2023);
§
l'articolo 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 (articolo 11-ter, D.L. n. 104/2023).
Ulteriormente, è stato previsto anche che:
§
i Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo (articolo 17-bis, comma 2, D.L. 44/2023);
§
con riguardo alla tutela dell'orso marsicano, chi li abbatte, cattura o detiene è sottoposto ad una sanzione penale (articolo 6-bis, D.L. n. 105/2023).
Sono, infine, all’esame della Commissione XIII (Agricoltura) le seguenti proposte di legge:
• A.C. 1375 Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive;
• A.C. 1548 e abbinate Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
• A.C. 167 e abbinate Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 7
(Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie del granchio blu)
Nel dettaglio, il comma 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato- Regioni, la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus).
Tale previsione ha una triplice finalità:
- contrastare e limitare la proliferazione della specie invasiva del granchio blu che da molti mesi sta infestando alcune zone costiere italiane;
- impedire l’ulteriore aggravamento dei danni economici subiti dalle imprese del settore ittico e, al contempo, promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore;
- contribuire a salvaguardare la biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza.
La medesima disposizione specifica poi i requisiti per la nomina, i casi di revoca, la durata dell’incarico (31 dicembre 2026), nonché il compenso spettante al Commissario straordinario.
Come si legge, nella Relazione Illustrativa, allegata al provvedimento in esame, l’intervento di una struttura commissariale è considerata una soluzione necessaria al fine di apprestare nel breve periodo strumenti efficaci di contrasto al suddetto fenomeno dell’invasione del granchio blu, che unitamente ad ai cambiamenti climatici, al perdurare del conflitto in Ucraina e, alla crisi energetica, hanno determinato, per le imprese del settore ittico, da un lato, un drastico calo della produzione e, dall’altro, un aumento dei costi di funzionamento aziendale. La stessa Relazione indica che le aree geografiche maggiormente colpite dal fenomeno in questione, sono le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Nel gennaio del 2024, in particolare, è stato registrato un calo del 96,9% della produzione, rispetto al corrispondente mese nell’anno precedente, che ha indotto gli operatori ad arrestare l’attività di raccolta a tempo indefinito. Nella medesima Relazione, si specifica poi che il danno arrecato dal granchio blu alle venericolture e alle attività legate alla pesca artigianale è da ricondurre alla perdita non solo di prodotto di taglia commerciale, ma anche delle mezzane e del seme, cui consegue la compromissione delle produzioni relative ai prossimi anni. Si segnalano, infine, i danni connessi all’aumento dei costi di produzione, dovendo gli allevatori sostenere i costi relativi all’installazione e alla manutenzione dei sistemi di protezione, all’acquisto o alla realizzazione in proprio delle attrezzature per catturare il granchio blu, allo smaltimento degli esemplari catturati, etc.
Il comma 2 reca disposizioni concernenti la struttura che opera a supporto del Commissario straordinario e che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. Essa è costituita e disciplinata con ordinanze del Commissario straordinario ed ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma 3 indica il contingente di personale non dirigenziale di 7 unità che è assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2.
Il comma 4 prevede che il predetto contingente può essere integrato con personale degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli stessi enti territoriali.
Il comma 5 prevede l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, di un piano di intervento, in cui sono delineate le diverse misure atte al contenimento e al contrasto della specie del granchio blu. Il predetto Piano - che è trasmesso dal Commissario Straordinario al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -, contiene diversi interventi tra i quali quelli diretti a:
1) salvaguardare la biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza;
2) catturare la specie del granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
3) porre in essere strutture idonee a contenere l’invasione delle suddette specie;
4) impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
5) promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore ittico.
Il comma 6 stabilisce che per la redazione del Piano sopra illustrato - che è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - il Commissario può avvalersi dell’ISPRA, del CNR e del CREA.
Ai sensi del comma 7 il Commissario provvede all’attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, attraverso ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall’intervento oggetto di attuazione.
Il comma 8 sancisce che per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.
Il comma 9 destina per l’attuazione del piano di intervento di cui al comma 5, 1 milione di euro per l’anno 2024, 3 milioni per l’anno 2025 e 6 milioni per il 2026. Sono indicate le modalità di copertura finanziaria.
Il comma 10 statuisce che il Commissario straordinario trasmette periodicamente una relazione sulle attività svolte e su quelle da svolgersi al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il comma 11, infine, precisa che le risorse di cui al comma 10 sono riversate in un’apposita contabilità speciale, presso la tesoreria statale intestata al Commissario.
Si ricorda che il decreto-legge n. 104 del 2023 è intervenuto prevedendo apposite misure normative volte a contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie di granchio blu (Callinectes sapidus).
In particolare, l’art. 10, comma 1, del predetto decreto-legge 104 del 2023 convertito, con modificazioni dalla legge n. 136 del 2023, ha autorizzato, a decorrere dal 1° agosto 2023, la spesa di 2,9 milioni di euro in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del granchio blu. Il comma 2 della stessa disposizione attribuisce ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di individuare le aree geografiche colpite dall’emergenza della proliferazione del granchio blu, i beneficiari del sostegno menzionato al comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere allo stesso sostegno nonché i costi ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse sopra menzionate. Il terzo comma dell’art. 10 ha poi istituito, nello stato di previsione del Ministero della agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500 mila euro per l’anno 2023 in favore delle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacoltura. Si prevede, nello specifico, che - nelle more della ridefinizione dei requisiti per l’accesso ai benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 102 del 2004 anche in favore delle imprese e dei consorzi operanti nel suddetto settore dell’acquacultura ed al fine di sostenere l’attività di tale tipologia di imprese a fronte dei danni causati dalla proliferazione del granchio blu - sia istituito il Fondo sopra menzionato al fine di assegnare alle suddette imprese il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. È poi demandato ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato- Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle predette somme. In attuazione di quanto disposto dai precedenti commi è stato emanato il D.M. 15 dicembre 2023.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) è intervenuta in materia:
- disponendo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (articolo 1, commi 443-445);
- introducendo modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi a sostegno delle imprese agricole. In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà (lettera a) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c) (articolo 1, comma 446).
Da ultimo, con decreto del 19 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 Aprile scorso, è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione della specie Granchio blu nei territori della regione Veneto. Tale decreto è stato emanato ai sensi dell’art. 6 del sopra citato decreto legislativo n. 102 del 2024. Tale ultima disposizione individua le procedure e le modalità per l’attivazione di interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l’individuazione dei territori danneggiati, le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale.
Si fa presente, infine, che la questione della misure da adottarsi con riferimento alla proliferazione della specie del granchio blu è stata affrontata nella Risoluzione 7-00141 e nella Risoluzione 7-00137 entrambe approvate dalla Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati.
Articolo 8, commi 1-3
(Commissario straordinario per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)
L’articolo 8, commi da 1 a 3, prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone durata dell’incarico, compiti assegnati e prevedendo, altresì, la nomina di un subcommissario.
Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in commento demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina. Tale nomina è volta a:
- rafforzare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina;
- vagliare l’efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali.
Come chiarito nella Relazione Illustrativa allegata al provvedimento in esame, la misura normativa sopra illustrata ha carattere straordinario e temporaneo: la stessa disposizione chiarisce, infatti, che la nomina ha una durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile per una sola volta per il medesimo periodo temporale.
Il comma 2 individua i compiti assegnati al predetto Commissario straordinario nazionale che consistono:
-
nell’attività di coordinamento e monitoraggio delle attività che hanno luogo nei territori ove è diffusa la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2;
-
nell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell’ecosistema o a fronteggiare situazioni eccezionali, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. È previsto anche un richiamo alla supervisione e promozione dei processi afferenti l’attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità alla normativa nazionale e unionale.
I predetti provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
Si fa presente che il sopra citato Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, ha integrato il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. L’Allegato IV, in particolare, reca specifiche prescrizioni per le diverse malattie ai fini della concessione, mantenimento, sospensione, ritiro dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento e prescrizioni specifiche per la concessione ed il mantenimento dello status di indenne da malattie a livello di Stati membri o zone. In tale ambito i Capitoli 3 e 4, elencano i requisiti richiesti agli Stati membri dell’UE per ottenere la concessione dello status di territorio indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini ovini e caprini detenuti. La parte II, Capitolo 2, indica i requisiti necessari da possedersi nei casi di infezione da Mycobacterium tuberculosis.
Il comma 3 precisa che il Commissario straordinario, per le esigenze connesse all’esecuzione e allo svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali, può avvalersi di un sub-commissario. A quest’ultimo sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario.
Si fa presente che lo scorso 28 febbraio nella seduta dedicata allo svolgimento del question time nell’Aula della Camera, è stata affrontata la questione della diffusione delle predette malattie, con particolare riferimento ad alcune regioni del Sud Italia e all'ipotesi della nomina di un commissario nazionale ad hoc, al fine di superare le criticità riscontrate.
Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2023 (L.n. 197/2022) ha istituito, presso il MASAF, il Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 427). In attuazione della misura si veda il D.M. 29 novembre 2023.
Articolo 8, commi 4 e 5
(Contingente di supporto al Commissario straordinario nazionale presso il Ministero della salute)
L’articolo 8, comma 4, stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo al rimborso delle spese sostenute.
Al tal fine, la Direzione può essere potenziata con l’assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
Il comma 5 precisa che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell’eventuale rimborso delle spese di cui al precedente comma.
L’articolo 8, comma 4, prevede che, relativamente alle misure di contrasto ed eradicamento della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, nonché della tubercolosi bovina e bufalina, il Commissario straordinario si avvale del supporto della Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale lo stesso opera.
A tale proposito si precisa, per completezza, che la denominazione formale della Direzione è “Direzione generale della salute animale e dei farmaci veterinari”.
In particolare, la Direzione è tenuta, nella sua attività ausiliare, a provvedere al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento di missione e nei limiti delle risorse disponibili.
Per lo svolgimento della sua attività di supporto, la Direzione generale della sanità animale può essere potenziata con un contingente massimo pari a quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
In proposito, secondo la relazione tecnica allegata al decreto-legge, il rimborso spese di cui al comma 4 spetta al personale eventualmente assegnato al contingente di supporto del Commissario.
Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Si precisa, inoltre, che dall’atto di collocamento fuori ruolo, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
In proposito, l’art. 17, comma 14, L. n. 127/1997 stabilisce che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari prevedano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
Il comma 5 stabilisce, inoltre, che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell’eventuale rimborso spese di cui al comma precedente.
Articolo 8, comma 6
(Copertura degli oneri di cui al comma 4)
L’articolo 8, comma 6, stabilisce la copertura degli oneri di cui al comma 4 del medesimo articolo, dovuti ai maggiori compensi per lavoro straordinario e buoni pasto del contingente di supporto per il Commissario straordinario nazionale.
Il comma 6 autorizza la copertura della spesa prevista per la corresponsione al contingente di personale di 15 persone di cui al precedente comma 4 (v. ante) a supporto del Commissario straordinario nazionale, a titolo di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni, come segue:
-
76.720 euro per l’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente costituito per reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti eliminati, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, come previsto dal comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026.
In proposito si ricorda che i residui delle spese correnti non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti – cioè non più disponibili - agli effetti amministrativi. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il settimo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Si osserva che i residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza sui pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità del loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.
-
125.160 euro per il 2025 e 54.800 per il 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Articolo 9
(Riorganizzazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri)
L’articolo 9, al fine di rafforzare le funzioni dell’Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare:
al comma 1, lettera a) istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive;
al comma 1, lettere b) e c) pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma 2 stabilisce una clausola di invarianza finanziaria.
Comma 1, lettera a)
Con il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, l’Arma dei carabinieri ha acquisito funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare.
Tale decreto ha anche istituito la figura del “personale ispettivo con compiti di polizia ambientale”, demandando a un decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’interno, la definizione delle competenze e dei criteri di svolgimento delle attività.
La norma in esame completa tale intervento, introducendo la figura del “personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare”. Viene anche stabilito che con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’interno, siano definite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive (prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale, nell’esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell’intervento stesso).
La norma in esame prevede altresì che il Comandante Generale dei Carabinieri individui con propria determinazione i militari incaricati dell’attività ispettiva, nonché i relativi requisiti, la formazione e l’aggiornamento.
Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l’intervento è motivato dall’aumento delle attività di controllo rientranti nell’area di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che non potrebbero essere svolte in maniera efficace dalle sole strutture ministeriali.
La relazione governativa indica in particolare alcuni recenti interventi normativi:
-l’entrata in vigore, il l° gennaio 2025, del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, che introduce norme relative all’immissione nel mercato comune e all’esportazione dall’Unione europea di prodotti contenenti le seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, nonché dei prodotti nutriti o fabbricati usando le suddette materie. Rispetto a tali prodotti le autorità nazionali dovranno anche controllare che operatori e commercianti adempiano agli obblighi previsti dal regolamento in tema di contrasto alla deforestazione, alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità;
-l’articolo 23-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che ha assegnato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite le unità specializzate dell’Arma dei carabinieri, la competenza (prima attribuita al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) al rilascio di tutte le certificazioni e licenze di esportazione, importazione e riesportazione, in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione di cui alla Convenzione di Washington CITES, così come recepita dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
La relazione segnala inoltre che - in virtù di “un’accentuata attenzione dell’opinione pubblica” e dell’evoluzione del quadro normativo, è necessario incrementare i controlli sulla salute e sul benessere degli animali nelle aziende agricole, verificando le relative condizioni ambientali (quali la qualità dell'aria, l'illuminazione, il rumore, etc.) e contribuendo a prevenire e controllare i focolai di malattie.
Comma 1, lettere b) e c)
Il comma 1, lettera b), modificando il comma 2, lettera a) dell’articolo 174 bis del codice dell’ordinamento militare, stabilisce la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva una dipendenza funzionale dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.
Si ricorda che il vigente articolo 174 bis del codice dell’ordinamento militare, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, prevede la dipendenza funzionale del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.??
La previsione – si legge nella relazione illustrativa – discende dal fatto che le attribuzioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - come definite dall’articolo 3 del decreto-legge n. 173 del 2022, convertito nella legge n. 204 del 2022 - risultano trasversali a tutte le attività espletate dai Comandi dipendenti dal Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari, non più solo dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.??
Secondo la relazione governativa, la modifica in esame consente la definizione di obiettivi strategici generali maggiormente sistemici e aderenti alle diverse funzioni del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari La norma è volta ad assicurare la necessaria continuità nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nella prospettiva di una maggiore efficacia, continuità ed unicità delle azioni di polizia forestale, idraulica e ambientale.
In linea con il nuovo assetto delle competenze, il comma 1, lett. c), modificando il comma 2-quater dell’articolo 174 bis del codice dell’ordinamento militare, stabilisce che gli obiettivi strategici del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari siano definiti dal Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 9-bis
(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)
L’articolo 9-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.
L’articolo in esame, approvato dal Senato, modifica l’articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito dalla legge n. 44 del 2019), recante norme sul monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.
La citata norma mira a monitorare la produzione lattiero-casearia in Italia per garantire la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi. Le principali misure istituite a tali fini sono:
·
Obbligo di registrazione: i primi acquirenti di latte crudo, le aziende produttrici di latticini e i produttori di latte (registrati nel SIAN) devono registrare periodicamente nella banca dati del SIAN una serie di informazioni. Gli obblighi di registrazione variano a seconda del soggetto: i primi acquirenti di latte crudo devono registrare mensilmente le quantità di latte vaccino, ovino e caprino conferito/acquistato/prodotto/ceduto; il tenore di materia grassa del latte ovino e caprino conferito; il Paese di provenienza del latte e dei prodotti lattiero-caseari semilavorati acquistati da Paesi extra Ue (comma 1). Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
·
Accesso ai dati: i produttori di latte (registrati nel SIAN) possono consultare i dati relativi ai primi acquirenti (quantità di latte registrate) nella banca dati del SIAN.
·
Sanzioni: chiunque non adempie agli obblighi di registrazione è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 20.000 euro (vedi infra).
·
Controlli: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF, che irroga le sanzioni) del MASAF, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni.
In particolare, il comma 4 dell’articolo novellato prevede che chiunque non adempie agli obblighi di registrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto a una amministrativa la cui forbice edittale viene ridotta dall’articolo in esame (lettera a) del comma 1). In particolare, il minimo edittale viene ridotto da 5.000 a 1.000 euro, mentre il massimo passa da 20.000 a 6.000 euro. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.
La lettera b) del comma 1 inserisce all'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 il nuovo comma 4-bis ai sensi del quale, nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.
Articolo 9-ter
(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche)
Il comma 1 della disposizione in commento, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone modifiche all’articolo 79 della L. n. 238/2016 (c.d. Testo unico della vite e del vino), sostituendo il comma 3 della citata disposizione.
In particolare, il nuovo comma 3 dell’articolo 79, così come novellato dal comma 1, stabilisce che il soggetto rivendicante una denominazione protetta, ed immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta in questione e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro 30 giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Inoltre, il soggetto inadempiente, oltre alla sanzione pecuniaria sopra indicata, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
Si ricorda che l’articolo 79 della L. n. 238 del 2016 (ricompreso nel Capo IV relativo alle violazioni in materia di adempimenti amministrativi) disciplina i piani di controllo di una denominazione protetta, approvati dal corrispondente provvedimento autorizzatorio.
Si fa presente che di recente, in ambito europeo è stato definitivamente approvato, il regolamento che riforma la normativa dell'Unione in materia di protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli.
Il regolamento - pubblicato nella G.U. dell'UE il 23 aprile 2024 - prevede, tra l'altro:
- una procedura di registrazione semplificata ed un periodo massimo di 6 mesi, per l'esame delle domande;
- una maggiore protezione delle indicazioni geografiche (IG), anche online. I nomi di dominio che le utilizzino illegalmente potranno essere chiusi o disabilitati. L'Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) istituirà a tal fine un sistema di allarme;
- un ruolo rafforzato per le associazioni di produttori che potranno, laddove non lo siano già, essere riconosciute dagli Stati membri e a cui potranno essere conferiti maggiori poteri e responsabilità;
- regole per l'uso di un prodotto a denominazione IG come ingrediente di un prodotto trasformato. Per comparire nell'etichetta o nella pubblicità di tali prodotti l'ingrediente IG dovrà essere utilizzato in quantità sufficienti da costituirne una caratteristica essenziale e la sua percentuale dovrà essere indicata. L'utilizzo dei prodotti con denominazioni IG come ingrediente di prodotti alimentari preimballati, dovrebbe essere consentito previa notifica alla pertinente associazione di produttori riconosciuta;
- regole per l'utilizzo dei nomi dei produttori e delle IG sugli imballaggi;
- la valorizzazione di pratiche di sostenibilità ambientale, sociale od economica, anche nel disciplinare
- l'abrogazione (art. 94) del regolamento UE n.1151 del 2012.
Il comma 2 della disposizione in esame, apporta modifiche all’articolo 9 della legge 23 del 2022 (“Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”) inserendo, nella citata disposizione, il nuovo comma 6-bis.
Si ricorda che l’articolo 9 sopra citato istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica.
In particolare, il comma 6-bis introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare di cui all’art. 59, comma 1 della legge n. 488 del 1999.
Si prevede, in particolare, che gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,- ossia i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari autorizzati e degli altri prodotti descritti al comma 1 del suddetto art. 59 -, certificano che il contributo annuale per la sicurezza alimentare sopra menzionato:
- sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato;
- sia stato corrisposto nel capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art. 9 legge 23 del 2022. È stabilito che le suddette certificazioni devono essere registrate sul portale informatico del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) del MASAF e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione in commento demanda la definizione delle modalità di inserimento delle predette certificazioni, ad un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L’art. 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), cosi come modificato dal sopra citato art. 9 della legge n. 23 del 2022, ha istituito, allo scopo di sostenere lo sviluppo di una produzione biologica e di perseguire l'obiettivo della riduzione dei rischi per la salute umana animale ed ambientale, un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di:
- prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del DPR 290 del 2001 e degli art. 5, al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
- fertilizzanti da sintesi da individuarsi con appositi decreti;
- prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con specifiche sigle identificative.
L’elenco aggiornato di tali prodotti è contenuto nei decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma. Il comma 1-bis individua i soggetti tenuti al versamento del predetto contributo individuandoli nei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti sopra richiamati, in base al relativo fatturato di vendita.
Inoltre, al comma 3 si stabilisce che le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020. È, infine, specificato che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare maggiori oneri, o nuovi oneri, per la finanza pubblica.
Infine, il comma 4 stabilisce che dalle disposizioni di cui all’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 9-quater
(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo de Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)
Il comma 1 della disposizione in commento indica la finalità della norma in esame, ossia, da un lato, razionalizzare e, dall’altro, implementare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, migliorando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Inoltre, col fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Si ricorda che il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN (articolo 15, D. Lgs. n. 74/2018).
In forza del comma 2, l’AGEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni che le sono attribuiti in base alle disposizioni vigenti.
Il comma 3 stabilisce che il Registro delle imprese deve provvedere alla cancellazione di SIN S.p.A., su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività indicate nel comma 4.
Quest’ultimo afferma che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione. In ragione dello stesso comma 4, tali documenti contabili vengono trasmessi ad AGEA, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
A norma del comma 5, ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti (a prescindere dal nomen iuris), fino alla data dell'incorporazione sopra specificati. Per gli adempimenti descritti nel comma 4, ai componenti di tali organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine sopra indicato.
Il comma 6 statuisce che le risorse finanziarie e i beni strumentali (materiali e immateriali) di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale, sono trasferiti al Fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 74/2018.
In forza del comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.
Ai sensi del comma 8, è stabilito che il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A. in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione sopra indicata, è trasferito alle dipendenze di AGEA. La disposizione, impone la necessità di operare una procedura di selezione pubblica, finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, anche tenendo conto dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica si svolgerà secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'AGEA, e dovrà essere completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione prevista dal comma 9.
Quest’ultimo stabilisce che il direttore di AGEA provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli di AGEA, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, che deve essere adottata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta da AGEA per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A., per l'anno 2024, alla data di entrata in vigore della normativa in esame.
Ciò posto, il comma 10 stabilisce che, all’esito della procedura di inquadramento (come disciplinata dai commi 8 e 9), la dotazione organica di AGEA è modificata in misura pari ai dipendenti presenti in servizio, e di un numero di posti equivalente, sul piano finanziario, alle possibilità di assunzione di AGEA, maturate e disponibili a legislazione vigente.
Tale numero viene incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze di AGEA.
In forza del comma 11, spetta al direttore dell’AGEA provvedere, inoltre, alle modifiche necessarie per l’adeguamento dello statuto, del regolamento di organizzazione e del regolamento del personale, in conseguenza dell'incorporazione.
Inoltre, il comma 12 afferma che, dalla data dell'inquadramento effettuato con le modalità descritte dal comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 7, il trattamento economico fondamentale di cui gode il restante personale dipendente di AGEA (lett. a)). Inoltre, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. (alla data di entrata in vigore del decreto in esame) maggiore rispetto al trattamento riservato al personale dipendente dell'AGEA, viene applicato un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche se determinati dalla contrattazione collettiva (a livello nazionale o decentrato), fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva (lett. b)). In aggiunta (lett. c)), è riconosciuto un trattamento retributivo accessorio, fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'AGEA e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti. Infine, è applicato il regime previdenziale in godimento (lett. d)).
Il comma 13 statuisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il direttore dell'AGEA deve predisporre un piano triennale, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in cui si enunciano le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN. Inoltre, dev’essere finalizzato alla razionalizzazione e all’efficientamento dell’intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, per conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.
A norma del comma 14, infine, si dispone che, per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano sopra descritto, all'articolo 01 del D. Lgs. n. 74/2018 in materia di attribuzioni del Ministero sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole il Ministero sono sostituite dalla parola AGEA, subentrando quest’ultima nelle funzioni di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica (articolo 1, comma 6-bis, D.L.n. 51/2015) e all'esecuzione dei relativi accordi quadro in relazione al governo e sviluppo di SIAN;
b) al comma 3 - attraverso la sostituzione della lettera a) - è previsto che al Ministero (MASAF) sono attribuite le funzioni di indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15, mentre ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
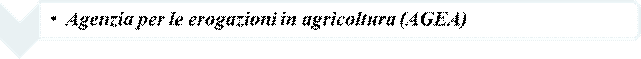
L’ Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è attualmente disciplinata dal D.lgs. n.74/2018 che ha provveduto alla sua riorganizzazione. In estrema sintesi l’Agenzia è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; ha una autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti. L'Agenzia svolge le funzioni di Organismo Pagatore (OP) e organismo di Coordinamento (OC) nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) [articolo 1, commi 1-3].
Come (OP) l’Agenzia provvede all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) [articolo 2, comma 1].
Come (OC) l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai Fondi FEAGA ed FEASR.
Inoltre è responsabile delle funzioni di rendicontazione all'UE dei pagamenti effettuati dagli Organismi Pagatori (OP) riconosciuti e promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi (articolo 3, commi 1-2).
Ultimi interventi normativi
Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, in favore di AGEA è stato autorizzato per l'anno 2024, un incremento di 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti (articolo 1, comma 41, della L. n. 213/2023).
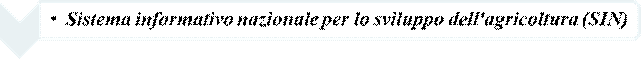
La società SIN S.r.l. è stata istituita il 29 novembre 2005, come società in house del Ministero dell’agricoltura e AGEA con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca (articolo 14, comma 10-bis, D.Lgs. n.99/2004).
Attualmente la società svolge le seguenti attività:
·
coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca;
·
progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;
·
ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;
·
supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA;
·
conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca (articolo 15-bis, D.Lgs. n.74/2018).
Si ricorda che, al fine dell’espletamento delle funzioni su richiamate, la società SIN è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le suddette finalità, la dotazione finanziaria dell'AGEA è incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 (articolo 1, commi 863 e 864 della L. n. 234/2021).
Articolo 10, comma 1
(Guardie venatorie)
L’articolo 10, comma 1, incide sul novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell’applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio.
Nel dettaglio, la disposizione in commento modifica la lett. b) dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza sull’applicazione della legge in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
In particolare, la norma, nella sua precedente formulazione, affermava che fosse affidata la vigilanza venatoria alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali, purché presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e, inoltre, alle guardie venatorie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali fosse riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. n. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS).
La disposizione in commento riconosce come affidatarie della vigilanza in materia le guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della L. n. 157 del 1992, e quelle delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS.
Si ricorda che l’art. 34 della L. n. 157/1992 disciplina le associazioni venatorie, affermando, al comma 1, la libertà nella loro costituzione.
Tuttavia, alle associazioni istituite mediante atto pubblico è permesso di chiedere il riconoscimento, purché in possesso di alcuni requisiti (precisi e non aggirabili, come affermato dal Consiglio di Stato, sent. N. 3339/2010): a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
Il riconoscimento avviene mediante decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (invero la norma si riferisce al Ministro dell’agricoltura e delle foreste) di concerto con il Ministro dell’interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (disciplinato dall’articolo 8 della L. n. 157/1992). Tale riconoscimento può essere revocato, a norma del comma 4 dell’articolo 34, ove vengano meno i requisiti indicati, mentre il comma 6 pone le associazioni nazionali riconosciute sotto la vigilanza del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Invero, alcune associazioni sono state riconosciute direttamente in forza della norma in esame, in particolare dal comma 5. A beneficiarne sono state: la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 1016/1939, come sostituito dall’art. 35 della L. n. 799/1967 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia).
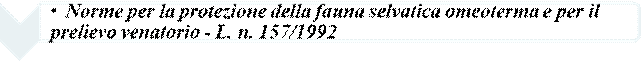
In estrema sintesi la legge riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne prevede la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
Nel corso della attuale legislatura il provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi modificativi ed integrativi, si segnalano al riguardo quelli apportati dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha interamente sostituito l'articolo 19 in materia di controllo della fauna selvatica e che ha aggiunto l'articolo 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
Inoltre, ulteriori modifiche hanno riguardato:
§
l'articolo 18 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria (articolo 11-bis, D.L. n. 104/2023);
§
l'articolo 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 (articolo 11-ter, D.L. n. 104/2023).
Ulteriormente, è stato previsto anche che:
§
i Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo (articolo 17-bis, comma 2, D.L. 44/2023);
§
con riguardo alla tutela dell'orso marsicano, chi li abbatte, cattura o detiene è sottoposto ad una sanzione penale (articolo 6-bis, D.L. n. 105/2023).
Sono, infine, all’esame della Commissione XIII (Agricoltura) le seguenti proposte di legge:
• A.C. 1375 Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive;
• A.C. 1548 e abbinate Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
• A.C. 167 e abbinate Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 10, comma 1-bis
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
L’articolo 10, comma-1bis, inserito durante l’esame al Senato, apporta una modifica alla disciplina di cui all’art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio: viene esteso - dal 1° ottobre al 31 gennaio -, il periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa).
Nel dettaglio, la disposizione in commento - inserita durante l’esame al Senato - reca una modifica all’art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria, attraverso la sostituzione della lettera d) del comma 1 del menzionato art. 18. Viene così stabilito che il periodo di attività venatoria della specie cacciabile cinghiale (Sus scrofa) ha durata dal 1° ottobre al 31 gennaio.
Si ricorda che la norma in esame, precedentemente, consentiva la caccia del cinghiale dal 1° ottobre al 31 dicembre oppure dal 1° novembre al 31 gennaio.
L’estensione del periodo ha lo scopo di potenziare l’azione di contrasto alla diffusione della pesta suina africana (PSA).
Si ricorda che il sopra menzionato articolo 18 indica le specie di cui è consentito il prelievo venatorio, con specificazione dei periodi in cui tale attività si può espletare.
In particolare, tale disposizione distingue le specie cacciabili in cinque categorie, descritte, rispettivamente, dalle lettere a) – e) del comma 1.
Inoltre, il comma 2 demanda alle regioni di pubblicare il calendario regionale e il regolamento relativi all’annata venatoria, specificando che, con tale strumento, le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini desumibili dal comma 1, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
Articolo 10-bis
(Riserva per il personale volontario in graduatoria
nella procedura di reclutamento nel ruolo iniziale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2024.
La disposizione – introdotta dal Senato – dispone circa le assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2024.
In particolare, prevede per esse una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
La riserva opera per tale personale volontario, secondo l’ordine della graduatoria in cui risulta iscritto.
Rimangono ferme le ordinarie facoltà assunzionali, previste dal d.P.C.m. 4 dicembre 2023 per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. È l’atto di autorizzazione a bandire ed assumere unità di personale a tempo indeterminato appartenente al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2023 (sulle risorse da cessazione 2022).
Siffatta riserva del 30 per cento per il personale volontario fu prevista, si ricorda, dall’articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, per un novero di assunzioni straordinarie valevoli per il quadriennio 2018-2022 nonché per assunzioni incrementali rispetto alla dotazione organica, con decorrenza dal 2018 (cfr. commi 287 e 289 dell’articolo 1 della citata legge n. 205).
Successivamente è intervenuta, per quelle assunzioni e per altre indi previste, una proroga del termine di effettuazione delle assunzioni, al 31 dicembre 2024. Essa è stata disposta dall’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 215 del 2023.
A questa proroga del termine assunzionale, la disposizione qui in commento ‘aggancia’ la proroga (al medesimo 31 dicembre 2024) della riserva di posti del 30 per cento a favore del personale volontario.
Articolo 11
(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche)
L’articolo 11 reca una serie di misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. L’articolo in commento apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 39 del 2023 (“Decreto siccità”). In particolare, viene prevista la proroga della durata dell’incarico del Commissario Straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l’articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità.
Il comma 1 dell’articolo in commento è volto, in primo luogo, a tenere in considerazione le ulteriori necessità emerse dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2023 (“Decreto siccità”) al fine di accrescere l’efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e le attività programmatorie finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.
A tale proposito si ricorda che il citato Decreto siccità, riconoscendo la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione metereologica in atto, ha introdotto misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica.
L’articolo 1 del decreto-legge in questione ha istituito una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità e, in particolare, a eseguire una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge stesso.
Il programma degli interventi individuati dalla Cabina medesima è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla luce delle risorse disponibili, come comunicate dalle amministrazioni competenti e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma in commento integra le disposizioni del Decreto siccità prevedendo ulteriori misure finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione da parte della Cabina di regia. In particolare, si prevede che detto piano venga elaborato dal Commissario sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali. Queste ultime, sentite le regioni e le province autonome, individuano, per il territorio di competenza, degli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico del relativo bacino. L’individuazione di nuovi interventi da parte delle autorità di bacino distrettuali è preceduta da una ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.
Per quanto attiene al dettaglio delle modifiche apportate al decreto-legge n. 39 del 2023 si segnala che alla lettera a), i numeri 1 e 2 introducono all’articolo 1 del decreto-legge i seguenti commi:
-
il comma 4-bis stabilisce che le Autorità di bacino distrettuali, entro il 31 maggio 2024, individuino e trasmettano al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica ed entro il 31 ottobre 2024, trasmettano al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell’ultimo quinquennio;
-
il comma 4-ter prevede che il Commissario straordinario, entro il 15 giugno 2024, trasmetta alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle Autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica;
-
il comma 3-bis con cui si prevede che, entro il 30 giugno 2024, la Cabina di regia approvi la proposta di elenco delle misure più urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, individuando quelle che possono essere realizzate dal Commissario straordinario, anche avvalendosi di soggetti attuatori. A tale riguardo si ricorda come per soggetti attuatori si intendono i soggetti, pubblici e privati, che agiscono per l’attuazione del Piano degli interventi urgenti sulla base delle direttive del Commissario.
Il numero 3, invece, sostituisce i commi 5 e 6 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023.
Per quanto attiene al nuovo comma 5 si prevede che, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili, siano assegnate le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Il medesimo comma prevede, altresì, che le risorse assegnate per la realizzazione degli interventi affidati al Commissario confluiscono nella contabilità speciale del medesimo Commissario.
Il nuovo comma 6, invece, al fine di individuare idonea copertura finanziaria per la celere realizzazione degli interventi di cui ai citati Allegati 1 e 2 (vedi infra), prevede che alla copertura finanziaria necessaria per la realizzazione di tali opere, si provveda a valere sulle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione sopra descritta.
La lettera b) interviene sull’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del2023 attraverso puntuali modifiche al comma 1, al fine di prorogare, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, la durata dell’incarico del Commissario, in considerazione dell’esigenza di assicurare adeguata tempistica per la realizzazione degli interventi assegnati al Commissario dalla Cabina di regia.
A tale proposito si prevede, pertanto, che al compenso del Commissario si provveda, anche per l’annualità 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo si ricorda che per il compenso del Commissario è stata autorizzata la spesa di euro 77.409 per l’anno 2023 e di euro 132.700 per l’anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione.
Una ulteriore modifica apportata dalla lettera b) riguarda, a seguito della proroga dell’attività del Commissario, l’individuazione di una idonea copertura finanziaria per l’attività della struttura commissariale anche per l’anno 2025. Si ricorda infatti che la struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario e che per la stessa era stata autorizzata la spesa di euro 873.591 per l’anno 2023 e di euro 1.497.584 per l’anno 2024.
Da ultimo il comma 2 aggiunge al decreto-legge n. 39 del 2023 gli Allegati 1 e 2, di cui agli allegati I e II del decreto in esame, che individuano, rispettivamente, gli interventi relativi alle infrastrutture idriche affidati al Commissario integralmente finanziati con le risorse messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelli che risultano già cofinanziati anche da precedenti fonti di finanziamento nazionali e regionali e che beneficiano di un ulteriore contributo. Di seguito il dettaglio degli interventi previsti:
| Regione
|
Intervento
|
| Emilia-Romagna
|
Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale
|
| Emilia-Romagna
|
Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo
|
| Emilia-Romagna
|
Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo
|
| Lazio
|
Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica
|
| Piemonte
|
Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° stralcio funzionale
|
| Lombardia-Trentino-Alto Adige
|
Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro
|
| Veneto
|
Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso
|
Da ultimo si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stato inserito il comma 2-bis in base al quale, entro il 31 dicembre del 2026, per tutte le derivazioni d’acqua debbono essere predisposti gli adeguamenti tecnici volti a garantire, a valle delle captazioni, il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati.
Articolo 12
(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)
L’articolo 12, modificato dal Senato, prevede l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni svolte dalla soppressa Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento.
La norma istituisce due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici dirigenziali di livello non generale, presso il medesimo Dipartimento per le politiche del mare.
Assegna al Dipartimento il contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla Struttura di missione. Prevede l’assegnazione al medesimo Dipartimento di ulteriori 5 unità di personale non dirigenziale.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento risulta elevato da 20 a 26 unità.
È inoltre assegnato al Dipartimento il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione.
L’articolo in esame provvede, altresì, alla copertura degli oneri.
Il comma 1 reca l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio, demandando la relativa disciplina di dettaglio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999 (concernente l’autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio).
Al nuovo Dipartimento sono attribuite le funzioni previste dall’art. 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 303, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione dell'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.
Si rammenta che l’art. 12 del decreto-legge n. 173 del 2022 (convertito dalla legge n. 204 del 2022), oltre ad inserire il citato art. 4-bis nel decreto legislativo n. 303 del 1999 dispone, altresì, l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) presso la Presidenza del Consiglio. Al CIPOM è assegnato il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Inoltre, il CIPOM provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia.
Il comma 2 di un decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.P.C.m. recante l’apposita disciplina di modifica del d.P.C.m. 1° ottobre 2022 (concernente l’Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Si prevede, inoltre, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore stabilita con il suddetto d.P.C.m. di modifica della dell’Ordinamento del Dipartimento per le politiche del mare. Le funzioni della Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento per le politiche del mare.
La Struttura di missione è stata istituita con il d.P.C.m. del 16 dicembre 2022, presso la Presidenza del Consiglio, alle dirette dipendenze del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. La Struttura assicura supporto tecnico-amministrativo alle attività del CIPOM (v. sopra) e supporta il Ministro medesimo nella predisposizione del Piano del mare e in ogni attività conferitagli.
Il comma 3 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche del mare, due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale. Si tratta delle posizioni dirigenziali aggiuntive rispetto alla vigente composizione della Struttura di missione.
Alla Struttura di missione è preposto un Coordinatore, con incarico dirigenziale di livello generale. Ad essa sono assegnati due dirigenti di livello non generale ed un contingente non superiore alle 15 unità di personale (art, 3, commi 1 e 2, del citato d.P.C.m. 16 dicembre 2022).
Tali incarichi dirigenziali, nonché l'incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A tal fine, la disposizione in esame autorizza la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 7 del presente articolo.
Si ricorda in proposito che le citate disposizioni del D.Lgs. n. 165 consentono alle amministrazioni statali di conferire incarichi dirigenziali: a dirigenti di ruolo di altre amministrazioni o di organi costituzionali (art. 19, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001) senza limiti percentuali rispetto alla dotazione organica (i limiti percentuali sono stati soppressi dal decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021); a soggetti – interni o esterni alle pubbliche amministrazioni – non appartenenti ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni stesse (art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001), in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia dell’amministrazione che conferisce l'incarico.
Il comma 4, modificato dal Senato, assegna al Dipartimento per le politiche del mare il contingente (di 15 unità) di personale non dirigenziale della Struttura di missione, al quale si aggiunge, secondo il testo originario del decreto-legge in esame, un ulteriore contingente 5 unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tali unità di personale sono equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Una modifica approvata dal Senato:
§
eleva a sette unità tale contingente;
§
assegna al Dipartimento ulteriori quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.
Conseguentemente, il personale non dirigenziale viene elevato da 20 a 26 unità complessive.
Le suddette unità sono collocate in posizione di fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Come specificato dalla relazione tecnica, si tratta di un contingente di complessivi 20 funzionari equiparati alla categoria A, posizione economica F1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Si prevede il corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito presso la Presidenza del Consiglio. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, come previsto dall’art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 (richiamato esplicitamente dal comma 4 in oggetto).
Con modifica approvata dal Senato, si specifica che tale personale proviene dai Ministeri (ove il testo originario del decreto-legge in esame stabilisce che il personale provenga da pubbliche amministrazioni «prioritariamente» da Ministeri).
All'atto del collocamento fuori ruolo, il personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
A tale fine, la disposizione, come modificata dal Senato, autorizza la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (in luogo di 615.400 euro per l'anno 2024 e di 1.054.972 euro annui a decorrere dall'anno 2025 previsti dal testo originario del decreto in esame).
Vi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
Il comma 5 assegna al Dipartimento per le politiche del mare il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione.
Si tratta degli esperti nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, e 12, comma 11, decreto-legge n. 173 del 2022 (convertito dalla legge n. 204 del 2022).
Si segnala, al riguardo che l’art. 3, comma 3, del citato d.P.C.m. del 16 dicembre 2022 istitutivo della Struttura di missione, prevede la costituzione del contingente di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero massimo di 10 unità.
Il trattamento economico per ciascun esperto è determinato con il decreto di nomina, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Il comma in esame pone il limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Vi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
Il comma 6, in sede di prima applicazione, che il personale non dirigenziale proveniente dalla Struttura di missione (ad essa assegnato sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto) deve intendersi assegnato agli uffici del Dipartimento per le politiche del mare senza soluzione di continuità (nell'ambito del suddetto contingente di venti unità) a decorrere dalla data prevista per la soppressione della Struttura di missione. Rimane salva la facoltà del Dipartimento per le politiche del mare di comunicare alle amministrazioni di provenienza del predetto personale, entro sessanta giorni dalla medesima data, la richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, in base ai quali il personale in oggetto è stato assegnato alla Struttura di missione.
Gli incarichi aggiuntivi (dirigenziali e non dirigenziali) rispetto a quelli vigenti per la Struttura di missione, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione.
Gli incarichi di esperti già conferiti presso la Struttura di missione si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
Il comma 7, modificato dal Senato, dispone circa la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Vi si provvede quanto a:
a)
1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b)
736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).
Articolo 12-bis
(Esclusione dai divieti di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza)
L’articolo 12-bis – inserito dal Senato – introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza. L’esclusione posta dalla novella di cui al comma 1 concerne il conferimento di incarichi a soggetti vicari dei soggetti titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche; l’esclusione – che integra quella già vigente per i titolari dei suddetti incarichi di vertice – è subordinata alla condizione che i soggetti vicari siano impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico e intero comparto di materia. L’esclusione posta dal comma 2 concerne gli iscritti agli ordini professionali, già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale (anche svolgendo incarichi che sarebbero soggetti alla disciplina restrittiva in esame). Resta ferma – come esplicitato nel comma 2 e come già previsto nella norma oggetto della novella di cui al comma 1 – l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.
Le esclusioni summenzionate di cui al presente articolo 12-bis sono poste rispetto alla disciplina restrittiva che, per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, vieta:
-
il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori – pubblici o privati e dipendenti o autonomi – e collocati in quiescenza; tale divieto concerne gli incarichi dirigenziali o direttivi, quelli di studio o consulenza, le cariche in organi di governo delle amministrazioni;
-
il conferimento ai medesimi soggetti in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno (entro il suddetto limite temporale, l’incarico a titolo gratuito è ammesso, presso ciascuna amministrazione, senza possibilità di proroga o di rinnovo).
Si ricorda che le tipologie di incarichi relativi agli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche – incarichi oggetto della parziale esclusione ampliata dalla novella di cui al comma 1 del presente articolo 12-bis – sono individuabili in base alla disciplina (in genere, di natura regolamentare) dei medesimi uffici (gli incarichi non aventi natura dirigenziale, direttiva, di studio o di consulenza sono comunque anch’essi esclusi, per definizione, dalla disciplina restrittiva in oggetto).
Riguardo alle esclusioni poste dal presente articolo 12-bis, resta ferma – come esplicitato nel comma 2 e come già previsto nella norma oggetto della novella di cui al comma 1 – l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici; tali limitazioni sono inerenti all’importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico (se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103).
Articolo 13
(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)
L’articolo 13, comma 1, dispone che l’amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. possa incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia s.p.a., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.
Il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva s.p.a. Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all’attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.
Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a., precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuino disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
In particolare, il comma 1 integra l’articolo 39 del D.L. n. 19/2024 (legge n. 56/2024), il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l’amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. trasferisca all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia s.p.a., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro.
L’integrazione prevede che tali risorse possano essere incrementate fino a ulteriori 150 milioni di euro. Anche tali importi sono reperiti a valere sulle somme di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. n. 1/2015 (L. n. 20/2015) (tale decimo periodo viene peraltro modificato dal comma 2-ter del decreto-legge della cui conversione si discute, v. infra): si tratta delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva spa in a.s., che sono state versate in apposito patrimonio destinato e originariamente destinate alle attività di bonifica ambientale, tutela della salute e sicurezza e a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo.
La relazione tecnica fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rileva che la movimentazione delle risorse in questione ha portato a un valore residuo disponibile del Patrimonio destinato di 464 milioni di euro, in cui sono ricomprese anche le risorse finalizzate alla decarbonizzazione.
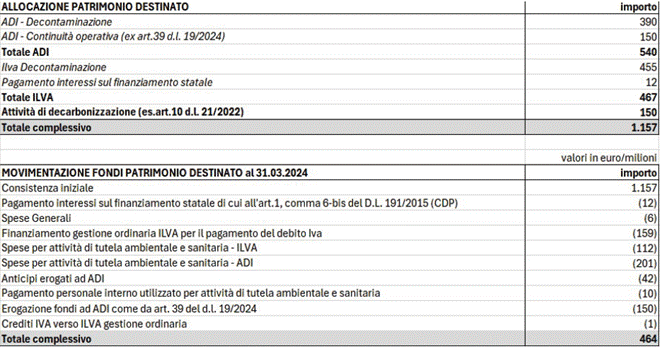
| D.L. n. 19/2024
|
| Testo previgente
|
Testo risultante dalle modificazioni apportate dall’art. 13 del D.L. n. 63/2024
|
| Art. 39, comma 1
|
Art. 39, comma 1
|
| Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
|
Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
|
Il comma 2 integra l’articolo 1, comma 1-sexies, del D.L. n. 142/2019 (L. n. 5/2020), che consente al Ministero dell’economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono impianti siderurgici della società Ilva s.p.a.
In particolare, il citato comma 1-sexies del D.L. n. 142/2019 - inserito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 4/2024 (L. n. 28/2024) - consente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società - ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - che gestiscono impianti siderurgici della società Ilva s.p.a.
Il finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura di amministrazione straordinaria anche in deroga all’articolo 222 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019), recante la disciplina dei crediti prededucibili. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario.
L’integrazione introdotta dall’articolo 13, comma 2, qui in commento, prevede che, per l’attuazione del sopraillustrato comma, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvalga di primarie istituzioni finanziarie senza l’applicazione della disposizione in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, previsti dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 78/2010 (L. n. 122/2010), a valere sulle risorse autorizzate per tali finalità di consulenza dall’articolo 1, comma 728, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
Ai sensi del citato articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.
Il comma 728 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad avvalersi della consulenza e dell’assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti e società partecipate. Per tali finalità è autorizzata una spesa, nel limite di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023.
| D.L. n. 142/2019
|
| Testo previgente
|
Testo risultante dalle modificazioni apportate dall’art. 13 del D.L. n. 63/2024
|
| Art.1, comma 1-sexies
|
Art.1, comma 1-sexies
|
| Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024. Il finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all’articolo 222 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario.
|
Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024. Il finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all’articolo 222 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario. Per l’attuazione del presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
|
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’iter di conversione al Senato, modifica la previsione di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 91/2017, la quale a sua volte contiene disposizioni volte ad attuare la normativa (di cui all’articolo 1 comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015) sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento.
Ai sensi di tale normativa, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell’ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti), e ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad Ilva è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. Si prevede quindi che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sequestrate siano destinate – tenuto conto dei previsti investimenti ambientali – al piano delle misure ed attività di tutela aziendale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria.
Ai sensi del comma 2-bis qui in esame si aggiunge ora che tali somme siano destinate anche all’attuazione degli interventi di cui al citato articolo 39 del D.L. n. 19/2024, fino a concorrenza dell’ammontare delle spese e dei costi sostenuti: si tratta di interventi che, come visto supra, hanno ad oggetto la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.
Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, interviene sulla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. n. 1/2015.
L’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015 ha autorizzato l’organo commissariale di Ilva s.p.a. a richiedere che l’autorità giudiziaria disponesse l’impiego delle somme sottoposte a sequestro cautelare, nell’ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da Ilva in a.s. (in luogo dell’aumento di capitale) intestate al Fondo unico di giustizia e, per esso, al gestore ex lege, Equitalia Giustizia s.p.a. Il versamento delle somme sequestrate e? stato disposto avvenisse al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all’ammontare di queste ultime. La previsione di cui al decimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 – più volte modificata e integrata, da ultimo con l’articolo 9-bis, del D.L. n. 69/2023 – ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni siano versate – previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a Ilva ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191/2015 (per la parte di essi erogata) – in un patrimonio dell’emittente (e, specificamente, sulla contabilita? speciale nr. 6055 intestata all’organo commissariale aperto presso la tesoreria statale) destinato all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, “nonché” a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
Il comma 2-ter del D.L. in conversione incide sul predetto decimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 1/2015, scorporandone la parte finale e facendola confluire in un nuovo undicesimo periodo (il comma 1 dell’articolo 3 si compone così di tredici periodi). Più precisamente si prevede ora che ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere utilizzate per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con DPCM adottato su proposta del MASE di concerto con MIMIT e MEF e con l’Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di Ilva s.p.a., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato. L’intervento normativo qui in esame, in sostanza esplicita, un ordine di priorità nell’utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s., specificando che la destinazione delle stesse a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto può aversi solo una volta completate le bonifiche ambientali e solo ove residuino disponibilità. Restano immutate, rispetto all’originaria previsione del decimo periodo, la modalità di determinazione e il limite masso dell’ammontare destinabile a tali progetti di decarbonizzazione.
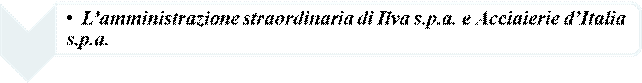
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, Ilva S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, c.d. “legge Marzano”); ai sensi dell’articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.
Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di società facenti parte del gruppo societario: Ilva Servizi Marittimi s.p.a.; Ilvaform s.p.a.; Innse Cilindri s.r.l.; Sanac s.p.a.; Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali s.p.a. (già Riva Fire s.p.a. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi commissari straordinari nominati per Ilva s.p.a.
Ilva s.p.a. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia qui, al sito del Gruppo Ilva in a.s.).
Secondo quanto poi disposto dall’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015, l’ammissione di Ilva s.p.a. alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.
L’organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di Ilva approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014 e modificato con D.P.C.M. 29 settembre 2017.
In ragione della peculiare situazione di Ilva, le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali di Ilva s.p.a., nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente connesse, soprattutto a seguito dell’adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel Piano ambientale. Dicasi al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei commissari straordinari è stato fatto coincidere con il termine di ultimazione del Piano ambientale di Ilva (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023) e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Sul punto si rimanda anche a quanto verrà detto infra a commento dell’articolo 15, comma 1, del decreto-legge della cui conversione si discute.
Quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) il decreto che ha abilitato i commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva s.p.a. ad Am Investco Italy s.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese ArcelorMittal. L’offerta di Am Investco Italy s.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.
AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d’azienda Ilva. In seguito, l’investitore ArcelorMittal ha reso nota la propria intenzione di rescindere l’accordo e provvedere al deconsolidamento della partecipazione di AmInvestCo.
Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della società Ilva s.p.a., il decreto-legge n. 103/2021 ha autorizzato l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - Invitalia, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-bis).
Il 14 aprile 2021, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell’economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell’adesione all’aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del 38% del capitale sociale (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione “Acciaierie d’Italia Holding s.p.a.”.
Con il D.L. n. 115/2022 Invitalia è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l’anno 2022 (art. 30, co. 1).
Il closing dell’acquisto (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di AM InvestCo dei rami d’azienda Ilva, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2024, al fine di consentire a Ilva di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto.
Per quanto qui interessa, l’articolo 9-bis del D.L. n. 69/2023 ha modificato la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all’articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l’ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell’organo amministrativo (art. 2). Quest’ultima norma è stata modificata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2024. Questo articolo consente, in generale, ai soci (tutti) che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, in caso di inerzia dell’organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).
In data 20 febbraio 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha informato (qui il comunicato) che, con decreto del Ministro, Acciaierie di Italia s.p.a. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l’istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia s.p.a. (ADI) ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2023.
In data 29 febbraio 2024, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato lo “stato di insolvenza” per Acciaierie d’Italia s.p.a., aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.
Si rammenta che Acciaierie d’Italia s.p.a è una delle società controllate da Acciaierie d’Italia - ADI Holding. Quest’ultima controlla altre società quali:
·
ADI Energia s.r.l.
·
ADI Servizi Marittimi s.r.l.
·
ADI Tubiforma s.r.l.
·
ADI Socova s.a.s.
·
ArcelorMittal Italy Services s.r.l. (già in liquidazione).
Con decreto del Ministro adottato il 1° marzo 2024, le società controllate ADI Energia s.r.l. ADI Servizi Marittimi s.r.l., ADI Tubiforma s.r.l., ADI Socova S.a.s. sono ammesse, in estensione e con decorrenza immediata, alla procedura madre di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. 347/2003 (L. n. 39/2004) e dagli articoli 80 e 81 D.lgs. n. 270/1999, ed è stato preposto alle predette società il medesimo organo commissariale nominato per ADI, composto dall’ing. Giancarlo Quaranta, dal prof. Giovanni Fiori e dal prof. Davide Tabarelli (vedasi qui, comunicato MIMIT del 1° marzo 2024).
In data 14 marzo 2024 e del 21 marzo 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza, rispettivamente, di ADI Tubiforma s.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l., ADI Energia S.r.l. e ADI Socova s.a.s..
Con ulteriore comunicato del 17 aprile 2024 (disponibile qui), il Ministero delle imprese e del made in Italy ha informato che il Ministro – su istanza dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, già in amministrazione straordinaria dal 20 febbraio u.s. – ha adottato il decreto ministeriale 17 aprile 2024 (in G.U. del 3 maggio 2024) di estensione della procedura di amministrazione straordinaria anche alla Holding (Acciaierie d’Italia Holding s.p.a.), confermando i commissari straordinari già nominati per le altre società del Gruppo.
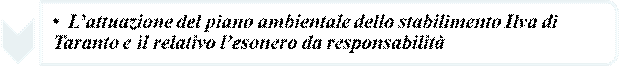
L’emergenza ambientale nell’area dell’Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l’emanazione del decreto legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell’area di Taranto e, per assicurarne l’attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.
Per un approfondimento sulle criticità connessi a tale emergenza si fa rinvio alla relazione sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta e sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e i loro benefìci, concernente lo stabilimento Ilva di Taranto (DOC. CCIV-bis).
In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell’ambiente, era stato disposto d’ufficio l’adeguamento dell’AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico. L’AIA rappresenta appunto il provvedimento che autorizza l’esercizio di uno stabilimento produttivo a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (requisiti IPPC) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle migliori tecniche disponibili (BAT).
Successivamente, il Ministero dell’ambiente ha concluso il riesame dell’AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l’esercizio dello stabilimento siderurgico. Al riguardo, si fa rinvio alla relazione al Parlamento sull’ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull’adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento (DOC. CCIV). L’ultima relazione disponibile è quella aggiornata al 31 gennaio 2016 (DOC. CCIV, n. 6).
Con il decreto legge n. 207 del 2012, l’ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti. Con il successivo decreto legge n. 61 del 2013 sono state dettate disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all’articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all’articolo 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla salute a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’AIA.
In particolare è stata disciplinata una specifica procedura per addivenire all’approvazione di un “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”. Tale Piano Ambientale (adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014) ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e delle due AIA approvate nonché, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legge n. 136 del 2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame derivanti dalle stesse (AIA del 4 agosto 2011 e AIA del 26 ottobre 2012).
Tra il 2015 e il 2016, come sopra ricordato, sono state ammesse ad amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 e del D.Lgs. 270/1999 una serie di società del gruppo ILVA e sono stati nominati i rispettivi commissari straordinari.
Si rammenta che a tali commissari, e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, è stata riconosciuta una sorta di immunità penale ed amministrativa per le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale, in virtù della disposizione introdotta dall’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. del 2015.
Successivamente, con il decreto legge n. 191 del 2015, oltre ad esser state dettate disposizioni finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva, è stato fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l’attuazione del Piano ambientale (articolo 1, comma 7). Tali disposizioni sono state modificate (articolo 1, comma 8) e integrate (nuovi commi 8.1 e 8.3 dell’articolo 1) con il successivo decreto legge n. 98 del 2016 che ha introdotto disposizioni volte a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del Piano ambientale.
Inoltre, il comma 4 dell’articolo 1 ha consentito la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l’attuazione del Piano ambientale (lettera a) ed esteso all’affittuario o all’acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l’esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all’ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso (lettera b). La decorrenza dei 18 mesi è stata poi fissata, dall’articolo 6, comma 10-ter, del decreto legge n. 244 del 2016, con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano ambientale.
In attuazione delle succitate disposizioni – e in seguito all’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA – è stato emanato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017) di approvazione delle modifiche al Piano ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
Conseguentemente, il termine di 18 mesi per l’attuazione del Piano sarebbe venuto a scadenza il 30 marzo 2019 e, tuttavia, lo stesso è stato successivamente prorogato, collegandolo alla data di scadenza dell’AIA, cioè al 23 agosto 2023.
Dunque, a fronte di una proroga per l’attuazione del Piano ambientale fino al 2023, l’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2015 prevedeva invece che l’esimente dalla responsabilità penale e amministrativa per i dirigenti di ILVA operasse fino alla scadenza di 18 mesi dall’entrata in vigore del DPCM del 2017 (marzo 2019). Interpellata sull’interpretazione di queste disposizioni dal Ministero dello Sviluppo economico, l’Avvocatura dello Stato, in un parere reso il 21 agosto 2018, ha sostenuto che “l’esimente di cui all’articolo 2, comma 6 operi per tutto l’arco temporale in cui l’aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall’amministrazione”, per cui “detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23 agosto 2023)”.
É quindi intervenuto l’articolo 46 del decreto legge n. 34 del 2019, che ha limitato dal punto di vista oggettivo l’esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del Piano Ambientale, escludendo l’impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ha individuato nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell’esonero da responsabilità.
Successivamente, sulla disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2015 è intervenuto l’articolo 14 del decreto-legge n. 101/2019, sia in merito all’ambito oggettivo dell’esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all’ambito temporale dell’esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile.
Tuttavia, in sede di conversione in legge (l. 2 novembre 2019, n. 128) la proroga disposta dal citato articolo 14 è stata stralciata, venendo lo stesso cancellato del decreto convertito e, conseguentemente, è stata ripristinata la disciplina dell’esonero di responsabilità previgente (con scadenza al 6 settembre 2019).
Il tema dell’esonero da responsabilità e della sua durata è stato oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali, anche da parte della Corte costituzionale.
In particolare, si richiama l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa in data 8 febbraio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto (pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2019), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legge n. 1 del 2015, nella formulazione antecedente al decreto legge n. 34 del 2019, nella parte in cui prorogano alla scadenza dell’AIA (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) i termini per l’attuazione del Piano Ambientale e escludono la responsabilità penale per le condotte attuative del Piano.
Secondo il GIP, la fissazione della scadenza al 2023 e l’introduzione della scriminante supererebbero i paletti fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013.
Si ricorda che in tale pronuncia la Corte aveva affermato che “è considerata lecita la continuazione dell’attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate […] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell’attività stessa” secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all’ambiente salubre e il diritto al lavoro. Il bilanciamento deve essere condotto senza consentire “l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”. Nel novembre 2019, la Corte Costituzionale, preso atto dell’intervenuta abrogazione dello scudo penale, ha restituito gli atti al GIP di Taranto sollecitandolo a riconsiderare la rilevanza della questione di costituzionalità (C. Cost., ord. 9.10.2019 n. 230).
In seguito, il D.L. n. 2/2023 ha nuovamente disposto, all’articolo 8, l’applicazione le disposizioni sullo scudo penale fino alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale.
In data 20 febbraio 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha informato (qui il comunicato) che con decreto del Ministro Acciaierie di Italia s.p.a. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta.
Il decreto ministeriale segue l’istanza del 18 febbraio 2024, con cui INVITALIA, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge qui in esame.
Tuttavia, occorre ricordare l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 25 giugno 2024 (C-626/22). La domanda originava da una controversia in cui alcuni residenti del comune di Taranto (e di comuni limitrofi) agivano nei confronti di Ilva a.s., in merito all’inquinamento causato dall’attività dello stabilimento Ilva e ai danni che ne derivano per la salute umana.
Ivi si afferma che la direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), letta alla luce dell’articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata, tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana, costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione.
Inoltre, si stabilisce che la direttiva suddetta deve essere letta nel senso che ai fini del rilascio, o del riesame, di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale direttiva, l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione.
Infine, la Corte di giustizia dell’UE interpreta la detta direttiva in modo tale che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora l’attività dell’installazione interessata presenti tali pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso.
Articolo 14, comma 1
(Valutazione del rapporto di sicurezza degli stabilimenti di interesse strategico nazionale)
L’articolo 14, comma 1, modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza e altre fattispecie specifiche, con esclusione dei casi di rapporto relativo a uno stabilimento nuovo o a uno stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche. In tale ambito, in base alla novella, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui il Comitato tecnico regionale valuti che nel relativo rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il medesimo Comitato dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Tale norma della novella costituisce una deroga rispetto alla norma che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio.
Il comma 1 dell’articolo 14 modifica l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”).
Tale articolo 17 reca la procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza trasmesso dal gestore degli impianti interessati al Comitato tecnico regionale – CTR (v. infra). Il comma 1 dell’art. 17 prevede che il CTR effettui l’istruttoria concernente il suddetto rapporto di sicurezza e adotti il provvedimento conclusivo, tenendo conto, ove previsto, delle prescrizioni ambientali applicabili.
Il comma 2 del citato articolo 17 reca la disciplina inerente al rapporto trasmesso dai gestori di stabilimenti nuovi o di stabilimenti esistenti che abbiano subito determinate modifiche.
Il successivo comma 3, qui oggetto di novella integrativa, si applica agli “altri casi” – costituiti dalla revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza nonché dalle fattispecie di cui all’art. 15, comma 8, lettera c), del citato D.Lgs. n. 105 del 2015 –. Il suddetto comma 3 prevede che il CTR esprima le proprie valutazioni entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, salve eventuali sospensioni, comunque non superiori a due mesi, per l’acquisizione di ulteriore documentazione. Nell'atto del CTR che conclude l'istruttoria, prosegue il comma 3, sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore dell’impianto siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio.
La novella in esame integra il comma 3 in oggetto, introducendo una specifica disciplina per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale – disciplina applicabile ai summenzionati “altri casi” (diversi dall’ipotesi di stabilimento nuovo o di stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche) –. In tali casi, qualora dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave ed imminente, il CTR dispone misure di salvaguardia in via cautelativa, assegnando un termine non superiore a 48 mesi per la trasmissione definitiva del rapporto di sicurezza. Se, decorso tale termine, le misure adottate dal gestore dell’impianto risultino nettamente insufficienti, è disposto dal CTR la limitazione o il divieto di esercizio.
La novella prevede inoltre, sempre con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, che la limitazione d’esercizio (fatta salva la suddetta ipotesi di adozione del divieto di esercizio) sia disposta con esclusivo riferimento all’impianto, al deposito, all’attrezzatura o all’infrastruttura ove sia stata individuata la carenza delle misure di prevenzione o limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti.
Si segnala, al riguardo, che l’art. 15, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 105, stabilisce che il rapporto di sicurezza debba attestare sicurezza e affidabilità “di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento” (v. infra).
La novella in esame, come già detto, si applica agli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 (convertito dalla legge n. 231 del 2012).
Tale articolo 1 stabilisce che uno “stabilimento di interesse strategico nazionale” sia individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che, con riferimento agli stabilimenti compresi nell’ambito di applicazione dell’istituto del rapporto di sicurezza, l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, prevede che gli Stati membri vietino l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. In relazione a tale norma dell’Unione europea, si consideri l’opportunità di una valutazione dell’articolazione in più fasi temporali – introdotta dalla presente novella con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale –, precedente all’eventuale adozione del provvedimento di divieto o di limitazione.
Il rapporto di sicurezza
L’articolo 15 del decreto legislativo n. 105 del 2015 reca la disciplina sul rapporto di sicurezza. Esso è previsto per gli stabilimenti di “soglia superiore”, ossia stabilimenti nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nell’allegato 1 (colonna 3 della parte 1 o colonna 3 della parte 2) annesso al medesimo decreto legislativo. Il medesimo allegato stabilisce le quantità (in tonnellate) di ciascuna sostanza, definendo le soglie minime e massime ai fini delle norme applicabili.
Il rapporto di sicurezza - redatto dal gestore dell’impianto - include il documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (previsto dall’articolo 14 e redatto secondo apposite linee-guida). Esso deve attestare: le misure attuate dal gestore inerenti alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all’applicazione del sistema di gestione della sicurezza; l’individuazione dei pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari nonché le relative misure di prevenzione e di riduzione delle conseguenze; la sicurezza e l’affidabilità di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante; la predisposizione dei piani d'emergenza interna e la trasmissione al Prefetto degli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna; la trasmissione all'autorità competente delle informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
L’art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 105 stabilisce che il gestore riesamini il rapporto: almeno ogni cinque anni e comunque nei casi di modifica dell’impianto previsti dall’art. 18. Inoltre, il rapporto deve essere rivisto a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento oppure in qualsiasi altro momento - su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR - qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza nonché a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali in materia. Rimane fermo l’obbligo di revisione biennale del documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti disciplinato dall’art. 14
Come detto, il Comitato tecnico regionale (CTR) compie le istruttorie ai fini della procedura di valutazione del piano di sicurezza. Sono membri del CTR (art. 10 del decreto legislativo):
-
il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;
-
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;
-
il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
-
un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;
-
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia o città metropolitana in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;
-
un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
-
due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;
-
un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente;
-
un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
-
un rappresentante del Comune territorialmente competente;
-
un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di stoccaggio sotterraneo sulla terraferma (come definite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 105);
-
un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;
-
un rappresentante della provincia o città metropolitana.
Si rammenta, infine, che l’art. 12 del decreto legislativo n. 105 pone in capo al gestore obblighi generali in materia di sicurezza dell’impianto. In particolare, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. È altresì tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie richieste.
Articolo 14, commi 2 e 3
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Il comma 2 dell’articolo 14 abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022).
Ed il comma 3 riconosce in via espressa alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le quali espletino funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.
Il comma 2 dell’articolo 14 abbrevia la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022.
La durata di tale corso di formazione è ridotta a cinque settimane.
Si tratta di disposizione derogatoria rispetto alla durata di tre mesi, prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Di questo, l’articolo 12, comma 1, prevede appunto che l’accesso alla qualifica di capo squadra avvenga (nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno) mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi.
La deroga è disposta “in via eccezionale”, recita la disposizione.
Peraltro, una tendenza ad abbreviare la durata dei corsi di formazione si direbbe in via di consolidamento, con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Disposizione analoga alla presente, in particolare, si ritrova, con decorrenza 1° gennaio 2022, nel decreto-legge n. 75 del 2023 (articolo 26, comma 4; ed il comma 5 riferisce la medesima previsione al personale capo squadra specialista di pilota di aeromobile, nautico di coperta, nautico di macchina, sommozzatore); con decorrenza 1° gennaio 2021, nel decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 32, comma 1); con decorrenza 1° gennaio 2020, nel decreto-legge n. 120 del 2021 (articolo 1-bis, comma 1).
La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge riporta come le unità di personale interessato, entro la procedura di accesso alla qualifica di capo-squadra e capo-reparto, ammontino a 1.181. Loro si aggiungono 88 unità di personale specialista, per il quale non si è conclusa la procedura di selezione entro il 2023.
Poiché la decorrenza economica dell’accesso alla qualifica è dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, una riduzione della durata del corso importa un onere finanziario. Esso è quantificato in 535.173 euro per il 2024.
La copertura finanziaria è assicurata attingendo in parte (per 300.000 euro) alle risorse del “Fondo unico giustizia” riassegnate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008), e per la restante parte alle risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste l’indomani del sisma in Abruzzo dal decreto-legge n. 39 del 2009 (cfr. suo articolo 7, comma 4-bis).
Il comma 3 ancora dell’articolo 14 del presente decreto-legge riconosce le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, altresì alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali espletino tali funzioni specialistiche.
Si tratta dunque di direttivi ‘ordinari’ espletanti le funzioni specialistiche, ai quali viene riconosciuto espressamente il trattamento indennitario previsto per il personale specialista.
La disposizione – formulata quale novella all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 97 del 2017 – non importa oneri aggiuntivi, riferisce la relazione tecnica, in quanto già ricompresi nella quantificazione originaria della disposizione ora incisa dalla novella.
Articolo 15
(Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)
L’articolo 15 contiene, nell’ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali (comma 1) e, dall’altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell’ambito della procedura speciale di accesso diretto all’amministrazione straordinaria (ex D.L. n. 347/2003), per l’individuazione dell’affittuario (comma 2).
L’articolo 15 si compone di due commi.
Nello specifico, il comma 1 integra, inserendo un nuovo periodo, l’articolo 1, comma 8.4, del D.L. n. 191/2015. Più in particolare, il comma 8.4 prevede che il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all’aggiudicatario definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari straordinari svolgono le attività funzionali all’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. A tale proposito, il comma 8.4 prevede che il termine di durata del programma dell’amministrazione straordinaria è esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l’attuazione del predetto Piano (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023), e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.
Il comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge in esame interviene su tale ultimo periodo del comma 8.4, aggiungendo che entro lo stesso termine può essere prorogato, su istanza dei commissari straordinari, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei complessi aziendali interessati.
La relazione illustrativa specifica che in questo modo viene allineato il termine di durata massima del programma delle amministrazioni straordinarie che siano affittuarie di compendi aziendali di interesse strategico e il termine previsto per la società in amministrazione straordinaria che sia proprietaria del compendio: così facendo, anche il programma per l’affittuaria potrà essere prorogato fino all’effettiva cessione a terzi del compendio. La relazione illustrativa aggiunge che l’intervento normativo è reso necessario per scongiurare difficoltà gestionali che potrebbero derivare dal possibile disallineamento tra le due procedure di amministrazione straordinarie nell’ipotesi in cui venga stipulato un contratto di affitto finalizzato alla gestione ponte sino alla vendita del compendio a terzi.
Si ricorda che l’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 270 del 1999, c.d. “legge Prodi-bis” e nel D.L n. 347/2003 (c.d. “legge Marzano”). Le finalità conservative sono perseguite mediante la ristrutturazione dell’impresa o la cessione dei complessi aziendali.
Rispetto alla procedura ordinaria di ammissione all’amministrazione straordinaria delineata nel D.lgs. n. 270 del 1999, il D.L. n. 347/2003 ha previsto una procedura speciale, di ammissione immediata (c.d. accesso diretto) all’amministrazione straordinaria, operante, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. Il D.L. n. 347/2003 ha, in sostanza, introdotto una semplificazione dell’ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all’autorità amministrativa e specifiche funzioni del commissario straordinario (o dei commissari, fino a tre, nei casi di particolare complessità).
Tale disciplina, adottata per far fronte al crack Parmalat, è stata ripetutamente modificata e implementata, anche per consentirne l’applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e, in particolare, Ilva.
Con riferimento alla cessione dei complessi aziendali dell’ex Ilva, in particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina generale, interpolandola con disposizioni di natura speciale, tra le quali l’articolo 4, comma 4-quater del D.L. n. 347/2003 (oggetto di modifica da parte del provvedimento qui in esame: cfr. subito infra), relativo alle modalità di cessione dei complessi aziendali delle imprese – ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria – che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, quali Ilva (ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012).
Il comma 2 dell’articolo 15 in esame aggiunge un nuovo secondo periodo al testo dell’articolo 4, comma 4-quater, del D.L. n. 347/2003.
L’articolo 4 del D.L. n. 347/2003 prevede, al comma 4-quater talune eccezioni alla disciplina generale dell’amministrazione straordinaria, e in particolare in deroga a quella di cui all’articolo 62 del D.lgs. n. 270/1999.
Nello specifico, il comma 4-quater esordisce al primo periodo prevedendo che il commissario straordinario – in deroga a quanto previsto dal predetto articolo 62, tramite trattativa privata, ma fermi restando i principi di trasparenza e non discriminazione – individui l’affittuario o l’acquirente tra i soggetti che garantiscono:
a) continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali;
b) rapidità ed efficienza dell’intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale;
c) rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall’Italia.
A questa previsione, come detto già derogatoria della predetta disciplina generale, il comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge della cui conversione si discute aggiunge ora un ulteriore grado di deroga, disponendo che ove ricorrano “ragioni di urgenza” (in merito alle quali il commissario straordinario redige e trasmette al MIMIT e al comitato di sorveglianza apposita relazione), l’affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto già previsto in termini di eccezione dal periodo appena citato del comma 4-quater. Le ragioni di urgenza dovrebbero ricorrere, stando al tenore letterale della previsione, “nelle more” di una “vendita” comunque “prevista”. Si aggiunge infatti subito dopo che in tale ipotesi il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l’intervento sarebbe necessario per garantire la stipula di contratti di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali.
Si valuti l’opportunità di meglio circoscrivere la portata di quella che si configura come eccezione a un regime già di per sé derogatorio della disciplina dell’accesso diretto all’amministrazione straordinaria, con particolare riferimento a ciò che può integrare “ragione di urgenza” o, come riportato dalla relazione illustrativa, “situazione di somma urgenza”. Il chiarimento si rende opportuno anche alla luce di quanto riferito dalla stessa relazione illustrativa, a tenore della quale la nuova disposizione consentirebbe di “derogare alle disposizioni del primo periodo dell’articolo 4, comma 4-ter, D.L. 347/2023”, dovendosi rilevare che il predetto comma 4-ter risulta in realtà composto di un unico periodo. Ipotizzandosi che la relazione illustrativa intendesse invero riferirsi alle disposizioni del primo periodo del comma 4-quater, bisognerebbe allora dedurre che con la previsione ora introdotta sarà possibile derogare integralmente alle clausole contenute in quel periodo.
Articolo 15-bis
(Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico)
L’articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.
L’ambito di applicazione della disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, è circoscritto alle procedure di vendita che interessano imprese di interesse strategico nazionale in procedura di amministrazione straordinaria, ovverosia quelle alle quali si applica la disciplina dettata dal decreto-legge n. 347 del 2003 in materia di ristrutturazione economica e finanziaria di grandi imprese in stato di insolvenza.
Il dl 347/2003 disciplina una particolare forma di amministrazione straordinaria, ad accesso immediato, rivolta alle imprese che, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 270/1999 (al quale l’art. 1 del citato decreto rinvia), presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, da realizzarsi o tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (c.d. "programma di cessione dei complessi aziendali", di cui all’art. 27, co. 2, lett. a)), o tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (c. d. "programma di ristrutturazione"), di cui all’art. 27, co. 2, lett. b)).
Per accedere a tale tipologia di amministrazione straordinaria, l’impresa deve possedere entrambi i seguenti requisiti:
- impiegare, da almeno un anno, non meno di 500 lavoratori subordinati;
- avere debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.
Il contratto di vendita di un bene da parte della Pubblica Amministrazione rientra nel più ampio genus dei contratti cd. “attivi”, ossia di contratti regolati dalla normativa di contabilità (R.D. 2440/1923) e con cui l’amministrazione incamera un corrispettivo contro una prestazione che essa eroga a vantaggio di un privato.
A tal proposito, l’articolo 13 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 chiarisce, che le disposizioni del codice non trovano applicazione per i contratti attivi, prevedendo, in ogni caso, che l’affidamento di tali contratti, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice dei contratti pubblici. Tali disposizioni sanciscono i principi, rispettivamente, del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, stabilendo a tal fine che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano rispettare i principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e di proporzionalità. Anche per i contratti attivi, dunque, sebbene non si applichi la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, si richiede il rispetto delle regole minimali dell’evidenza pubblica, a tutela della concorrenza e del mercato in corrispondenza della cessione di beni che appartengono alla collettività.
L’articolo in commento, tenuto conto della rilevanza della fattispecie in esame, prevede che la vendita dei compendi aziendali appartenenti ad imprese di interesse strategico nazionale sia effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica.
Per le procedure di vendita che rientrano nell’ambito sopra indicato, si prevede il mantenimento degli effetti della vendita nei confronti degli acquirenti, anche qualora la vendita dovesse essere dichiarata nulla ovvero fosse annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita.
Con specifico riguardo alla nullità si ricorda che essa costituisce una categoria giuridica che interviene al momento genetico in cui l’atto viene ad esistenza e ne pregiudica in modo originario e radicale la validità. Ciò significa che il contratto nullo, a differenza di quello annullabile, è, di regola, fin dall’origine inefficace, come emerge anche dalla natura dichiarativa – non costitutiva – della pronuncia che accerti un vizio di nullità.
Nei confronti di eventuali terzi danneggiati dai vizi che abbiano portato alla nullità o all’annullamento della vendita la disposizione in commento prevede un risarcimento per equivalente, ovvero attraverso un ristoro di carattere monetario corrispondente in valore al danno subito.
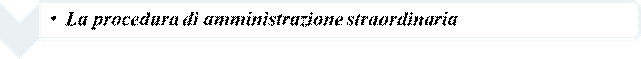
L’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La disciplina è contenuta nel d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, c.d. “legge Prodi-bis” e nel D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. “legge Marzano”).
Rispetto alla procedura ordinaria di ammissione all’amministrazione straordinaria delineata nel D.lgs. n. 270/19998, il D.L. n. 347/2003 ha previsto una procedura speciale, di ammissione immediata – c.d. accesso diretto – all’amministrazione straordinaria, operante, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge, per imprese, con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. Tale disciplina speciale, adottata per far fronte al crack Parmalat, è stata ripetutamente modificata e implementata, anche per consentirne l’applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e, in particolare, Ilva. Da ultimo, l'articolo 4-bis, del decreto-legge n. 4 del 2024, ha consentito l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in deroga, delle imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica nonché delle imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno. Appare opportuno segnalare che, per quanto non diversamente disposto dal D.L. n. 347/2003, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui al d.lgs. n. 270/1999.
Quanto specificamente all’accesso immediato, la disciplina speciale contenuta nell’articolo 2, comma 1, del D.L. 347/2003 dispone che l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1 possa richiedere l’ammissione alla procedura al Ministro delle imprese e del made in Italy (presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale competente). Ai sensi del comma 2, il Ministro, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, può procedere immediatamente, con proprio decreto, all’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario (che assume dunque ab initio l’amministrazione dell’impresa).
Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (c.d. D.L. Ilva), l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, incluse le altre condizioni dell’incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle imprese e del made in Italy, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270/1999, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.
Articolo 15-ter
(Clausola di salvaguardia)
L’articolo 15-ter, introdotto durante l’esame al Senato, stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Le disposizioni del provvedimento in esame, in sostanza, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.
Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con “un contenuto precettivo prevalente” non opera la “generale clausola di salvaguardia” (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).
La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale.
L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale, per quanto di qui di interesse, le disposizioni che novellano l'art.117 Cost., si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti". Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.
Articolo 16
(Entrata in vigore)
L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 16 maggio 2024.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
![]()
![]() @SR_Studi
@SR_Studi
![]()
![]() @CD_agricoltura
@CD_agricoltura