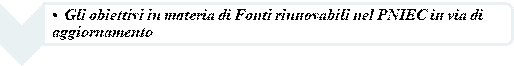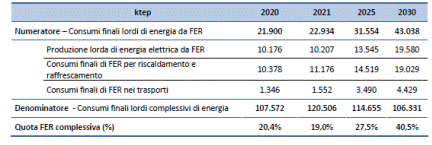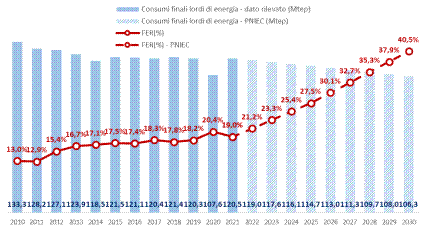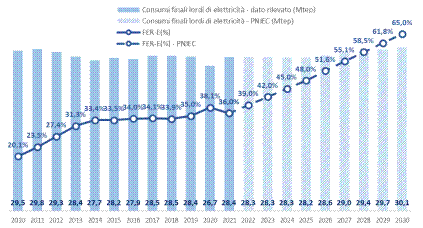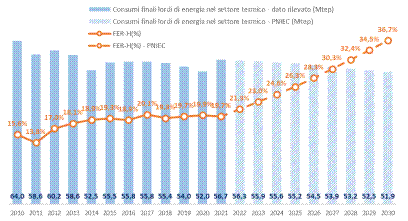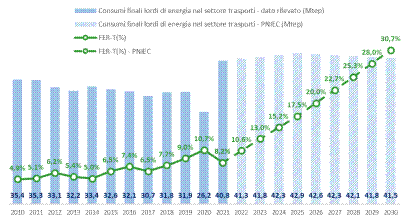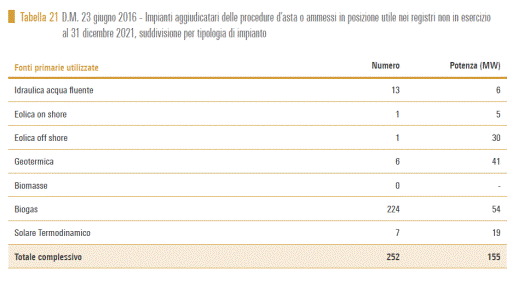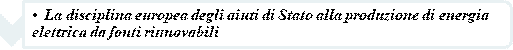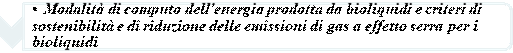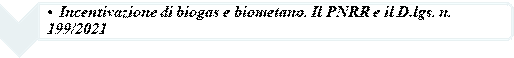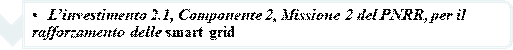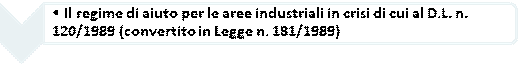Capo I – Misure in materia di energia
Articolo 1, commi da 1 a 4
(Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)
L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.
In particolare, il comma 1 dispone che - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza - ai fini dell’individuazione del concessionario - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all’apposito elenco presso la CSEA).
Il comma 2 – modificato in sede referente - demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati. L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A.
Il comma 1, tenuto conto dell’esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica in conformità al PNIEC, dispone che, fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti concedenti attribuiscono una preferenza - ai fini dell’individuazione del concessionario - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese elettrivore) istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA.
Il comma 1 richiama l’articolo 12, comma 2, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ai sensi del quale i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto della disciplina di cui al Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e ss. mod. e int.). Quanto sopra si applica anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall’articolo 355 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010) sulla valorizzazione degli immobili militari.
Ai sensi del comma 2, per il medesimo fine di cui al comma l, entro l’8 febbraio 2024 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge intervenuta il 10 dicembre 2023), il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma.
Ai sensi della lettera a), la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell’elenco delle imprese elettrivore, anche attraverso aggregazione tra loro, o da terzi con i quali le imprese sottoscrivono - anche indirettamente, secondo quanto inserito in sede referente - contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno al doppio di quella anticipata dal GSE nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità e oggetto di restituzione al medesimo GSE ai sensi della lettera i), numero 1). Se la nuova capacità è realizzata da terzi, l’impresa elettrivora deve assicurare che i terzi si impegnino a restituire al GSE l’energia rinnovabile alle stesse imprese anticipata.
Come si dirà meglio infra, le imprese elettrivore, ai sensi della lettera d), possono richiedere al GSE un’anticipazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati. L’anticipazione, ai sensi della lettera i), deve essere restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
Ai sensi della lettera b), la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari 200 KW ciascuno (prima della modifica approvata in sede referente era prevista una potenza minima pari a 1MW);
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 200 kW (prima della modifica in sede referente era previsto l MW).
Ai sensi della lettera c), l’entrata in esercizio degli impianti o l’entrata in operatività degli interventi di potenziamento deve avvenire entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla successiva lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all’impresa.
La lettera d) – come già accennato – consente alle imprese elettrivore – nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione degli impianti - di chiedere al GSE un’anticipazione per un periodo limitato - 36 mesi - di una quota parte dell’energia rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell’energia anticipata è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive.
Ai sensi della lettera e), la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all’energia nella disponibilità del GSE medesimo, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti: tariffe onnicomprensive, meccanismi del ritiro dedicato dell’energia, o scambio sul posto.
Ai sensi della lettera h), la suddetta quantità è assegnata alle imprese elettrivore in relazione alla quantità dalle stesse richiesta ai sensi della lettera d). Nel caso in cui l’ammontare complessivo richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate.
Ai sensi della lettera g), per ogni singola impresa iscritta nell’elenco delle impese elettrivore, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco.
Ai sensi della lettera f), il GSE rende disponibile l’energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore del mercato elettrico - GME S.p.A. GME), nei limiti della produzione attesa.
La lettera i), già citata, impone la restituzione al GSE dell’energia elettrica rinnovabile oggetto di anticipazione, mediante contratti per differenza stipulati tra impresa e GSE. Tali contratti devono prevedere le seguenti condizioni minime:
1) la potenza oggetto del contratto o dei contratti (nel caso di una molteplicità di impianti) deve essere tale per cui - sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti - l’energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Se il contratto ha ad oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l’energia ceduta al GSE è determinata con ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
2) il prezzo di cessione è pari al prezzo dell’energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l’inflazione. È fatta salva l’applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, se prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
3) la durata del periodo di restituzione è di venti anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;
5) fermo restando quanto previsto dai punti precedenti, trova applicazione la disciplina contrattuale in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature.
La lettera l) impone alle imprese elettrivore, ai fini della stipula dei contratti di anticipazione cui alla lettera d), la presentazione di idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte.
A copertura del premio della garanzia, la lettera m) prevede che possano essere riconosciuti contributi di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro, e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell’ambito dei contratti cui alla lettera d).
Si evidenzia che non viene espressamente indicata la pertinente disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel rispetto della quale sarà attuata la misura in commento.
Si valuti l’opportunità di precisare, nel quadro della disciplina europea, il regime di aiuto di Stato che si intende applicare al caso di specie.
Infine, ai sensi della lettera n), per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese elettrivore e soggetti terzi, è promossa l’utilizzazione della piattaforma gestita dal GME per gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, di cui all’articolo 28 del D.lgs. n. 199/2021.
L’articolo 28, al comma 1, ha demandato al GME la realizzazione di una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede l’obbligo di registrazione dei dati dei contratti che risultano necessari a garantire la massima diffusione degli esiti e il monitoraggio. Il comma 2, tenuto conto dell’evoluzione del mercato dei contratti di lungo termine, della liquidità della domanda e dell’offerta, nonché di specifici rapporti di monitoraggio forniti dal GME, ha facoltizzato il MASE a fornire indirizzi al GME per lo sviluppo di una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. Si rinvia all’apposita pagina dedicata del sito istituzionale del GME.
Ai sensi del comma 3, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, con uno o più provvedimenti, stabilisce:
§ le modalità di copertura degli oneri derivanti dall’anticipazione dell’energia nella disponibilità del GSE, di cui alla lettera d) del comma 2, nonché
§ le modalità di riconoscimento e copertura degli eventuali oneri derivanti dal contributo a copertura del premio della garanzia, di cui alla lettera m) del medesimo comma 2.
La copertura è a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
La relazione tecnica afferma che la misura comporta un impatto certo sulla componente ASOS delle bollette elettriche nei primi tre anni in cui è prevista l’anticipazione a favore delle imprese energivore assegnatarie. Secondo una stima aggiornata del GSE, l’energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità dello stesso GSE ammonta per il 2023 a circa 25 TWh. Complessivamente, la misura riguarda circa 3.800 imprese potenzialmente interessate, tra cui principalmente quelle operanti nei settori della metallurgia, chimica, vetro, materie plastiche, tessili, alimentari. L’elevato numero di imprese coinvolte è conseguenza degli effetti della riforma in corso delle misure agevolative per gli energivori, prevista dall’art. 3 del D.L. n. 131/2023. In termini di impatto sulle bollette, assumendo il prezzo PUN pari a 128 €/MWh nel 2024, 125€/MWh nel 2025 e 108€/MWh nel 2026, nonché, il prezzo di riferimento (strike) dei contratti per differenza a due vie per l’anticipazione dell’energia, pari a circa 80€/MWh, la relazione ipotizza un impatto dei contratti di anticipazione nella componente ASOS per i tre anni di riferimento pari a circa 1-1,2 mld€, cui occorre aggiungere infine il valore delle garanzie di origine nella titolarità del GSE e riconosciuto alle imprese assegnatarie per un valore pari a circa 200 mln €/anno (per un valore delle Garanzie di Origine pari a circa 8 €/MWh).
Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A.
L’articolo 1-bis del D.L. n. 105/2010 (L. n. 129/2010), citato nel comma 4 norma in commento, ha istituito il Sistema informativo integrato (SII), ossia un sistema informatico centralizzato, basato su una banca dati dei punti di riconsegna dei clienti finali, per “la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas”; il SII è gestito dalla società Acquirente unico S.p.A., mentre ARERA ne disciplina le modalità di funzionamento, e, in quanto competente alla regolazione dei servizi, regola gli specifici flussi informativi attraverso i quali soltanto gli operatori dei mercati - al dettaglio e all’ingrosso - possono interagire tra loro al fine di attuare le prestazioni disciplinate dall’Autorità funzionale alla esecuzione fisica ai contratti di compravendita.
Le modalità di funzionamento del SII sono state definite, in termini generali, con la deliberazione ARG/com 201/2010 – sulla base della quale Acquirente Unico ha adottato il relativo Regolamento di funzionamento.
La relazione illustrativa osserva come il PNIEC, il cui aggiornamento è stato di recente inviato alla Commissione europea (cfr. infra, box di approfondimento), ha previsto specifiche misure volte a promuovere un crescente ricorso da parte dei processi industriali all’energia da fonti rinnovabili, anche in ragione dell’esigenza di ridurre, grazie allo sviluppo dell’autoproduzione e dei contratti di approvvigionamento energetico a lungo termine, il rischio di esposizione dei consumatori e delle imprese alla volatilità dei prezzi nei mercati.
La disposizione in esame riveste carattere di urgenza in ragione del fatto che, nell’attuale contesto di mercato, caratterizzato da dinamiche incerte anche per effetto del conflitto russo-ucraino e delle conseguenti ricadute geopolitiche, l’esposizione alla volatilità dei prezzi dell’energia elettrica costituisce un elemento di rischio per la competitività internazionale delle imprese energivore e richiede misure tempestive, funzionali a contenere la crescita dei costi energetici, anche attraverso un maggior ricorso all’autoproduzione da fonti rinnovabili.
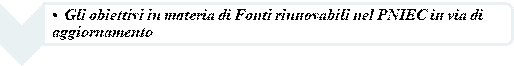
La transizione verso un sistema energetico centrato su un maggiore impiego delle fonti energetiche rinnovabili è fondamentale e strumentale alla riduzione le emissioni di gas a effetto serra. Il traguardo in materia di fonti rinnovabili fissato al 2020 è stato conseguito dall’Italia e dall’UE nel suo complesso. L’Italia e l’UE hanno raggiunto rispettivamente il 20,1% e il 22,1% di copertura di consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili superando gli obiettivi che si erano posti (l’overall target italiano al 2020 era del 17% di consumo da FER sui CFL di energia).
Per il periodo 2021-2030, gli obiettivi italiani sono stati delineati nel Piano nazionale italiano per l’energia e clima (PNIEC) presentato dall’Italia alle istituzioni europee a fine dicembre 2019. La proposta nazionale di aggiornamento del Piano, prevista dall’articolo 14, par. 2 del citato Regolamento Governance, è stata inviata alla Commissione il 19 luglio 2023 dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
Il PNIEC italiano del 2019 ha prospettato obiettivi conformi a quelli previsti a livello europeo nella Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili- cd. RED II, la quale ha fissato al 2030 una quota obiettivo dell’UE di energia da FER sul consumo finale lordo almeno pari al 32%.
L’Italia, ai sensi del PNIEC del 2019, concorre al raggiungimento del target UE fissato dalla Direttiva RED II con un obiettivo di consumo di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30% e una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22% (a fronte del 14% previsto dalla UE). La Direttiva RED II è stata recepita dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199.
Nel quadro di un’economia a basse emissioni di carbonio, il PNIEC del 2019 ha anche indicato il phase out del carbone dalla generazione elettrica al 2025.
Il Piano del 2019 ha indicato un ampio portafoglio di misure, sia per grandi che per piccoli impianti, tra le quali nuove procedure competitive per l’assegnazione di incentivi nell’ ambito dei PPA - Power Purchase Agreement (accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine), semplificazione delle procedure autorizzative, ottimizzazione delle principali produzioni esistenti, promozione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo.
La recente Direttiva 2023/2413/UE, del 18 ottobre 2023, cd. RED III - facente parte del Pacchetto Fit for 55 - modifica la Direttiva RED II a decorrere dal 20 novembre 2023, prevedendo un nuovo, più alto, overall target europeo in materia di consumo di fonti energetiche rinnovabili al 2030: l’overall target fissato è del 42,5% di FER nel consumo finale lordo di energia – CFL.
La proposta di aggiornamento PNIEC indica quindi il contributo italiano al 2030 aggiornato, attraverso l’applicazione dei principi contabili delineati dalla Direttiva RED II come modificata dalla direttiva RED III (di cui il Governo ha considerato i testi della proposta disponibili a giugno 2023).
Secondo la proposta italiana di aggiornamento del PNIEC, l’Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 40,5% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili. Per il 2030, in particolare, si stima un consumo finale lordo di energia di circa 100 Mtep, di cui 43 Mtep da FER.
Obiettivo complessivo FER al 2030 (ktep)
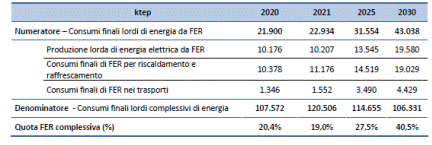
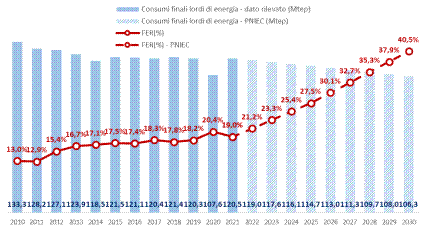
In particolare, il contributo 2030 delle FER risulta così differenziato:
? settore elettrico: quota dei consumi complessivi nazionali di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili pari al 65,0%;
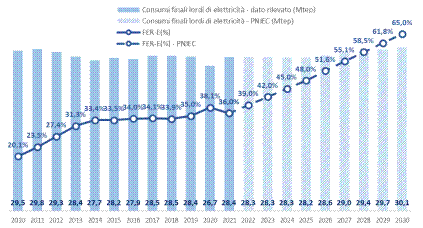
? settore termico: quota dei consumi complessivi di energia per riscaldamento e raffrescamento coperta da FER del 36,7%. Si precisa che la RED III porta a individuare per l’Italia un target settoriale al 2030 pari al 29,6%, che sale al 39,1% se si considerano gli incrementi indicativi previsti dall’Allegato 1 della RED III;
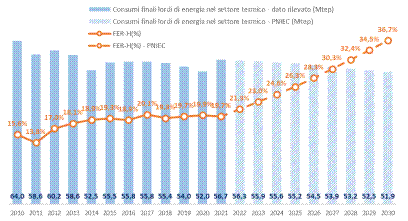
? settore trasporti: quota dei consumi complessivi di energia per trasporto coperta da fonti rinnovabili pari al 30,7% a fronte di un obiettivo settoriale del 29% fissato dalla medesima Direttiva.
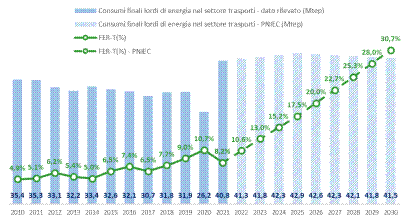
Per un approfondimento, si rinvia al dossier dedicato alle politiche e agli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
La RED III prevede poi che gli Stati Membri definiscano alcuni specifici target di penetrazione delle FER, trasversali ai macro-settori ora descritti. In particolare, con riferimento al settore industriale, gli incrementi indicativi previsti portano per l’Italia a una quota FER al 2030 pari al 29%; il valore è leggermente superiore a quello risultante dallo scenario che tiene conto di tutti gli effetti delle politiche (27%).
Articolo 1, comma 4-bis
(Recesso dai contratti stipulati nell’ambito della misura cd “Electricity release”)
L’articolo 1, comma 4-bis, riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il GSE ai sensi della disciplina del cd “Electricity release” (D.M. 341/2022), senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di riferimento zonale maturati durante il periodo di vigenza contrattuale. Tali modalità si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
L’articolo 1, comma 4-bis, dispone più nello specifico che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, i titolari di dei contratti per differenza stipulati con il GSE, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, ai sensi della disciplina del cd. “electricity release” di cui al D.M. 341/2022, in attuazione dell'articolo 16-bis del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022) (cessionari dell’energia in questione), possono esercitare la facoltà di recesso dagli stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 3, lett. a), maturati durante il periodo di vigenza contrattuale.
Le medesime modalità si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
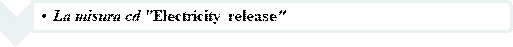
L'articolo 16-bis del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022) ha previsto, al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, che il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. proceda a offrire un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale e a cedere tale energia, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal GME. Il comma 3 dell’articolo 16-bis ha previsto, in particolare, che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, siano stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all’articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022 (prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al decreto-legge in riferimento a ciascuna zona di mercato);
b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato (RID), o dello scambio sul posto (SSP), ai quali non si applicano i commi 1-5 dell’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 – che già disciplinavano uno specifico meccanismo di compensazione a due vie - garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: ARERA) 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia elettrica, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalità di coordinamento del meccanismo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo n. 199 del 2021 (di recepimento della Direttiva sulle fonti rinnovabili RED II), gestite dal GSE.
Ha dato attuazione alla disciplina sopra citata il D.M. 16 settembre 2022, n. 341, recante Definizione delle modalità e condizioni per la cessione dell'energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE) ai fini dell'integrazione degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico e trasferimento ai consumatori dei relativi benefici (cd “Electricity release”). Tale D.M., all’articolo 4, ha definito le modalità e le condizioni con le quali il GSE cede l'energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP ai quali non si applica il meccanismo di compensazione a due vie di cui al D.L. n. 4/2022[3].
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto, la cessione avviene sulla base della procedura di selezione di cui all'articolo 4, mediante la stipula di contratti a termine di durata fino al 31 dicembre 2025. Ai sensi dell’articolo 5, In esito alla procedura di assegnazione disciplinata dall’articolo 4, il GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie, di durata fino al 31 dicembre 2025, in relazione al volume di energia elettrica assegnato, acquisendo idonee garanzie.
Il contratto di cessione deve prevedere:
a) che a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'energia aggiudicata sia rideterminata sulla base dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE al 31 gennaio di ogni anno;
b) che per tutta la durata del contratto, il GSE calcoli, in relazione a una quota pari al 70% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata, la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella sua disponibilità;
c) il GSE, nel caso in cui la differenza sia negativa, eroghi il relativo importo al cliente finale ovvero, nel caso in cui la differenza stessa risulti positiva, conguagli o provveda a richiedere al cliente finale l'importo corrispondente;
d) sia fatto divieto di cessione a terzi del contratto ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale aggregatario;
e) debba essere prevista la facoltà di recesso, senza penali, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso e la facoltà per il cliente finale di modificare annualmente la quantità di energia ritirata.
Il GSE provvede, con cadenza almeno annuale, a stabilire, sulla base dell'energia elettrica nella propria disponibilità, il volume dell'energia elettrica spettante a ciascun cliente finale, procedendo al conguaglio delle differenze, nei limiti del 30% dell'energia elettrica aggiudicata purché consumata.
Il GSE provvede ad adeguare il valore alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto, nonché di quanto stabilito dall'ARERA in attuazione dell'articolo 6, che prevede la revisione del meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.
Sono stati ammessi a partecipare al meccanismo i cd. Clienti finali prioritari e cioè i clienti finali che sono alternativamente o congiuntamente:
- clienti finali industriali: clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); o piccole e medie imprese o
- clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell’ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel o
- clienti finali energivori: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017; o
- clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna.
Nel caso in cui, all’esito della procedura di assegnazione non sia stato assegnato l’intero volume di energia elettrica, il GME è stato autorizzato a svolgere una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari.
Dal 22 novembre 2022 al 5 dicembre 2022, sul Portale ER-Energy Release del GSE, si è svolta la procedura di accreditamento per partecipare alla procedura di assegnazione del GME. All’esito della procedura di assegnazione del 9-10 gennaio 2023, il GME ha assegnato l’intero volume di energia messo a disposizione, pari a 16.024.960 MWh/anno a 1.420 clienti finali prioritari.
Il provvedimento sopra citato ha definito un prezzo “politico” di riferimento per il contratto finanziario a due vie dell’Energy Release pari a 210 e/MWh che è stato ritenuto, a seguito della riduzione dei prezzi dei mercati, troppo alto.
Lo scenario congiunturale, infatti, che ha caratterizzato il 2022 aveva portato il Legislatore ad identificare un valore di cessione dell’energia nell’ambito del meccanismo pari a 210 euro/MWh, con facoltà di ridurre il prezzo a 180 euro/MWh una volta entrato in vigore il tetto al costo dell’energia elettrica da fonte rinnovabile previsto dal Reg. UE 2022/1854 (applicato con l’art. 1, commi 30-38 della L. n. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023).
Gli operatori (es. Confindustria) hanno sollecitato un’estensione del termine per aderire alla proposta contrattuale del GSE e contestualmente apportare modifiche al Regolamento contrattuale del GSE che consentissero ai soggetti firmatari di azzerare i quantitativi già assegnati, contestualmente all’entrata in vigore della misura, tenendo conto del differenziale di prezzo sopraggiunto rispetto al parametro dei 210 euro/MWh.
Con comunicato del 10 febbraio 2022, nelle more degli approfondimenti in corso con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alle richieste di recesso parziale e di riduzione dei volumi di energia aggiudicati, il GSE ha disposto la proroga del termine ultimo per la stipula del Contratto da parte dei clienti finali Assegnatari al 28 febbraio 2023.
Con Atto di Indirizzo dello stesso 10 febbraio 2023, n. 3399, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha preso atto che, al 9 febbraio 2023, risultavano 559 contratti attivi o in fase di stipula, corrispondenti a circa 2,2 TWh, e che tale risultato, non in linea con le aspettative, poteva essere spiegato con il fatto che il prezzo di riferimento pari 210€/MWh fosse sensibilmente più elevato rispetto all’attuale prezzo del mercato all’ingrosso.
Alla luce del quadro delineato, il MASE ha iniziato a valutare l’opportunità di intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria.
Secondo l’Atto di Indirizzo, si è posta tuttavia la necessità di salvaguardare la posizione dei partecipanti alla procedura di assegnazione svolta e - anche alla luce di un parere reso in proposito dall’Avvocatura Generale dello Stato, si è ritenuto utilizzabile lo strumento di cui all’articolo 5, comma 3, lett. e), del D.M. n. 341/22, dunque la facoltà di modifica o recesso senza penali.
Il MASE, nel medesimo Atto di Indirizzo, ha ritenuto opportuno consentire che la facoltà di riduzione del quantitativo (contrattualizzato) potesse riguardare l’intera quantità di energia assegnata, portandola anche a zero, con effetto dal 1° gennaio 2023.
Il MASE ha demandato al GSE gli adempimenti necessari ad assicurare che siano accantonati e resi indisponibili, a valere per la partecipazione al successivo avviso, gli oneri amministrativi versati dalle società partecipanti che non risultavano aver sottoscritto il contratto entro il termine stabilito.
Il MASE, infine, ha invitato il GSE, in linea con la ratio della normativa, ad avvisare pubblicamente i soggetti sottoscrittori del Contratto di cessione della possibilità di esercitare nelle modalità indicate, entro la scadenza ultima prevista per la sottoscrizione, la facoltà di chiedere una riduzione fino all’azzeramento delle quantità richieste, con l’effetto di una rinuncia de facto all’energia assegnata e con conseguente venir meno dell’obbligo di versare il relativo corrispettivo.
Il 16 febbraio 2023 è stato pubblicato dal GSE l'Avviso che ha definito le modalità per la richiesta di riduzione, fino all’azzeramento, dei volumi di energia aggiudicati. La riduzione ha potuto essere richiesta, dagli operatori interessati, entro e non oltre il 6 marzo 2023.
Ai sensi di quanto indicato dal GSE per le vie brevi, sono 51 i contratti (per 100 GWH) per i quali non è stata presentata alcuna istanza di riduzione/azzeramento o recesso.
Articolo 2, comma 1
(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)
L’articolo 2, al comma 1, modificato in sede referente, sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta - volta all’incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico.
Il comma 1 dell’articolo qui in commento sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), recante norme per incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli a clienti finali industriali a forte consumo di gas, cd. "gasivori".
Come evidenzia la relazione illustrativa, la finalità dell’intervento è quella di superare le criticità della disciplina in questione, manifestatesi in sede attuativa.
Secondo l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), nel testo previgente al decreto legge in esame, il GSE stipula con i produttori contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale, di durata massima pari a 10 anni e con verifica dei termini alla fine del quinto anno (commi 1 e 4). Il GSE, al contempo, procede a sottoscrivere - per corrispondenti quantità - contratti finanziari per differenza con i clienti finali industriali a forte consumo di gas ai medesimi prezzi previsti nei contratti d’acquisto (comma 5). In relazione al prezzo dei contratti finanziari per differenza, la norma ne ha previsto la determinazione con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, in modo da garantire la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, con una equa remunerazione del capitale investito. La medesima norma ha previsto che tale prezzo dovesse essere comunque compreso tra 50 e 100 euro per MWh (comma 4).
Al GSE, su direttiva del Ministro dell’ambiente e sicurezza energetica-MASE (Dir. 28 giugno 2022 prot. n. 15307 e 4 agosto 2022 prot. n. 18345), è stato quindi dato il compito di invitare a manifestare interesse a partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas i titolari delle concessioni nazionali di coltivazione nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale con impianti situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Tali soggetti sono stati obbligati a comunicare al GSE, al MASE e all’ARERA i programmi delle proprie produzioni di gas per gli anni dal 2022 al 2031 e i piani per i loro possibili sviluppi. Gli inviti a manifestare interesse ad aderire alle procedure sono stati pubblicati dal GSE il 6 luglio 2022 e il 9 agosto 2022 (comma 2).
Il perimetro delle concessioni nazionali ammissibili a partecipare alle procedure è stato successivamente esteso alle concessioni operanti anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale; sono state anche ammesse a partecipare:
§ le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste in mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi, previa verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sotto controllo ministeriale (comma 2);
§ nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni mc (comma 2-bis).
Il Ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, in Aula alla Camera il 31 maggio 2023, in risposta all’interrogazione Pavanelli e altri n. 3-00442, ha evidenziato che, in ragione della favorevole evoluzione dei prezzi del gas naturale, i limiti di prezzo previsti dalla disciplina sopra descritta rendono inefficace la misura, poiché non vi è interesse per i clienti a sottoscrivere i contratti di acquisto con il GSE a 50 o 100 euro per Mwh, rispetto alla ben più bassa quotazione media (pari a 25 euro a maggio 2023).
Nella consapevolezza delle criticità poste dall’attuale formulazione della norma e nella convinzione che le motivazioni alla base del gas release permangano intatte, anche a causa del quadro di incertezza nello scenario internazionale, il Ministro ha preannunciato l’opportunità di modifiche alla misura, nell’ottica di contemperare le esigenze di un’equa remunerazione della maggior produzione nazionale con il beneficio atteso dai settori produttivi connotati da un intenso consumo di gas e colpiti dagli effetti dell’aumento dei costi della materia prima, qualora dovessero verificarsi degli sbalzi particolari.
Nel nuovo testo qui introdotto, il comma 1 dell’articolo 16 conferma GSE quale soggetto responsabile ad avviare, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, le procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli.
Quanto ai soggetti legittimati a partecipare alle procedure, su invito del GSE, questi trovano indicazione nei nuovi commi 2, 3 e 4.
Il comma 2, conferma, quali soggetti legittimati a partecipare alle procedure, i titolari di concessioni – esistenti, come viene specificato - anche se improduttive o in sospensione volontaria, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali.
Con riferimento a tale ultima previsione, la relazione illustrativa evidenzia come questa intenda consentire, ai fini della partecipazione alle procedure di gas release, nuove attività e nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, nell’ambito delle concessioni esistenti e alle condizioni sopra specificate.
Il comma 3 conferma, con alcune correzioni rispetto alla normativa previgente, l’ammissibilità, in deroga al divieto delle attività upstream nell’alto Adriatico (articolo 4 della legge n. 9/1991) e nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006), delle concessioni di coltivazione di idrocarburi – esistenti o nuove, qui si precisa - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud (nel testo previgente si faceva riferimento al parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po), a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia (nella formulazione previgente, era “almeno superiore” alle 9 miglia). Le condizioni di ammissibilità in deroga, che opera per la durata di vita utile del giacimento, rimangono invariate:
§ i giacimenti devono avere un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;
§ i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni devono aderire alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine, previa verifica preventiva dell’assenza di effetti di subsidenza, fermi rimanendo gli impegni che devono essere assunti in sede di manifestazione di interesse (cfr. in merito, il successivo comma 5).
Il comma 4 conferma, in deroga al divieto delle attività upstream nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006) - per la durata di vita utile del giacimento – l’ammissibilità della coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, sempre a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; e che i richiedenti le nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine.
Il nuovo comma 5 riproduce quanto previsto dall’originario comma 2 dell’articolo 16, circa la presentazione, da parte dei soggetti legittimati, della manifestazione di interesse ad aderire alle procedure al GSE, comunicando - non più i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere per gli anni dal 2022 al 2031 - bensì i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, oltre che (come già in origine previsto) un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari.
La manifestazione di interesse deve poi ora contenere una serie di impegni da parte del presentatore (di cui si darà conto nella descrizione del successivo comma 7).
Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all’attuazione dei programmi di produzione di gas, sono rilasciate sulla base di un procedimento unico ora previsto dal nuovo comma 6 dell’articolo 16.
Tale procedimento, che deve essere svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990 (non viene operato, al riguardo, un esplicito richiamo alla Conferenza dei servizi), è comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III, Parte II del Codice dell’ambiente (D.lgs. n. 152/2006), e vi partecipano tutte le amministrazioni interessate.
Il procedimento unico si deve chiudere entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse.
Rimane confermato, rispetto alla disciplina previgente – la quale comunque non recava la previsione di un procedimento unico - che l’attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, sia svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Ciò si applica, su richiesta dell’interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il nuovo comma 6 dispone, infine, che l’efficacia delle nuove concessioni, delle proroghe e delle modifiche delle concessioni esistenti, nonché delle autorizzazioni delle opere necessarie sia condizionata alla stipula dei contratti finanziari di vendita di lungo termine, di cui al successivo comma 10, lettera a) stipulati tra GSE e titolari delle concessioni, aventi ad oggetto i diritti sul gas da questi prodotto.
Strumentale alla conclusione dei contratti è quanto previsto dal nuovo comma 7, che impone ai titolari degli atti concessori/autorizzatori, di comunicare al gruppo GSE e al MASE – entro 45 giorni dalla chiusura del procedimento unico che li rilascia - il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi incrementali di produzione - già indicati in sede di manifestazione di interesse. Il costo deve essere indicato per livello di produzione e campo di coltivazione e, a corredo, vi deve essere una relazione dettagliata circa le modalità della sua determinazione, ivi inclusa l’indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione deve essere asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.
Si noti che, ai sensi del nuovo comma 5, l’impegno a presentare la relazione dettagliata in questione, nonché l’impegno a cedere il gas prodotto e a mettere a disposizione del GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato, deve essere adottato già in sede di manifestazione di interesse. Il quantitativo di diritti sul gas è messo a disposizione per cinque anni dal 1° ottobre 2024 o, in caso di contratto stipulato successivamente al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.
Il meccanismo delineato dall’articolo in esame si differenzia quindi in parte dal precedente, in quanto i produttori, partecipanti alle procedure di gas release, si impegnano “a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato” per cinque anni.
Il Gruppo GSE, a sua volta, ai sensi del comma 8, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., offre, senza che ciò rechi nuovi o maggiori oneri, i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 7, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas (cd. “gasivori”), che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni tariffarie di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Il testo dell’articolo 16, prima dell’intervento qui in commento, prevedeva che il Gruppo GSE stipulasse contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas prodotto dai partecipanti alle procedure, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno; e che lo stesso GSE procedesse, al contempo, a sottoscrivere - per corrispondenti quantità - contratti finanziari per differenza con i clienti finali industriali a forte consumo di gas ai medesimi prezzi previsti nei contratti d’acquisto (commi 1, 4 e 5 della formulazione precedente dell’articolo 16).
Il nuovo comma 8 dettaglia altresì i criteri cui il GSE si deve attenere nell’ambito delle procedure di allocazione, disponendo che:
§ i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione (lett. a));
§ il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo asseverato (lett. b));
§ i diritti sono aggiudicati ai clienti in ordine crescente di prezzo all’esito di una o più aste che prevedono che:
· l’allocazione sia effettuata in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas (cd. gasivori). Questi ultimi possono fare offerte per quantitativi pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni corretto di un fattore che tiene conto dell’intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto dell’impresa nel periodo, ovvero, se maggiore, dell’indice di prevalenza dell’impiego di gas rispetto all’energia elettrica (lett. c), n. 1.1) e 1.2)).
· I diritti non assegnati sono oggetto di una ulteriore eventuale procedura, aperta alle a clienti diversi dai gasivori per quantità, comunque, non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti gasivori per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta sulla base delle precedenti aste (lett. c), n.2));
· la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili (lett. c), n.3));
· la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura (lett. c), n.4));
§ i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi asseverati per lo specifico campo di coltivazione e, se ricorrono le condizioni di prezzo crescente, per livello di produzione (lett. d)).
Il nuovo comma 9 demanda all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la definizione, con proprio provvedimento, delle modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura, tra i proventi di aggiudicazione delle procedure e il costo asseverato riconosciuto ai concessionari dal Gruppo GSE viene destinata alla riduzione delle tariffe per l’utilizzo della rete di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali partecipanti alla procedura specifica, secondo un criterio pro quota in ragione delle offerte presentate nell’ambito della procedura.
Il nuovo comma 10 stabilisce che, in esito alle procedure di allocazione sopra descritte, il Gruppo GSE:
§ stipula con i titolari delle concessioni di coltivazione - che abbiano ottenuto gli atti autorizzativi di cui al comma 6 - contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, in forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A. (prima della modifica in sede referente la norma faceva invece riferimento al punto di scambio virtuale - PSV), di durata pari a cinque anni, al prezzo pari al costo asseverato (lett. a));
§ stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A. (prima della modifica in sede referente la norma faceva invece riferimento al punto di scambio virtuale - PSV), per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alla procedura di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti con i concessionari, dunque, cinque anni (lett. b)).
La previgente formulazione dell’articolo 16, in ordine ai contratti finanziari per differenza con i titolari delle concessioni, prevedeva che il prezzo d’acquisto da parte del GSE fosse determinato - con decreto interministeriale - in modo da garantire la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, e una equa remunerazione del capitale investito e, altresì, che il prezzo fosse compreso tra 50 e 100 euro per MWh (comma 4). In ordine ai contratti finanziari per differenza con i clienti finali industriali a forte consumo di gas, la previgente formulazione prevedeva che si rispettassero i medesimi prezzi previsti nei contratti d’acquisto (comma 5).
Il comma 11 stabilisce che la quantità di diritti oggetto dei contratti di cui sopra, con i concessionari e i clienti finali, sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno, in modo che si possa tenere conto delle produzioni effettive nel corso dell’anno precedente.
Ai sensi del nuovo comma 12, il Gruppo GSE comunica periodicamente al MASE l’elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10.
Nel caso di contratti stipulati dai clienti finali in forma aggregata, questi devono assicurare che gli effetti siano trasferiti a ciascuno di essi.
È vietata la cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
La nuova disciplina non prevede più che vi sia uno schema di contratto tipo con i clienti finali, predisposto dal GSE e approvato dal MEF e MASE (previsione invece contenuta nel previgente articolo 16, comma 5-bis).
Il comma 13 conferma quanto già previsto dalla disciplina previgente il ordine alla garanzia che il gruppo GSE presta a beneficio dei concessionari, in relazione ai contratti con essi stipulati, e alla garanzia che acquisisce dai clienti finali industriali in relazione ai contratti con essi stipulati.
| Articolo 16 del D.L. n. 17/2022
Misure per fronteggiare l’emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi |
| Testo previgente |
Testo vigente come sostituito dall’art. 2 |
| Art. 16
(Ordinamento) |
Art. 16
(Ordinamento) |
| 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. |
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4. |
| 2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. |
5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre: a) l’impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7; b) l’impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al primo periodo è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal primo ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a) sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo. |
| 2. (segue) La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali. |
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali. |
| 2. (segue) La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. |
3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all’articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia dalle linee di costa, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto al comma 5. |
| La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell’ARERA, entro trenta giorni dall’invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo |
|
| 2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1. |
4. In deroga a quanto previsto all’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi; b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1. |
| 3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2, nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis, si concludono entro il termine di tre mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all’attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L’attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il terzo periodo si applica, su richiesta dell’interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). |
| |
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato da una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l’indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali. |
| 4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un’equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis. |
|
| 5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. |
8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell’ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo: a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione; b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7; c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all’esito di una o più aste che prevedono: 1) l’allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra: 1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall’intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento; 1.2) l’indice di prevalenza dell’uso del gas rispetto all’energia elettrica determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh; 2) l’assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un’eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità, comunque, non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1); 3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti; 4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura; d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione. |
| |
9. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l’entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l’ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell’ambito della specifica procedura. |
| |
10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE: a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all’IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7; b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all’IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a). |
| 5. (segue) Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. |
12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b) sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. |
| 5. (segue) Il contratto prevede, altresì, che: a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente; b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. |
11. La quantità di diritti oggetto del contratto di cui al comma 10, lettere a) e b), è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente. 12 (segue). È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. |
| 5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della sicurezza energetica. |
|
| 6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5. |
13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).”. |
Articolo 2, commi 2 e 2-bis
(Misure per il rafforzamento dei terminali di rigassificazione on-shore e off-shore)
L’articolo 2, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, apporta modifiche alla disciplina – di cui all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 50/2022 – istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione off-shore di cui al medesimo articolo 5 del D.L. n. 50/22.
Il comma 2 dell’articolo, in considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ossia al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Secondo la relazione illustrativa, rientra, a titolo esemplificativo, nell’ambito di applicazione della disposizione, il progetto di rigassificatore on-shore insistente sul territorio del comune di Porto Empedocle, destinato a contribuire in modo significativo all’approvvigionamento di gas del Paese e agli obiettivi nazionali di sicurezza energetica.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, sostituisce l’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022), il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze, un fondo con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, finalizzandolo a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei impianti di rigassificazione off-shore dal medesimo articolo 5 previsti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL definita dall’ARERA.
Con la novella si precisa che la quota dei ricavi è inclusiva non di tutto il costo di acquisto/o realizzazione degli impianti di rigassificazione off-shore, bensì dei costi di capitale per l’acquisto e/o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, rimanendo ferma la suddetta priorità.
L’ importo residuo – qualora vi sia, si specifica con la novella – rimane sempre destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori.
Quanto al decreto ministeriale attuativo della disciplina del Fondo, la novella conferma che esso è adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ARERA, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma introduce il concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
La novella qui in commento inserisce altresì la previsione per cui la gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da riconoscere e dispone l’erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto sopra menzionato, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente dedicato.
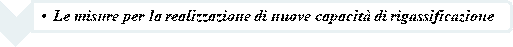
Il decreto legge n. 17/2022 ha introdotto misure per diversificare la provenienza del gas importato, massimizzando l'utilizzo delle infrastrutture disponibili e aumentando contestualmente la capacità nazionale di rigassificazione di GNL.
La sostituzione del gas di provenienza russa è così avvenuta tramite i maggiori afflussi dal gasdotto dell'Algeria e un forte incremento delle importazioni di gas liquefatto.
I nuovi accordi di approvvigionamento di GNL, per oltre 10 miliardi di metri cubi, hanno richiesto l'installazione di 2 nuovi terminali, oltre ai tre già operativi al massimo della capacità (Fonte: DEF 2023, III Sez. pag. 57).
Sono state, pertanto, previste, con il D.L. n. 50/2022, semplificazioni amministrative e la possibilità per il Governo di nominare dei commissari straordinari per la realizzazione di tali infrastrutture.
In particolare, l’articolo 5, come successivamente modificato dal successivo D.L. n. 57/2023, qualifica le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione o per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più Commissari straordinari di Governo (comma 1).
Lo stesso articolo 5, per quanto qui interessa, ha disposto, al comma 8, la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, destinandolo a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione (da parete di SNAM), inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione off-shore dal medesimo articolo previsti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera ARERA 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, si è provveduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla nomina di due strutture Commissariali, individuate nel Presidente della Regione Toscana per la realizzazione del rigassificatore di Piombino e nel Presidente della regione Emilia Romagna per la realizzazione del rigassificatore di Ravenna. Per Piombino è stato assunto dal Governo l’impegno a consentirne un uso temporaneo, non oltre i tre anni (Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, in audizione alla Camera dei deputati, il 21 dicembre 2022).
Con il D.L. n. 57/2023, il termine per la presentazione di progetti, anche di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione è stato riaperto fino al 29 luglio 2023. Per maggiori informazioni, si rinvia al sito istituzionale di SNAM.
Quanto al rigassificatore di Ravenna, il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, l'11 ottobre 2023, in risposta ad un question time in Assemblea della Camera dei deputati (Interrogazione a risposta immediata Bonelli 3/00726), ha affermato che sono in corso i lavori propedeutici all'installazione, poiché l'autorizzazione è stata rilasciata il 7 novembre del 2022. La regione Emilia-Romagna ha confermato la correttezza formale e giuridica del provvedimento; la procedura ha contemplato l'indizione di numerose conferenze di servizi, durante le quali non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione del progetto. La conferenza di servizi conclusiva del 28 ottobre 2022 ha approvato il progetto con l'unanimità degli enti intervenuti. A proposito del collaudo, il Ministro ha confermato la conformità della procedura di attivazione con le disposizioni della regola tecnica di cui al decreto ministeriale del 17 aprile 2008. Segnatamente, verranno effettuate delle verifiche analitiche per valutare l'origine di eventuali riduzioni di volume e nel flusso di metano verrà immessa una miscela di azoto, inerte e non infiammabile, anziché aria.
| Articolo 5 del D.L. n. 50/2022
Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione |
| Testo vigente |
Testo vigente come sostituito dall’art. 2, co- 2-bis |
| Art. 5, comma 8 |
Art. 5, comma 8 |
| 8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. |
8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione delle unità di cui al comma 1, inclusivi dei costi di capitale per l’acquisto e/o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL definita dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. L’eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da riconoscere e dispone l’erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto sopra menzionato, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente dedicato. |
Articolo 2, comma 2-ter
(Criteri per l’affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale)
L’articolo 2, comma 2-ter prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all’ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara. Non si prevede più, invece, che l’offerta di gara possa prevedere il versamento in ogni caso agli enti locali dell'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.
L’articolo 2, comma 2-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente, modifica le disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale contenute all’articolo 6 della legge n. 118/2021 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
I criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale sono stabiliti dal Regolamento di cui al D.M. 12 novembre 2011, n. 226, adottato in attuazione dell’articolo 46-bis del D.L. n. 159/2007 e successivamente modificato con D.M. 20 maggio 2015, n. 106
L’articolo 6 della legge n. 118/2022 reca disposizioni volte a valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal suddetto regolamento.
In particolare, la lettera d) del citato articolo 6, comma 1 della legge n. 118/2021 è sostituita per prevedere, con una norma di rango primario, che, in sede di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le condizioni offerte da ciascun concorrente prevedano anche l’effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell’ambito territoriale minimo di riferimento.
L’articolo 46-bis del D.L. n. 159/2007 ha previsto l’individuazione, da parte dei ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, nonché la definizione misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
Con il decreto attuativo del 19 gennaio 2011 sono stati individuati 177 ambiti territoriali (elencati nell’allegato 1 al decreto). Con successivo D.M. 18 ottobre 2011 sono stati indicati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale.
Gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 19 gennaio 2011, affidano il servizio di distribuzione gas tramite gara unica (art. 2, comma 1). La gara unica può essere estesa anche a due o più ambiti confinanti previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati (art. 2, comma 4). L'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito (art. 2, comma 3). Nel periodo di prima applicazione, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale (art. 3, comma 1).
Tali interventi devono essere atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 164 del 2000.
L’articolo 16, comma 4 del D.Lgs. n. 164/2000 impone alle imprese di distribuzione il perseguimento del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La norma rinvia a successivi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata la definizione degli obiettivi quantitativi nazionali, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati.
Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.
In attuazione di tali disposizioni sono stati adottati i decreti ministeriali del 20 luglio 2004, del 28 dicembre 2012, dell’11 gennaio 2017 e, da ultimo, per il periodo dal 2021 al 2024, con D.M. 21 maggio 2021. Le imprese di distribuzione con almeno 50.000 clienti finali, in particolare, devono realizzare interventi utili al conseguimento, nel 2024, di un risparmio energetico pari a 1,34 milioni di TEP. Le imprese ottengono dal GME titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi) di valore pari alla riduzione dei consumi conseguita attraverso gli interventi posti in essere. Al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico, le imprese di distribuzione possono anche acquistare i certificati bianchi da soggetti terzi.
I costi connessi al meccanismo dei certificati bianchi trovano copertura attraverso le tariffe di distribuzione. Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 164/2000, infatti, gli interventi realizzati dalle imprese di distribuzione per il perseguimento del risparmio energetico e lo sviluppo delle rinnovabili rientrano tra le iniziative volte ad innalzare l’efficienza energetica che, ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del medesimo decreto, possono essere remunerate attraverso le tariffe per la distribuzione.
Per un approfondimento, si rinvia alla pagina del sito del GSE dedicato al meccanismo dei certificati bianchi e al tema web consultabile sul sito della Camera dei deputati.
Qualora detti interventi non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all’ambito il contributo tariffario determinato dall’ARERA per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico e ferma restando l’applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi.
Il contributo tariffario è altresì versato agli enti locali appartenenti all’ambito, in luogo dell’effettuazione degli interventi di efficientamento energetico, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi.
La norma, infine, prevede che le modalità per la definizione delle procedure operative siano stabilite in sede di aggiornamento del Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale di cui al D.M. n. 226/2011.
Si osserva che l’articolo 13 del Regolamento di cui al D.M. n. 226/2011 già comprende, tra le condizioni economiche da valutare da parte della stazione appaltante per la scelta del concessionario del servizio di distribuzione di gas naturale maggiormente efficiente, l’effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell’ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000.
Tuttavia, il regolamento attualmente prevede che le imprese di distribuzione versino agli enti locali concedenti per intero il valore dei titoli di efficienza energetica corrispondente. Sempre in tema di investimenti in efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione, il testo vigente dell’articolo 6, comma 1, let. d) della legge n. 118/2022, che la novella intende sostituire, prevede che il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo.
La novella, quindi, al fine di migliorare l’efficacia della misura e di incentivare la realizzazione di tali interventi da parte dei gestori aggiudicatari, prevede che gli interventi di efficientamento energetico continuino ad essere indicati tra le condizioni economiche offerte dall’impresa, ma che l’obbligo di versamento di parte dei ricavi tariffari (unitamente a una somma a titolo di penale) solo in caso di inadempimento.
| Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 5 agosto 2022, n. 118) |
| Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 2, comma 2-ter dell’AC 1606-A |
| Art. 6
(Concessioni di distribuzione del gas naturale) |
Art. 6
(Concessioni di distribuzione del gas naturale) |
| 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni: (…) d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del citato regolamento di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226. (…) |
1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni: (…) d) in sede di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l’effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell’ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all’ambito il contributo tariffario determinato dall’ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000 e ferma restando l’applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all’ambito, in luogo dell’effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale n. 226 del 2011. (…) |
Articolo 3
(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)
L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell’impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
Le lettere 0b) e 0c), integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l’uno e per l’altra, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.
Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall’autorità competente, consente di rimodulare l’esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lett. b)).
In sede referente, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.
L’articolo 3 modifica e integra la disciplina sulle concessioni di coltivazione riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, cd. concessioni geotermoelettriche, di cui al D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.
Il comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, interviene sull’articolo 1 del Decreto legislativo, e in particolare:
1) modifica il comma 3-bis.2, il quale consente ai soggetti titolari di permessi di ricerca rilasciati per impianti pilota, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, di presentare, nell'ambito della successiva richiesta della concessione, contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e che agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico.
Con la novella qui in esame, si rimuove sia l’obbligo di attendere cinque anni dall’inizio dei lavori per presentare l’istanza di potenziamento, sia il richiamo alle ore annue di funzionamento su cui valutare i risultati sperimentali.
2) aggiunge un nuovo comma 8-bis, il quale consente la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. In questo caso, le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche, o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo.
La lettera 0b) inserita in sede referente, interviene sull’articolo 3, comma 6 del Decreto legislativo, integrando i criteri per la selezione del concessionario in caso di più domande di permesso di ricerca concorrenti. Viene in particolare inserita (con una nuova lettera e-bis) nel comma) tra i criteri di selezione del concessionario la ponderazione sulle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca.
Il comma 6 dell’articolo 3 del D.lgs. dispone che, in caso di domande di permesso di ricerca concorrenti, l'autorità competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: a) sull'interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari; b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta; c) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti; d) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa; e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati.
La lett. 0c) inserita in sede referente, interviene sull’articolo 8, comma 5 del Decreto legislativo, integrando i criteri per la selezione del concessionario in caso di più domande di permesso di coltivazione concorrenti. Anche in questo caso, viene inserita (con una nuova lettera c-bis) nel comma) tra i criteri di selezione del concessionario la ponderazione sulle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.
Il comma 5 dell’articolo 8 del D.lgs. dispone che, per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l'autorità competente, acquisito l'esito positivo della VIA per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:
a) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilità di lungo periodo;
b) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria;
c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.
lett. a), n. 1 e 2, interviene sull’articolo 16 del Decreto legislativo, ed in particolare:
§ novella il comma 10-bis, primo periodo, al fine di prorogare ulteriormente il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2)).
§ aggiunge, al comma 10, un ultimo periodo, il quale dispone che, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - è stabilito in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni, come invece in via generale previsto dall’articolo 9, comma 1, del medesimo D.lgs. (lett. a), n. 1).
Ai sensi di quanto prevede il D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, recante la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, l’esercizio di un impianto geotermoelettrico richiede la previa concessione di coltivazione per risorse geotermiche. Ai sensi dell’articolo 16, comma 10, ultimo periodo, del D.lgs. n. 22/2010, le scadenze delle concessioni di coltivazione riferite ad impianti per produzione di energia elettrica sono state (tutte) allineate al 2024. Questo termine è stato successivamente prorogato dal D.L. n. 51/2023, articolo 6, comma 2-septies (L. n. 87/2023). La norma ha introdotto nell’articolo 16 del D.lgs. n. 22/2010, un ulteriore comma, comma 10-bis, il quale dispone la proroga del termine di scadenza del 2024 per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 22/2010, tre anni prima della scadenza della concessione o nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, l'autorità competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione onerosa della concessione per trenta anni.
Come evidenzia la relazione illustrativa, le autorità competenti avrebbero dovuto, quindi, avviare le procedure per la riassegnazione delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2022. Si è, tuttavia, verificata una fase di "stallo", cui si ritiene necessario, con la norma qui in commento, porre rimedio.
Il comma 1, alla lett. b), introduce un nuovo articolo 16-bis, rubricato “Piano pluriennale per la promozione degli investimenti”, nel D.lgs. n. 22/2010.
Il nuovo articolo, con il fine espresso di rafforzare l’autonomia energetica nazionale e il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, dispone, al comma 1, che l’autorità competente può chiedere al concessionario uscente di una concessione geotermoelettrica di presentare, entro un termine stabilito dall’autorità, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un apposito piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;
d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
e) misure per l’innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.
Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis dispone che l’autorità competente proceda alla valutazione del piano, tenendo conto della funzionalità dello stesso a realizzare le finalità di cui al comma 1, nonché la sua fattibilità tecnico ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano, l’autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro 30 giorni dalla data di presentazione, o entro 15 giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato, l’autorità provvederà a rimodulare le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano, anche sotto il profilo della durata - comunque non superiore a 20 anni - in coerenza con quanto previsto nel piano positivamente valutato.
Ai sensi del comma 3, qualora il concessionario uscente non presenti il piano pluriennale degli investimenti oppure l’autorità competente non lo valuti positivamente, si procederà alla riassegnazione della concessione di coltivazione secondo il procedimento delineato dal già citato articolo 9 del Decreto legislativo.
Inoltre, qualora l’autorità competente accerti, in sede di monitoraggio, l’inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi del piano, la stessa autorità, entro centottanta giorni dall’accertamento, avvia le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione.
La relazione illustrativa afferma che “una simile misura con riguardo al settore della geotermia si rende necessaria, anche tenuto conto della circostanza che lo sfruttamento della risorsa geotermica è una peculiarità del nostro contesto nazionale (o, meglio, di alcune specifiche aree del Paese), la cui strategicità in rapporto agli obiettivi di decarbonizzazione nazionali esige di essere valorizzata e sostenuta, anche mediante la promozione di nuovi investimenti. A livello europeo, gli investimenti nel settore in parola sono, invece, pressoché inesistenti (la capacità geotermica in Europa ammonta a poche centinaia di MW). E proprio in considerazione del fatto che lo sfruttamento della risorsa geotermica a fini energetici si presenta quale peculiarità del nostro Paese che si giustifica l'assenza di milestone PNRR suscettibili di frapporre ostacoli a un intervento normativa del tipo di quello che si propone”.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n.112/2011, ha avuto modo di rilevare che le “risorse geotermiche” costituiscono un bene giuridico multifunzionale, per le diverse utilità che esse esprimono: quella economica, relativa alla produzione di energia, e quella ambientale conseguente al fatto che esse costituiscono una fonte di energia rinnovabile e, quindi, compatibile con la tutela dell'ambiente. Energia e ambiente, in queste disposizioni, non sono più termini antitetici, ma conciliabili tra loro. Le risorse geotermiche, infatti, sono, contemporaneamente, un bene giuridico economico-produttivo e un bene ambientale (sentenze n. 1 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – nel parere inviato al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’allora Ministero dello Sviluppo economico in data 12 settembre 2008 (AS 474) - aveva peraltro già evidenziato, con riferimento alla disciplina sulla geotermia previgente a quella attuale che “un’eventuale proroga delle concessioni in capo al concessionario uscente (quale quella prefigurata nel protocollo d’intesa del 2007), rappresenta una forma di deroga alla concorrenza per il mercato, che consentirebbe il consolidamento “in via automatica” delle gestioni esistenti, traducendosi in un ostacolo all’accesso al mercato di nuovi operatori, incompatibile con un contesto di piena liberalizzazione del settore. Un confronto tra più operatori nell’ambito di procedure di gara per l’affidamento delle concessioni appare, invece, come peraltro già osservato dall’Autorità in più occasioni, idoneo a consentire un corretto confronto tra gli eventuali aspiranti concessionari, garantendo che le funzioni assegnate siano svolte con minori costi o, a parità di costi, con maggiori benefici per le comunità locali e, più in generale, per la collettività”.
Inoltre, si rammenta come nel campo applicativo della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE, cd. Direttiva Bolkestein, attuata dal D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno) ricade «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione» (art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 59/2010), salve le eccezioni specificamente ivi indicate.
Al fine di garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura del mercato a una concorrenza non falsata e più ampia possibile negli Stati membri, si rammenta che l’articolo 12 della direttiva Servizi prevede l’obbligo per gli stessi di adottare “una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.
La Corte di giustizia ha più volte evidenziato (ex multis, Sentenza Sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15) l’illegittimità di proroghe ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, in quanto ritenute equivalenti al rinnovo automatico delle concessioni in essere, che è espressamente vietato dall’art. 12 della Direttiva. Ad ogni buon fine, la Corte ha comunque chiarito che, l’art. 49 del TFUE, in generale, osta a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni, nei limiti in cui queste presentino un interesse transfrontaliero certo.
In sede referente, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche, previsti dal D.M. 29 giugno 2016.
Il D.M. 23 giugno 2016 reca una disciplina di sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica. Si consideri che il successivo D.M. 4 luglio 2019 ha rideterminato meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da alcune delle fonti rinnovabili precedentemente beneficiarie degli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016, disponendo che il medesimo decreto continui ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto (articolo 1, comma 4).
Il D.M. 23 giugno 2016 ha dunque dispiegato gran parte dei suoi effetti; la norma in commento riguarda i progetti di impianti in posizione utile nelle aste e nei registri previsti dal suddetto decreto che devono entrare in esercizio.
In particolare, il D.M. 23 giugno 2016 ha riconosciuto una incentivazione all’energia prodotta netta e immessa in rete, pari al minor valore fra la produzione netta (produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite) e l’energia effettivamente immessa in rete. Ha previsto due forme di incentivazione:
· una tariffa onnicomprensiva (TO, data dalla somma tra tariffa incentivante base e ammontare totale degli eventuali premi). Nel caso di TO, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia ritirata dal GSE. La potenza massima per l’accesso alla TO è di 500 kW.
· un incentivo (I), calcolato come la differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario dell’energia (zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). Nel caso di incentivo, l’energia resta invece nella disponibilità del produttore. Gli impianti di potenza superiore a 500 kW possono pertanto optare per il solo incentivo.
A seconda della potenza degli impianti, l'accesso agli incentivi è stato soggetto – come sopra accennato - all'iscrizione degli impianti a registri o alla partecipazione ad aste competitive, mentre, nel caso degli impianti più piccoli è stato previsto l'accesso diretto. Gli impianti iscritti ai Registri e risultati ammessi in posizione utile o aggiudicatari di Procedure d'Asta hanno potuto presentare domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dal termine massimo per l'entrata in esercizio previsto dal Decreto per i differenti contingenti. Per quanto qui interessa, per gli impianti iscritti a registro geotermoelettrici (articolo 11 del D.M.) devono entrare in esercizio entro 51 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura (secondo la proroga prevista dall'art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 91/2018 (L. n. 108/2018).
Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria.
Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
Per le procedure d’asta il termine per l’entrata in esercizio dell’impianto geotermoelettrico è di 51 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione (articolo 16 del D.M.).
Il GSE, nell’ultimo Rapporto disponibile sull’attività 2022, relativo all’anno 2021, ha indicato gli impianti risultati aggiudicatari delle procedure d’asta o ammessi in posizione utile nei registri che, pur non essendo entrati in esercizio al 31 dicembre 2021, mantenevano a tale data la possibilità di accedere all’incentivazione.
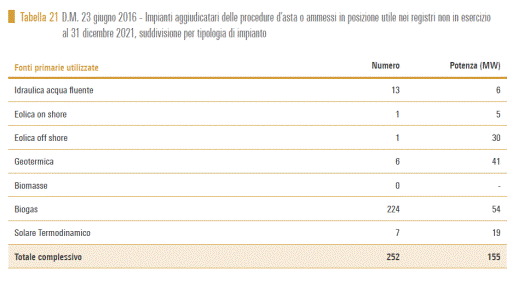
Fonte: GSE
Articolo 4
(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili)
L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.
In particolare, il comma 1 prevede che, per le finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020 numero 47, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, sia destinata ad alimentare un fondo ad hoc da istituire nello stato di previsione del MASE poi da ripartire tra le Regioni.
A tale proposito si ricorda che l’articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/410 e in adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, disciplina la messa all’asta delle quote di anidride carbonica ed individua il GSE quale soggetto responsabile per il collocamento e le attività connesse alle aste suddette.
Si segnala che, durante l’esame da parte delle Commissioni riunite, è stato soppresso l’originario comma 2 del decreto-legge in esame che introduceva un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza degli impianti di energia prodotti da fonti rinnovabili, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il l° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, da versare al GSE.
Il comma 2 della disposizione in commento, prevedendo la stipula di una convenzione tra il GSE e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, affida allo stesso Gestore dei Servizi Energetici il compimento delle attività funzionali all’operatività delle misure del presente articolo.
Nel dettaglio, è attribuito espressamente al GSE il compito di definire e pubblicare sul proprio sito istituzionale i flussi informativi che Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione, è tenuta a trasmettere al GSE, relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I costi derivanti dall'attività anzidetta sono coperti a valere sulle risorse relative ai contributi annuali di cui al comma 2, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 3 demanda quindi ad un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 1, considerando, a tale fine, come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La disposizione in questione, inoltre, demanda al medesimo decreto, per il solo anno 2024, la definizione delle modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma l tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti aventi ad oggetto i principi e i criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui al comma l dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
Articolo 4-bis
(Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)
L’articolo 4-bis, inserito durante l'esame in sede referente, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.
L’articolo in esame integra il disposto della lettera b) del comma 6 dell’art. 6 del Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006).
Tale lettera b) prevede che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per le modifiche o le estensioni dei progetti sottoposti a VIA o a screening di VIA (elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del citato Codice) e la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che non determinino il superamento dei valori limite (indicati negli allegati II e III) oltre i quali è obbligatoria la procedura di VIA.
L’articolo in esame integra tale disposizione al fine di includere, tra le modifiche o estensioni assoggettate a screening di VIA, gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.
La norma in esame chiarisce che la propria finalità è quella di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica.
Articolo 4-ter
(Ulteriori disposizioni per la promozione
di impianti a fonti rinnovabili)
L’articolo 4-ter, inserito durante l'esame in sede referente, prevede, al comma 1 le attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAEE fotovoltaici. Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dai soli incentivi previsti dal D.lgs. n. 28/2011, e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al D.lgs. n. 199/2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3 lett. a) e b). In particolare, la lettera a), dispone che è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. La lettera b) adegua la disciplina dei meccanismi d’asta al ribasso, sopprimendo la previsione che consente l’accesso ai meccanismi d’asta ai (soli) impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
Il comma 3, alla lettera c), dispone, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, che le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti (di cui all’articolo 43, comma 1 del D.lgs. n. 199/2021) - si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.
Il comma 4, interviene sempre sul D.lgs. n. 199/2021, laddove prevede, una volta entrato in vigore il nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche (con l’adozione dei decreti attuativi), la soppressione del meccanismo di sostegno dello scambio sul posto. Il medesimo comma 4, in particolare, demanda ad ARERA, su proposta del GSE, il compito di disciplinare le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto. I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del meccanismo incentivante del ritiro dedicato (cui i nuovi impianti, entrati in esercizio dopo la soppressione dello scambio sul posto, potranno accedere). Il comma 7 disciplina la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica.
L’articolo in esame è volto ad ottimizzare la gestione dei RAAE fotovoltaici, attraverso la promozione dell’utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei RAEE.
A tale fine, il comma 1 modifica il D. Lgs. 49/2014 che reca la disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e specificamente:
· la lettera a) integra il comma 1 dell’articolo 24-bis, e stabilisce che il GSE svolge un’attività di monitoraggio relativa:
- alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi;
- alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti;
- ai costi medi di adesione ai consorzi;
- nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.
Il comma 1 dell’articolo 24-bis disciplina il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche di fotovoltaico, che risulta a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
· la lettera b) modifica il comma 3 dell’articolo 40, al fine di specificare che la somma trattenuta da GSE per la copertura dei costi di gestione dei RAEE fotovoltaici deve essere pari al doppio della somma determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.
Il comma 3 dell’art. 40 stabilisce che, per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti per legge, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti, da restituire al detentore in base a specifici adempimenti.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell’articolo 65 del D.L. 1/2012, che reca la disciplina degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, al fine di prevedere che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sia consentito l'accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili previsti esclusivamente dal D. Lgs. 28/2011.
Si evidenzia, al riguardo, che il nuovo sistema incentivante per le fonti energetiche rinnovabili è delineato nel D.lgs. n. 199/2021 (che viene peraltro modificato dai commi successivi dell’articolo in esame e dall’articolo 4-septies del decreto-legge, alla cui scheda di lettura si rinvia). Tale nuovo sistema diverrà operativo con l’adozione dei decreti ministeriali attuativi, non ancora adottati.
La novella inserite dal comma in esame sembra dunque disporre l’applicabilità tout court dei nuovi incentivi previsti dal D.lgs. n. 199/2021.
L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2021, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012, dispone – in via generale –, al comma 1, che, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Questa previsione ha trovato poi una serie di eccezioni - previste dai successivi commi dell’articolo 65 stesso (commi da 1-bis a 1-octies e comma 2) - via via implementate nel corso degli anni e, da ultimo, con il D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022).
Il comma 3, alle lett. a) e b) interviene sulla disciplina di cui al Capo II del Titolo II del D.lgs. n. 199/2021, relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli da 5 a 9), ed in particolare:
· alla lettera a), interviene sull’articolo 5, integrando l’elenco – contenuto nel comma 5 – degli specifici criteri da seguire nella definizione dei meccanismi di incentivazione. Vi inserisce, in particolare una nuova lettera e-bis), ai sensi della quale è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva;
· alla lettera b), interviene sull’articolo 6 del D.lgs. che prevede e disciplina i criteri per la definizione, con decreto ministeriale, delle procedure competitive d’asta al ribasso (procedure previste per l’assegnazione degli incentivi ai grandi impianti di produzione di energia elettrica da FER, con potenza superiore a 1 MW). La lettera qui in esame sopprime la lettera l) che consente l’accesso ai meccanismi d’asta al ribasso ai (soli) impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
La lettera c) del comma 3 integra l’articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021, che reca i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, il cui rispetto è condizione per l’accesso agli incentivi. La lettera inserisce, in particolare, nell’articolo 42, un nuovo comma 18-bis, ai sensi del quale - con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose - le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti - di cui all’articolo 43, comma 1 del D.lgs.- si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che, ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 42, dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità (attualmente contenuta D.M. 14 novembre 2019).
Si rammenta che, l’articolo 43 del D.lgs. n. 199/2021 dispone che deve essere certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici della filiera di produzione devono aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o ad un sistema volontario di certificazione.
Contestualmente, l’articolo 42, nel dettare i criteri di sostenibilità dei carburanti in base ai quali ottenere la certificazione, dispone, al comma 16, l’aggiornamento del D.M. 14 novembre 2019, recante la disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. Nelle more dell'aggiornamento – che avrebbe dovuto avvenire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs – trova applicazione tale ultimo decreto limitatamente alle disposizioni non contrastanti con l’articolo 42 stesso.
Il comma 4 interviene in relazione a quanto previsto dall’articolo 9, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 199/2021. Ai sensi di tali commi, decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi dei nuovi incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (allo stato non ancora adottati), il vigente meccanismo incentivante dello scambio sul posto verrà soppresso e nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data possono quindi accedere ai nuovi meccanismi incentivanti, ovvero al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 387/2003 (comma 2). I decreti ministeriali dovranno indicare le modalità per la conversione graduale delle tariffe incentivanti degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto. Tale conversione dovrà attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024 (comma 3).
Il comma 4 qui in esame, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 3, demanda ad ARERA il compito di disciplinare, su proposta del GSE, le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:
a) priorità di uscita degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. A tale fine, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni stesse;
b) applicazione delle modalità di ritiro dedicato dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.
L'articolo 13, comma 3 e 4, del D.lgs. n. 387/03 – già sopra citato – ha previsto che l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. il medesimo comma ha demandato ad ARERA la determinazione delle modalità per il ritiro dell'energia elettrica, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato (deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05, la deliberazione 6 aprile 2005, n. 64/05, la deliberazione 6 novembre 2007, n. 280/07, e la deliberazione 21 aprile 2008, n. ARG/elt 48/08).
Il comma 5, al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nella erogazione dei corrispettivi afferenti al citato ritiro dedicato, dispone che, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dal 2024, il GSE eroghi corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali da ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tener conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
Ai sensi del comma 6, con propri provvedimenti da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, ARERA definisce, su proposta GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato anche per periodi non inferiori a 5 anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
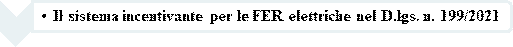
Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento nell’ordinamento della Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), disciplina nel Titolo II, i tegimi di sostegno e gli strumenti di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
Accanto ai principi generali (articolo 4) enunciati nel Capo I del Titolo, il Capo II disciplina il sostegno per le FER elettriche con il relativo sistema transitorio dal vecchio al nuovo regime (articoli 5-9).
Quanto alle FER elettriche, l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata e sono fissati criteri specifici ai fini della definizione dei meccanismi incentivanti, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione dell'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica.
Per i grandi impianti di produzione di energia elettrica da FER, con potenza superiore a 1 MW, l'incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza (articoli 5 e 6).
Per i gli impianti di piccola taglia (<1 MW), si distingue a seconda:
· di impianti innovativi o con costi di generazione maggiormente elevati, per i quali l'incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi
· di impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, per i quali l’accesso agli incentivi avviene attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale (articolo 5, comma 3).
La disciplina della regolamentazione dei meccanismi d’asta al ribasso (i cui criteri sono dettati nell’articolo 6) e delle tariffe per i piccoli impianti (i cui criteri sono dettati nell’articolo 7) è demandata ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata. Tali decreti che (rispettivamente, ai sensi degli articoli 6 e 7) avrebbero dovuto essere adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 199 (dunque, entro il 13 giugno 2022) non sono stati ancora adottati.
Fino all’entrata in vigore dei nuovi meccanismi – dunque, fino all’entrata entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi continua ad operare del meccanismo d'asta e registro di cui al D.M. cd. FER 1 (D.M. 4 luglio 2019), con la messa a disposizione da parte del GSE della potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento (articolo 9, comma 4).
Decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore dei decreti volti a fissare i nuovi meccanismi incentivanti, il vigente meccanismo incentivante dello scambio sul posto verrà soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data possono quindi accedere ai nuovi meccanismi incentivanti, ovvero al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 387/2003 (articolo 9, comma 2). I decreti ministeriali attuativi indicheranno le modalità per la conversione graduale delle tariffe incentivanti degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024 (articolo 9, comma 3).
Il comma 7 dispone che per le aree dei siti oggetto di bonifica, individuate secondo quanto previsto nel Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) interessate dalla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile - in quanto aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicate alla colonna B, della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte quarta del Titolo V del medesimo Codice dell’ambiente.
Nella Tabella 1 in questione sono elencate le concentrazioni dei valori di soglia per diversi composti chimici relativi alla contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, che per la colonna B riguarda i siti ad uso commerciale e industriale.
Articolo 4-quater
(Misure a sostegno dell’edilizia)
L’articolo 4-quater, introdotto in sede referente, proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
L’articolo 4-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, con novella all’art. 10-septies del D.L. 21/2022, interviene su termini in materia di edilizia e urbanistica già da tale norma prorogati in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, e poi ulteriormente prorogati dall’art. 10, comma 11-decies, del D.L. 198/2022.
Nel dettaglio, la norma in esame estende da due anni (come previsto dal vigente art. 10-septies) a 30 mesi la proroga:
- dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
Il secondo periodo della lettera a) (come da ultimo modificata dall’art. 10, comma 11-decies, lett. b), del D.L. 198/2022) del comma 1 dell’art. 10-septies specifica che la proroga in oggetto (e dunque ora l’ulteriore proroga disposta dalla norma in esame) si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020.
Si ricorda che l’art. 15 del Testo unico dell’edilizia disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. Ai sensi del comma 1, nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il comma 2 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive.
Si ricorda altresì che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al citato art. 15, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono stati prorogati di ventiquattro mesi dall’art. 18, comma 4, del D.L. n. 13/2023, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 e al regolamento (UE) 2021/241.
- del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
Il secondo periodo della lettera b) (come da ultimo modificata dall’art. 10, comma 11-decies, lett. c), del D.L. 198/2022) del comma 1 dell’art. 10-septies precisa che la proroga in oggetto (e dunque ora l’ulteriore proroga disposta dalla norma in esame) si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di tre anni di cui all'art. 30, comma 3-bis, del D.L. n. 69/2013, e della analoga proroga di tre anni di cui all'art. 10, comma 4-bis, del D.L. n. 76/2020.
Si ricorda che il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico, a iniziativa prevalentemente privata, disciplinato dall’art. 28 della L. 1150/1942, attuativo della pianificazione urbanistica generale e finalizzato a realizzare un intervento edilizio che richieda nuove opere di urbanizzazione o comporti l’aggravio del carico urbanistico esistente.
Articolo 4-quinquies
(Semplificazione dell’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area del Centro Italia post sisma 2016)
L’articolo 4-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi per la realizzazione di interventi sugli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016.
Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame prevede che, per facilitare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all’articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Il comma 2 della disposizione in esame prevede che per realizzare l’accesso a tali interventi, gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 possano presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.
Infine, il comma 3 dell’articolo in esame dispone la decadenza, per gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma, dal diritto alla prenotazione dell’incentivo, se:
- entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non abbiano presentato la documentazione attestante l’assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto,
- entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
Articolo 4-sexies
(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)
L’articolo 4-sexies, inserito durante l'esame in sede referente, prevede – al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale – l’incremento da 50 a 70 del numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS (lettera a), numero 1)), nonché la riscrittura della disciplina relativa alla copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA e ai compensi dei relativi componenti (lettera b)).
Sono inoltre modificate (dalla lettera a), numero 2)) le modalità mediante le quali la Commissione VIA-VAS si avvale, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca. In particolare viene previsto che l’avvalimento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) non è più facoltativo e avviene sulla base di un’apposita convenzione nel limite di 500.000 euro annui.
La finalità dell’articolo in esame, come indicata chiaramente dallo stesso, è quella di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale. A tal fine vengono operate le seguenti modifiche all’art. 8 del Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006), che reca la disciplina delle cosiddette Commissioni VIA (vale a dire della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica competente per la valutazione di impatto ambientale dei progetti PNRR-PNIEC).
Si ricorda che l’art. 8, comma 1, del Codice dell'ambiente, dispone che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme in materia di VIA e VAS nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il comma 2-bis del medesimo articolo (inserito nel testo del Codice dell'ambiente dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, successivamente più volte modificato) – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al Codice, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica assoggettati a VIA statale – ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Entrambe le Commissioni VIA (VIA-VAS e PNRR-PNIEC) sono poste alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
La lettera a), numero 1), modifica il primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 citato al fine di incrementare da 50 a 70 il numero massimo di componenti, inclusi il Presidente e il Segretario, della Commissione VIA-VAS.
La lettera a), numero 2), riscrive il secondo periodo del comma 1 dell’art. 8, che consente alla Commissione VIA-VAS – per lo svolgimento delle istruttorie tecniche – di avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca.
Il nuovo testo, risultante dalla riscrittura operata dall'articolo in esame, conferma quanto già previsto dal testo vigente, prevedendo però che:
- la clausola di invarianza finanziaria (“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”) si applica non solo nel caso di avvalimento degli altri pubblici di ricerca ma anche degli enti del SNPA diversi dall’ISPRA;
- l’avvalimento dell’ISPRA non è più facoltativo e avviene con modalità diverse: viene infatti previsto che – per lo svolgimento delle istruttorie in questione – la Commissione VIA-VAS si avvale dell’ISPRA sulla base di un’apposita convenzione, nel limite di 500.000 euro annui. Alla copertura degli oneri conseguenti si provvede con i proventi delle tariffe che l’art. 33, comma 1, del Codice dell'ambiente, pone a carico dei soggetti che presentano l’istanza di valutazione ambientale.
La lettera b) riscrive quasi interamente il comma 5 che disciplina la copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA e i compensi dei relativi componenti.
Per la precisione, il testo vigente del primo periodo di tale comma dispone in particolare che, con apposito decreto annuale del Ministro dell'ambiente (emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (Commissione VIA-VAS) e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti.
Tale previsione viene confermata dalla riscrittura operata dal comma in esame e costituisce il nuovo primo periodo del comma 5.
Il nuovo secondo periodo del comma 5 riprende, nella sostanza, integrandolo, il restante contenuto del primo periodo del testo vigente del comma 5.
In base al richiamato testo vigente, i citati costi di funzionamento sono definiti in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe poste a carico dei soggetti proponenti (cioè dei soggetti che presentano l’istanza di valutazione ambientale) versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il nuovo testo dispone che alla copertura dei costi in questione si provvede con i proventi delle tariffe citate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in tal modo riproducendo sostanzialmente quanto previsto dal testo vigente. Tale disposizione viene però integrata al fine di precisare che tali proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), sino a concorrenza dei costi in questione, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.L. 68/2022 e ai sensi dell’art. 2, comma 617-bis, della L. 244/2007, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617 della medesima legge.
Si ricorda, in particolare, che l’art. 12, comma 1, del D.L. 68/2022, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, ad integrazione delle risorse già previste, ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il nuovo terzo periodo, che non trova corrispondenze nel testo vigente, è volto a precisare che le risorse derivanti dal versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi in questione, eccedenti la quota riassegnata ai sensi del periodo precedente, restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato.
Il nuovo quarto periodo riproduce invece fedelmente le disposizioni recate dal secondo periodo del testo vigente, secondo le quali i compensi dei Commissari sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale della Commissione PNRR-PNEC restano in carico all'amministrazione di appartenenza.
Il nuovo quinto ed ultimo periodo conferma quanto già previsto dal terzo periodo del testo vigente – secondo cui a decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione VIA-VAS si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC –, integrandolo al fine di precisare che tali compensi, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l’attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall’anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo.
Articolo 4-septies
(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
L’articolo 4-septies – inserito in sede referente – prevede l’introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7). A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-bis il citato decreto legislativo.
Segnatamente, l’articolo 4-septies, inserito in sede referente, integra la disciplina di cui al Capo II del Titolo II del D.lgs. n. 199/2021, relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli da 5 a 9) con un nuovo articolo 7-bis, rubricato “disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.
Il comma 1 del nuovo articolo demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite l’ARERA e la Conferenza unificata, la definizione delle modalità per l’implementazione di un meccanismo, alternativo a quelli già disciplinati dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 199/2021, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Il meccanismo deve essere definito nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
b) è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla successiva lettera h);
c) i contratti devono essere caratterizzati dai seguenti elementi:
1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell’energia elettrica nei mercati a pronti;
2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla successiva lettera h);
3) l’obbligo, in capo all’operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
4) il diritto dell’operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
5) l’individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti in relazione a ciascun periodo rilevante dell’anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a uno;
6) il lasso temporale tra la data di sottoscrizione del contratto e l’inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di regolazione di cui ai suddetti numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto delle tempistiche di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell’obbligo di immissione di un quantitativo minimo di energia, di cui alla lettera d) di seguito descritta;
d) gli operatori titolari dei contratti sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell’energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposto albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi della successiva lettera e). Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, l’operatore deve consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all’obbligo medesimo, rilasciati dallo stesso Gestore;
e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell’energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell’albo. I certificati rilasciati possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell’ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal GME;
f) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
g) la quota percentuale dell’energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, di cui alla lettera d), è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 210/2021.
L’articolo 18 del D.lgs. 210/2021, di recepimento della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede l’introduzione nell’architettura del mercato elettrico italiano di un nuovo meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico (cd. MACSE), da affiancare ai mercati dell’energia, dei servizi ancillari e della capacità. Nel dettaglio, l’articolo 18 del D.lgs. 210/2021 stabilisce che il Gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna), in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione sottopone all’approvazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l’ARERA, una proposta di progressione temporale del fabbisogno della capacità di stoccaggio, articolato su base geografica e sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno. ARERA definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabora e presenta al Ministro, per la relativa approvazione, una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento a lungo termine della capacità di stoccaggio, basato su aste concorrenziali, trasparenti e non discriminatorie svolte da Terna.
La capacità di stoccaggio realizzata è allocata attraverso una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici (GME), secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio (comma 5).
L’attuazione della misura è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea (comma 6).
Con deliberazione 247/2023/r/eel del 6 giugno 2023 ARERA ha definito i criteri e condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento sopra delineato. Terna, ad ottobre 2023, ha avviato le consultazioni con gli operatori interessati. In esito alle consultazioni, terminate il 30 novembre 2023, tenuto conto delle osservazioni pervenute, i documenti sono trasmessi al MASE per le opportune valutazioni.
h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgersi con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;
i) in relazione alle procedure competitive, i prezzi a base d’asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di immissione in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;
l) le procedure competitive sono coordinate con le procedure di allocazione di cui al già citato articolo 18, comma 5, D.lgs. n. 210/2021;
m) i contingenti resi disponibili nell’ambito delle procedure competitive:
1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;
2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
3) sono definiti tenendo conto dell’esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità, la sicurezza del sistema elettrico al minor costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
n) i contingenti sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti ministeriali di disciplina del meccanismo;
o) in caso di mancato rispetto dell’obbligo di immissione in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, di cui alla lettera d), l’operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:
1) un valore, indicato nel contratto, definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;
2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell’obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della medesima lettera.
Con riferimento alla misura in esame, appare opportuno richiamare la pendente riforma del mercato europeo dell’energia elettrica, e, in particolare, dalla Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Nella relazione di accompagnamento di tale proposta, si evidenzia che alcune forme di sostegno pubblico garantiscono al produttore di energia un prezzo minimo grazie all'intervento del governo, mentre gli consentono di ottenere comunque l'intero prezzo di mercato quando questo è molto elevato. Con il recente aumento dei prezzi, molta dell'energia (economica) che gode di sostegno pubblico ha beneficiato dei prezzi di mercato elevati. Per arginare questo fenomeno e stabilizzare i prezzi, il sostegno agli investimenti dovrebbe essere strutturato come "bidirezionale" (contratto bidirezionale per differenza), con un prezzo minimo ma anche un prezzo massimo, in modo da restituire eventuali ricavi superiori al massimale. La proposta di regolamento si applicherà ai nuovi investimenti per la produzione di energia elettrica, che comprendono investimenti in nuovi impianti di generazione di energia, investimenti per la revisione della potenza degli impianti di generazione esistenti, investimenti volti ad ampliare gli impianti di generazione esistenti o a prolungarne il ciclo di vita. Inoltre la proposta prevede che tali fondi siano poi convogliati per sostenere tutti i consumatori di energia elettrica in proporzione al loro consumo, al fine di attenuare l'effetto dei prezzi elevati.
Il Consiglio dell’UE ha adottato, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il mandato negoziale per l’avvio dei negoziati interistituzionali con il Parlamento europeo il 19 giugno 2023, sulla prima proposta e il 17 ottobre 2023 sulla seconda. Il Consiglio ha convenuto che i contratti bidirezionali per differenza (contratti a lungo termine conclusi da enti pubblici per sostenere gli investimenti, che integrano il prezzo di mercato quando è basso e chiedono al generatore di rimborsare un importo quando il prezzo di mercato è superiore a un determinato limite, al fine di evitare proventi straordinari eccessivi) costituiranno il modello obbligatorio utilizzato per i finanziamenti pubblici nei contratti a lungo termine, con alcune eccezioni.
I contratti bidirezionali per differenza si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di generazione di energia elettrica basati sull'energia eolica, sull'energia solare, sull'energia geotermica, sull'energia idroelettrica senza serbatoio e sull'energia nucleare. Ciò garantirebbe prevedibilità e certezza.
Le norme relative ai contratti bidirezionali per differenza si applicherebbero solo dopo un periodo di transizione di tre anni (cinque anni per i progetti di dispositivi ibridi offshore collegati a due o più zone di offerta) dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza del diritto per i progetti in corso.
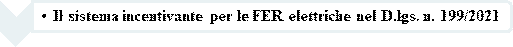
Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento nell’ordinamento della Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), disciplina nel Titolo II, i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
Accanto ai principi generali (articolo 4) enunciati nel Capo I del Titolo, il Capo II disciplina il sostegno per le FER elettriche con il relativo sistema transitorio dal vecchio al nuovo regime (articoli 5-9).
Quanto alle FER elettriche, l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata e sono fissati criteri specifici ai fini della definizione dei meccanismi incentivanti, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione dell'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica.
Per i grandi impianti di produzione di energia elettrica da FER, con potenza superiore a 1 MW, l'incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza (articoli 5 e 6).
Per i gli impianti di piccola taglia (<1 MW), si distingue a seconda:
· di impianti innovativi o con costi di generazione maggiormente elevati, per i quali l'incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi
· di impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, per i quali l’accesso agli incentivi avviene attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale (articolo 5, comma 3).
La disciplina della regolamentazione dei meccanismi d’asta al ribasso (i cui criteri sono dettati nell’articolo 6) e delle tariffe per i piccoli impianti (i cui criteri sono dettati nell’articolo 7) è demandata ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata. Tali decreti che (rispettivamente, ai sensi degli articoli 6 e 7) avrebbero dovuto essere adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 199 (dunque, entro il 13 giugno 2022) non sono stati ancora adottati.
Fino all’entrata in vigore dei nuovi meccanismi – dunque, fino all’entrata entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi continua ad operare del meccanismo d'asta e registro di cui al D.M. cd. FER 1 (D.M. 4 luglio 2019), con la messa a disposizione da parte del GSE della potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento (articolo 9, comma 4).
Decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore dei decreti volti a fissare i nuovi meccanismi incentivanti, il vigente meccanismo incentivante dello scambio sul posto verrà soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data possono quindi accedere ai nuovi meccanismi incentivanti, ovvero al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 387/2003 (articolo 9, comma 2). I decreti ministeriali attuativi indicheranno le modalità per la conversione graduale delle tariffe incentivanti degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024 (articolo 9, comma 3).
Articolo 4-octies
(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)
L’articolo in esame, introdotto in sede referente, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
La disposizione novella l’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020. Tale comma 8 dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra che supera il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
Con la novella in esame rimane invariata la quota prevista fino al 2024 e viene innalzata a 300 milioni annui (rispetto ai 150 milioni previsti a legislazione vigente) la quota destinata al Fondo a decorrere dal 2025.
Come sopra accennato, la disposizione specifica che le risorse in oggetto sono destinate al Fondo nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e delle disposizioni dettate dalla direttiva 2003/87/CE in materia di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra - ETS.
Per quanto concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, si rinvia al relativo dossier sulla disciplina nazionale ed europea in materia, curato dal Servizio studi della Camera. Per un quadro sintetico ed aggiornato sulla normativa in materia di aste ETS, si veda la scheda dell’art. 12 nel dossier di documentazione sull’A.S. 969 (ddl delegazione europea, all’esame del Senato al momento della redazione della presente scheda).
Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di attuazione della direttiva (UE) 2018/410 volta a sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, all’articolo 23 disciplina le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2 equivalente attraverso la vendita all'asta, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa. Come detto, una quota dei proventi delle aste viene destinata, dal comma 8 del medesimo art. 23, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Si ricorda che il Fondo è stato istituito dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (come convertito dalla legge n. 128 del 2019), che ha novellato l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
Il Fondo è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette).
Nell’ambito della quota assegnata al Fondo a valere sui proventi delle aste, si prevede, inoltre, l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 (misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
Il decreto 12 novembre 2021 dell’allora Ministero delle transizione ecologica definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea.
Gli aiuti concedibili riguardano due diversi filoni normativi e due diversi periodi:
a) la comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) («Linee guida ETS del 2012») disciplina i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
b) la comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) («Linee guida ETS del 2021»), disciplina i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030.
Da rimarcare che le misure di aiuto alle imprese appena citate sono state notificate ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e – pur costituendo sovvenzione diretta – sono compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato (art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato) in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS del 2012 e del 2021.
Peraltro, il decreto prevede che al fine di garantire la trasparenza (degli aiuti di Stato), il soggetto gestore pubblichi il testo integrale del regime di aiuti approvato, cura la redazione di una relazione sulla misura di aiuto, con le modalità previste dalle Linee guida ETS del 2012 di cui ai punti da 48 a 50 e da 52 a 54, ai fini della trasmissione alla Commissione europea e conserva per dieci anni la documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti da mettere a disposizione su richiesta del Ministero e della Commissione per eventuali controlli.
La gestione del Fondo è affidata a Acquirente Unico S.p.a., società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), di proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della transizione ecologica.
L'intensità massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020, non sarà superiore al 75%, come previsto al paragrafo 26 degli orientamenti ETS del 2012.
L’ultimo rapporto pubblicato a settembre 2023 da GSE sulle aste di quote europee di emissioni è relativo al II trimestre 2023.
Per una ricostruzione della normativa sui cambiamenti climatici vedi il relativo tema dell’attività parlamentare.
Articolo 5, commi da 1 a 3
(Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)
L’articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili. Il comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall’ARERA. Il comma 3, infine, prevede che il decreto di istituzione della Commissione preposta all’esame delle proposte di modifica e integrazione dell’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy (lett. a)) e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy (lett. b)).
L’articolo 5, comma 1, istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettano i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del D.Lgs. n. 199/2021 e i cui impianti siano già in esercizio alla data del 10 dicembre 2023 (ossia alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame). Si veda, in proposito, il box in calce alla presente scheda.
La finalità della misura è indicata al comma 1 nel conseguimento degli obiettivi di crescita della quota di consumi finali coperti da fonti rinnovabili indicanti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999.
La relazione illustrativa segnala che il parco delle centrali esistenti, per una potenza installata complessiva pari a 1.000 MW, è in grado di garantire un sostegno importante al mantenimento delle traiettorie di decarbonizzazione in virtù di alcune specifiche tecniche. In particolare, trattandosi di centrali a fonti totalmente rinnovabili, programmabili, flessibili e ad elevata affidabilità di funzionamento, gli impianti alimentati da bioliquidi sono capaci di compensare l’eventuale deviazione dalla traiettoria di installazione di almeno 3 GW di nuovi impianti fotovoltaici, senza l’utilizzo di ulteriore suolo (trattandosi di infrastrutture esistenti). L’elevata programmabilità di tali impianti, peraltro – prosegue la relazione illustrativa - può contribuire alla flessibilità e alla sicurezza del sistema elettrico nazionale mediante la previsione di un idoneo meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto della peculiarità della filiera e, in particolare, delle sue specificità di approvvigionamento, logistica e stoccaggio del combustibile.
L’urgenza della misura, sottolinea la relazione illustrativa, deriva dall’esigenza di evitare la chiusura degli impianti che, a partire dal 31 dicembre 2022, non godono più della garanzia di copertura dei costi assicurata dal cosiddetto “programma di massimizzazione a carbone” (di cui all’articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022)
Per un’analisi degli obiettivi indicati nel Piano e nella proposta di aggiornamento dello stesso, si rinvia al dossier sulle politiche pubbliche italiane dedicato alle fonti rinnovabili e agli obiettivi di sviluppo delle stesse.
Il meccanismo tiene conto, tra l’altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell’approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell’energia primaria, delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico, nonché, come prevede un’integrazione al testo approvata nel corso dell’esame in sede referente, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione.
La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’ARERA, la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per l’attuazione, da parte di Terna, società concessionaria dei servizi di trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica, del meccanismo, nonché dei relativi schemi di contratto-tipo
Il comma 2 prevede che, dal 10 dicembre 2023, fino alla data di entrata in operatività del meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, e comunque non oltre – prevede ora il testo come modificato in sede referente - il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili che rispettano i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del D.Lgs. n. 199/2021 si applicano i prezzi minimi garantiti definiti dall’ARERA secondo i criteri previsti all’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021; pertanto, per quanto di interesse, i prezzi minimi garantiti sono:
§ corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente dell’impianto;
§ differenziati in base alla potenza dell’impianto;
§ aggiornati annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all’utilizzo energetico delle stesse.
L’ARERA è chiamata ad adottare i provvedimenti attuativi di competenza entro l’8 febbraio 2024.
La relazione tecnica ricorda anche che l’articolo 5, comma 5, lettera h) del citato D.Lgs. n. 199/2021 ha previsto misure per integrare i ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, a favore di impianti a fonti rinnovabili che continuino ad essere eserciti al termine del periodo di diritto agli incentivi, con particolare riguardo agli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione legati ai costi di approvvigionamento del combustibile, tenendo conto della necessità di contenimento dei costi secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un principio di economia circolare e della disciplina i materia di aiuto di Stato. Chiarisce, inoltre, che l’articolo 5, commi 1 e 2 introduce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da impianti già esistenti alimentati a bioliquidi sostenibili, che sono perlopiù prossimi al termine del periodo di incentivazione, volto a mantenere la loro capacità produttiva in condizioni di funzionamento efficiente nei prossimi anni anche per far fronte alle crescenti esigenze di back up e modulazione del sistema elettrico, in particolare, quando la disponibilità delle altre fonti rinnovabili non è pienamente sufficiente a coprire la domanda elettrica. Ricorda, inoltre, che gli incentivi mediante prezzi minimi garantiti trova copertura a valere sugli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico, posti a carico degli utenti del servizio elettrico. Posto che la produzione netta annua da bioliquidi è stimabile in 2.940 GWh, stima in 233 milioni di euro l’anno il costo derivante dalla corresponsione in via transitoria dei prezzi minimi garantiti che saranno definiti dall’ARERA.
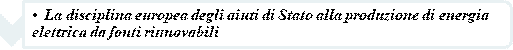
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), possono dirsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE impone agli Stati di comunicare, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Il successivo paragrafo 4 prevede l’adozione da parte della Commissione europea di regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito che possono esser dispensate dalla procedura di notifica.
Con Comunicazione 2022/C 80(01), la Commissione ha adottato la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022. Essa consente l’adozione di misure di sostegno per i bioliquidi nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione (punto 4.1.2.1). Tuttavia, lo Stato deve dimostrare la necessità di tali aiuti per le attività proposte (punto 4.1.3.1), nonché giustificare le misure che non includono tutte le tecnologie e i progetti che sono in concorrenza (punto 4.1.3.3). Dal 1° luglio 2023, inoltre, prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico in merito all’impatto sulla concorrenza e alla proporzionalità delle misure da notificare a norma della presente sezione. Gli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero in generale essere concessi mediante una procedura di gara competitiva; deroghe all’obbligo di assegnare gli aiuti mediante una procedura di gara competitiva possono essere giustificate in particolari circostanze: ad esempio quando è dimostrabile che l’offerta potenziale o il numero di potenziali partecipanti sia insufficiente a garantire la concorrenza o qualora i beneficiari siano piccoli progetti (impianti con capacità installata fino a 1 MW).
Con successiva Comunicazione del 9 marzo 2023 ((2023) 1711), la Commissione ha stabilito un quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Il paragrafo 2.5.2 è dedicato specificatamente agli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia. La comunicazione precisa che la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per la promozione delle energie rinnovabili concessi per la produzione di energia sulla base di un regime che prevede una stima della capacità e dei risultati per quanto riguarda il volume e del bilancio fino al 31 dicembre 2025. L’aiuto deve essere concesso sotto forma di contratti per differenza bidirezionali, in relazione alla produzione energetica dell’impianto e con una durata contrattuale non superiore a 20 anni dall’inizio delle attività dell’impianto sovvenzionato. La Commissione, si precisa, considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti per aumentare la capacità massima di generazione degli impianti esistenti, senza effettuare ulteriori investimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
§ l’impianto sia collegato alla rete prima del 1° ottobre 2022 e abbia beneficiato di aiuti approvati dalla Commissione o è stato esentato dall’obbligo di notifica;
§ l’aiuto sia necessario per aumentare la capacità massima degli impianti esistenti, in modo che la loro capacità sia aumentata fino a 1 MW per impianto o equivalente, senza effettuare ulteriori investimenti;
§ gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2023 e il periodo ammissibile al sostegno termini il 31 dicembre 2024;
§ gli aiuti non siano cumulati con altri aiuti concessi a sostegno della stessa capacità supplementare.
Infine, occorre segnalare che il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), come da ultimo modificato con Regolamento 2023/1315/UE, prevede, all’articolo 43, l’esenzione dall’obbligo di notifica per determinati aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta purché:
§ siano concessi agli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia;
§ siano concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari;
§ non siano concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione;
§ l’importo dell’aiuto per unità di energia non superi la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione, aggiornati almeno a cadenza annuale, e il prezzo di mercato della forma di energia interessata;
§ il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non supera il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base;
§ siano concessi solo fino al completo ammortamento dell’impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati.
Per un approfondimento, si rinvia al dossier su “Gli aiuti di Stato”, parte generale e parte speciale.
Si valuti il contenuto delle misure di cui ai commi 1 e 2 alla luce della disciplina europea sopra illustrata.
Il comma 3, infine, modifica le disposizioni transitorie e finali del D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale. In particolare, le modifiche riguardano l’articolo 298, comma 2-ter del suddetto decreto, che prevede l’adozione di un decreto ministeriale volto a istituire nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l’esame delle proposte presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni di integrazione ed aggiornamento dell’Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, recante disciplina dei combustibili (cd Commissione combustibili).
Il citato allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006:
§ elenca i combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti che producono emissioni in atmosfera (Parte I, Sezioni 1 e 2);
§ contiene disposizioni specifiche per alcune tipologie di combustibili liquidi (Parte I, Sezione 3);
§ stabilisce i valori di emissione equivalenti per i metodi di riduzione delle emissioni (Parte I, Sezione 4);
§ indica i criteri per l’utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni (Parte I, Sezione 5);
§ contiene il fac-simile del Rapporto di indisponibilità di combustibile a norma, da comunicare ai sensi dell’articolo 296, comma 10-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (Parte I, Sezione 6);
§ indica le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo dei combustibili liquidi (Parte II, Sezione 1), dei combustibili solidi (Parte II, Sezione 2), delle emulsioni acqua-gas, acqua-kerosene e acqua-olio combustibile (Parte II, Sezione 3), delle biomasse combustibili (Parte II, Sezione 4), degli idrocarburi (Parte II, Sezione 5), del biogas (Parte II, Sezione 6);
§ stabilisce le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del CSS-combustibile (Parte II, Sezione 7).
Dette modifiche sono volte a:
§ precisare che il decreto è adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (nuova denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio), di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; non è più previsto, quindi, il concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro delle imprese e del made in Italy (lettera a));
§ modificare la composizione della Commissione, che sarà formata da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri; non è più prevista, quindi, la partecipazione di due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy (lettera b));
§ precisare, laddove ora la norma prevede che i componenti della Commissione non siano dovuti compensi, né rimborsi di spese, che ai medesimi non siano dovuti neppure gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati (lettera b)).
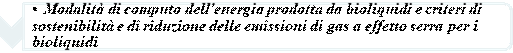
L’articolo 40 del D.Lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, reca norme specifiche per i biocarburanti e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere. In particolare, dispone che, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di raggiungimento di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo del 30 per cento su base nazionale al 2030 (art. 3 del D.Lgs. n. 199/2021) e del soddisfacimento dell’obbligo in capo ai fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento:
a) la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa consumati nei trasporti, quando prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non deve superare più di un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale di energia nei settori stradali e ferroviario nel 2020;
b) la quota dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, che sono qualificati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni con atto delegato della Commissione europea, e per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019. Rinvia ad un decreto del Ministero della transizione ecologica, l’individuazione della traiettoria di decrescita lineare di tale limite fino ad azzerarsi entro il 31 dicembre 2030. Il limite non si applica con riferimento ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa certificati a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni in conformità al relativo atto delegato della Commissione europea;
c) a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025 non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (termine da ultimo modificato dall’articolo 7-bis, comma 1 del D.L. n. 132/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 170/2023, alla cui scheda si rinvia).
L’articolo 42 detta i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Stabilisce, in particolare, che al fine di contribuire agli obiettivi di conseguimento, da parte dei fornitori di carburanti, della quota del 16% al 2030 di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento, nonché per beneficiare di regimi di sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, indipendente dall’origine geografica della biomassa, sono presi in considerazione de rispettano determinati criteri di sostenibili, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica.
Con specifico riferimento ai bioliquidi impiegati per la produzione di energia elettrica, l’articolo 42 del D.Lgs. n. 199/2021 stabilisce i seguenti criteri.
Criteri di sostenibilità:
§ nel caso di bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione ecologica, su proposta dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (si veda, in proposito, le linee guida adottate con Decreto Direttoriale 22 febbraio 2023). Le informazioni relative al rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono comunicate a ISPRA;
§ i bioliquidi provenienti dall’agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente, si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato dette situazioni:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e nei quali i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;
b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall’autorità competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;
c) aree designate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con la finalità di protezione della natura:
1. per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall’autorità competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate; nel caso di materie prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357;
2. per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento da parte della Commissione europea;
d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati dalla Commissione europea, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità aventi un’estensione superiore a un ettaro, ossia:
1. terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o
2. terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall’autorità competente del paese in cui la materia prima è stata coltivata a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.
e) I bioliquidi provenienti dall’agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel frattempo persi:
1. zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell’anno;
2. zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
3. terreni aventi un’estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che l’uso di bioliquidi assicura una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 70 per cento per l’energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all’80 per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026
§ I bioliquidi provenienti dall’agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.
Criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: a decorrere dall’adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i bioliquidi ottenuti da biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry - LULUCF):
f) il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell’accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e:
1. ha presentato, nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution -NDC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC; oppure
2. dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;
g) se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine.
Criteri di efficienza energetica:
§ un impianto è considerato in esercizio quando sono state avviate la produzione fisica dei bioliquidi;
§ Gli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l’utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, solo se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei quali non costituisce condizione per accedere a eventuali regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021:
h) l’energia elettrica è prodotta in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
i) l’energia elettrica è prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento, oppure è prodotta da impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai livelli netti di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) così come definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione;
j) l’energia elettrica è prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento o da impianti che producono solo energia elettrica e che raggiungono un’efficienza energetica netta almeno pari al 36%;
k) l’energia elettrica è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa
Articolo 5, comma 3-bis
(Incentivi agli impianti alimentati da biomasse)
L’articolo 5, comma 3-bis – inserito in sede referente – interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.
Il comma 3-bis in esame dispone che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
Il comma 3-bis, inserito in sede referente, dispone che il riferimento agli impianti alimentati a biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del D.lgs. n. 28/2011, come modificato dall'articolo 3-ter del D.L. n. 57/2023 (L. n. 174/2023), comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA ai sensi del citato articolo 24, comma 8, del D.lgs. n. 28/2011, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
L’articolo 3-ter, del D.L. n. 57/2023 ha sostituito l’articolo 24, comma 8 del D.lgs. n. 28/2011, prevedendo la definizione, da parte dell’ARERA, di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi. Sono indicati i seguenti criteri per la definizione di prezzi minimi garantiti o delle integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico:
§ i prezzi minimi garantiti, o le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e un funzionamento efficiente dell'impianto;
§ i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;
§ gli impianti rispettano i requisiti di sostenibilità cui all'articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021;
§ il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi sull'utilizzo energetico delle stesse.
Articolo 5, commi da 3-ter a 3-quinquies
(Misure per la promozione del biometano)
L’articolo 5, al comma 3-ter, inserito in sede referente, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.
Il comma 3-quater – inserito in sede referente – dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal TU delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. n. 504/1995), si applichino, nell’ambito di un programma pluriennale previsto dalla direttiva 2003/96/CE(ETD), anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione ha efficacia dalla data del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Il comma 3-quinquies, inserito in sede referente, dispone che Acquirente Unico S.p.A. possa svolgere le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.
L’articolo 5, comma 3-ter, inserito in sede referente, ammette la partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 5 del D.M. 15 settembre 2022 di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale - indette dal GSE a partire dal 2024 - anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti, si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE pubblica nelle sue procedure operative il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per le riconversioni degli impianti alimentati a rifiuti organici ed ogni aggiornamento necessario per la partecipazione di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive.
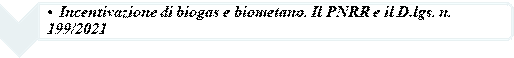
Il PNRR, nella Missione 2, Componente 2, reca l’Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare». L’investimento si pone come obiettivo sostenere gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e per la riconversione, totale o parziale, di impianti esistenti a biogas, inclusa la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani – OFUSW).
Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento Direttiva 2018/2001/UE, all’articolo 11 disciplina gli incentivi materia di biogas e produzione di biometano, prevedendo, per il biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale, un incentivo mediante l'erogazione di una specifica tariffa. Ha demandato ad un decreto del Ministro della transizione ecologica (ora dell’ambiente e della sicurezza energetica)le modalità di attuazione del nuovo sistema incentivante, le condizioni di cumulabilità e le modalità di transizione dal vecchio (D.M. 2 marzo 2018) al nuovo sistema (commi 1 e 2). Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di biometano, che accedono agli incentivi, l’articolo 11 ha previsto che la verifica del rispetto dei requisiti si basi sulle quantità e tipologie dei materiali risultanti dal titolo autorizzativo (cfr. art. 24 del D.Lgs. n. 199). In ogni caso, devono essere rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni calcolati sull'intero mix dei materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano (D.M. 14 novembre 2019), in attuazione del Titolo V del D.Lgs. n. 199/2021 (articoli da 42 a 44), che reca la disciplina dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.
Quanto all’attuazione del succitato Investimento M1C2 I 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare» del PNRR, l'articolo 14 comma 1, lettera b), del medesimo D.Lgs. n. 199/2021, ha previsto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica (ora ambiente e sicurezza energetica) fossero definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano. Al decreto è stata demandata la definizione delle condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e il raccordo del regime incentivante con quello già previsto dal D.M. 2 marzo 2018.
In attuazione dell’articolo 11 e dell’articolo 14, co. 1, lett. b) è stato adottato Decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022. Il D.Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 ha definito le regole applicative (qui gli allegati e le appendici alle regole applicative). A marzo 2023 è stato chiuso l’accordo tra MASE e GSE per la realizzazione dell’investimento.
Il Decreto 15 settembre 2022 riconosce un contributo in conto capitale (calcolato in funzione delle spese ammissibili ed equivalente al massimo al 40% dell’investimento sostenuto) e una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano. I requisiti di accesso agli incentivi devono risultare rispettati al fine di partecipare alle procedure competitive pubbliche, indette ai sensi dell’articolo 5 del DM, e ottenere il diritto al riconoscimento degli incentivi previsti (come detto, contributo in conto capitale e tariffa incentivante).
Le risorse disponibili in termini di contingenti annui di capacità produttiva, stabilite dall’articolo 5 del DM 2022, sono riportate nella successiva Tabella.
| Nuova costruzione e riconversione di impianti di produzione di biometano (impianti agricoli e impianti a rifiuti organici) |
2022 |
2023 |
2024 |
Totale |
| Contingenti annui di capacità produttiva [Smc/h] |
67.000 |
95.000 |
95.000 |
257.000 |
|
Ai sensi delle regole applicative, sono previsti 5 bandi per la partecipazione alle procedure competitive, con le tempistiche di seguito riportate in Tabella. Per ciascuna procedura e per tutte le tipologie di impianti viene assegnato un unico contingente di capacità produttiva. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli interventi, sono previste specifiche modalità di riallocazione della quota dei contingenti non assegnati.
| Nr. Procedura |
Apertura procedura |
Chiusura procedura |
Limite pubblicazione graduatoria |
Contingente disponibile [Smc/h] |
| 1 |
30/01/2023 |
31/03/2023 |
29/06/2023 |
67.000 |
| 2 |
14/07/2023 |
12/09/2023 |
11/12/2023 |
71.250 |
| 3 |
22/12/2023 |
20/02/2024 |
20/05/2024 |
23.750 |
| 4 |
3/06/2024 |
2/08/2024 |
31/10/2024 |
71.250 |
| 5 |
18/11/2024 |
17/1/2025 |
17/04/2025 |
23.750 |
| TOTALE |
|
|
|
257.000 |
Nel caso in cui il contingente totale di capacità produttiva disponibile non sia esaurito con la quinta procedura, il D.M. 15 settembre 2022 prevede la possibilità di apertura di nuove procedure fino all'esaurimento delle risorse disponibili (in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2026).
L’allegato 2 del D.M. 15 settembre 2022 riporta, nella seguente Tabella, le tariffe di riferimento per gli interventi di realizzazione di impianti di nuova realizzazione e impianti agricoli riconvertiti.
| Tipologia impianti di produzione del biometano |
Capacità produttiva biometano (Cp) |
Tariffa di riferimento [Euro/MWh] |
| Nuovi impianti agricoli e alimentati da rifiuti organici e riconversioni solo per impianti agricoli |
| Impianti agricoli di piccole dimensioni |
Cp? 100 Smc/h |
115 |
| Altri impianti agricoli |
>100 Smc/h |
110 |
| Impianti alimentati da rifiuti organici |
Qualsiasi |
62 |
Avvisi e bandi
· Bando n. 1 pubblicato il 7 febbraio 2023, chiuso il 31 marzo 2023. Graduatoria pubblicata il 10 luglio. Ammesse 60 richieste su 72, per una capacità produttiva di 29.977,7 Smc/h.
· Bando n. 2 pubblicato il 20 luglio 2023, chiuso il 12 settembre 2023. Graduatoria pubblicata il 24 novembre 2023, con gli impianti ammessi ed esclusi. Sono 51 i progetti di impianti di produzione, nuovi o riconvertiti, ammessi a finanziamento, per una capacità produttiva totale pari a 25.881 Smc/h (qui comunicato stampa MASE).
Si rinvia anche al D.M. 14 luglio 2023 sulle garanzie di origine per la produzione di biometano.
Per quanto riguarda il decreto relativo alla promozione di pratiche ecologiche nelle fasi di produzione del biometano, lo schema è stato finalizzato dalle strutture istituzionalmente competenti del MASE e trasmesso alla DG Concorrenza secondo le procedure previste per il regime di esenzione ABER.
Il comma 3-quater – inserito in sede referente – interviene sull’articolo 3-quinquies del D.L. n. 57/2023 (L. n. 95/2023), recante misure per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi, aggiungendovi due nuovi commi 2-bis e 2-ter.
Ai sensi del comma 2-bis, le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal TU delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. n. 504/1995), si applicano, nell’ambito di un programma pluriennale previsto dall’articolo 16, della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione in esame ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.
La Direttiva 2003/96/CE (ETD) definisce il quadro europeo per la tassazione dell’energia elettrica e dei prodotti energetici utilizzati per il settore dei trasporti e del riscaldamento, introducendo livelli minimi di armonizzazione della di tassazione per gli SM e prevendendo la possibilità per questi ultimi di definire ambiti di esenzione e agevolazioni. La direttiva 2003/96/CE ha ampliato l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, insieme in precedenza formato dai soli “olî minerali”. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l’elettricità.
L’articolo 16 della Direttiva dispone che le esenzioni o le riduzioni per i prodotti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 16 possono essere concesse, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico per più di un anno civile. La durata dell'esenzione o della riduzione così autorizzata non può superare sei anni consecutivi. Questo periodo è eventualmente rinnovabile.
Ai sensi del comma 2-ter, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al citato comma 2-bis.
Il comma 3-quinquies inserito in sede referente, integra l’articolo 62-bis del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020) con un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale Acquirente Unico S.p.A. può svolgere anche le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente comma, prevedendo l’obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.
L’articolo 62-bis del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020) ha modificato la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante la “Disciplina delle bombole per metano”. L’articolo ha attribuito ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla citata legge n. 640 del 1950, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti. In attuazione, sono stati adottati il D.M. 30 settembre 2021, che ha disciplinato le modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione, e il Decreto 28 settembre 2022, che ha stabilito gli indirizzi in base ai quali Acquirente Unico S.p.A. esercita le suddette attività.
Inoltre, base all’articolo 62-bis, Acquirente Unico S.p.A. ha acquisito la Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM»), dal 1 gennaio 2023. L’articolo 62-bis ha disposto la ridefinizione del contributo a carico dei proprietari delle bombole di metano, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della acquisita SFBM.
Articolo 5-bis
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)
Il presente articolo, inserito nel corso dell’esame in sede referente, introduce delle modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso.
In particolare il comma 1 del presente articolo introduce un periodo finale all’articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di produzione di biometano.
La nuova disposizione statuisce che per gli impianti di produzione di biometano che usufruiscono degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere introdotto nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura nel settore trasporti, il Gestore Servizi Energetici (di seguito: GSE) annulla le garanzie originarie in favore dei clienti finali con cui il produttore ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti.
Il comma 2 dispone che, per uniformare le metodologie di calcolo dei Certificati di Immissione in Consumo (di seguito: CIC) da parte del GSE, a partire dal 2024, sarà utilizzato, quale parametro, il potere calorifico superiore del biometano prodotto.
Il comma 3 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, con l’espressione “ritardi nella conclusione dei lavori relativi all’impianto per ragioni non imputabili al produttore” ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 5 agosto 2022, si intendono anche quelli relativi all’attivazione da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale, ovvero nell’effettuazione di verifiche o attestazioni da parte delle autorità ed enti di controllo. Allo stesso modo, le stesse precisazioni valgono anche per gli impianti patrocinati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022.
Articolo 6
(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)
L’articolo 6, comma 1, prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o, come aggiunge un’integrazione al testo approvata nel corso dell’esame in sede referente, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di pre-screening; analogamente, ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all’autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione (comma 2). I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all’interno della medesima centrale termoelettrica (comma 3).
L’articolo 6 reca semplificazioni amministrative ai fini della realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o, come aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti.
La relazione illustrativa osserva che le norma mira a preservare i livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale e, in particolare, la continuità nella produzione energetica, messa ormai sempre più frequentemente a rischio dalle situazioni di carenza della risorsa idrica in casi di siccità nonché dalle situazioni in cui, a causa delle elevate temperature, risulta più difficoltoso utilizzare la medesima risorsa idrica per il raffreddamento degli impianti rispettando i limiti di temperatura allo scarico. Al fine di risolvere tali problematiche, si ritiene indispensabile dotare le centrali a valore di sistemi di raffreddamento alternativi in grado di evitare o ridurre al minimo in consumo di acqua. Si tratta, in particolare, di realizzare condensatori ad aria in grado di risparmiare ingenti quantità di acqua di raffreddamento evitandone il prelievo dal mare o da acque interne.
L’articolo 6, comma 1, in particolare, prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o, come aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del D.L. n. 7/2002. Detti interventi, pertanto, sono subordinati alla comunicazione preventiva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da effettuare almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori, anziché all’autorizzazione unica del medesimo ministero cui sono sottoposte le modifiche sostanziali.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 2-bis del D.L. n. 7/2002 qualifica come interventi di modifica sostanziale di impianto esistente, subordinati all’autorizzazione unica del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Dispone, quindi, che tutti gli altri interventi costituiscano modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e che la loro esecuzione sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento. Fa, in ogni caso, salvo il pagamento del contributo a copertura delle spese istruttorie previsto all’articolo 1, comma 110, della legge n. 239/2004.
La relazione illustrativa osserva che il comma 1 semplifica e accelera le procedure autorizzative per la sostituzione funzionale del sistema di raffreddamento in uso nelle centrali termoelettriche consentendo, tramite una semplificazione autorizzatoria, la realizzazione di sistemi alternativi o integrativi di raffreddamento tramite l’installazione di sistemi di condensazione ad aria. In particolare, poiché la realizzazione di tali sistemi ha natura di modifica non sostanziale, in quanto conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 2-bis del D.L. n. 7/2002, (non producendo, quindi, impatti significativi e negativi sull’ambiente e non comportando, al contempo, una variazione positiva della potenza elettrica), si prevede che essa sia soggetta al procedimento semplificato disciplinato dal medesimo articolo 1, comma 2-bis del D.L. n. 7/2002.
Il comma 2 prevede che, per i medesimi interventi, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, abbia la facoltà di richiedere, ai sensi dell’articolo 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006, all'autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare (cd pre-screening VIA). L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura di valutazione ambientale. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.
Con riguardo all’autorizzazione integrata ambientale, si applica l’articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale il gestore comunica le modifiche progettate dell’impianto all’autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Qualora le modifiche progettate siano considerate sostanziali ai fini delle applicazioni delle disposizioni in materia di AIA, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
Il comma 3 prevede, sempre con riguardo alla realizzazione nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW di sistemi di condensazione ad aria o, come aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, che detti interventi non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all’interno della medesima centrale termoelettrica. A tal fine, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro della cultura, unitamente alla comunicazione preventiva per l’avvio dei lavori, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l’assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.
Si rammenta che, di norma, invece, le modifiche non sostanziali ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 7/2002 sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica, ove necessario.
Il comma 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione dell’articolo in commento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Articolo 7
(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2)
L’articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in esame l'urgenza delle misure proposte deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "Hard To Abate" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.
In particolare, al comma 1, lettera a), viene inserita, all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 162 del 2011, la lettera a-bis), che reca la definizione dei programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, individuati come stoccaggio geologico che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.
La lettera b), numero 1), dello stesso comma 1 chiarisce che, anche in mancanza del piano aree di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 162 del 2011, idonee allo stoccaggio geologico di CO2 nei giacimenti di idrocarburi esauriti off-shore, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per questa tipologia di siti, possa rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 secondo il quadro normativo di riferimento del sopra richiamato decreto legislativo n. 162 del 2011.
Il numero 2) della medesima lettera b), invece, chiarisce che sono soggette a conferma solo le autorizzazioni rilasciate nelle more dell'adozione del Piano delle aree, mentre il numero 3) della medesima lettera b) modifica l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 162 del 2011, affiancando alle autorizzazioni allo stoccaggio, anche le autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2, per chiarire che qualora queste ultime siano rilasciate in aree già interessate da titoli minerari, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica valuta la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in essere.
Il numero 4) della medesima lettera b), precisa che le relative previsioni si applicano allo stoccaggio di CO2 anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali. La lettera c), invece, interviene in materia di proroga delle concessioni.
La lettera d) del medesimo comma 1 inserisce gli articoli 11-bis e 11-ter al decreto legislativo n. 162 del 2011 per disciplinare l'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2, prevedendo che le autorizzazioni allo svolgimento di tali programmi sono rilasciate ai soggetti richiedenti, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico, nel cui ambito viene acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali e precisando che, qualora per lo stoccaggio geologico di CO2 in siti idonei off-shore, a fini sperimentali, sia necessario realizzare o utilizzare infrastrutture a terra, la relativa autorizzazione è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
Come per le autorizzazioni allo stoccaggio, i soggetti richiedenti sono tenuti a dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale.
L'autorizzazione per i programmi sperimentali ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un massimo di tre volte, con proroghe di durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione medesima, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa.
Le disposizioni in commento prevedono, inoltre, che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo la gravità delle infrazioni, provveda alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità
Per quanto attiene alla richiesta di autorizzazione, la domanda è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per il medesimo sito idoneo off-shore, una volta presentata istanza di programma sperimentale di stoccaggio, la stessa viene pubblicata e possono essere presentate ulteriori domande sulla stessa area entro 30 giorni dalla data della predetta pubblicazione. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca un'apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e rilascia l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza dei servizi pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi 30 giorni, con contestuale sospensione del termine del procedimento. La regione, ove previsto, rilascia l'intesa nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione che comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l'intesa con la regione interessata nei casi previsti.
In caso di concorrenza, l'autorizzazione al programma sperimentale è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei relativi programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.
La lettera e) apporta modifiche all'art. 12 del d.lgs. 162/2011 prevedendo, al numero 1) che, come per chi ha fatto esplorazione, anche chi ha fatto sperimentazione di stoccaggio, effettuando pertanto investimenti, abbia la precedenza nell'ottenimento dell'autorizzazione finale allo stoccaggio di CO2. Ciò a condizione che abbia portato a termine l'attività sperimentale di stoccaggio e che abbia presentato la domanda di autorizzazione definitiva durante il periodo di svolgimento del programma sperimentale. La domanda di autorizzazione definitiva all'attività di stoccaggio di CO2 può essere pertanto presentata e istruita, con avvio del relativo procedimento, nelle more dello svolgimento del programma sperimentale, mentre l'autorizzazione finale sarà rilasciata, senza concorrenza, a condizione che sia ultimata la sperimentazione.
Il numero 2) della stessa lettera e) abroga il comma 8 del suddetto art. 12, il quale prevede che lo stoccaggio geologico di CO2 per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 12 dell'articolo 16 del medesimo decreto.
La lettera f) abroga il comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 162 del 2011, in materia di stoccaggio "sperimentale" entro il limite di 100.000 tonnellate, dato che lo stesso è assimilato allo stoccaggio che avviene nel programma sperimentale disciplinato in ogni dettaglio dai nuovi art. 11-bis e 11-ter, descritti in precedenza.
La lettera g) modifica l'art. 16 del decreto legislativo n. 162 del 2011. In particolare: al numero 1) si conferma che la procedura di concorrenza non trova applicazione nei casi in cui siano già stati realizzati investimenti funzionali allo sviluppo del sito di stoccaggio, mediante svolgimento pregresso di programmi sperimentali di stoccaggio. Il numero 2) sostituisce il comma 8, eliminando il rimando a successivi decreti e prevedendo che in caso di concorrenza, l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. Il numero 3) abroga il comma 12 in quanto tratta di stoccaggio "sperimentale" sotto la soglia di 100.000 tonnellate assimilabile all'autorizzazione ai programmi sperimentali di stoccaggio disciplinati nel dettaglio dai nuovi articoli 11-bis e 11-ter.
La lettera h) inserisce all'art. 25 del decreto legislativo 162 del 2011 il comma 2-bis, il quale prevede che, nelle more della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo art. 25, l'entità della garanzia finanziaria sia definita in sede di rilascio dell'autorizzazione, secondo specifici criteri definiti dalla norma.
La lettera i) inserisce all'art. 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011 il comma 2-bis, il quale prevede che nelle more dell'efficacia del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo art. 27, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché di quelle svolte dagli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, di autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o di autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo non superiore all'uno per mille del valore delle opere da realizzare.
La lettera l) apporta modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 162 del 2011; in particolare, il numero 1) inserisce al comma 1, dopo le parole "geologico di CO2" le parole ", anche nell'ambito di programmi sperimentali" e il numero 2) abroga il comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la definizione dei contenuti e delle modalità di diffusione delle informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2.
Il comma 2 dispone che le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 3 stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico: a) ad effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia; b) ad elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2; c) ad elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio; d) ad effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza; e) ad individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali hard to abate e termoelettrico; f) a definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2.
Il comma 4 dispone che il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 della disposizione in esame.
A seguito di una modifica approvata durante l’esame in sede referente, dopo il comma 4 è stato aggiunto un ulteriore comma (4-bis) in base al quale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui al decreto legislativo n. 162 del 2011.
La disposizione in esame prevede inoltre che per l’adozione della regola tecnica sopra menzionata, nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell’ambiente della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici e del Comitato italiano gas (CIG), tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisica del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale
Il comma 5 apporta modifiche all'articolo 52-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, precisando che per infrastrutture lineari energetiche si intendono altresì le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio.
Articolo 8, commi 1 e 2
(Misure per lo sviluppo della filiera agli impianti eolici galleggianti in mare)
L’articolo 8, nel testo modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
L’articolo 8 reca disposizioni finalizzate al raggiungimento dell’autonomia energetica nazionale e di sostegno agli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
La relazione illustrativa precisa che l’articolo 8 reca disposizioni funzionali a creare il sostrato idoneo allo sviluppo di una filiera che conduca alla realizzazione e all’esercizio di impianti eolici flottanti in mare, promuovendo specifici investimenti nel Mezzogiorno d’Italia.
A tal fine, il comma 1 prevede la pubblicazione, entro il 9 gennaio 2024, da parte del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale o, come prevede un’integrazione al testo approvata nel corso dell’esame in sede referente, in aree portuali limitrofe ad aree in phase out dal carbone, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee, da destinare, attraverso gli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
Si segnala che il testo originario del decreto-legge prevedeva l’individuazione di due porti (anziché “almeno” due porti) del Mezzogiorno di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale per l’eolico off-shore.
L’articolo 6 della legge n. 84/1994 di riordino della legislazione in materia portuale, richiamato dal comma 1, istituisce quindici Autorità di sistema portuale. I porti rientranti nelle Autorità di sistema portuale sono indicati nell’Allegato A alla medesima legge.
Si osserva che l’articolo 18, comma 1, della medesima legge n. 84/1994 prevede che l’Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l’autorità marittima diano in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Il secondo periodo del comma 1, richiamato dal comma 1 dell’articolo 8 in commento, prevede che siano altresì sottoposte a concessione la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch’essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
Le manifestazioni di interesse sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente (come prevede un’integrazione al testo approvata nel corso dell’esame in sede referente), sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti la sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.
Il comma 2 prevede, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l’individuazione con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
Il suddetto decreto individua anche:
§ gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi, nonché
§ le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica allegata al decreto-legge evidenzia che l’articolo 8 si pone in conformità alla Strategia europea per le energie rinnovabili off-shore (vedasi la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su una strategia per le energie innovabili offshore), nella quale è stato posto in evidenza che “gli Stati membri meridionali dell’UE che si affacciano sul Mediterraneo hanno un elevato potenziale per l’energia eolica prodotta prevalentemente da turbine galleggianti”.
Articolo 8, comma 2-bis
(Avvalimento della Guardia costiera)
L’art. 8, comma 2-bis, prevede che il MASE si avvalga del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nelle attività connesse allo sviluppo delle piattaforme galleggianti per l’energia eolica in mare.
Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera in sede di conversione, si aggiunge all’art. 8 (v. supra, l’apposita scheda) e prevede che – il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) si avvalga del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per le seguenti attività:
- regolamentazione dei movimenti delle unità in mare;
- controllo del rispetto delle regole ambientali;
- vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti.
Articolo 8, comma 2-ter
(Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021)
L’articolo 8, comma 2-ter, introdotto nel corso dell’esame da parte della Commissioni riunite, modifica il comma 6 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 199/2021.
In particolare il comma in esame introduce modifiche all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021 statuendo che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta, rendendolo pubblico sul proprio sito web, un vademecum per i soggetti proponenti dei progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con gli adempimenti e le informazioni minime necessarie ai fini dell’avvio del procedimento unico.
A tale riguardo si ricorda che l’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo de quo (Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee) riguarda le procedure autorizzative che devono essere eseguite affinché possa essere ritualmente presentato un progetto per impianti off-shore per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Articolo 9, commi da 1 a 4
(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica – portale digitale degli interventi di sviluppo e delle connessioni alla RTN)
L’articolo 9 dispone e disciplina, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all’Arera, alle regioni e provincie autonome e, aggiunge una modifica approvata in sede referente, agli operatori interessati, l’accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.
L’articolo 9, comma 1 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 7 giugno 2024), Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisca un Portale digitale dove sono riportati:
a) i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna.
L’articolo 9, comma 1, quindi, prevede l’obbligo per Terna di realizzare il suddetto portale digitale e redigere relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete di trasmissione nazionale.
La norma è finalizzata a garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia.
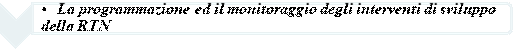
Attualmente, dati e informazioni in merito agli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e alle richieste di connessione sono reperibili nel Piano di sviluppo che Terna è tenuta a predisporre ogni due anni ai sensi dell’articolo 36, comma 12 del D.Lgs. n. 93/2011, come recentemente modificato dall’articolo 1 della legge n. 214/2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). Detto piano, infatti, individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica attribuita a Terna S.p.A..
L’articolo 36, comma 12, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 93/11 prevede inoltre la presentazione, ogni anno, da parte di Terna S.p.A., al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA di un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti piani.
Altre norme di rango primario in materia di programmazione degli interventi di sviluppo della RTN sono contenute all’articolo 17 del D.lgs. n. 28/2011, laddove prevede, ai commi 1 e 2 l’individuazione in apposite sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale:
§ degli interventi di realizzazione di opere di sviluppo funzionali all’immissione e al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione;
§ degli interventi di potenziamento della rete che risultano necessari per assicurare l’immissione e il ritiro integrale dell’energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile già in esercizio.
La convenzione annessa alla Concessione rilasciata a Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, da ultimo aggiornata con D.M. 15 dicembre 2010, all’articolo 9 precisa ulteriormente i contenuti che il piano di sviluppo, predisposto nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, deve contenere:
a) un’analisi costi-benefici degli interventi e l’individuazione degli interventi prioritari, in quanto in grado di dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l’estero e alla riduzione delle congestioni;
b) l’indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell’impegno economico preventivato;
c) una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell’anno precedente con l’indicazione delle cause delle mancate realizzazioni o dei ritardi, dei tempi effettivi di realizzazione e dell’impegno economico sostenuto;
d) un impegno della Concessionaria a conseguire un piano minimo di realizzazioni nel periodo di riferimento, con indicatori specifici di risultato, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle congestioni;
e) un’apposita sezione relativa alle infrastrutture di rete per lo sviluppo delle fonti rinnovabili volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali con il massimo sfruttamento della potenza installata, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema elettrico.
L’articolo 17 della Convenzione annessa alla concessione impone, poi, a Terna l’obbligo di fornire al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dietro sua richiesta, le informazioni e quant’altro il Ministero ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.
Il comma 2 prevede l’accesso al Portale da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché, come prevede un’integrazione al testo approvata nel corso dell’esame in sede referente, degli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.
Il comma 3 affida la gestione e l’aggiornamento del Portale a Terna S.p.A.
Il comma 4, infine, affida all’ARERA il compito, su proposta di Terna S.p.A., di disciplinare le modalità di funzionamento del Portale e la copertura dei costi sostenuti per le attività di realizzazione, gestione e aggiornamento del medesimo portale.
Si rammenta, a tal proposito, che i servizi di rete sono attualmente remunerati attraverso il meccanismo tariffario. La tariffa TRAS, in particolare, applicata a tutti i clienti finali, ad eccezione delle utenze domestiche in bassa tensione, copre i costi per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale.
La stessa autorità è chiamata, in base ad un’integrazione al testo approvata nel corso dell’esame in sede referente, a definire altresì le modalità di accesso ai contenuti del Portale da parte dei soggetti abilitati.
Articolo 9, commi da 5 a 9-quater
(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica – semplificazioni per le opere sulle reti distribuzione e di connessione di queste alla RTN)
L’articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi, siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici. Una modifica approvata in sede referente prevede che non sia richiesta la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica preventiva archeologica, nei casi in cui la denuncia di inizio lavori (DIL) sia corredata dall’asseverazione da parte di che l’esecuzione dei lavori non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti né mutamenti nell’aspetto esteriore dei luoghi.
Ove non sussistano le condizioni per sottoporre le opere a DIL, i suddetti interventi sono sottoposti ad un’autorizzazione unica, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi. L’istanza di autorizzazione unica si intende comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
I commi da 9-bis a 9-quater, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, prevedono la possibilità di autorizzare con il medesimo procedimento previsto per la costruzione e l’esercizio delle cabine primarie della rete di distribuzione possono essere autorizzate, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, purché abbiano una tensione non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato.
L’articolo 9, comma 5, prevede l’applicazione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, di una disciplina autorizzatoria semplificata (disposta ai commi successivi) per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti di rafforzamento delle smart grid finanziati nell’ambito del PNRR (vedi box infra), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi. Ciò, si precisa, al fine di conseguire gli obiettivi di smartizzazione delle infrastrutture di rete del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
È comunque fatta salva l’applicazione di regimi più favorevoli eventualmente previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale.
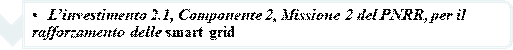
L’investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, infatti, stanzia 3,61 miliardi di euro per il rafforzamento delle smart grid. L’obiettivo della misura è digitalizzare le infrastrutture di rete, per abilitare e accogliere l’aumento ad almeno 4.000 MW di produzione da fonti rinnovabili, convertire all’elettrificazione dei consumi almeno 1.500.000 utenti (es. mobilità elettrica, riscaldamento con pompe di calore) e aprire nuovi scenari in cui potranno avere un ruolo anche i prosumer, i consumatori-produttori di energia. Gli interventi saranno attuati per circa il 40% nelle regioni del Sud Italia (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia) e contribuiranno ad aumentare la coesione sociale ed economica del Paese.
Sono destinatari della misura gli operatori del sistema di distribuzione - DSO. La misura prevede come obiettivo ultimo l’elettrificazione dei consumi di almeno 1,5 milioni di abitanti e, come obiettivi intermedi: l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per incrementare la capacità di rete entro fine 2022, l’aumento di almeno 1.000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile entro la fine del 2024 e di almeno 4.000 MW entro il 30 giugno 2026.
Ai fini dell’attuazione della misura, è stato adottato il D.M. n. 146/2022, recante i “Criteri e le modalità per la realizzazione dell’investimento M2C2 – I 2.1”. Il decreto destina i 3,61 miliardi dell’investimento ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione die energia elettrica sull’intero territorio nazionale, sotto forma di contributo a fondo perduto al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software.
Il 22 giugno 2022, sul sito del Ministero è stato pubblicato l’avviso pubblico n. 119/2022 per la presentazione di proposte progettuali di costruzione, adeguamento, e potenziamento di infrastrutture per le reti intelligenti (smart grid).
A fronte di una dotazione finanziaria di 3,61 miliardi euro sono stati presentati dai concessionari della rete elettrica di distribuzione 27 progetti per un importo complessivo di circa 4 miliardi di euro.
Il 14 novembre 2022 è stato pubblicato dal Ministero il decreto direttoriale n. 274 di nomina della Commissione di valutazione.
Il 23 dicembre 2022 è stato adottato il Decreto Direttoriale n. 426 della Direzione Generale Incentivi Energia di approvazione degli elenchi dei 22 progetti ammessi al Bando smart grid.
Nello specifico, il comma 6 subordina, di norma, la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui di cui sopra alla semplice presentazione di una denuncia di inizio lavori (DIL) alle regioni o alle province autonome almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Il ricorso alla DIL è ammesso a condizione che sia acquisito il consenso dei proprietari delle aree interessate e che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria. Dalla lettura del testo, si evince che una terza condizione è rappresentata dalla compatibilità urbanistica delle opere.
La DIL, infatti, deve essere corredata dal progetto definitivo e da una relazione attestante, oltre all’assenza di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria, anche la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti. La relazione, inoltre, deve attestare il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
Un’integrazione approvata nel corso dell’esame in sede referente prevede che non sia richiesta la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica preventiva archeologica, indicata all’articolo 1, comma 2 dell’Allegato I.8 al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2003), nei casi in cui la denuncia di inizio lavori (DIL) sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata, redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l’esecuzione dei lavori non comporti:
- nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o
- mutamento nell’aspetto esteriore dei luoghi.
Il citato articolo 1, comma 2 dell’Allegato I.8 del Codice di contratti pubblici prevede, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione del codice, la trasmissione al soprintendente territorialmente competente, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, prima dell'approvazione, di copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione, ove richiesta, è raccolta ed elaborata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.
Si osserva che articolo 1, comma 2 del citato allegato I.8 già prevede che la trasmissione della documentazione suindicata non sia richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
Le modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente, inoltre, fanno comunque salva la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, relativa alle scoperte fortuite, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
La norma fa espresso riferimento all’articolo 90 e seguenti e all’articolo 28, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
L’articolo 90 prevede che chi scopra fortuitamente cose immobili o mobili configurabili come beni culturali ai sensi dell’articolo 10 del codice debba denunciarlo entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla loro conservazione temporanea.
Ai sensi dell’articolo 91, le cose configurabili come beni culturali, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato. Il successivo articolo 92 prevede, tuttavia, il riconoscimento di un premio, non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento, al concessionario dell’attività di ricerca e allo scopritore fortuito.
L’articolo 28, comma 2, infine, dà al soprintendente la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose configurabili come beni culturali ai sensi dell’articolo 10 del codice.
Il comma 7, a complemento di quanto previsto al comma 6, disciplina i casi in cui non siano soddisfatte una o più condizioni che consentono altrimenti il ricorso a DIL. Riguarda, quindi, le ipotesi in cui:
§ sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero
§ occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità (propedeutica, si rammenta, all’adozione di un decreto di esproprio, che si rende necessario nei casi in cui non sia stato acquisto il consenso del proprietario alla cessione dell’area interessata o alla costituzione su di essa di una servitù) ovvero
§ occorra l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti.
In tali casi, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti di rafforzamento delle smart grid finanziati nell’ambito del PNRR (vedi box supra), nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi, avviene a seguito del rilascio di un’autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale, ma nel rispetto di alcuni principi comuni stabiliti dal medesimo comma 7, ossia:
§ il ricorso alla conferenza di servizi semplificata, in modalità asincrona;
Ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990, invece, l’amministrazione procedente ha la facoltà di convocare direttamente la conferenza di servizi simultanea se lo ritiene necessario in ragione della particolare complessità della determinazione da assumere. L’articolo 9 comma 5, in esame, prevede, analogamente a quando già disposto dall’articolo 14-bis, comma 1, un termine di dieci giorni per l’avvio della conferenza di servizi.
§ l’obbligo per le amministrazioni coinvolte di rilasciare le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, fatto salvo il rispetto della normativa eurounitaria;
Ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, let. c), invece, il termine è stabilito dall’amministrazione procedente e non può essere superiore a quarantacinque giorni o a novanta giorni, se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini. L’articolo 9, comma 7, lettera a) del decreto-legge in esame prevede che, decorso il termine di trenta giorni senza che l’amministrazione si sia espressa, la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni. Ad ogni modo, l’articolo 14-bis, comma 4 della legge n. 241/1990 già prevede che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivalga ad assenso senza condizioni.
§ qualora l’amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso con condizioni e prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, la convocazione entro i successivi quindici giorni di una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, per procedere, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all’adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
L’articolo 14, comma 5 della legge n. 241, applicabile anche ai progetti compresi nell’ambito di applicazione della norma in commento, prevede l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato o recanti condizioni e prescrizioni che possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Nel caso sia stato acquisito uno o più atti di dissenso che si ritiene non superabili, l’amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza.
Fuori dei casi di cui sopra, si applica – di norma – il successivo comma 6, che prevede lo svolgimento di una riunione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona, da tenersi (la data è indicata già al momento dell’indizione della conferenza di servizi) entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l’espressione delle determinazioni nell’ambito della conferenza di servizi semplificata. L’articolo 14-ter, nel disciplinare dettagliatamente lo svolgimento della conferenza di servizi simultanea, prevede sia svolta “ove possibile” anche in via telematica e indica in quarantacinque giorni o, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, novanta giorni.
Pertanto, rispetto alla disciplina generale prevista dalla legge n. 241/1990, a fronte di un lieve differimento del termine per la convocazione della riunione in forma simultanea e in modalità sincrona, la norma in commento si differenzia prevedendo come necessaria la modalità telematica di svolgimento della riunione e riducendo da novanta (o quarantacinque) a dieci giorni il termine per l’adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi qualora si renda necessario lo svolgimento di una riunione in forma simultanea.
Il comma 8 prevede che l’istanza di autorizzazione unica si intenda comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
In tal caso, l’amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla sua richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nei casi, invece, di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi dopo dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, il Presidente della regione, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta.
Si osserva che il primo periodo disciplina i casi in cui, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, prevedendo come conseguenza il suo accoglimento. Il quarto periodo, invece, fa riferimento ai casi in cui non sia stata adottata una determinazione conclusiva della conferenza di servizi entro dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Nei casi in cui sia un’amministrazione diversa da quelle preposte alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ad esprimere un dissenso congruamente motivato, parrebbero applicabili sia il primo che il quarto periodo, giacché il quarto periodo non riguarda solo il caso in cui sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Il comma 9 prevede che, su richiesta del soggetto interessato, le disposizioni di semplificazione in commento possano applicarsi anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 10 dicembre 2023.
Il comma 9-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l’esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all’amministrazione procedente di un’istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se trattasi di linee aeree, o a venti chilometri, se trattasi di linee in cavo interrato.
Si valuti l’opportunità di precisare se dette opere possono consistere anche in interventi sulle stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale.
Il comma 9-bis dispone, inoltre, che dette opere di connessione siano individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale che predispone ogni due anni, o siano previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.
Il comma 9-ter prevede che, in caso di procedimento autorizzatorio congiunto, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, siano di competenza regionale.
Il comma 9-quater dispone il rilascio dell’autorizzazione sia a favore del gestore della rete di distribuzione, sia a favore del gestore della rete di trasmissione, per le rispettive opere di competenza.
Il rilascio dell’autorizzazione:
- costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, in conformità al progetto approvato,
- comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione per pubblica utilità e,
- in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante urbanistico.
Articolo 9, commi da 9-quinquies a 9-undecies
(Semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili)
L’articolo 9, commi da 9-quinquies a 9-undecies prevedono misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 9-quinquies proroga fino al 30 giugno 2025 l’efficacia delle semplificazioni previste dall’articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023 che esentano dallo svolgimento della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA taluni impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aeree idonee contemplate da piani sottoposti a VAS.
il comma 9-sexies eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.
Il comma 9-septies eleva da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica.
Il comma 9-octies precisa che le suddette semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il comma 9-novies prevede espressamente che anche il concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all’esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell’ambiente provvede all’adozione della VIA.
Il comma 9-decies estende alle dichiarazioni di cui agli articoli 12 (verifica dell’interesse culturale) e 13 (dichiarazione dell’interesse culturale) del D.Lgs. n. 42/2004 l’ambito di applicazione della disposizione in base alla quale gli effetti delle nuove dichiarazioni non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento propedeutico a tali dichiarazioni, il provvedimento di VIA o altro titolo abilitativo.
Il comma 9-undecies, infine, consente l’avvio dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili anche in assenza del parere del gestore di rete di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, comunque da acquisirsi nel corso del procedimento.
I commi da 9-quinquies a 9-undecies dell’articolo 9, aggiunti nel corso dell’esame in sede referente, prevedono semplificazioni amministrative per l’autorizzazione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 9-quinquies proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 le semplificazioni in materia di VIA applicabili gli impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio dell’energia previste dall’articolo 47, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, punto 6 del Regolamento 22 dicembre 2023, n. 2024/223/UE.
Si rammenta che l’articolo 47, comma 1-bis, esercitando una facoltà prevista dall’articolo 6 del Regolamento 2022/2577/UE, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ha previsto l’esenzione, fino al 30 giugno 2024, dalle valutazioni ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (VIA e verifica di assoggettabilità a VIA) per:
- i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;
- i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;
- i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;
- i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'inter-vento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;
- i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.
L’articolo 9 del Regolamento 2022/2577/UE, richiamato dalla novella in commento, prevede che entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesamini le disposizioni contenute nel medesimo regolamento in vista dell'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili. A valle di tale riesame, è previsto che essa presenti al Consiglio una relazione e che, sulla base di tale relazione, la Commissione possa proporre di prorogare la validità del presente regolamento.
la Commissione ha svolto il riesame del regolamento, come previsto all’articolo 9, ed ha presentato al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame. La Commissione, in base a tale riesame, ha proposto di prorogare la validità di alcune disposizioni di tale regolamento.
In particolare, l'articolo 1, paragrafo 1, punto 6, del Regolamento 22 dicembre 2023, n. 2024/223/UE ha integrato il testo dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/2577 prevedendo che le misure di semplificazione consentite dall’articolo 6, ossia l’esenzione, a determinate condizioni, dalla valutazione di impatto ambientale per progetti di energia rinnovabile, di stoccaggio dell’energia e i connessi progetti di rete elettrica, siano applicabili fino al 30 giugno 2025.
Il comma 9-sexies eleva le soglie superate le quali è necessario svolgere la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sui progetti di impianti fotovoltaici che:
- Si trovino in aree classificate idonee dalle regioni o, in via transitoria, ai sensi dell’articolo 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 ovvero
- Si trovino in zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento ovvero
- non siano situati all'interno di aree sensibili o vulnerabili comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
Con D.M. 10 settembre 2010 sono state adottate le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’allegato 3 reca i criteri per l’individuazione di aree non idonee e alla lettera f) indica quali aree individuabili come non idonee per la loro vulnerabilità e sensibilità:
- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
- le zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale);
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette);
- le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;
- le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
- aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 200, ossia: territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, territori coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, aree assegnate alle università agrarie, zone gravate da usi civici, vulcani e zone di interesse archeologico.
In particolare, la norma eleva:
- da 20 a 25 MW la soglia di potenza degli impianti fotovoltaici sopra la quale è necessario svolgere la VIA statale;
- da 10 a 12 MW la soglia di potenza degli impianti fotovoltaici sopra la quale è necessario svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA regionale.
Il comma 9-septies reca modifiche al D.Lgs. n. 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 4, comma 2-bis per:
- elevare da 10 a 12 MW la soglia di potenza fino alla quale i progetti di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e le opere connesse, nonché i potenziamenti, i rifacimenti e le ricostruzioni di impianti esistenti e le opere connesse sono sottoposti a procedura abilitativa semplificata;
- elevare, conseguentemente da 10 a 12 MW la soglia di potenza oltre la quale si applica la procedura di autorizzazione unica
- correggere l’alinea del comma 2-bis, che chiama regimi di autorizzazione, anziché semplicemente regimi, la dichiarazione di inizio lavori asseverata, la procedura abilitativa semplificata e la procedura di autorizzazione unica propriamente detta.
Analogamente, la lettera b) modifica l’articolo 6, comma 9-bis, per elevare da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale è possibile ricorrere alla procedura abilitativa semplificata per progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee.
Il comma 9-octies precisa che le semplificazioni previste dai due commi precedenti si applicano alle procedure abilitative semplificate e ai procedimenti autorizzativi avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione unica, le disposizioni di cui al comma 9-sexies si applicano alle procedure di valutazione ambientale avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il comma 9-novies modifica l’articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo del D.Lgs. n. 152, che prevede l’acquisizione del concerto del competente direttore generale del ministero della cultura da parte del direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA sui progetti sottoposti alla Commissione PNIEC-PNRR, per fare espressamente salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 199/2021, in base al quale nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Il comma 9-decies modifica l’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2013, che disciplina il procedimento di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili e in particolare il comma 3-bis, sulla partecipazione del Ministero della cultura al procedimento. La norma prevede che estende alle dichiarazioni di cui agli articoli 12 (verifica dell’interesse culturale) e 13 (dichiarazione dell’interesse culturale) del D.Lgs. n. 42/2004 l’ambito di applicazione della disposizione in base alla quale gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento di notevole interesse pubblico, il provvedimento di VIA o altro titolo abilitativo.
Il comma 9-undecies prevede che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica avvii il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Articolo 10
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti
di teleriscaldamento e teleraffrescamento)
L’articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
In particolare il comma 1 dell’articolo in esame assegna delle risorse finanziarie ai progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all’ammodernamento di sistemi esistenti.
Nello specifico si tratta dei progetti contenuti nell’elenco di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 435 del 2022, qualora gli stessi progetti non risultino finanziabili a valere sulle risorse di cui all’Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, Componente 3 “Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici”, del PNRR.
A tale proposito è utile ricordare come il decreto ministeriale sopra citato aveva approvato le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’avviso pubblico del Ministero della transizione ecologica del 28 luglio 2022, n. 94, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell’ambito della sopra citata misura del PNRR.
Tuttavia, a seguito dell’assessment condotto sulla terza rata del PNRR, la Commissione europea ha disposto che solamente 14 progetti sui 29 approvati sono compatibili con il principio Do No Significant Harm (DNSH), in quanto solo alcune delle reti di teleriscaldamento oggetto di intervento sono totalmente alimentate da fonti rinnovabili, con al più impianti di back-up alimentati da fonti fossili. Alla luce di tale decisione si è comunque ritenuto - come emerge dagli elementi contenuti nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento – di considerare gli altri progetti non finanziabili con le risorse del PNRR comunque meritevoli di finanziamento in quanto pienamente rispettosi dei requisiti richiesti dalla normativa europea e statale sull’efficienza energetica e, più in generale, in ragione del contributo che potranno offrire nel percorso di mitigazione delle emissioni di gas serra legate al settore della climatizzazione degli edifici.
Le risorse complessivamente stanziate sono pari a 96.718.200 euro per l’anno 2023.
Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, maturati nell’anno 2022, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, già versati all’entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 2, invece, dispone, con riguardo ai proventi delle aste CO2 maturate nel 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che, il 50% dei proventi medesimi, sia assegnato complessivamente ai Ministeri dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell’80% al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del 20% al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Articolo 11
(Misure urgenti in materia di infrastrutture per il
decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)
L’articolo 11, modificato in sede referente, reca numerose modifiche alla disciplina per l’individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell’ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l’individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA).
In relazione alle modifiche introdotte, la relazione illustrativa evidenzia che “sommando le tempistiche previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (come modificato dalla disposizione in esame, con specifico riferimento all’articolo 27), incluse quelle relative alla procedura di VAS (della durata di circa 5 mesi), l’adozione del decreto di approvazione della CNAA, da parte dei Ministri competenti, avverrà entro massimo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. In questa eventualità, le successive fasi procedurali risulteranno notevolmente semplificate nonché facilitate, in quanto si passerà direttamente al raggiungimento dell’intesa delle Regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate, o del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, alle indagini tecniche su tali aree. In alternativa, in assenza di autocandidature, o nel caso che le medesime non siano risultate idonee, il decreto di approvazione della CNAI avverrà entro massimo 9 mesi. L’iter procedurale proseguirà, quindi, come già previsto dall’articolo 27 del d.l.gs. n. 31 del 2010, con tempistiche attese tuttavia ragionevolmente più lunghe in ragione della necessità preventiva di raggiungere l’intesa con le regioni o i territori interessati”.
Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.
Disciplina del Parco Tecnologico (lett. a))
La lettera a) reca alcune novelle all’articolo 25 del D.Lgs. 31/2010, che disciplina il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell’ambito del Parco Tecnologico. In particolare le novelle riguardano il comma 2 dell’articolo 25, ove sono elencate le attività da svolgere nel Parco tecnologico.
La modifica operata dal numero 1) della lettera in esame è volta a precisare che, tra le attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato da svolgere nel Parco tecnologico rientra – oltre alla caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio, già previsti dal testo previgente – anche lo smaltimento.
Il successivo numero 2) novella la parte del comma 2 – ove si prevede che nel Parco tecnologico sono svolte tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione – al fine di precisare che sono altresì incluse le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 26, introdotta dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame.
Compiti attribuiti alla Sogin S.p.A. (lett. b))
La lettera b) reca una serie di modifiche all’articolo 26 del D.Lgs. 31/2010, che disciplina i compiti attribuiti alla Sogin S.p.A.
Il numero 1) di tale lettera prevede una modifica di carattere formale (al numero 1.1)) e una modifica di carattere integrativo al comma 1 dell’articolo 26. Tale integrazione (recata dal numero 1.2)) consiste nell’aggiunta di una nuova lettera e-ter) che attribuisce alla Sogin S.pA. il compito di predisporre, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che lo approva entro i successivi trenta giorni.
Il numero 2) della lettera in esame, che introduce nell’ articolo 26 un nuovo comma 1-bis, prevede una autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma poc’anzi menzionato (previsto dalla lettera e-ter del comma 1 dell’articolo 26).
Viene altresì disciplinata la copertura degli oneri relativi (pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024), prevedendo che agli stessi si provvede:
§ quanto a 1 milione di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MASE;
§ e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili previsto dall’ articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.
Nuova procedura per l’individuazione dell’area destinata ad ospitare il Parco Tecnologico (lett. c))
La lettera c) reca una serie di modifiche all’articolo 27 del D.Lgs. 31/2010, finalizzate a modificare la disciplina per l’individuazione dell’area destinata ad ospitare il Parco Tecnologico.
Il numero 1) di tale lettera prevede una modifica di carattere formale, volta a introdurre l’acronimo CNAI accanto alla denominazione “Carta nazionale delle aree idonee” già prevista dal testo previgente.
Il numero 2) introduce una serie di disposizioni (nuovi commi da 5-bis a 5-septies dell’articolo 27) finalizzate a disciplinare la presentazione di autocandidature ad ospitare il Parco tecnologico.
Le disposizioni in esame hanno una finalità analoga a quelle recate dalla proposta di legge C. 492, all’esame della VIII Commissione della Camera.
Presentazione delle autocandidature (comma 5-bis dell’articolo 27)
Il comma 5-bis dell’articolo 27 prevede che il MASE pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI.
Si valuti l’opportunità di introdurre un termine temporale per la pubblicazione in questione.
Entro i successivi 90 giorni (tale termine è stato così incrementato in sede referente, rispetto ai 30 giorni previsti dal testo iniziale), possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al MASE e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l’eventuale idoneità:
§ gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI;
§ il Ministero della difesa per le strutture militari interessate;
§ gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.
Elenco delle autocandidature e valutazione delle stesse (comma 5-ter dell’articolo 27)
Il comma 5-ter, primo periodo, dispone che, nel caso di presentazione di autocandidature entro il termine previsto, il MASE redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A.
In base al secondo periodo, entro i 30 giorni successivi la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all’autorità di regolamentazione competente.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 45/2014, “l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)”.
In sede referente è stato introdotto un periodo aggiuntivo, dopo il secondo, volto a precisare che, in particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico.
L’ultimo periodo del comma in questione dispone che, entro 30 giorni dalla ricezione delle risultanze citate, l’ISIN provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al MASE e alla Sogin S.p.A.
Proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate - CNAA (comma 5-quater dell’articolo 27)
Il comma 5-quater dispone che, entro 30 giorni dalla ricezione del parere dell’ISIN (previsto dal comma precedente), la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l’ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al MASE.
Valutazione ambientale strategica della proposta di CNAA o CNAI (comma 5-quinquies dell’articolo 27)
Il comma 5-quinquies dispone che, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il MASE, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Si ricorda che la disciplina della VAS è contenuta nel titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente).
In caso di mancata presentazione di autocandidature entro il termine previsto, il MASE, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI.
Aggiornamento della proposta di CNAA o CNAI (comma 5-sexies dell’articolo 27)
Il comma 5-sexies prevede che entro i 30 giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, la Sogin S.p.A., aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima.
La proposta aggiornata è poi trasmessa al MASE, che richiede il parere tecnico all’ISIN.
Parere dell’ISIN (comma 5-septies dell’articolo 27)
Il comma 5-septies prevede che entro 30 giorni dalla richiesta di parere inoltrata dal MASE, l’ISIN esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI e lo trasmette al MASE.
Approvazione della CNAI o della CNAA (numero 3) della lettera c))
Il numero 3.1) della lettera c) in esame riscrive il primo periodo del comma 6 dell’articolo 27 – che nel testo previgente disciplina l’approvazione con apposito decreto ministeriale della CNAI – al fine di tener conto della proposta di CNAA, nonché di adeguare la norma alle nuove competenze e ai nuovi organi.
Il nuovo testo previsto dalla disposizione in esame prevede quindi che:
§ con apposito decreto ministeriale è approvata la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità;
§ tale decreto è emanato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, e non dal Ministro dello sviluppo economico (in virtù del trasferimento di competenze operato dal D.L. 22/2021 e della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022); viene invece confermato il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre è eliminato il riferimento all’Agenzia per la sicurezza nucleare essendo la medesima stata soppressa (v. articolo 21, comma 13, del D.L. 201/2011).
Il numero 3.2) interviene sul secondo periodo del comma 6 dell’articolo 27 – che nel testo previgente disciplina la pubblicazione della CNAI – al fine di precisare che in alternativa alla CNAI potrà essere pubblicata la CNAA.
Procedura per la localizzazione del sito del Parco Tecnologico da seguire in caso di approvazione della CNAA in luogo della CNAI (n. 4) della lett. c))
Il numero 4) inserisce disposizioni (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 27 del D.Lgs. 31/2010) finalizzate a disciplinare la procedura per la localizzazione del sito del Parco Tecnologico da seguire in caso di approvazione della CNAA in luogo della CNAI.
Il comma 6-bis dell’articolo 27 dispone che, entro 30 giorni dall’approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco tecnologico.
Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle citate trattative, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione – di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 26 (v. supra) – che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26.
A conclusione del procedimento, il MASE acquisisce l’intesa:
§ delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate;
§ o del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.
Il comma 6-ter dell’articolo 27 dispone che, con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma precedente, nell’ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all’individuazione dell’area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro 15 mesi dal perfezionamento dell’intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall’Agenzia. L’Agenzia vigila sull’esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al MASE parere vincolante sulla idoneità del sito proposto.
In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al MASE.
Si valuti l’opportunità di modificare il riferimento all’Agenzia (che ai sensi delle definizioni recate dall’articolo 2 del D.Lgs. 31/2010 è da intendersi all’Agenzia per la sicurezza nucleare), in quanto tale Agenzia è stata soppressa dall’articolo 21, comma 13, del D.L. 201/2011.
Modifiche alla procedura per la localizzazione del sito del Parco Tecnologico da seguire in assenza di autocandidature (n. 5) della lett. c))
Il numero 5.1) riscrive i primi tre periodi del comma 7 dell’articolo 27 del D.Lgs. 31/2010, che nel testo vigente disciplinano le manifestazioni di interesse da parte di regioni ed enti locali inclusi nella CNAI approvata.
Le novità introdotte con la riscrittura in esame consistono:
§ nella precisazione che la procedura prevista dal comma 7 si applica solo in assenza di autocandidature o nel caso che le medesime non siano risultate idonee;
§ nella riduzione da 60 a 5 giorni del termine, decorrente dall’approvazione della CNAI, entro il quale la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento;
§ nell’introduzione di una disposizione (analoga a quella prevista dal nuovo comma 6-bis dell’articolo 27, v. supra) volta a precisare che, con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative succitate, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione – di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 26 (v. supra) – che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26;
§ nella soppressione della disposizione secondo cui, in caso di assenza di manifestazioni d’interesse, la Sogin S.p.A. promuove trattative bilaterali con tutte le regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.
Il numero 5.2) modifica il riferimento al “livello di priorità”, presente nel quarto periodo del comma 7 dell’articolo 27, al fine di riferire la disposizione all’ordine di idoneità delle aree idonee per le quali sono siglati protocolli di accordo.
Modifiche di coordinamento e aggiornamento (lett. c), n. 6), e lett. d))
Il numero 6) della lettera c) modifica il comma 8 dell’articolo 27 al fine di coordinarlo con le modifiche operate ai commi precedenti.
La lettera d) è volta a precisare che ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al fine di tener conto del trasferimento di competenze operato dal D.L. 22/2021 e della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022.
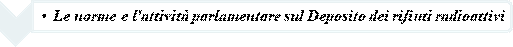
La disciplina vigente relativa al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
Il D.Lgs. n. 31/2010 detta la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché in materia di benefici economici, a norma dell’articolo 25 della L. n. 99/2009. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31/2010, il "Deposito nazionale" è il sito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
A norma dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 31/2010, sono soggetti alle disposizioni del Titolo III del medesimo decreto la localizzazione, la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico. Il comma 2 prevede che il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.
Il comma 3 dell’articolo 25 attribuisce alla SOGIN S.p.A. il compito di realizzare il Parco Tecnologico e in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza.
Il comma 1 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 31/2010 stabilisce, a sua volta, che la SOGIN S.p.A. definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.
La proposta di CNAPI (attualmente oggetto, peraltro, di revisione, v. infra) è stata trasmessa da SOGIN S.p.A. al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 15 marzo 2022.
L’articolo 12-bis del D.L. 183/2020 (c.d. milleproroghe) è intervenuto sulle disposizioni dettate dall’articolo 27 del D.Lgs. 31/2010, che disciplinano la fase successiva alla pubblicazione della CNAPI, al fine di disporre un differimento dei termini previsti. È stato infatti differito da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di CNAPI – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, anch’esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.
Gli indirizzi del Parlamento approvati nella scorsa legislatura
Con l’approvazione delle mozioni 1-00414 e abbinate, avvenuta nella seduta del 13 aprile 2021, si è impegnato il Governo, tra l’altro:
§ ad adottare iniziative per assicurare che tutte le fasi procedimentali in cui si articola la scelta dei siti idonei e l’individuazione del sito ove ubicare il Parco tecnologico siano caratterizzate dalla concertazione e condivisione con le regioni, i territori e le comunità locali interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, leale collaborazione e cooperazione istituzionale, prevedendo una tempistica adeguata che tenga conto della complessità della materia e dell’impatto della pandemia sulla operatività delle strutture amministrative (punto 1);
§ ad informare preventivamente il Parlamento sugli esiti della consultazione pubblica e sulle scelte del Ministri interessati per la definitiva approvazione della Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), nonché riguardo all’individuazione dei previsti benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere; ad esplicitare le intese raggiunte con le regioni interessate e gli enti locali coinvolti, nonché la corretta esecuzione delle fasi di chiusura e post chiusura dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni emesse nel «periodo di controllo istituzionale», presentando a tal fine una relazione annuale alle Camere (punto 2);
§ a valutare l’accoglimento delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute dai comuni e dagli enti territoriali che intendono ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi, purché vengano rispettati i criteri di esclusione e approfondimento già in vigore (punto 18).
Elementi di informazione e impegni risultanti dai recenti atti di sindacato ispettivo
In risposta all’interrogazione 5/00182, nella seduta del 25 gennaio 2023 il rappresentante del Governo ha ricordato che "la procedura di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico (DNPT) è di primario interesse per il Paese. La necessità di dotarsi di tale infrastruttura non scaturisce soltanto dall’esigenza di assicurare un’idonea gestione in sicurezza dei rifiuti derivanti dal pregresso programma nucleare, anche a tutela delle future generazioni, e il completamento del processo di disattivazione delle installazioni con il rilascio dei siti senza vincoli di natura radiologica (decommissioning), ma anche dall’oggettiva necessità di assicurare una gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi di origine medica, industriale e di ricerca, la cui produzione proseguirà negli anni a venire, attualmente stoccati in siti non idonei allo smaltimento e comunque spesso già al limite della propria capacità. I depositi temporanei presenti in ogni sito, infatti, pur rispettando i requisiti di sicurezza previsti dalla loro autorizzazione all’esercizio, non possono essere considerati la sistemazione finale dei rifiuti radioattivi. Solo una struttura come il Deposito nazionale potrà difatti garantire lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e lo stoccaggio in sicurezza di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato, provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari. L’iter procedurale di realizzazione del DNPT, complesso e articolato in più fasi, è definito nel dettaglio all’articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dove sono stabiliti i tempi, i passaggi istituzionali e la documentazione tecnica da produrre, a partire dalla localizzazione fino all’autorizzazione unica per la sua costruzione ed esercizio. La proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), citata dall’onorevole interrogante e trasmessa al Ministero della transizione ecologica (MiTE) in data 15 marzo 2022, a valle di interlocuzioni tecniche tra la SOGIN e l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), è stata aggiornata in data 17 giugno 2022. Successivamente, il 28 ottobre 2022 le strutture preposte del Ministero, in assenza del necessario riscontro da parte dell’ISIN sulla proposta di CNAI, hanno chiesto al medesimo Ispettorato di conoscere la tempistica di presentazione del parere tecnico di competenza. Suddetto parere risulta vincolante per la successiva emanazione del decreto interministeriale di approvazione della CNAI, ai fini della prosecuzione del procedimento di localizzazione del DNPT, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo suddetto. Il parere tecnico ISIN è stato pertanto ricevuto da questo Ministero l’11 novembre. Gli esiti delle attività di verifica hanno tuttavia fatto emergere una valutazione positiva solo parziale della proposta di CNAI, evidenziando la necessità di integrazioni e valutazioni circa l’applicazione di alcuni dei criteri di esclusione o di approfondimento adottati dalla SOGIN riguardo ad alcune delle aree potenzialmente idonee. Rilevando l’opportunità di giungere al superamento di tutte le criticità evidenziate dall’ISIN in via preliminare rispetto all’emanazione del suddetto decreto interministeriale, in data 30 dicembre 2022 è stato chiesto alla SOGIN di effettuare le integrazioni richieste, e quindi trasmettere nel più breve tempo possibile una proposta di CNAI conforme alle richieste dell’ISIN, al fine di consentire l’approvazione della CNAI verosimilmente entro il corrente anno. In seguito all’approvazione e alla pubblicazione della CNAI, l’iter per la localizzazione del DNPT proseguirà come definito dal decreto legislativo n. 31 del 2010. Ipotizzando l’esito positivo di tutte le fasi procedurali, particolarmente complesse e dipendenti da un insieme di fattori – quale l’acquisizione di manifesto interesse ed autocandidatura da parte dei comuni incidenti nelle aree idonee ad ospitare il Deposito – e al netto di eventuali ricorsi, l’emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT potrebbe avvenire nel 2026 e la sua messa in esercizio nel 2030. Si evidenzia, infine, che la realizzazione del DNPT costituisce altresì parte integrante delle tappe significative del «Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2019. Inoltre, atteso che il parere di compatibilità ambientale relativo a detto Programma richiede che venga effettuata specifica Valutazione ambientale strategica (VAS) sul DNPT, si precisa che la tempistica ipotizzata per il procedimento che porterà all’emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT considera altresì il compimento della procedura di VAS. Infine, qualora riguardo l’intesa con le regioni ad ospitare il Deposito non si verificasse una intesa immediata, si configurerebbe l’attivazione di specifiche procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 31 del 2010 causando uno slittamento delle date di conclusione delle diverse fasi, fino a 12 mesi".
Nella risposta all’interrogazione 5-00958, resa nella seduta della VIII Commissione del 9 giugno 2023, il rappresentante del Governo ha ribadito, con riferimento alla conclusione delle procedure per la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco tecnologico, che "sono in corso gli ultimi aggiornamenti e integrazioni alla Carta nazionale delle aree idonee (CNAI) da parte della Sogin" e che "in seguito all’approvazione e alla pubblicazione della CNAI, l’iter per la localizzazione del DNPT proseguirà, auspicabilmente in termini celeri, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010".
Si ricorda inoltre che nella seduta dell’Assemblea della Camera del 9 maggio 2023 sono state discusse, e in parte approvate, mozioni concernenti iniziative in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all’energia nucleare. In particolare con la mozione 1-00098 si è impegnato il Governo "ad adottare iniziative volte a procedere alla localizzazione e realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, al fine di consentire lo smaltimento in totale sicurezza di tutti quelli prodotti in Italia, evitando di prolungare ulteriormente il loro stoccaggio in numerosi depositi temporanei sparsi sul territorio e permettere il rimpatrio dei rifiuti attualmente custoditi all’estero con notevole risparmio di denaro pubblico" e con la mozione 1-00122 "a concludere il programma, già avviato, per l’individuazione di un sito unico per i rifiuti nucleari sia di intensità bassa e media sia, in fase intermedia, per gli stessi rifiuti ad alta intensità, al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori...".
L’attività parlamentare in corso
E’ all’esame dell’VIII Commissione (Ambiente) della Camera, in sede referente, la proposta di legge n. 492 recante “Modifica all’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l’individuazione dell’area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità".
Nell’ambito dell’esame di tale proposta di legge, la Commissione Ambiente ha svolto alcune audizioni informali.
Articolo 12
(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)
L’articolo 12 attribuisce all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) - al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti - il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.
Come noto il fotovoltaico rappresenta una delle tecnologie chiave per il raggiungimento degli obiettivi della decarbonizzazione del sistema energetico, dell’indipendenza energetica e della transizione verde fissati dal Green Deal europeo e dal Piano REPowerEU.
Dato il ruolo strategico che i sistemi fotovoltaici assumeranno nel processo di transizione energetica, in quanto destinati a divenire la fonte di energia rinnovabile in più rapida crescita, è essenziale che tutti i moduli fotovoltaici installati nell’UE siano prodotti in modo rispettoso dell’ambiente, all’insegna dei più elevati standard di sostenibilità sociale e governance.
A tal proposito, la disposizione in esame intende realizzare una più completa mappatura dei prodotti e delle tecnologie disponibili sul mercato attraverso l’istituzione di un apposito registro.
Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame affida all’ENEA il compito di istituire e curare la tenuta del registro, composto da tre diverse sezioni, in cui sono iscritti, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
§ moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
§ moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
§ moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Il comma 2 della disposizione in esame prevede che l’ENEA, sentiti il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, definisca e pubblichi sul proprio sito istituzionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, fornendo altresì la documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione.
Al comma 3 si prevede che l’ENEA pubblichi sul proprio sito istituzionale l’elenco dei prodotti, dei produttori e dei distributori che hanno ottenuto l’inserimento nel registro. Ai fini dell’iscrizione, la stessa Agenzia può procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro.
Gli eventuali oneri derivanti da tali controlli sono posti a carico dei richiedenti l’iscrizione.
Il comma 4 è relativo agli oneri finanziari, e stabilisce che l’ENEA provveda all’attuazione della disposizione in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12-bis
(Disposizioni in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici)
L’articolo 12-bis, inserito durante l'esame in sede referente, introduce misure riguardanti: la quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici, gli elementi che devono essere descritti nella documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici e misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.
L’articolo 12-bis, inserito durante l'esame in sede referente, modifica il D. Lgs. 49/2014 che disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Con il comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni.
La lettera a), che integra il comma 10-bis dell’articolo 10, prevede che ciascun sistema collettivo per la gestione dei RAEE debba rappresentare una quota di mercato di AEE almeno pari all'1 per cento degli impianti fotovoltaici incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi indicato dall'articolo 24-bis, comma 1, del D. Lgs. 49/2014.
L’art. 10, comma 10-bis stabilisce che ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento.
La lettera b), che integra il comma 1 del richiamato articolo 24-bis, stabilisce che la documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici ad un sistema collettivo deve comprendere l'elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto.
A tale fine si prevede che il GSE aggiorni l'elenco delle matricole registrate nella propria banca dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto.
In caso di non completa corrispondenza dei predetti numeri di serie non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), fermo restando l’obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici.
Il comma 2, al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, stabilisce l’iscrizione di ciascun sistema collettivo al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, secondo le modalità previste dal regolamento 185/2007.
Ciascun sistema comunica inoltre i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti come previsto all'articolo 24-bis, comma 1, del D. Lgs. 49/2014 (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)).
I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, come previsto dall'articolo 7, comma 3 del citato regolamento 185/2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.
Articolo 12-ter
(Sogesid)
L’articolo 12-ter, introdotto in sede referente, individua la Sogesid spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica, ivi inclusi gli interventi previsti dal PNRR, autorizzandola a tal fine, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il MASE e il MIT, a stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
L’articolo 12-ter, introdotto in sede referente, prevede, al comma 1, che la Sogesid S.p.A., società per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 96/1993, è individuata quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal PNRR.
La norma dispone che la Sogesid S.p.A., fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l’esecuzione di attività tecnico specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.
Sogesid Spa è la società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Il suo capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Svolge in particolare interventi che concorrono ad avviare a soluzione le criticità ambientali, (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti idrogeologici ecc.) e finalizzati ad utilizzare in modo idoneo ed efficace i fondi strutturali nazionali e europei.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 96/1993 ha previsto (al comma 1) che per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici già detenuti dalla stessa Cassa. Tale autorizzazione è stata poi disposta con il DM 27 gennaio 1994.
Il comma 2 dispone che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 13
(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)
L’articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell’UE, attraverso l’assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).
L’articolo 13 dispone il rifinanziamento del Fondo italiano per il clima, istituito dall’articolo 1, comma 488, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 489, della medesima legge n. 234/2021 (consistenti in operazioni di assunzione di capitale di rischio, concessione di finanziamenti e rilascio di garanzie).
Si ricorda che i commi da 488 a 497 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) hanno istituito un fondo rotativo, denominato “Fondo italiano per il clima” (FIC), con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027.
Il Fondo italiano per il clima è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte. Il comma 488 della legge di bilancio 2021 dispone, tra l’altro, che con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo. In attuazione di tale disposizione, la disciplina di dettaglio del FIC è stata emanata con il D.M. 21 ottobre 2022.
Il comma 488-bis (inserito dall’articolo 45, comma 2-bis, del D.L. 13/2023) prevede che le risorse del FIC sono impignorabili.
Con la disposizione in esame la dotazione per l’anno 2024 è rifinanziata di 200 milioni di euro (e quindi portata complessivamente a 1.040 milioni di euro) per gli interventi indicati dal comma 489 dell’articolo 1 della citata L. n. 234/2021. Tale ultima disposizione prevede che il FIC può intervenire, in conformità alla normativa dell’UE, attraverso: a) l’assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l’iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all’esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.
Si ricorda inoltre che il comma 493 dispone che il FIC è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Ai sensi del primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l’operatività e potenziandone la capacità d’impatto – la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell’esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell’UE, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l’impiego delle risorse della gestione separata, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l’assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Il secondo periodo del comma 494 (di cui viene peraltro disposta l’abrogazione dall’articolo 88, comma 17, del disegno di legge di bilancio per il 2024, attualmente all’esame del Senato) prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale (non ancora adottato).
Per assicurare la governance del FIC sono istituiti (dal comma 496 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022) due organi interministeriali: il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo. La disciplina di tali organi è stata adottata con il D.M. 21 ottobre 2022, come modificato dal D.M. 15 giugno 2023.
Il secondo periodo della disposizione in esame reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo che all’onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020.
Il comma 17 dell’articolo 27 del D.L. 34/2020 dispone che ai fini degli apporti di cui al comma 2 (ossia gli apporti di beni e rapporti giuridici del Ministero dell’economia e delle finanze al Patrimonio Destinato costituito dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi e per le finalità di cui alla medesima disposizione), è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell’ambito del predetto limite, l’apporto di liquidità.
Articolo 14
(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica)
L’articolo 14, comma 1, stanzia un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico.
Al comma 2, trasferisce al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità.
Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall’ARERA e che l’approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico.
Il comma 4 abroga la norma che prevedeva l’inserimento di una clausola sociale nell’affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela, disponendo, tuttavia, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore.
Il comma 4-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che gli esercenti il servizio di tutela presentino all’ARERA una relazione indicante i costi direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, ai fini del loro riconoscimento a valere sulle tariffe elettriche.
I commi 5 e 5-bis prevedono che l’addebito diretto autorizzato dal cliente per la fatturazione nell’ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità e disciplinano gli obblighi informativi utili affinché ciò avvenga in modo trasparente ed efficace.
Il comma 6 dispone che l’ARERA provveda ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, assegnando un termine tra il 9 e il 10 gennaio 2024 per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, al fine di garantire un’adeguata informazione preventiva dell’utenza domestica nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici.
Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele graduali e che l’ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.
Il comma 7-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, modifica la disciplina del portale delle offerte prevista dalla legge n. 124/2017 affinché gli operatori trasmettano tempestivamente le proprie offerte e rafforza il ruolo del comitato tecnico consultivo.
L’articolo 14, comma 1, autorizza la spesa di un milione di euro per il 2024 per la promozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica promuova, tramite di Acquirente unico S.p.A. e per un periodo non superiore a dodici mesi, di specifiche campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico.
Ciò al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici senza fornitore di energia elettrica, nonché di assicurare un’adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi i clienti vulnerabili, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall’avvio del servizio a tutele graduali.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 22, comma 6 del D.Lgs. n. 164/2000, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che prevede l’istituzione, da parte dell’ARERA, anche avvalendosi dell’Acquirente unico S.p.A., di sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti del servizio di fornitura di gas tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
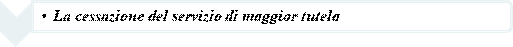
La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto, all’articolo 1, comma 60, la cessazione dell’efficacia del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico istituito dall’articolo 35, comma 2 del D.Lgs. n. 93/2011 per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero.
Tale regime cd “servizio di maggior tutela", ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 73/2007, prevede che il servizio elettrico sia erogato dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, ma che la funzione di approvvigionamento sia svolta da Acquirente Unico S.p.A..
Nel 2017, anno in cui è stata approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza, erano già passate al mercato libero il 38,8 per cento delle utenze domestiche e il 50,8 per cento delle altre utenze in bassa tensione.
Il completamento della liberalizzazione del segmento retail del mercato elettrico concorre all’attuazione del PNRR (Riforma M2C1-7). Nel PNRR si legge, in particolare, che “in materia di vendita di energia elettrica occorre completare il processo di piena liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attraverso l’adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori”.
La legge n. 124/2017 stabiliva inizialmente un unico termine a decorrere dal quale sarebbe cessato il regime dei prezzi regolati per dette imprese e clienti civili, fissato al 1° gennaio 2019.
Detto termine è stato successivamente più volte prorogato e da ultimo fissato al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese ed al 1° gennaio 2023 per le micro imprese e i clienti domestici (art. 12, comma 9-bis del D.L. n. 183/2020).
Per piccola impresa si intende un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, mentre per microimpresa si intende un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (articolo 2, numeri 6) e 7) della direttiva (UE) n. 2019/944). L’articolo 1, comma 60 della legge n. 124/2017 ha per altro previsto che l’ARERA definisse un livello di potenza contrattualmente impegnate quale criterio identificativo in aggiunta a tali criteri. Detto limite di potenza è stato individuato con Deliberazione 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel in 15 kW.
Per i clienti domestici, tuttavia, il servizio di maggior tutela continua ad applicarsi, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, come stabilito dall’art. 16-ter, commi 1 e 2 del D.L. n. 152/2021.
Il medesimo comma 60 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017, infatti, prevede l’istituzione, con provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di un servizio a tutele graduali per accompagnare i clienti finali nel passaggio al mercato libero dopo la rimozione della tutela di prezzo. Detto servizio è erogato da operatori selezionati attraverso specifiche procedure competitive ai clienti che non hanno scelto un venditore sul mercato libero, per garantire comunque la continuità della fornitura di energia elettrica.
L’articolo 1, comma 60-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124 ha rinviato ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi sentite l’ARERA e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione delle modalità e dei criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
Alla norma è stata data attuazione con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 18 maggio 2023, che stabilisce, quindi, le modalità di ingresso consapevole dei clienti domestici non vulnerabili nel mercato libero e di assegnazione dell’STG.
Il decreto prevede – in vista della cessazione del regime di maggior tutela - la promozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di campagne informative istituzionali destinate ai clienti domestici attraverso una pluralità di canali divulgativi e sui principali media a diffusione nazionale, utilizzando anche i canali televisivi in orari di maggior ascolto e assicurando lo svolgimento delle campagne con adeguata tempestività e periodicità.
Il provvedimento non stanzia nuove risorse a tal fine, ma nelle premesse richiama il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2022, di approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, come proposti da Arera con la deliberazione 30 novembre 2021, 532/2021/E/com. Tra questi, si segnala il Progetto Informazione Mercati (PIM) relativo alla realizzazione di campagne informative sulla piena apertura dei mercati rivolte ai consumatori di energia elettrica e gas naturale, al quale sono destinate risorse per complessivi quattro milioni di euro nel biennio 2022-2023. Si ricorda, in proposito, che l’articolo 11-bis del D.L. n. 35/2005 prevede che l’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’Arera sia destinato a un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello sviluppo economico (per il trasferimento di detta competenza al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, si veda l’articolo 14, comma 2 del D.L. n. 181/2023 ed il seguito della presente scheda), che possono consistere anche in campagne informative.
L’articolo 14, comma 1 del D.L. n. 181/2023 prevede, quindi, come sottolinea la relazione illustrativa, un distinto stanziamento, per un milione di euro nel 2024, per l’effettuazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, di specifiche campagne informative e per lo svolgimento delle azioni individuate con il citato D.M. 18 maggio 2023.
Per promuovere la concorrenza nel settore, il decreto fissa inoltre una soglia delle aree aggiudicabili al medesimo operatore ai fini dell’erogazione del Servizio a Tutele Graduali pari al 30% (nei decreti adottati in precedenza per l’ingresso delle imprese nel mercato libero delle imprese connesse in bassa tensione, la quota era stata fissata al 35%).
Il servizio a tutele graduali è erogato per un massimo di quattro anni, al termine dei quali, se il cliente non ha ancora scelto un operatore sul mercato libero, questi viene rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. Almeno sei mesi prima della scadenza, l’esercente il STG ne dà avviso al cliente. Analoghe disposizioni sono previste in vista della cessazione del servizio a tutele graduali per le piccole e medie imprese.
Il comma 2 prevede il trasferimento del fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato di cui all’articolo 11-bis del D.L. n. 35/2005, alimentato con le risorse rivenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’Arera, allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Modifica, quindi, il citato articolo 11-bis del D.L. n. 35/2005, prevedendo che sia il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, anziché il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) ad approvare i progetti proposti dall’ARERA.
La relazione illustrativa osserva che la norma intende superare le criticità correlate alla circostanza che il fondo, benché volto a finanziare azioni e progetti per i consumatori energetici e ambientali (nella più parte dei casi affidati a società o enti soggetti alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), è rimasto “incardinato” nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Ciò, riporta la relazione illustrativa, ha creato ridondanze e complicazioni amministrative, suscettibili di compromettere – specie in momenti “delicati” come quello del passaggio dei clienti domestici al mercato libero – l’efficienza delle azioni di tutela programmate. Pertanto, la norma trasferisce alla competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il fondo, superando le incertezze normative emerse in fase esecutiva dei progetti già presentati dall’ARERA per le finalità dell’apertura dei mercati energetici.
Il comma 3 reca specifiche disposizioni circa la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1 del D.Lgs. n. 210/2021.
Per clienti vulnerabili, si intende, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del D.Lgs. n. 210/2021, i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilità;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di età superiore ai 75 anni.
Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 181/2023, l’articolo 11, comma 2 del D.Lgs. n. 210/2021 si limitava a prevedere l’obbligo per i fornitori di offrire a detti clienti la fornitura di energia elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell’energia nel mercato all’ingrosso e i costi efficienti del servizio di commercializzazione, a condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.
La relazione illustrativa osserva che la norma previgente non prevedeva un obbligo di contrarre in capo ai fornitori, bensì unicamente un obbligo di offerta, con la conseguenza che i clienti vulnerabili potrebbero non trovare un fornitore disposto a servirli e non riuscire a beneficiare delle condizioni contrattuali dedicate. Si sarebbero prodotti così dei risultati paradossali avuto riguardo alla condizione della generalità dei clienti finali domestici, per i quali l’ordinamento prevede invece il passaggio graduale al libero mercato, attraverso la fruizione del servizio a tutele graduali reso da fornitori scelti con procedure competitive.
Il comma 3, let. a) dell’articolo 14 del decreto-legge in esame sostituisce interamente tale disposizione, dettando una disciplina organica di quello che ora è denominato il servizio di vulnerabilità.
La relazione illustrativa osserva, in particolare, che il comma 3 intende introdurre un quadro completo e certo per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, in chiave pro-competitiva e a prezzi market-based, in linea con l’articolo 5 della direttiva 2019/944/UE.
L’ARERA rimane competente a stabilire le condizioni contrattuali e la norma continua a prevede che il prezzo applicato debba riflettere il costo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base – si precisa – di criteri di mercato. Tuttavia, la novella affida ad Acquirente unico S.p.A. il compito di svolgere, secondo le modalità stabilite dall’ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il suddetto servizio di vulnerabilità.
Si prevede, inoltre, che il servizio di vulnerabilità sia esercitato da fornitori iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al D.M. n. 164/2022, e individuati mediante procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A. (art. 14, comma 3, let. a)).
Il comma 3, let. b) aggiunge, dopo il comma 2 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 210/2010, due ulteriori commi.
Il comma 2-bis prevede che l’ARERA, entro l’8 febbraio 2024, disciplini il servizio di vulnerabilità prevedendo:
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;
b) l’assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;
c) l’entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio;
d) l’obbligo per ciascun fornitore di svolgere l’attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1. il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;
2. i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
3. per l’esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo.
Nel corso dell’esame in sede referente, è stato aggiunto un ulteriore criterio per la disciplina del servizio di vulnerabilità da parte dell’ARERA, per:
- consentire ai soggetti interessati, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura competitiva, di manifestare la volontà di avvalersi dell’azienda o del ramo d’azienda dell’impresa di distribuzione esercente il servizio di maggior tutela, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici in capo alla stessa al momento della cessazione del servizio di maggior tutela, correlati al servizio medesimo sulla base delle informazioni relative all’azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici messe a disposizione dagli interessati, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di gara, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite da ARERA in coerenza con quanto previsto dal comma 4-bis (vedi infra);
- prevedere che, ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati da ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di avvalersi dell’azienda o del ramo d’azienda dell’impresa di distribuzione esercente il servizio di maggior tutela, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici in capo alla stessa, e del conseguente minor reintegro dei costi sostenuti dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, da riconoscere agli esercenti il servizio di maggior tutela (vedi infra);
- obbligare i soggetti che manifestano la volontà di avvalersi di avvalersi dell’azienda o del ramo d’azienda dell’impresa di distribuzione esercente il servizio di maggior tutela, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici in capo alla stessa, a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dalla medesima Autorità in coerenza con l’oggetto della manifestazione stessa.
Il comma 2-ter prevede che, in caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all’esito delle procedure competitive, Acquirente unico provveda a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.
Si rammenta che l’articolo 16-ter, comma 3 del D.L. n. 152/2021, prevede che, per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, il servizio di tutela continui ad applicarsi finché non siano adottate le misure previste dall’articolo 11, comma 2 del D.lgs. n. 210/2021, oggetto di un’ampia revisione ad opera del D.L. n. 181/2023.
Il D.M. 18 maggio 2023, ha previsto che l’Arera, entro il 10 gennaio 2024, assicurasse il superamento del vigente regime di maggior tutela anche per i clienti vulnerabili, in conformità alle disposizioni del diritto eurounitario, dando attuazione all’articolo 11 del D.Lgs. n 210/2021. In questo modo si intendeva garantire alla data del 10 gennaio 2024 fossero adottati tutti i provvedimenti utili a permettere la cessazione del regime di maggior tutela sia per la generalità dei clienti domestici sia, specificatamente, per i clienti vulnerabili.
Tuttavia, l’articolo 14, comma 3 ora prevede un nuovo termine per l’adozione da parte dell’ARERA della disciplina del servizio prestato ai clienti vulnerabili, con la conseguenza che ad essi continuerà ad applicarsi, nelle more dell’istituzione del servizio di vulnerabilità, il servizio di maggior tutela.
Il comma 4 modifica la disciplina volta a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella gestione di attività di maggiore tutela nei contact center, contenuta all’articolo 36-ter del D.L. n. 48/2023. Il testo previgente della norma prevedeva l’inserimento di una clausola sociale nell’ambito delle procedure competitive per l’assegnazione del servizio a tutele graduali, affinché il suddetto personale continuasse a svolgere la propria attività lavorativa presso i soggetti aggiudicatori e, successivamente, presso gli operatori del mercato libero.
A seguito dell’approvazione di tale disposizione, l’ARERA segnalava (Segnalazione 6 luglio 2023 308/2023/I/EEL) come la previsione della clausola sociale nell’ambito delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, da un lato, non risultasse compatibile con il rispetto del termine di gennaio 2024 per la conclusione di tali procedure, in considerazione delle tempistiche associate alle attività necessarie per darvi puntuale e corretta attuazione e, dall’altro, creasse potenziali complessità applicative e procedurali che avrebbero potuto ridurre la partecipazione alle predette gare, a detrimento degli esiti concorrenziali delle stesse.
Il comma 4, sostituendo il comma 1 dell’articolo 36-ter del D.L. n. 48/2023, prevede ora che le imprese di distribuzione che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.
La relazione illustrativa evidenzia che, per effetto della disposizione in commento, i costi relativi ai servizi di contact center resteranno a carico delle imprese esercenti il servizio di maggior tutela e saranno considerati dall’ARERA nell’ambito della determinazione dei corrispettivi da riconoscere a detti esercenti per la copertura dei costi efficienti per lo svolgimento dell’attività di commercializzazione del servizio di maggior tutela.
Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di vulnerabilità, gli esercenti il servizio di tutela presentino all’ARERA una relazione che indica i costi sostenuti dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L’ARERA, con propria delibera, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, disciplina termini e modalità per la presentazione della suddetta relazione. Detti costi comprendono quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di maggior tutela, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l’affidamento di detti servizi e dell’esigenza di evitare sovracompensazioni. La norma prevede, infine, il riconoscimento da parte di ARERA di detti costi entro novanta giorni dalla presentazione della relativa relazione e che essi siano posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
Il comma 5, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che l’addebito diretto sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento autorizzato dal cliente domestico per la fatturazione nell’ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o del servizio di vulnerabilità, sempre fatta salva la facoltà di revoca da parte del cliente. Ciò, si precisa, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica, l’emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative detta fornitura fina dalla data di cessazione del regime di maggior tutela e dell’assegnazione del nuovo fornitore, nonché la regolarità dei relativi pagamenti.
La norma rinvia la definizione delle condizioni e dei termini per l’attuazione della disposizione in commento ad un provvedimento dell’ARERA, da adottare d’intesa con la Banca d’Italia e sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive per l’assegnazione del servizio a tutele graduali.
Il comma 5-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede, al fine di assicurare il rinnovo dell’autorizzazione all’addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, che gli esercenti il servizio di maggior tutela siano tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità sono tenuti, invece, ad informare i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
Il comma 6 dispone che l’ARERA provveda ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive per l’aggiudicazione del servizio a tutele graduali, assegnando un termine tra il 9 e il 10 gennaio 2024 (la lettera della disposizione indica “un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrate in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024), per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un’adeguata informazione preventiva dell’utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure.
Si segnala, in proposito, che il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. n. 181/2023, l’ARERA ha adottato la deliberazione 9 dicembre 2023, n. 580/2023/R/EEL con cui differisce dall’11 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024 la data di svolgimento delle aste per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell’energia elettrica.
Nel provvedimento si rammenta che, con deliberazione 362/2023/R/eel, l’ARERA aveva affidato ad Acquirente unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate così da rispettare il termine di conclusione delle procedure concorsuali del 10 gennaio 2024. Pertanto, il 26 settembre 2023, Acquirente unico ha pubblicato il Regolamento di gara che fissava: al 5 ottobre 2023 il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli operatori interessati; all’11 dicembre 2023 la data di svolgimento dell’asta; al 10 gennaio il termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali. La sopracitata deliberazione dell’ARERA ha fissato poi al 1° aprile 2024 la data di attivazione del servizio a tutele graduali.
Alla luce delle novità contenute dall’articolo 14 e considerato che il comma 6 dispone che l’Autorità adotti i provvedimenti di competenza per lo svolgimento delle procedure competitive coerente con le nuove disposizioni, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un’adeguata informazione preventiva dell’utenza domestica, anche mediante campagne informative, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure, ha deliberato di fissare al 10 gennaio 2024 la data alla quale dovranno essere svolte le aste da parte di Acquirente Unico. Acquirente Unico è inoltre incaricato di pubblicare il Regolamento aggiornato con le nuove scadenze, che dovranno essere fissate in modo tale da garantire le medesime tempistiche minime tra le varie attività strumentali all’assegnazione del servizio attualmente previste da detto Regolamento.
Il comma 7 prevede lo svolgimento di specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive per l’assegnazione del servizio a tutele graduali, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele graduali. Dette attività sono affidate ad Acquirente unico S.p.A., secondo criteri e modalità definiti dall’ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il testo originario del decreto-legge prevedeva che la definizione delle attività di monitoraggio da parte dell’ARERA avvenisse d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Si dispone che gli esiti di dette attività siano contenuti in una relazione che l’ARERA è chiamata a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale.
Il comma 7-bis, aggiunto con una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, reca modifiche all’articolo 1, comma 61, della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) volte ad assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas.
Tali modifiche riguardano il funzionamento del portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. Le modifiche, in particolare:
- dispongono che la trasmissione delle offerte da parte degli operatori per la loro pubblicazione nel portale delle offerte debba essere effettuata “tempestivamente” (lett. a));
- specificano le funzioni in capo al comitato tecnico consultivo costituito presso l’ARERA, prevedendo che esso svolga funzioni di confronto, oltre che di raccordo, delle istanze dei diversi portatori di interesse, inerenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico (lett. b));
- prevedono la convocazione “senza indugio” del comitato da parte dell’Autorità su istanza motivata di uno dei suoi componenti (lett. c)).
Si rammenta che il funzionamento del Portale delle offerte è stato disciplinato con deliberazione 1 febbraio 2018 51/2018/R/COM, successivamente modificato dalla deliberazione 263/2018/A. Il Comitato Tecnico Consultivo è composto da un rappresentate dell'Autorità, uno del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno delle associazioni dei consumatori non domestici, uno del CNCU ed uno degli operatori di mercato. Inoltre, è prevista la presenza di un rappresentante dell'Acquirente Unico, in qualità di uditore.
Articolo 14-bis
(Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo)
L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica. Il comma 2 del medesimo articolo prevede un decreto ministeriale che individui le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi.
Nel dettaglio, la disposizione in commento, al comma 1, prevede che, al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nel corso dell’anno 2023 in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, il fondo di cui all’art. 1, comma 369 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), ossia il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024, da destinare alle finalità di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022). All’onere di cui sopra, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (legge n. 307 del 2004).
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione (dei contributi stessi).
Si rammenta che il citato art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (attualmente Dipartimento per lo sport), un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui sopra è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
Il suddetto Fondo, come anticipato, viene rifinanziato dalla disposizione in commento di 5 milioni di euro, per il 2024, per le finalità di cui di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 144 del 2022.
Ora, il citato art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 – così come modificato, da ultimo, dall’art. 4-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito dalla legge n. 56 del 2023 – prevede, al primo periodo che, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del suddetto Fondo di cui all'art. 1, comma 369, della legge di bilancio 2028, sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la società Sport e Salute S.p.A.
Il secondo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 7, che indica le finalità del rifinanziamento in esame, prevede poi che, una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.
Il comma 2 del suddetto art. 7 del DL 144 del 2022 – non modificato dalla disposizione in esame - prevede che decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Si ricorda che gli articoli da 4 a 13 del citato decreto legislativo 39/2021 (modificato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 120 del 2023), recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, attengono all’istituzione, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche (art. 4, comma 2).
Si prevede, in particolare, che nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo 39/2021. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal Comitato italiano paralimpico (CIP). L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP (art. 5).
Per un approfondimento sui contenuti del decreto legislativo n. 39 del 2021, si rinvia all’apposito dossier redatto sul relativo schema di decreto. Per un approfondimento sul suo decreto integrativo e correttivo n. 120 del 2023, si rinvia al relativo dossier.
Articolo 14-ter
(Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l’integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)
L’articolo 14-ter, inserito durante l'esame in sede referente, prevede (comma 1, lettera a)) che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE). Viene altresì previsto (comma 1, lettera b)) che la valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità dei progetti relativi a tali interventi compete alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e viene disciplinata la valutazione di incidenza per gli interventi e le opere in questione che rientrino in siti che costituiscono la rete “Natura 2000”. Infine viene disposto (comma 2) che i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il comma 1 dell’articolo in esame – al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'art. 5 del D.L. 111/2019 (v. infra), necessari per il superamento delle procedure di infrazione relative alla depurazione delle acque reflue urbane richiamate dall'art. 3 del D.P.C.M. 7 agosto 2023 (v. infra) – reca una serie di modifiche all’art. 2 del decreto-legge 243/2016 (v. infra).
La lettera a) riscrive, integrandolo, il comma 11 dell’art. 2 del D.L. 243/2016. L’integrazione è volta a prevedere che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, d’ora in poi indicato semplicemente come Commissario unico (v. infra) opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.
La lettera b) introduce tre nuovi commi (11-bis, 11-ter e 11-quater) all’art. 2 del D.L. 243/2016.
Il nuovo comma 11-bis dispone che, ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità, è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC (istituita dall'art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006). Lo stesso comma dispone che ai relativi procedimenti si applicano tutte le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) per i progetti di cui al citato comma 2-bis.
Si ricorda che il comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell'ambiente (inserito nel testo del Codice dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, successivamente più volte modificato) – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al Codice, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica assoggettati a VIA statale – ha istituito la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma 11-ter dispone che, ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete “Natura 2000”, la valutazione di incidenza è conclusa entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorità competente un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene altresì previsto che al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altro emolumento comunque denominato, nonché che può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico.
Il comma 11-quater disciplina il caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, prevedendo che, in tale caso, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 (cioè agli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire il superamento del contenzioso in essere), può applicarsi – in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico – la disciplina di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
La richiamata disposizione prevede che “qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
Il comma 2 dell'articolo in esame riscrive il testo del comma 1 dell’art. 99 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Mentre il testo vigente si limita a demandare ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente (adottato sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive) la definizione delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, il nuovo testo (previsto dalla riscrittura operata dal comma in esame) dispone che i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
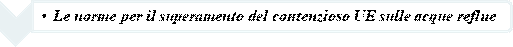
Per le inadempienze nell'attuazione della Direttiva europea 91/271/CEE (recepita dall'Italia con il D.Lgs. 152/2006), che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE, la C565-10 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e la C85-13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) ed è stata aperta una ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059).
Con la successiva sentenza del 31 maggio 2018, causa C-251/17, la stessa Corte ha condannato l'Italia, per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata.
Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2017/2181) per violazione della direttiva in questione, in particolare per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui. Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore condanna di cui alla sentenza 6 ottobre 2021, causa C-668/19.
Si ricorda che con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 243/2016, è stato nominato il prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle succitate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.
Al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso in atto con l'UE, l'articolo 4-septies del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito (al comma 1) al succitato Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'UE e quindi superare tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
Lo stesso articolo ha previsto (al comma 2) la cessazione delle funzioni dei precedenti commissari (previsti dall'art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014) e il subentro del Commissario unico in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dagli stessi.
E' inoltre previsto (dal comma 3) che le Regioni trasmettano al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica) e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione in corso, precisando la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti e che, sulla base di tale dati, il Commissario unico provveda a una ricognizione dei progetti esistenti, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi. Dovrà inoltre effettuare una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e darne comunicazione al Ministro dell'ambiente (ora Ministro della transizione ecologica).
Il comma 4 prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con cui sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assumerà il compito di soggetto attuatore. Il medesimo decreto dovrà individuare le risorse finanziarie disponibili necessarie, con riferimento anche agli interventi volti a garantire l'adeguamento alle succitate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE. In attuazione di tale comma è stato emanato il D.P.C.M. 30 settembre 2022 recante “Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore”.
Il comma 5 prevede invece che, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente, con sede presso il medesimo Ministero, mentre il comma 7 apporta una serie di modifiche all'art. 2 del D.L. 243/2016 al fine, tra l'altro, di disporre il trasferimento degli impianti alle Regioni, in mancanza degli enti di governo dell'ambito.
Ulteriori disposizioni sono state successivamente dettate dall'art. 5 del D.L. 111/2019 che (al comma 6), al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione in questione, prevede la nomina di un nuovo Commissario unico, in sostituzione di quello nominato con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, che cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario. Lo stesso articolo prevede (al comma 7) la possibilità, per il nuovo Commissario unico, di avvalersi al massimo di due sub-commissari, in relazione alla portata e al numero degli interventi, che dovranno essere nominati con apposito D.P.C.M., con oneri a carico del quadro economico degli interventi.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 11 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. del 10 giugno 2020), con cui si è provveduto alla nomina del prof. Maurizio Giugni a commissario unico e del dott. Stefano Vaccari e prof. Riccardo Costanza a sub-commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 152/2021:
- l'art. 18, comma 1- bis, integra la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 243/2016, relativa alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. L'integrazione prevista è volta a stabilire che - ai sensi dell'art. 7- bis, comma 8- bis, del D.Lgs. 152/2006 - in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione VIA, provvede alla verifica di assoggettabilità alla VIA regionale (c.d. screening) o alla VIA regionale per i progetti di competenza del Commissario;
- l'art. 18- bis, novella, introducendo commi aggiuntivi, l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. In base alle disposizioni introdotte, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio-assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede altresì il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Si segnalano inoltre le disposizioni recate dai commi 692-693 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022). Il comma 692, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'UE nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, ha autorizzato la spesa complessiva di 110 milioni di euro (10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016. Il comma 693 prevede invece che le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla CGUE nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto.
Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 (pubblicato nella G.U. dell’8 settembre 2023) si è provveduto alla nomina del prof. Fabio Fatuzzo a commissario unico e del dott. Antonino Daffinà e dell'avvocato Salvatore Cordaro a sub-commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.
L’art. 3, comma 1, di tale decreto (che viene richiamato dall'articolo in esame) dispone che il Commissario unico effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-septies, del D.L. 32/2019, e ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni.
Articolo 14-quater
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti
nella Regione Siciliana)
L’articolo in esame prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei poteri a lui attribuiti.
Il comma 1 prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Siciliana mediante decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, al fine di completare una rete impiantistica integrata che consenta una gestione del processo di smaltimento dei rifiuti improntata alla protezione della salute pubblica e dell’ambiente.
Viene prevista una durata dell’incarico di due anni, prorogabili.
Il comma 2 disciplina i poteri spettanti al Commissario straordinario di cui al comma 1.
La lettera a) definisce le modalità di adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di chiudere il ciclo dei rifiuti nella Regione Sicilia. Ciò deve avvenire a seguito di rituale svolgimento di VAS (Valutazione ambientale strategica).
A tal fine, dopo aver condotto le analisi funzionali a valutare il reale fabbisogno regionale, verrà incentivata la realizzazione e la localizzazione di nuovi termovalorizzatori che possano permettere una migliore qualità di recupero energetico.
La lettera b) prevede che il Commissario straordinario approvi, secondo le modalità di cui al comma 5 (infra) i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione del ciclo dei rifiuti, ivi compresi i termovalorizzatori di cui alla lettera a), fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006.
La lettera c) prevede che gli impianti di cui alla lettera b) vengano realizzati secondo procedure ad evidenza pubblica.
Il comma 3 prevede l’immediata efficacia sulla pianificazione d’ambito del Piano regionale di cui al precedente comma 2, adottato mediante ordinanza del Commissario straordinario.
Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del Commissario straordinario. Questi, ove necessario, può provvedere con ordinanza, derogando a tutte le disposizioni di legge ad eccezione della legge penale, facendo tuttavia salve le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. lgs. 159/2011), del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004), del codice dei contratti pubblici (D. lgs. 36/2023), nonché i vincoli normativi europei.
Le ordinanze adottate ai sensi del presente comma sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il comma 5 dispone che l’autorizzazione dei progetti, rilasciata mediante ordinanza del Commissario straordinario, sostituisce ogni ordinanza, visto, parere e nulla osta occorrenti per i lavori, salvo quelli relativi alla tutela ambientale ed a quelli relativi alla tutela dei vincoli paesaggistici e culturali, per i quali trova applicazione l’art. 4 comma 2 del D.L. n. 32 del 2019.
Tale norma prevede che per i predetti pareri, visti e nulla osta, il termine di adozione dell'autorizzazione è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Il termine viene sospeso nel caso in cui l’autorità competente chieda chiarimenti o elementi integrativi del giudizio, che si intendono acquisiti con esito positivo decorsi 30 giorni dalla produzione della documentazione. In caso di necessità di accertamenti tecnici, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.
Il comma 6 disciplina la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario che può nominare fino a due sub-commissari, il cui compenso è stimato in misura non superiore a quella indicata dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2001. L’incarico di sub-commissario ha una durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.
Il comma 7 prevede che per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022.
Il comma 8 dispone l’autorizzazione all’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse di cui al comma 9.
Il comma 9 prevede la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi.
Articolo 14-quinquies
(Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)
L’articolo 14-quinquies, inserito durante l'esame in sede referente, modifica la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, prevedendo la possibilità che la stessa possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori e disciplinando la composizione delle sottocommissioni medesime.
L’articolo in esame integra il testo del comma 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che disciplina la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, prevedendo che tale Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori.
Viene altresì disposto che la composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal Presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione e dei gruppi istruttori interni.
Si ricorda che il comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell'ambiente (inserito nel testo del Codice dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, successivamente più volte modificato) – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al Codice, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica assoggettati a VIA statale – ha istituito la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 15
(Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
L’articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all’attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.
Nel dettaglio, la disposizione in esame, interviene, modificandolo, sul comma 3, lettera c), dell’articolo 20-sexies del D.L. n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni), - convertito, con modificazioni dalla L. n. 100 del 2023 - che disciplina gli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, compresi nell’Allegato 1 annesso al richiamato D.L. n. 61 del 2023.
Le modifiche previste dalla disposizione in esame consistono:
§ nella sostituzione del riferimento ai prodotti agricoli “in corso di maturazione” con quello - più ampio - inerente la loro qualità di prodotti già raccolti, in corso di stagionatura o affinamento e di maturazione, nel caso del vino. Tale specificazione riguarda la quantificazione dei danni economici ai prodotti agroalimentari di qualità ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
§ nell’inserimento del riferimento agli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018.
Si fa presente che in materia di indicazioni geografiche è da mesi in corso di esame, da parte delle Istituzioni europee, la proposta di Regolamento (2022) COM 134 che ha ad oggetto, tra l’altro, la revisione del vigente Regolamento UE n. 1151 /2012 sopra richiamato. In particolare, il 24 ottobre scorso il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla suddetta proposta, che è stato successivamente anche approvato dal Comitato speciale Agricoltura.
Quanto all’articolo 104 del Regolamento UE n. 1038 del 2013, esso prevede che la Commissione Europea detiene e aggiorna un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo grafiche protette dei vini, accessibile al pubblico. La stessa disposizione stabilisce che le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente, possono essere registrate nel registro. L’articolo 8 del Regolamento 2019/33 riguarda la disciplina della protezione nazionale transitoria in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
Il succitato articolo 20-sexies del D.L. 61 del 2023 in materia di ricostruzione privata, individua i parametri per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali, cui destinare contributi, distinguendo tra quelli di immediata riparazione, quelli di ripristino o ricostruzione puntuale delle strutture e quelli di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati. Il comma 3, in particolare, definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all’articolo 20-ter del predetto D.L. n. 61 del 2023.
Tali contributi, che possono concorrere fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle diverse tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi metereologici nei sopra richiamati territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, compresi nell’Allegato 1 annesso al decreto n. 61 del 2023.
La succitata lettera c) fa riferimento, nella versione precedente alla disposizione in esame, ai danni economici subiti da prodotti agricoli e alimentari di qualità ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre.
Si ricorda, infine che, tra le altre tipologie di interventi e danni menzionati dall’articolo 20-sexies comma 3 sono compresi:
a) danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
b) danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;
c) danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;
e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità;
f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
g) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all’articolo 20-bis.
Articolo 16
(Deroga ai requisiti minimi di efficienza
per la ricostruzione a seguito di alluvione)
L’articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l’obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.
L’articolo 16 stabilisce una deroga nei casi di ricostruzione privata previsti all’articolo 20-sexies del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni), che disciplina gli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
L’articolo 20-sexies del D.L. 61/2023 individua i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio privato danneggiato e definisce i criteri sulla base dei quali assicurare l’erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda del dossier sul D.L. 61/2023.
La deroga introdotta dalla disposizione in esame esclude l’applicazione dei requisiti minimi di efficienza energetica, indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 192/2005 (recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato in seguito agli eventi calamitosi.
Tale deroga non si applica nel caso di demolizione e ricostruzione del patrimonio privato.
L’articolo 4 del richiamato D. Lgs. 192/2005, che disciplina l’adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica del patrimonio edilizio, è stato attuato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), che prevede il rispetto di determinati requisiti minimi energetici nel caso di costruzione di nuovi edifici e· di ristrutturazione degli edifici esistenti, tenendo conto dei criteri generali riportati allo stesso articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del citato D. Lgs. 192/2005.
La Relazione illustrativa giustifica l’intervento in esame ritenendo “inopportuno porre in capo ai cittadini colpiti da calamità l’onere obbligatorio degli adeguamenti richiesti dal decreto legislativo 192/2005. Infatti, in tali casi, l’obbligo di adeguamento alla normativa in materia di requisiti minimi non sorge a seguito della decisione volontaria di eseguire una manutenzione straordinaria sul proprio edificio, ma in ragione di riparare i danni prodotti da eventi calamitosi. Peraltro, laddove tale obbligo dovesse scattare in capo ai cittadini, sicuramente si genererebbero dei contenziosi”.
La medesima relazione conclude, inoltre, che “fatta salva la possibilità di incrementare le risorse pubbliche per la ricostruzione, da destinare ai costi necessari per il rispetto dei requisiti minimi in materia di efficienza energetica, che garantirebbero al contempo il miglior rapporto tra costi e benefici, si ritiene che tali adeguamenti debbano poter essere eseguiti in maniera volontaria, e non obbligatoria”.
Articolo 17
(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese
agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi
nei mesi di ottobre e di novembre 2023)
L’articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo- di cui all’articolo 5, D. Lgs. n.102/2004 - anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative (comma 1). Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (comma 2).
Più nel dettaglio:
il comma 1 - in deroga all’articolo 5, comma 4, primo periodo, del D. Lgs. n. 102/2004 – prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva, di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 102/2004, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni nei limiti di 6 milioni di euro.
Si ricorda che l’articolo 5, comma 4, primo periodo, del D. Lgs. n. 102/2004 prevede che sono esclusi dalle agevolazioni previste i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.
Inoltre, in deroga a quanto disposto dal presente comma 4, si segnala anche l’articolo 11, comma 1, D.L. n. 104/2023, destinato ad imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole.
L’articolo 2135 del codice civile qualifica come imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
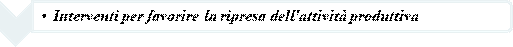
Possono beneficiare di questa tipologia di intervento le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
Al tal fine possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento (48);
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (49);
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8.
In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all’80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. (50)
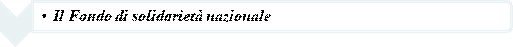
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102/2004 – è chiamato ad intervenire per prevenire danni alle produzioni agricole e zootecniche, danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, per eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti.
Gli interventi del Fondo – che opera con due sezioni: Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi e Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori (articolo 15) - sono di tre tipologie:
§ misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;
§ interventi compensativi ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura - di cui all’articolo 4 - finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni calamità naturali (avversità atmosferiche, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti), nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
§ interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.
Inoltre sono disciplinati anche interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato.
Il comma 2 prevede che la regione Toscana - anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 102/2004 (entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso) - può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 102/2004, al fine di attivare gli interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva di cui all’articolo 5, prevede che le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.
Articolo 18
(Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 29 ottobre 2023)
L’articolo 18, al comma 1, modificato in sede referente, dispone l’applicazione - nei territori della Regione Toscana interessati condizioni metereologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis” e in esenzione dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l’attuazione degli interventi, il comma demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana.
Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 destina risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Nel dettaglio, il comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva, dispone che nei territori della Regione Toscana di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, e– secondo quanto introdotto in sede referente – di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 - si applica il regime di aiuto per le aree di crisi industriale – di cui al D.L. n. 120/1989 (L. n. 181/1989) - limitatamente a quanto disciplinato dal D.M. del 24 marzo 2022, e ai sensi di quanto previsto:
§ dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE e
§ dal Regolamento 2023/2831/UE sugli aiuti di stato «de minimis», che esenta taluni aiuti di piccolo importo dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.
La delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata in G.U. del 13 novembre 2023, reca la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 2 novembre 2023.
La delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 ha disposto l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023.
Il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013. L’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e ss. mod. e int., ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa (articolo 27, commi 1-8) sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa (articolo 27, comma 8-bis, inserito dall’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013). Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022 come da ultimo modificato dal D.M. 10 novembre 2023 e la circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022 come da ultimo modificata dalla circolare direttoriale 21 dicembre 2023, n. 4242, hanno stabilito nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa, di cui alla Legge n. 181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa. Il D.M. dispone il rispetto dei princìpi generali e delle specifiche condizioni fissate nel Regolamento 651/2014/UE GBER, come recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023. Le imprese beneficiarie del regime di aiuto possono chiedere di accedere ad un sostegno finanziario per iniziative:
o finalizzate alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione e progetti per la formazione del personale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro possono essere completati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
o che comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Il sostegno finanziario è riconosciuto nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal GBER. Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili.
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato. Il loro importo complessivo massimo è determinato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Per un dettaglio, si rinvia al box successivo.
Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato de minimis, a decorrere dal 1° gennaio 2024, opera invece il nuovo Regolamento 2023/2831/UE, il quale trova applicazione fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste. Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che - in caso di trasformazione dei prodotti agricoli - l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Il Regolamento non si applica:
· agli aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso Stati intra e extra UE, o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
· agli aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione (articolo 1).
Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa (o per impresa unica[23]), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina ancora attualmente vigente.
Quando la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporta il superamento dei massimali, le nuove misure non possono beneficiare del «de minimis» (articolo 3).
Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.
Ai fini del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, i cui valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (ESL).
I prestiti beneficiano del regime “de minimis” se:
a) il beneficiario non è in procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa, secondo il diritto interno, le condizioni per accedervi su richiesta dei creditori (le grandi imprese devono trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-») e
b) fino a 1,5 milioni di euro su un periodo di cinque anni o a 750 mila euro per un periodo di dieci anni assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del prestito stesso; o
c) l’ESL è calcolato sulla base dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto.
Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale o sotto forma di misure per il finanziamento del rischio (investimenti in equity o quasi-equity), rientrano nel Regolamento “de minimis” se, rispettivamente, l’apporto pubblico nel primo caso, o il capitale fornito nel secondo caso, non superano i 300 mila euro in 3 anni.
Quanto al cumulo, gli aiuti «de minimis» concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio quando il cumulo supera le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5).
Per disciplinare l’attuazione degli interventi, il comma 1 dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) sottoscriva con la regione Toscana un apposito accordo di Programma.
Circa la stipula dell’accordo di programma e gli effetti ad esso ascritti dalla richiamata disciplina di cui al D.M. 24 marzo 2022, si rinvia al box ricostruttivo infra.
Infine, il comma 2, per le finalità dell’articolo, destina le risorse disponibili - sino a un massimo di 50 milioni di euro - che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Il D.M. 23 aprile 2021 ha quantificato (a quella data) in 661,6 milioni di euro le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile (Fondo presso il quale sono iscritte le risorse per l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui alla L. n. 181/1989) ma non ancora programmate. Conseguentemente, ha ripartito l’importo non ancora programmato nel seguente modo:
§ 210 milioni per interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa
§ 451,6 milioni ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello.
La relazione tecnica al provvedimento in esame rileva che le risorse attribuite alle aree di crisi industriale non complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione; risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l’importo di euro 251.642.835,66, sul quale si provvede alla copertura dell’onere previsto dall’articolo qui in esame.
L’importo di euro 251.642.835,66 è al netto dei 100 milioni già stanziati per i territori alluvionati di maggio scorso dall’articolo 20-undecies del D.L. n. 61/2023. L’articolo 20-undecies, in particolare, reca un intervento pedissequo a quello in esame, a sostegno nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, destinando, appunto, fino a 100 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2021.
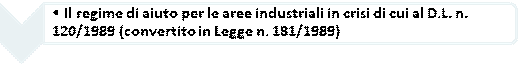
Si è sopra accennato che il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato da ultimo riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013.
In particolare, l’articolo 27 del D.L. 83/2012 prevede, al comma 1, che, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MiMiT adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) e demanda al Ministero delle imprese e del made in italy il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di apposita istanza presentata dalla regione interessata, per specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
§ una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
§ una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Ai sensi del comma 2, i progetti promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Ai sensi dei commi 3 e 4, i progetti di riconversione e riqualificazione sono adottati tramite accordi di programma (di cui all’articolo 15 della L. n. 241/1990)
Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le conferenze di servizi strumentali all’attuazione del progetto sono indette dal MIMIT.
La disciplina agevolativa contempla la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.
Il comma 5, infatti dispone che la concessione di agevolazioni per l’incentivazione degli investimenti di cui al D.L. 120/1989, incluse quelle sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, in via prioritaria nell’ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale di situazioni di crisi industriale complessa, nonché per gli interventi agevolativi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina europea per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5)[25].
È stato demandato al MIMIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l’attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8).
Il soggetto gestore della misura è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) cui il Ministero impartisce direttive prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.
Quanto alle aree di crisi non complessa, il comma 8-bis dell’articolo 27, inserito dall’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013, ha demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. Con decreto direttoriale 19 dicembre 2016 il Ministero ha pubblicato l’elenco dei territori che possono accedere alle agevolazione per le aree di crisi industriali non complesse.
Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022 ha stabilito nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale di cui alla Legge n. 181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa (D.M. 30 agosto 2019 e circolare ministeriale 16 gennaio 2020, n. 10088, come modificata dalla circolare direttoriale 26 maggio 2020, n. 153147).
Il decreto stabilisce, in particolare, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali complesse e non complesse (articolo 1), demandando (articolo 4 e 5, comma 14) ad un’apposita circolare esplicativa (Circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022) la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.
È data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
A tale proposito, il D.M. dispone che il soggetto gestore operi nel rispetto dei princìpi generali del Regolamento 651/2014/UE GBER (articolo 2, comma 2. Sui compiti del soggetto gestore, cfr. anche articolo 3). Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all’articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, le quali, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso di una serie di requisiti dettagliati nell’articolo 4)
Sono ammissibili alle agevolazioni:
· i programmi di investimento produttivo, nel rispetto degli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER (articoli 13,14, e 17), diretti a:
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;
b) l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti;
d) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, punto 49, del Reg. GBER (articolo 5, comma 3 -5) -
· i programmi di investimento per la tutela ambientale i quali devono essere conformi al Regolamento GBER (artt. da 36 a 47) e devono essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale delle attività dell’impresa;
b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione non ancora in vigore che innalzano il livello di tutela ambientale;
c) ottenere una maggiore efficienza energetica;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
f) risanamento di siti contaminati;
g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (articolo 5, comma 6);
· i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione (se conformi all’articolo 29 del regolamento GBER). Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti devono essere realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e le PMI coinvolte devono sostenere almeno il 30% dei costi ammissibili del progetto (articolo 5, comma 7);
· i progetti per la formazione del personale (se conformi all’articolo 31 del regolamento GBER). Tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalità del programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale (articolo 5, comma 8).
· i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (se conformi all’articolo 25 GBER), finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale (articolo 5, comma 9).
I programmi devono essere sviluppati nei seguenti settori economici a) estrazione di minerali da cave e miniere; b) attività manifatturiere; c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo (e in conformità all’articolo 17 del GBER) ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale; d) attività dei servizi alle imprese; e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva (articolo 5, comma 10).
Nel caso in cui l’intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest’ultimo, nei limiti dei vincoli in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l’applicazione dell’intervento, nonché prevederne una limitazione a specifici settori (articolo 5, comma 11).
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento produttivo devono:
a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi;
b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro. (per le imprese partecipanti alla rete, non inferiori a 400 mila euro);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
d) essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni, pena la revoca, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a dodici mesi, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria;
e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, caratterizzato da un incremento degli addetti.
Nei casi in cui l’intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall’accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell’unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L’accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali (articolo 5, commi 12-14).
Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. La durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, massimo di tre anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato. Il rimborso deve seguire un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato I finanziamenti relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili pari o superiori a 10 milioni di euro devono essere assistiti da garanzie reali.
Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite.
Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla spesa concedibili.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell’eventuale partecipazione transitoria al capitale dell’impresa (consentita alle condizioni dell’articolo 8, comma 1), non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili (per un dettaglio, si rinvia all’articolo 7).
Quanto alle risorse finanziarie, si rammenta che la misura in esame è stata più volte rifinanziata, da ultimo con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, co. 80-81) ha incrementato la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l’anno 2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse (complessivamente pari, nel periodo 2021-2026 a 320 milioni di euro) alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012. Il Fondo è stato finanziato anche con le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» FESR.
Il D.M. 23 aprile 2021 ha quantificato complessivamente le risorse in euro 661.642.835,66 provvedendo al relativo riparto fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.
Articolo 18-bis
(Disposizioni in favore dei territori della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)
L’articolo 18-bis, inserito durante l'esame in sede referente, prevede l’esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
L’articolo in esame modifica il comma 560 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che prevede l’esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tale esenzione opera per l'anno 2024 o fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024.
La modifica è volta ad estendere l’esenzione in questione a tutti i territori della regione Umbria (quindi non solamente al territorio del comune di Umbertide) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant’Orfeto del comune di Perugia. La successiva delibera del 31 maggio 2023 ha disposto l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023 al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.
Articolo 19, comma 1
(Riutilizzo dei materiali di dragaggio )
L’articolo 19, comma 1, consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l’emanazione di un regolamento ministeriale, per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.
Il comma 1 dell’articolo 19 apporta modificazioni all’art. 184-quater del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) al fine di:
§ sopprimere, al comma 5-bis, il riferimento alle ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter;
§ e abrogare il comma 5-ter.
L’intervento, in sostanza, è rivolto a eliminare la previsione, contenuta nel citato comma 5-ter, secondo cui deve essere adottato un decreto ministeriale che disciplini le norme tecniche in materia di opzioni di riutilizzo dei materiali di dragaggio, dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili, che in base a determinati requisiti e condizioni cessano di essere rifiuti.
Più in particolare, i commi 5-bis e 5-ter dell’art. 184-quater, introdotti dall’art. 4, comma 6-quater del D.L. 121/2021, disciplinano il riutilizzo dei materiali derivanti dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, prevedendo l’adozione di un decreto per disciplinare le norme tecniche in materia di opzioni di riutilizzo.
Secondo la relazione illustrativa, l’intervento in esame, che abroga la norma che prevede l’emanazione del suddetto decreto ministeriale, è necessario in quanto le norme tecniche in questione risultano oggetto di un decreto ministeriale che semplifica la disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, emanato ai sensi dell’articolo 48 del D.L. 13/2023, di prossima pubblicazione al termine della consultazione pubblica in atto.
Specificatamente, il comma 5-bis dell’art. 184-quater, al fine di promuovere gli investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, consente alle amministrazioni competenti di autorizzare il riutilizzo, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, dei materiali derivanti dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, condotta secondo la disciplina vigente in materia stabilita all’articolo 109 del Codice dell’ambiente, che disciplina l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, e all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), che reca norme sulle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite al successivo comma 5-ter.
A tale riguardo, il comma 5-ter dell’art. 184-quater ha previsto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, l’emanazione di un decreto per le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.
In tema, l’art. 6-bis del D.L. 77/2021 (Governance del PNRR) ha previsto l’emanazione con decreto ministeriale (non ancora pubblicato in G.U.) di un Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.
L’art. 48 del D.L. 13/2023 prevede che con l’emanazione del decreto di semplificazione, il cui schema, come detto, è attualmente in fase di consultazione pubblica, si intervenga in materia di:
- gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
- abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 e l’aggiornamento delle disposizioni da esso previste tramite l’adozione del decreto oggetto della consultazione.
Articolo 19, comma 2
(Abrogazione articolo 33-ter D.L. 77/2021 – riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico)
L’articolo 19, comma 2 dispone l’abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico.
L’articolo 19, comma 2, dispone l’abrogazione dell’articolo 33-ter del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (L. n. 108/2021), che demanda ad un decreto interministeriale la rideterminazione del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico.
In particolare, l’articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 demanda ad un decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica (Ministero ora ambiente e sicurezza energetica), da adottare su proposta dell’ARERA, la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali, prevedendo a tale fine che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori. Sebbene la norma non lo abbia affermato esplicitamente, la problematica relativa alla riscossione è relativa al sistema elettrico. Il termine per la riforma delle modalità di riscossione è stato fissato da ultimo con l’art. 11, comma 5-octies del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022) al 30 giugno 2022. L’ARERA, con Deliberazione 17 maggio 2022, n. 216/2022/R/eel, ha presentato ai Ministri interessati una proposta di riforma.
La relazione illustrativa afferma che “le soluzioni individuate sono state esaminate da ciascuna delle amministrazioni coinvolte, anche congiuntamente, e non sono state ritenute percorribili per gli impatti amministrativi ed economici che comporterebbero sul sistema”.
Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta[30] volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative, che attengono allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ma anche a misure di politica sociale (per esempio, i bonus sociali) e di politica industriale (per esempio, le agevolazioni per imprese energivore o alla trazione ferroviaria, esclusi i servizi sulla rete Alta Velocità) in qualche modo correlate ai sistemi energetici.
Il D.lgs. 79/1999 – all’articolo 3, comma 11- ha istituito gli oneri generali del sistema elettrico come “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica pagati in bolletta. Quanto al meccanismo di riscossione, i fornitori (ossia i venditori) fatturano e riscuotono dai propri clienti finali gli oneri generali, con le altre voci che compongono la bolletta. I fornitori, a loro volta, pagano gli oneri generali ai distributori nelle fatture del servizio di trasporto. I distributori, quindi, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 36 del “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” TIT, versano, con cadenza mensile, il gettito degli oneri generali (componente ASOS e ARIM della bolletta, cfr. infra) in appositi conti presso la Cassa per i servizi energetico ambientali CSEA, la quale li destina alle diverse finalità definite dalla legge. I conti aperti presso CSEA sono molteplici e indicati nell’articolo 41 del Testo integrato. La molteplicità dei conti è dovuta al fatto che, come sopra illustrato, sono molteplici le finalità per le quali sono riscossi gli oneri generali di sistema.
Si rammenta come svariate sentenze del giudice amministrativo abbiano individuato nel cliente finale l’unico soggetto tenuto a pagare gli oneri generali di sistema (cfr. Consiglio di Stato, Sez VI, sent. 2182/2016; Tar Lombardia, Sez. II, sent.237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent.5619/2017 e 5620/2017). Le statuizioni giurisprudenziali hanno in sostanza ribaltato il principio generale di metodo impostato dall’ARERA, che poneva in capo ai venditori e ai distributori l’eventuale rischio legato alla morosità della propria controparte (per i venditori, dei clienti finali, e, per i distributori, dei venditori). Pertanto, i venditori - secondo le sentenze sopra richiamate - sono tenuti a versare ai distributori solo quanto effettivamente incassato dai clienti finali.
Appare peraltro opportuno evidenziare che sul sistema di riscossione incide la fiscalizzazione di quota parte degli oneri di sistema, attualmente in itinere.
In particolare, con la fiscalizzazione degli oneri di sistema afferenti al decommissioning nucleare e alle relative misure di compensazione territoriale disposte dalla legge di bilancio 2023, le relative sotto componenti tariffarie prima pagate in bolletta elettrica (componente tariffaria A2RIM e componente AmctRIM) hanno cessato di esistere, in quanto il relativo onere è spostato sul bilancio statale. I conti presso CSEA (il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, e il conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale), invece, rimangono, ma le risorse che li alimentano provengono direttamente dal bilancio dello Stato.
Articolo 19, comma 3
(Efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)
L’articolo 19, comma 3, sopprime la previsione dettata dall’art. 19-ter del D.L. 17/2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali.
Il comma 3 dell’art. 19 abroga l’articolo 19-ter del D.L. 17/2022, che nel testo previgente prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, per stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali.
La Relazione illustrativa spiega che l’intervento in esame risulta necessario in quanto, in materia di illuminazione pubblica, trovano applicazione svariate norme tecniche (in particolare: UNI 11248; UNI 10819:2021; UNI 11431:2021; il decreto ministeriale del 28 marzo 2018 che disciplina i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica), che riscontrano la presenza di criteri già stabiliti relativamente ai dispositivi e alla strumentazione del sistema di illuminazione pubblica.
La medesima Relazione rappresenta, inoltre, che la predisposizione del decreto de quo presenta notevoli criticità derivanti dalla mancanza di conoscenza dello stato dell’illuminazione pubblica degli enti locali, il che rende particolarmente complessa la definizione di una disciplina non discriminatoria, in termini di obblighi di efficientamento energetico, soprattutto in considerazione della probabile eterogeneità delle diverse situazioni territoriali. Tra l’altro, l’onere di adeguamento sarebbe posto a carico delle amministrazioni pubbliche locali (regioni, province e comuni).
L’art. 19-ter del D.L. 17/2022 ha previsto che, al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di incremento dell’efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull’ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri: a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l’affievolimento dell’intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli; b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica; c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all’applicazione e all’utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
Articolo 19, comma 4
(Abolizione della possibilità per il Ministero dell’ambiente di accedere alle informazioni relative ai mercati elettrico e del gas)
L’articolo 19, comma 4, prevede l’abrogazione della disposizione (introdotta con il decreto-legge 176/2022) che consente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di accedere, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas.
Il comma in esame prevede l’abrogazione del comma 1-ter dell’art. 11 del D.L. 176/2022, che dispone che il MASE accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell’economia e delle finanze.
La disposizione recata dal comma 1-ter prevede inoltre, in relazione al citato accesso, l’emanazione di un decreto ministeriale (a tutt’oggi non avvenuta) per la definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.
In relazione al succitato sistema informatico, si ricorda che lo stesso è stato istituito, presso l’Acquirente unico S.p.a., dall’art. 1-bis del D.L. 105/2010, al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale. Lo stesso articolo dispone che tale Sistema informatico è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.
L’art. 22 del D.L. 1/2012 ha inoltre stabilito, al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e del gas, che tale Sistema informatico integrato è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e che la banca dati succitata raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.
Le norme richiamate hanno demandato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA) l’emanazione dei criteri generali per il funzionamento del Sistema nonché la definizione delle modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema medesimo. Si rinvia in proposito alla sezione “Sistema informativo integrato – SII” del sito web dell’ARERA.
La relazione illustrativa segnala che l’abrogazione del citato comma 1-ter è disposta “considerato che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica può già accedere, tra l’altro, alle ‘informazioni rilevanti ai fini dell’attività di governo che si rendano di volta in volta necessarie’, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Articolo 19, comma 4-bis
(Regolamentazione dell’erogazione di incentivi da parte del GSE e dei connessi flussi informativi)
L’articolo 19, comma 4-bis abroga la norma che prevede la disciplina con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dei rapporti tra Acquirente Unico S.p.A. e GSE nell’ambito della regolamentazione del sistema di misura dell’energia elettrica da fonti rinnovabili per l’attribuzione degli incentivi.
Il comma 4-bis dell’articolo 19, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, modifica l’articolo 36 del D.Lgs. n. 199/2021 che, al comma 1 prevede, al fine di fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore elettrico, l’adozione di uno o più provvedimenti dell’ARERA per l’individuazione delle modalità con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico.
Si dispone che, con tali provvedimenti, siano definite le modalità con cui i gestori di rete possono trasmettere i dati di misura effettivamente rilevati sui nuovi impianti di produzione o rettificare le informazioni relative alla produzione degli impianti in esercizio, le modalità con le quali il GSE effettua verifiche di congruità sui dati trasmessi dai gestori di rete rispetto alla producibilità attesa e alla potenza massima erogabile, nonché le modalità con le quali i dati delle misure di produzione e immissione degli impianti fornite dai gestori di rete confluiscono all'interno del Sistema informativo Integrato istituito presso Acquirente unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105.
L’articolo 1-bis del D.L. n. 105/2010 (L. n. 129/2010) ha istituito il Sistema informativo integrato (SII), ossia un sistema informatico centralizzato, basato su una banca dati dei punti di riconsegna dei clienti finali, per “la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas”; il SII è gestito dalla società Acquirente unico S.p.A., mentre ARERA ne disciplina le modalità di funzionamento, e, in quanto competente alla regolazione dei servizi, regola gli specifici flussi informativi attraverso i quali, soltanto gli operatori dei mercati - al dettaglio e all’ingrosso - possono interagire tra loro al fine di attuare le prestazioni disciplinate dall’Autorità funzionale alla esecuzione fisica ai contratti di compravendita.
Le modalità di funzionamento del SII sono state definite, in termini generali, con la deliberazione ARG/com 201/2010 – sulla base della quale Acquirente Unico ha adottato il relativo Regolamento di funzionamento.
La norma in commento abroga il comma 2, che prevede la definizione, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle modalità con le quali sono disciplinati i rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE e le modalità di accesso all'infrastruttura informatica.
Articolo 19, comma 4-ter
(Superamento del Prezzo Unico Nazionale)
L’articolo 19, comma 4-ter fissa al 1° gennaio 2025 il termine a partire dal quale ai clienti finali si applicano i prezzi zonali e prevede l’istituzione di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell’eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale.
Il comma 4-ter dell’articolo 19, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, modifica l’articolo 13 del D.Lgs. n. 210/2021, in materia di formazione dei prezzi nei mercati dell’energia elettrica, che prevede il superamento del prezzo unico nazionale.
In particolare, la lettera a), modificando il comma 1:
- fissa al 1° gennaio 2025 il termine a partire dal quale ai clienti finali si applicano i prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;
- prevede l’istituzione di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all’efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell’eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale.
Ai fini dell’adozione del decreto attuativo del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione ai clienti finali dei prezzi zonali e, secondo quanto previsto dalla norma in commento, anche gli indirizzi da rivolgere all’ARERA per l’istituzione del suddetto meccanismo transitorio di perequazione, non si prevede più il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La lettera b), invece, abroga il successivo comma 2 che prevedeva l’elaborazione da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi di RSE S.p.A., di un rapporto relativo all'impatto sui mercati dell'energia elettrica della modifica del mix tecnologico di generazione, per effetto della crescita della generazione da fonti rinnovabili e delle prospettive di sviluppo della partecipazione attiva della domanda nei mercati, dello sviluppo delle reti, nonché dell'impatto del passaggio ai prezzi zonali sui clienti finali e dell'esigenza di adeguamento degli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili.
Articolo 20
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 20 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 21
(Entrata in vigore)
L’articolo 21 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge in esame il 10 dicembre 2023.
L’articolo 21 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, intervenuta il 9 dicembre 2023.
Pertanto, il decreto-legge è entrato in vigore il 10 dicembre 2023.
L’articolo 21, inoltre, prevede la presentazione del decreto-legge alle Camere per conversione in legge.
Il decreto-legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 9 dicembre 2023 e dovrà essere convertito in legge entro il 7 febbraio 2024, ossia entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
![]()
![]() @SR_Studi
@SR_Studi 
![]() @CD_attProd
@CD_attProd![]() @CD_ambiente
@CD_ambiente