Articolo 1
(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)
L’articolo 1 modifica l’art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l’accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l’autorizzazione o la convalida del giudice. L’intervento normativo è determinato dall’esigenza di dare urgente seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Nel corso dell’esame in sede referente, la Commissione di merito ha apportato alcune modifiche al testo, inserendo una disposizione che sanziona con l’inutilizzabilità l’acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge ed introducendo una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l’accertamento dei gravi o specifici reati.
Un’ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere “specifiche”.
Anzitutto, si ricorda che l’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) disciplina la data retention, ovvero l’obbligo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per 24 mesi i dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi i dati relativi al traffico telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta, per finalità di accertamento e repressione di reati (commi 1 e 1-bis).
In deroga a questa disciplina, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo (di cui agli artt. 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.), il termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in 72 mesi dall’art. 24 della legge n. 167 del 2017.
Anche se l’obbligo di conservazione riguarda i dati di traffico (c.d. tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, appare evidente come si tratti comunque di dati personali, idonei a rivelare molto della vita privata dell’utente, verificandosi quindi una contrapposizione tra la tutela della privacy e le finalità di giustizia.
Il bilanciamento tra questi due valori è realizzato dal comma 3 dell’art. 132 prevedendo che l’acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuato con decreto motivato del pubblico ministero, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'indagato può anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito; la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive. In tutti gli altri casi, l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) tramite il Garante (ai sensi dell’art. 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del d.lgs. n. 196 del 2003).
Come chiariscono le premesse del decreto-legge, il Governo interviene con urgenza sull’art. 132 del Codice per la protezione dei dati personali per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale.
La richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha affermato, infatti, il principio che l’accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all’ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente (diversa dall’autorità che chiede l’accesso ai dati).
Nello specifico la Corte, interpellata in via pregiudiziale per un caso sorto in Estonia, dove un imputato era stato condannato sulla base di una copiosa raccolta di dati personali generati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, ha ritenuto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letta alla luce della normativa comunitaria:
- osti ad una normativa nazionale, la quale permetta l’accesso delle autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica;
- osti ad una normativa nazionale che renda il pubblico ministero competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione al fine di condurre un’istruttoria penale. Secondo la Corte è intatti essenziale che l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. In considerazione della particolare delicatezza della questione, la Corte afferma che il requisito di indipendenza che l’autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l’accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.
La normativa nazionale, di cui all’art. 132 del Codice, non pare conforme al primo principio enunciato dalla Corte di Giustizia, posto che consente l’accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato.
Inoltre, dubbi sono sorti anche in relazione alla conformità con l’ordinamento UE dell’acquisizione a seguito di semplice richiesta del PM, senza il vaglio del giudice, con conseguenti incertezze anche della giurisprudenza circa l’applicabilità attuale dell’art. 132.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge riporta la recente sentenza n. 28523 del 22 luglio 2021, ric. Lordi, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che l'attuazione nell'ordinamento dei princìpi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento legislativo che dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha esposto in termini passibili di diverse modalità di attuazione.
Conseguentemente, il decreto-legge interviene sull’art. 132, comma 3, del Codice della privacy consentendo l’accesso ai dati di traffico solo nell’ambito di indagini penali per i seguenti reati:
§ reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 c.p.p. (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale). Si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l’accesso alle intercettazioni. Si ricorda, infatti, che l’art. 266 c.p.p. consente l’intercettazione, tra l’altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».
§ reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».
Anche l’art. 266 c.p.p. consente espressamente le intercettazioni nelle indagini relative a «reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono».
In merito, la Relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea l’esigenza di tenere conto «del fatto che vi sono specifici reati, la cui pena edittale è inferiore, per i quali, però, la principale, se non unica, modalità di accertamento è da rinvenire esattamente nei dati del traffico telefonico (oltre che, quando la condotta è in atto, nelle intercettazioni telefoniche): reati che, al di là del dato sanzionatorio, possono, però, in concreto manifestarsi come particolarmente gravi per beni primari della persona, soprattutto allorché prodromici a condotte estremamente più serie (di aggressione fisica), che spesso ne costituiscono lo sviluppo concreto, prevenibili solo a mezzo di mirati e tempestivi accertamenti. Per questo, per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone posti in essere col mezzo del telefono, si è derogato al limite di pena edittale indicato; tuttavia, anche in questo caso, come ulteriore limite, si è imposta una valutazione, in concreto questa volta, della gravità delle condotte di minaccia, molestia o disturbo, allo scopo di confermare l'esigenza di un rapporto di proporzionalità tra l'atto di indagine e i diritti compressi con esso».
Il decreto-legge consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi – che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica – l’acquisizione dei dati di traffico, subordinandola però al requisito della “gravità” della minaccia, della molestia o del disturbo.
Con la modifica del comma 3 dell’art. 132 del Codice, il decreto-legge individua inoltre ulteriori presupposti per l’acquisizione dei dati di traffico:
§ in relazione ai suddetti reati, l’autorità inquirente deve aver già acquisito “sufficienti indizi”;
§ i dati di traffico devono apparire “rilevanti” ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel corso dell’esame in sede referente, la Commissione Affari costituzionali ha previsto che i dati di traffico debbano essere rilevanti per l’accertamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini.
Appare evidente la scelta del legislatore di considerare comunque l’acquisizione dei dati di traffico meno penetrante rispetto alle intercettazioni, per le quali l’art. 267 c.p.p. prevede “gravi indizi di reato” e richiede che il mezzo di prova sia “assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”.
Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di Giustizia, e dunque la procedura per l’acquisizione dei dati, il decreto-legge, così come modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede:
§ che i dati possano essere acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del PM o istanza del difensore dell’indagato, della persona offesa o di un’altra parte (comma 3). La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all’art. 24 della legge n. 167 del 2017, v. sopra). Il decreto-legge, sostituendo il comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l’accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice;
§ che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell’acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il PM possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis). Il testo del decreto-legge prevede che se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possano essere utilizzati; la Commissione ha eliminato questo periodo, avendo inserito una previsione più ampia al nuovo comma 3-quater dell’art. 132 (v. infra).
La formulazione del nuovo comma 3-bis ricalca il contenuto dall’art. 267, comma 2, c.p.p. che, in relazione alle intercettazioni prevede che il PM quando agisce in via d’urgenza debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore.
Inoltre, il decreto-legge inserisce nell’art. 132 del Codice della privacy il nuovo comma 3-ter, che riproduce una previsione già contenuta nell’ultimo periodo del comma 3 (conseguentemente soppressa), e volta a prevedere che l’interessato possa esercitare i propri diritti relativi al trattamento dei dati personali solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell’art. 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del d.lgs. n. 196 del 2003).
La Commissione di merito ha inserito nell’art. 132 un ulteriore comma 3-quater che sanziona con l’inutilizzabilità l’acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge.
Il decreto-legge non prevedeva una disciplina transitoria, e dunque non disciplinava l’utilizzabilità dei dati acquisiti prima della sua entrata in vigore. La Commissione è intervenuta per introdurre una specifica disciplina relativa all’utilizzabilità, a carico dell’imputato, dei dati di traffico telefonico, telematico e relativi alle chiamate senza risposta, acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge (30 settembre 2021). Con l’inserimento nell’art. 1 del decreto-legge del comma 1-bis, la Commissione ha previsto che tali dati potranno essere utilizzati contro l’imputato solo:
§ unitamente ad altri elementi di prova;
§ per l’accertamento dei gravi o specifici reati per i quali il decreto-legge ora consente l’acquisizione (reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi).
La norma transitoria non disciplina dunque l’utilizzabilità di tutti i dati di traffico; per i dati che possano essere utilizzati a vantaggio dell’imputato si applica quindi la disciplina vigente al momento dell’acquisizione (tempus regit actum).
Infine, nel corso dell’esame in sede referente, la Commissione ha inserito - nell’articolo 1 - il comma 1-ter con il quale interviene sull’art. 267 del codice di procedura penale con particolare riferimento al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan). Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo dell’art. 267, comma 1) che impone al giudice di indicare, in sede di autorizzazione all’uso del trojan, le “ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini”, la Commissione ha aggiunto che tali ragioni devono essere “specifiche”.
| Normativa previgente |
D.L. n. 132/2021 |
A.C. 3298-A |
| Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) Art. 132 Conservazione di dati di traffico per altre finalità |
| 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. |
1. Identico. |
1. Identico. |
| 1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. |
1-bis. Identico. |
1-bis. Identico. |
| [2 – abrogato] |
|
|
| 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. |
3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. |
3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l’accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. |
| |
3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. |
3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. |
| (V. sopra, comma 3, ult. periodo) |
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. |
3-ter. Identico. |
| |
|
3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati. |
Normativa vigente |
A.C. 3298-A |
| Codice di procedura penale |
| Art. 267 Presupposti e forme del provvedimento |
| 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. |
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. |
| omissis |
|
Articolo 2, comma 1
(Disposizioni urgenti in materia di difesa)
L’articolo 2, comma 1, novella l’articolo 25 del Codice dell’ordinamento militare di cui la decreto legislativo n. 66 del 2010 concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della Difesa.
Nello specifico, scopo dell’intervento legislativo è quello di consentire il conferimento dell’incarico di Capo di stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio “automatico” ai sensi del comma 4 dell’articolo 1094 (cfr. infra).
Al riguardo, si ricorda, che l’articolo 25 del Codice dell’ordinamento militare, nel testo antecedente l’entrata in vigore del decreto legge, prevedeva che il Capo di stato maggiore della difesa venisse scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare.
A sua volta il comma 4 dell’articolo 1094 (richiamato dalla nuova formulazione dell’articolo 25 del Codice), prevede che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.
| Normativa previgente |
A.C. 3298-A |
| Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) |
| Art. 25
Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa |
| 1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. |
1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell’articolo 1094, comma 4, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.1) Identico; |
| 2. Il Capo di stato maggiore della difesa: |
|
| a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;; |
a) Identica; |
| b) è gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; 3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate; |
b) Identica; |
| c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. |
c) Identica; |
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame, con la nuova disposizione s’intende dunque ampliare la platea dei possibili destinatari della nomina, consentendo con ciò di superare eventuali criticità nel processo selettivo, introducendo la possibilità, per l’Autorità politica, di individuare il Capo di stato maggiore della difesa, oltre che - come oggi - tra tutti il generali di corpo d’armata o equivalenti in servizio permanente, anche tra quelli che, già ricoprendo la carica di vertice nell’ambito della rispettiva Forza armata, legittimamente si trovano a svolgere le loro funzioni di comando nella posizione di richiamo in servizio “automatico” previsto a normativa vigente.
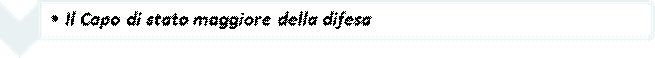
L’attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il risultato di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni novanta, che hanno riguardato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa e direttore nazionale armamenti. Tali interventi hanno, altresì, interessato, la riorganizzazione delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del dicastero.
In particolare, con la legge di riforma dei vertici militari (legge 18 febbraio 1997, n. 25) il Capo di stato maggiore della difesa, da figura di primus inter pares, è stato sovraordinato rispetto ai Capi di stato maggiore delle tre forze armate e, insieme al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale agli armamenti (SGD/DNA), posto alle dipendenze del Ministro della Difesa. La medesima legge (successivamente confluita nel Codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010) ha, altresì, stabilito che il Capo di stato maggiore della difesa predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di forza armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, nonché a definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari.
In modo particolare, il Capo di stato maggiore della difesa esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore investimento e al settore funzionamento, al fine di definire le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, nel primo caso, e di stabilire i criteri di massima nel secondo, sempre nel quadro della migliore utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.
Nel settore investimento, emana le direttive volte alla realizzazione dei singoli programmi e all'assegnazione dei relativi mezzi finanziari, mentre con riferimento al settore funzionamento, esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando loro i relativi mezzi finanziari.
In ogni caso, il controllo operativo rimane di esclusiva competenza del Capo di Stato maggiore della difesa, dato che allo stesso spetta la predisposizione della pianificazione generale finanziaria e di quella operativa interforze.
Al Capo di stato maggiore della difesa sono attribuite anche tutte le attività inerenti alla struttura e all'organizzazione tecnico-operativa delle Forze Armate, nonché l'adozione delle misure riguardanti l'impiego del personale militare (o anche civile) in ambito interforze, internazionale o presso altri dicasteri.
Si ricorda che il Capo di stato maggiore della difesa è un Ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica scelto tra gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'Armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente (ovvero, richiamati in servizio in quanto abbiano raggiunto i limiti di età nel corso del triennio di comando e pertanto stiano completando il mandato in tale posizione cfr. sopra). All'atto della nomina, a seconda della FA di provenienza, viene promosso al grado apicale di Generale (EI e AM) o Ammiraglio (MM).
È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa. Dipende direttamente dal Ministro della Difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare ed al quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute. Fa parte, in qualità di membro di diritto, del Consiglio Supremo di Difesa. Dura in carica tre anni e, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di forza armata.
Per una approfondimento si rinvia al seguente link del sito della Difesa
Articolo 2 comma 1-bis
(Riduzione dei periodi di comando per l'avanzamento degli ufficiali)
Il comma 1-bis introdotto nel corso dell’esame in sede referente, novella il Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di ridurre, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari ai fini dell’inserimento del personale militare nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali.
Nello specifico, il nuovo comma 3-quater dell’articolo 2233-quater del Codice dell’ordinamento militare, - di cui si prevede l’inserimento con la disposizione in esame -, riduce di trenta giorni i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal Codice dell’ordinamento militare ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento.
La riduzione dei richiamati termini è limitata agli anni 2021, 2022 e 2023.
Si ricorda che in base al comma 1 dell’articolo 1053 del Codice dell’ordinamento militare il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, il 15 settembre di ogni anno, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.
Con riferimento agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, il comma 2 dell’articolo 1242 richiama il medesimo termine del 15 settembre per la formazione, da parte del Ministro della Difesa, delle richiamate aliquote.
La data del 15 settembre è stata da ultimo stabilita, in sostituzione di quella del 31 ottobre, dall'art. 8, comma 4-bis, lett. a), del decreto legge n. 111 del 2021, convertito, dalla legge n.133 del 2021. Il medesimo articolo 8, comma 4-bis, lett. b) ha altresì previsto che per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre.
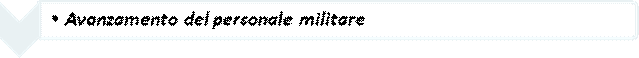
Per avanzamento del personale si intende la progressione nei gradi della carriera militare. Le forme di avanzamento hanno caratteristiche particolari per ciascuna categoria di militari.
Per gli Ufficiali corrispondono a criteri di anzianità, di scelta e per meriti eccezionali (il personale dell'Arma dei Carabinieri anche per benemerenze d'istituto); per i Sottufficiali ad anzianità, a scelta, per concorso per titoli di servizio ed esami e per meriti eccezionali (il personale dell'Arma dei Carabinieri anche per benemerenze d'istituto).
Per poter essere promosso il personale viene inserito in apposite aliquote di valutazione in cui sono iscritti tutti coloro che alla data di formazione delle stesse soddisfino i requisiti richiesti (tra i quali l'assolvimento dei periodi di comando/attribuzioni specifiche e i periodi minimi di servizio).
In relazione all'avanzamento a scelta degli ufficiali il procedimento definito dall'articolo 1058 del Codice si articola in due fasi.
In via preliminare la commissione è tenuta ad accertare l'idoneità di ciascun ufficiale all'avanzamento al grado superiore (commi da 1 a 4). Successivamente, la commissione attribuisce al personale valutato un punteggio di merito e, quindi, procede alla formazione della graduatoria di merito.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1058 affinché un ufficiale sia valutato idoneo è necessario che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
I punti di merito vanno da uno a trenta e sono attribuiti valutando, oltre all'attitudine dell'ufficiale ad assumere incarichi nel grado superiore, una serie di elementi espressamente indicati dall’articolo 1058.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito, l'articolo 1058 distingue a seconda che l'ufficiale da valutare sia un militare avente grado non superiore a colonnello (o grado corrispondente) o sia un ufficiale avente grado di generale di divisione o di brigata (o ufficiale di grado corrispondente). Nella prima ipotesi il punteggio si otterrà sommando i punti assegnati per ciascun complesso degli elementi sopra richiamati, tale somma sarà poi divisa per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno sommati fra di loro. Il totale sarà diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo, che costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Nella seconda ipotesi, la somma dei punti assegnati è divisa per il numero dei votanti. Il quoziente, al centesimo, costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Formata la graduatoria, l'avanzamento si effettuerà promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima o nell'ordine di iscrizione in ruolo.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1034 del Codice dell'ordinamento militare esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento sono costituite presso ciascuna Forza armata. Per quanto riguarda l'Esercito la disciplina delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento sono regolate, rispettivamente, dagli articoli 1037 e 1042 del Codice dell'ordinamento militare. Per la valutazione del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare apposite Commissioni permanenti (artt. 1047 e ss. del Codice dell'ordinamento militare).
Articolo 3
(Proroga di termini in materia di referendum)
L’articolo 3 proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Inoltre, vengono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.
La previsione reca un intervento analogo a quello disposto dal decreto-legge 52/2021 (art.11, comma 1-bis) che ha prorogato di un mese i termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati elettorali necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 maggio 2021. Successivamente, il decreto-legge 77/2021 (art. 39-bis) ha esteso il termine per il deposito alle richieste annunciate al 15 giugno 2021, oltre a differire altri termini relativi alla procedura referendaria.
In maniera corrispondente ai due provvedimenti sopra indicati, la disposizione in esame interviene sulla legge che disciplina i referendum (L. 352/1970).
In particolare si prevede che anche per le richieste annunciate dopo il 15 giugno 2021, sia differito il termine del deposito delle richieste (ossia delle firme), dal 30 settembre al 31 ottobre (art. 32, 1° comma, L. 352/1970), così come era stato differito il termine per le richieste pubblicate prima del 15 giugno dal D.L. 52/2021).
Inoltre, in analogia con quanto disposto dal D.L. 77/2021, anche per le richieste successive al 15 giugno vengono differiti di un mese i seguenti termini:
§ rilevazione, con ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Cassazione, delle eventuali irregolarità delle singole richieste, dal 31 ottobre al 30 novembre, e assegnazione del termine per la sanatoria di esse, dal 20 novembre al 20 dicembre (art. 32, 3° comma, L. 352/1970);
§ decisione definitiva, con ordinanza dell’Ufficio centrale, sulla legittimità delle richieste presentate, dal 15 dicembre al 15 gennaio (art. 32, 7° comma, L. 352/1970);
§ fissazione da parte della Corte costituzionale della data di deliberazione in camera di consiglio della ammissibilità della richiesta di referendum dal 20 gennaio al 20 febbraio (art. 33, 1° comma, L. 352/1970);
§ pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla ammissibilità del referendum entro il 10 marzo anziché entro il 10 febbraio (art. 33, 4° comma, L. 352/1970).
Rimane ferma la finestra temporale (15 aprile – 15 giugno) entro la quale deve essere fissata la data del referendum indetto con DPR, su deliberazione del Consiglio dei ministri, non appena ricevuta comunicazione da parte della Corte costituzionale (art. 34, L. 352/1970).
Restano altresì fermi i termini previsti dalla disciplina della propaganda elettorale attraverso i mezzi di comunicazione di massa in occasione dei referendum, regolata dalla legge n. 28 del 2000, che fissa l’inizio dell’arco temporale di regolamentazione della propaganda alla data di convocazione dei referendum (L. 28/2000, art. 4).
Nel preambolo del decreto-legge in esame, viene ritenuta “la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per il deposito delle richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la concomitanza con le elezioni amministrative [del 3 e 4 ottobre 2021 N.d.r.] e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di referendum entro la data prevista del 30 settembre 2021, a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali”.
La Costituzione (art. 75) disciplina il referendum abrogativo, stabilendo che quando lo richiedono 500.000 elettori o cinque Consigli regionali, è indetto un referendum per decidere sull'abrogazione (cancellazione) totale o parziale di una legge o di un atto con valore di legge. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La proposta abrogativa è approvata se la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione ed è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.
Per il referendum abrogativo, la legge prevede, relativamente alla richiesta di referendum un duplice vaglio: il controllo di legittimità-regolarità, condotto dall'Ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di Cassazione; il giudizio di ammissibilità (quanto ad oggetto e contenuto della richiesta di referendum), condotto dalla Corte costituzionale.
Lo svolgimento del referendum abrogativo è regolato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e principalmente dal titolo II.
Si ricorda che l’iniziativa finalizzata al raccoglimento delle 500.000 firme necessarie a portare a compimento la richiesta di referendum abrogativo è avviata da un gruppo di almeno dieci persone, munite del certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Tali persone devono presentarsi alla Cancelleria della Corte di cassazione che ne dà atto con verbale (art. 4, legge n. 352/1970).
Di ogni iniziativa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a quello della sua presentazione.
Dal 1° gennaio al 15 giugno 2021 risultano pubblicati 13 annunci di richieste di referendum abrogativo in: GU Serie Generale n. 35 dell’11 febbraio 2021; GU Serie Generale n. 43 del 20 febbraio 2021; GU Serie Generale n. 80 del 02 aprile 2021; GU Serie Generale n. 95 del 21 aprile 2021; GU Serie Generale n. 115 del 15 maggio 2021; GU Serie Generale n. 121 del 22 maggio 2021; GU Serie Generale n. 132 del 4 giugno 2021.
Dal 16 giugno al 30 settembre 2021 sono 6 gli annunci pubblicati, 2 nella G.U. Serie Generale n. 215 dell’8 settembre 2021 e 4 nella G.U. Serie Generale n. 223 del 17 settembre 2021.
La legge n. 352 del 1970 stabilisce che successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’iniziativa è possibile chiedere la vidimazione dei fogli sui quali saranno raccolte le firme degli elettori.
L’articolo 27 della L. 352 del 1970 stabilisce che nei fogli vidimati si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula «volete che sia abrogata. . . ».
È possibile procedere alla raccolta delle firme solo dopo che l’iniziativa referendaria è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La raccolta delle firme avviene sui fogli vidimati secondo la disciplina di cui all’articolo 8 della L. 352/1970. Accanto alle firme sono riportati nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Le firme debbono essere autenticate.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine (L. 53/1990, art. 14, come modificato da ultimo dall'art. 38-bis, comma 8, D.L. 77/2021).
Si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2021 le firme necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione (nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare) si possono raccogliere anche on-line, mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.
Si tratta di una norma transitoria, introdotta dal D.L. 77/2021 (art. 38-quater), destinata ad applicarsi fino alla data di operatività della piattaforma elettronica pubblica per la raccolta on-line delle sottoscrizioni per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare. La piattaforma è stata introdotta dalla L. 178/2020 (art. 1, commi 341-344) che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 100 mila euro a decorrere dal 2021; tale previsione normativa è stata poi modificata ed integrata dal suddetto 77/2021 (art. 38-quater), che ha inserito inoltre la citata norma transitoria.
Destinataria delle risorse del fondo è la Presidenza del Consiglio che dovrà realizzare la piattaforma entro il 31 dicembre 2021 dopo averne definito i requisiti tecnici e di sicurezza e le modalità di funzionamento con apposito decreto, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Garante della protezione dei dati personali.
Le firme elettroniche qualificate raccolte devono essere accompagnate, come quelle cartacee, dagli elementi di individuazione dell’elettore (nome, cognome ecc.) ma non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 352/1970.
Sia in caso di raccolta cartacea, sia di quella in formato elettronico, alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare i certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.
I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa (normalmente un codice QR).
Articolo 4
(Proroga di un termine per le domande di assegno temporaneo per i figli minori)
L’articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell’ambito della disciplina delle domande relative all’assegno temporaneo per i figli minori - assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 -. Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell’assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l’assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.
Si ricorda che l’assegno temporaneo per i figli minori è stato introdotto per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 dagli articoli da 1 a 4 del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2021, n. 112, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare.
Il suddetto istituto transitorio è stato introdotto nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla L. 1° aprile 2021, n. 46, la quale ha previsto il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.
Riguardo alla disciplina dell’assegno temporaneo, di cui ai citati articoli da 1 a 4 del D.L. n. 79, si ricorda che esso consiste in un assegno mensile, subordinato ai requisiti ivi posti dall'articolo 1, comma 1, e dalla relativa tabella (di cui all'allegato 1); l'importo dell'assegno, con riferimento a ciascun figlio minore, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e alla suddetta tabella allegata - i quali fanno riferimento al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni - e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3, comma 3). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3; la disciplina di cui al comma 2 si applica solo fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al comma 2-bis. Il citato comma 3 dell'articolo 4 prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del comma 1 dell'articolo 4. L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il periodo temporale in oggetto è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 4.
Per un quadro più completo della disciplina dell’istituto transitorio in esame, si rinvia alla scheda di lettura del citato D.L. n. 79, con riferimento al testo definitivo come convertito in legge, nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo all’A.C. n. 3201 (dossier n. 397/2 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 449/2 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).
Articolo 5
(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)
L’articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Le norme intervengono sull’articolo 42-bis, comma 5 del decreto-legge n. 104 del 2020.
La norma dispone, in caso di errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) in materia di sospensione del pagamento dell’IRAP dovuta per il 2019 e per il 2020 (prima rata dell’acconto), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche, per cui si veda il sito della documentazione parlamentare), che l'importo dell'imposta erroneamente non versata sia dovuto entro il 30 settembre 2021, senza applicazioni di sanzioni né interessi.
Tale termine, originariamente fissato al 30 novembre 2020, è stato successivamente prorogato dall’articolo 13-quinquies, comma 6 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori) e dall’articolo 01 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. Sostegni).
Per effetto delle disposizioni in esame, il termine per il versamento dell’imposta sospesa ed erroneamente non pagata viene spostato, senza sanzioni e interessi, al 30 novembre 2021.
Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate. Tali disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal menzionato Temporary Framework, come successivamente modificato nel tempo.
Articoli 6 e 7
(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)
L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 7 dispone in merito all’entrata in vigore.
L’articolo 6 dispone che dall'attuazione del decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal decreto si provvede dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 7 prevede dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 settembre 2021.
![]()
![]() @SR_Studi
@SR_Studi
![]() @CD_istituzioni
@CD_istituzioni