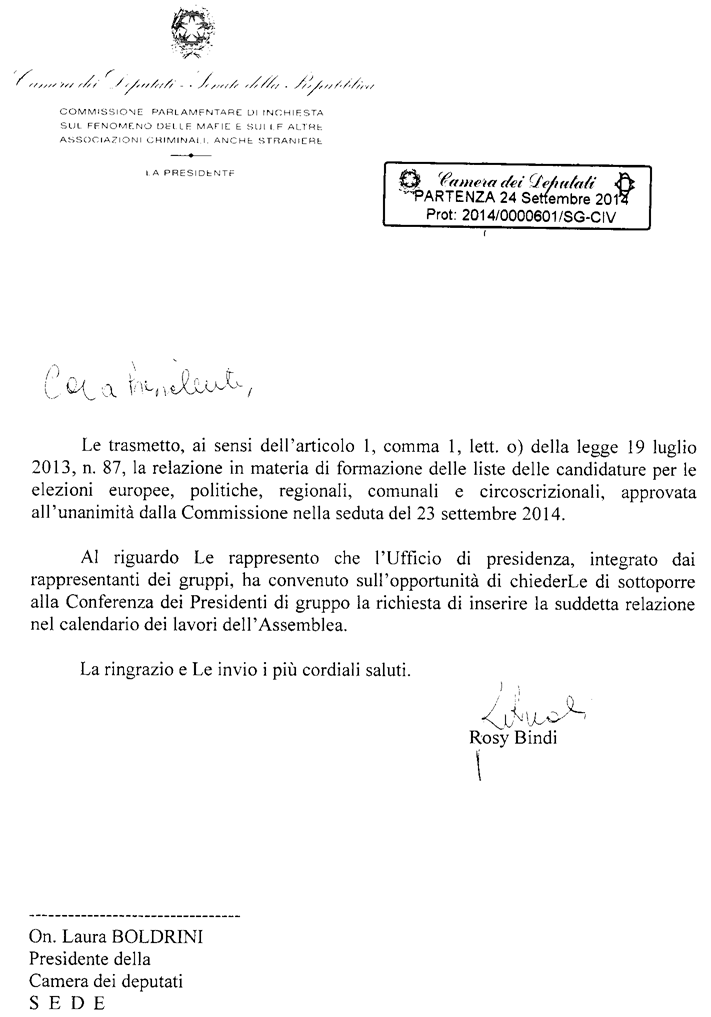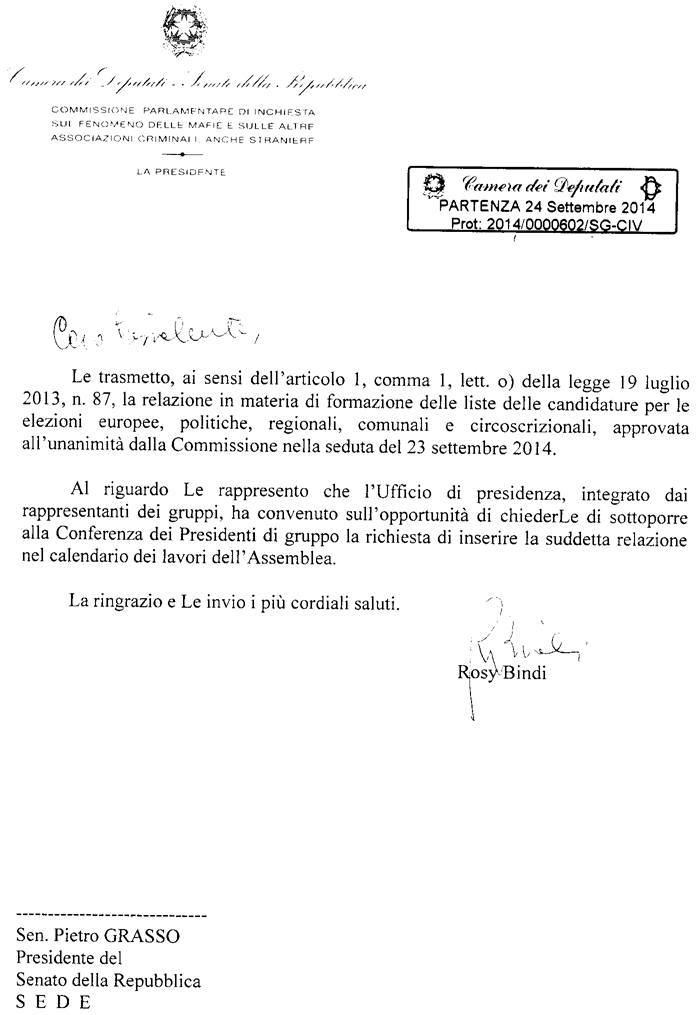I tre progetti di legge in esame (C. 336, Anzaldi, C. 513, Nesci ed altri, e C. 664, Verini) prevedono l’istituzione, per la durata della XVIII legislatura, di una Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere.
Mentre la proposta di legge C. 336 Anzaldi riproduce sostanzialmente il testo della legge istitutiva della Commissione antimafia approvata nella XVII legislatura (L. 87/2013), le altre due proposte (C. 513 Nesci e C. 664 Verini) pur ricalcando nell’impianto generale e in gran parte della formulazione il testo della legge, vi introducono diverse modifiche, che trovano principale fondamento nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione antimafia alla fine della XVII legislatura il 7 febbraio 2018 (doc. XXIII, n. 38, pag. 385 e segg.).
Infatti, nella sua relazione conclusiva, la Commissione “unitamente alla ricostruzione dell’attività svolta dalla Commissione nel corso di questa legislatura, ha inteso sottoporre all’attenzione del Parlamento e dell’opinione pubblica, insieme alle risultanze dell’attività, anche alcune riflessioni più generali in ordine al funzionamento, alle competenze e ai poteri della Commissione, insieme alla allegata proposta di riscrittura del testo della legge istitutiva. Si tratta di un’innovazione che, senza condizionare le scelte del prossimo Parlamento, si ritiene che possa essere utile in sede di discussione del provvedimento istitutivo della Commissione Antimafia che potrà essere definito all’inizio della XVIII legislatura” (relazione conclusiva, pag. 398).
Le principali modifiche sono riconducibili essenzialmente a tre profili:
· l’individuazione di ulteriori ambiti di indagine, rispetto a quelli della legge 87/2013;
· il rafforzamento dei poteri della Commissione nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali competenti nel contrasto al fenomeno mafioso;
· la riduzione del numero dei componenti la Commissione:
Per quanto riguarda il primo profilo, ossia i compiti della Commissione le due proposte di legge (C. 513 e C. 664), congiuntamente o singolarmente, prevedono l’ampliamento dell’oggetto dell’inchiesta a diversi nuovi argomenti, tra cui:
§ tutela delle vittime di estorsione e usura;
§ tutela dei familiari delle vittime delle mafie;
§ monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena;
§ sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia;
§ corruzione;
§ massoneria e associazioni segrete;
§ traffico di stupefacenti e commercio di opere d’arte;
§ rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti;
§ giochi e scommesse;
§ movimento civile antimafia;
§ lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie.
Relativamente ai poteri della Commissione, in primo luogo, le pdl C. 513 e C. 664 stabiliscono che la Commissione antimafia possa chiedere al Governo una relazione di valutazione degli effetti che “specifici” progetti di legge in discussione presso le Camere possono determinare rispetto alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione.
Analoga relazione può essere chiesta dalla Commissione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con riferimento agli effetti rispetto alle modalità di difesa delle procedure di affidamento degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.
E’ altresì previsto che la Commissione antimafia possa chiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un’amministrazione locale.
Le due proposte di legge, inoltre, danno la possibilità alla Commissione di chiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche di dati di cui all’articolo 117 del codice di procedura penale (richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero), limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo.
Le proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini prevedono infine, in capo alla Commissione, la facoltà di adottare iniziative volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione della cittadinanza sui temi della lotta alle mafie e della cultura della legalità.
Infine, sulla composizione le proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini prevedono la riduzione da 50 a 40 del numero dei membri della Commissione e una durata per tutta la legislatura, senza il rinnovo biennale.
La pdl C. 664 prevede, inoltre, la scelta del presidente della Commissione da parte dei Presidenti di Camera e Senato che lo nominano al di fuori dei componenti la Commissione.
Le leggi istitutive e l’attività delle precedenti commissioni antimafia sono disponibili sul sito del Senato.
Denominazione e ambito di applicazione della Commissione di inchiesta
L’articolo 1 delle tre proposte di legge reca l’istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri.
Per quanto riguarda la denominazione della Commissione, le proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini mantengono quella adottata nella XVI legislatura con la legge 132/2008 (e confermata nella XVII con la legge 87/2013), quando per la prima volta è stato operato un mutamento nella denominazione, che rimanda alla volontà di allargare l’attività d’inchiesta parlamentare alle associazioni criminali anche straniere operanti sul territorio nazionale.
Dal punto di vista formale, si rileva che nella pdl C. 336 Anzaldi la denominazione è “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia”, al singolare, a differenza delle altre proposte (e della legge 87/2013) dove il riferimento è alle “mafie” al plurale. Per il resto, la proposta di legge riproduce pressoché testualmente il contenuto della legge 87/2013.
Per quanto riguarda l’ambito di inchiesta, le proposte di legge prevedono che i compiti previsti dalla legge sono attribuiti alla Commissione anche con riguardo alle altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell’art. 3 della L. 146/2006 e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso) codice penale. Tale previsione è presente con contenuto analogo in tutte le proposte di legge (C. 336 Anzaldi art. 1, comma 3; C. 513 Nesci art. 1, comma 7; C. 664 Verini art. 1, comma 8) e nella L. 87/2013 (art. 1, comma 3).
La L. 146/2006, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – intende promuovere la cooperazione tra gli Stati per prevenire e combattere in maniera efficace il crimine organizzato transnazionale. In particolare, l’art. 3 definisce quale reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Per quanto riguarda i compiti della Commissione indicati nell’articolo 1 delle proposte di legge, alcuni coincidono (con qualche modifica) con quelli della legge 87/2013 e cioè:
§ verificare l’attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza e quelle relative al regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;
§ accertare la congruità della legislazione vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva le iniziative di Stato regioni ed enti locali contro la mafia, anche al fine di costituire uno spazio giuridico antimafia a livello europeo e internazionale;
§ accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell’ambito della criminalità di tipo mafioso anche con riferimento a processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali in attività illecite rivolte contro la proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, avendo particolare riguardo – in tale ultimo campo – al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali;
§ indagare sul rapporto tra mafia e politica anche riguardo alla sua articolazione territoriale e ai delitti e alle stragi di carattere politico-mafioso (fino a quelle degli anni 1992 e 1993 secondo quanto proposto dalla pdl C. 664);
§ accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti di tipo mafioso, anche in relazione all’accumulazione di patrimoni illeciti e al fenomeno del riciclaggio;
§ esaminare l’impatto negativo derivante al sistema produttivo dalle attività delle associazioni mafiose, con particolare riferimento all’alterazione della libera concorrenza, dell’accesso ai sistemi bancario e finanziario, della trasparenza della gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo imprenditoriale;
§ verificare l’adeguatezza delle norme patrimoniali, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci (tale finalità non compare esplicitamente nella pdl C. 513 Nesci che purtuttavia cita le principali disposizioni in materia tra cui la legge Rognoni - La Torre, n. 646 del 1982);
§ verificare l’adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio;
§ svolgere un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali (con particolare riguardo alla componente amministrativa secondo quanto specificato dalle pdl C. 515 e C. 664) e proporre misure per prevenire e contrastare tali tentativi, anche alla luce di una verifica dell’efficacia delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali e di rimozione degli amministratori di tali enti;
§ riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
Come accennato, mentre la proposta di legge C. 336 riproduce i medesimi compiti della legge 87, le altre due proposte introducono le seguenti nuove finalità:
§ verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione e usura (C. 664);
§ verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie (C. 664);
§ verificare il monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena per delitti di tipo mafioso (C. 513 e C. 664);
§ verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua applicazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia (C. 513 e C. 664);
§ estendere l’analisi delle nuove tendenze e dei mutamenti in atto nell’ambito della criminalità di tipo mafioso (vedi sopra) anche ai seguenti ulteriori ambiti:
- condotte corruttive o collusive (C. 513 e C. 664);
- infiltrazioni all’interno di associazioni massoniche (C. 513) o a carattere segreto (C. 513 e C. 664);
- traffico di stupefacenti e commercio di opere d’arte (C. 513 e C. 664);
§ estendere l’indagine sul rapporto tra mafia e politica anche in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia nella XVII legislatura (Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 23 settembre 2014 (C. 513);
§ programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti (C. 664);
§ estendere l’indagine relativa al riciclaggio anche al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse (C. 513 e C. 664);
§ esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito (C. 513 e C. 664);
§ monitorare la normativa in materia di lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie (C. 513).
Si tratta, come accennato, di compiti che traggono ispirazione dagli spunti emersi nel corso dei lavori della Commissione antimafia della XVII legislatura e formalizzati nella sua relazione conclusiva, dove si auspicava che in sede di discussione della nuova legge istitutiva se ne valutasse l’introduzione.
Si tratta in particolare delle seguenti esigenze:
“1. svolgere il monitoraggio dell’applicazione del nuovo codice antimafia, verificare l’attuazione delle nuove disposizioni in tema di testimoni di giustizia e verificare l’attuazione dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, anche con riguardo ai soggetti scarcerati per conclusione dell’espiazione della pena;
2. sviluppare, in tema di accertamento e valutazione della natura e delle trasformazioni del fenomeno mafioso, l’indagine sul rapporto tra mafia e corruzione, e in tale ambito, compiere uno sforzo – da estendere anche agli elementi che definiscono il concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso – di migliore individuazione e, ove possibile e non controproducente, di tipizzazione delle condotte agevolative, soprattutto a carattere collusivo, allo scopo di punire più efficacemente la zona grigia dei tecnici e dei professionisti facilitatori delle organizzazioni mafiose;
3. proseguire l’inchiesta sull’infiltrazione di cosa nostra e della ‘ndrangheta nella massoneria, e comunque all’interno di associazioni a carattere segreto o riservato, da parte di esponenti riconducibili a cosche mafiose, estendendo il campo di investigazione a tutte le regioni italiane;
4. approfondire la tematica del contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso nel campo del traffico internazionale di stupefacenti che, come ricordato a più riprese dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, continua a essere il principale e imponente canale di finanziamento della criminalità organizzata;
5. continuare a indagare sul rapporto tra mafia e politica, verificando in concreto le condizioni legali di elettorato attivo e passivo e promuovendo efficaci politiche in tema di selezione delle candidature elettorali da parte dei partiti e movimenti politici;
6. verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, con particolare riguardo alle dotazioni organiche della magistratura e delle forze di polizia, alla rivisitazione dei compiti della magistratura di sorveglianza, quanto meno con riferimento all’attuazione del regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis, e alla riflessione sulla possibilità di introdurre anche nella magistratura giudicante un nuovo modello organizzativo, simmetrico alle competenze territoriali delle procure distrettuali antimafia;
7. curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso al fine di approfondire l’analisi delle proposte da essi elaborate;
8. valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell’antimafia e monitorare l’attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l’apporto fornito;
9. svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente burocratico-amministrativa e al ruolo dei funzionari, dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo; estendere ove possibile la verifica all’efficacia delle norme vigenti in materia di pubblica amministrazione e delle disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alla prevenzione della corruzione, alla pubblicità e alla trasparenza;
10. promuovere la realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all’attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20” (Relazione conclusiva approvata dalla Commissione antimafia della XVII legislatura il 7 febbraio 2018, pag. 394).
Con riferimento ai poteri della Commissione, le proposte di legge introducono limitazioni rispetto a quelli astrattamente riconosciuti alle Commissioni di inchiesta dall’articolo 82 Cost., in base al quale esse procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione nella XVII legislatura (L. 87/2013) e dalle precedenti L. 132/2008 e L. 277/2006, la proposta di legge C. 336 Anzaldi stabilisce (art. 1, comma 2) che, ad eccezione dell’accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale.
Le proposte di legge C. 513 Nesci (art. 1, comma 2) e C. 664 Verini (art. 1, comma 3) recano una formulazione meno ampia nella limitazione dei poteri, stabilendo che la Commissione non possa adottare, ad eccezione dell’accompagnamento coattivo dei testimoni, provvedimenti attinenti alla libertà personale (senza il riferimento, quindi, ai provvedimenti relativi alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, che quindi rientrerebbero nei poteri della Commissione).
L’art. 133 c.p.p. prevede che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
La limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta, introdotta la prima volta con la L. 277/2006 (e confermata dalla L. 132/2008), ha origine da una proposta avanzata dai relatori (Sesa Amici e D’Alia) nel corso dell’esame in sede referente alla Camera del progetto di legge di istituzione della Commissione “antimafia” nella XV legislatura ( A.C. 40 ed abb.). In quella sede i due relatori hanno sottolineato la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati, in quanto all'interno della Commissione non è attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero (13 giugno 2006).
Detta innovazione è stata oggetto di numerose modifiche e affinamenti nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento.
Inizialmente, infatti, il progetto di legge approvato in prima lettura dalla Camera nel 2006 recava – all’articolo 4 – una procedura aggravata per l’adozione, da parte della Commissione d’inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite. In particolare, si richiedeva che l’adozione, da parte della Commissione, delle “deliberazioni aventi a oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti” avvenisse “a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Il Senato, esaminando il progetto di legge approvato dalla Camera in prima lettura, aveva introdotto all’articolo 1, comma 2, il divieto per l’istituenda Commissione “antimafia” di “adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”. Il Senato aveva contestualmente soppresso il successivo articolo 4.
Il testo deliberato dalla Camera in seconda lettura riformulava il comma 2 dell’articolo 1 prevedendo che “la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni”.
Il testo approvato definitivamente è il frutto di una ulteriore modifica introdotta dal Senato, che individua il divieto con una formula più ampia di quella delle “intercettazioni delle comunicazioni”, che riprendendo quella usata dall’art. 15 della Costituzione.
Rispetto alla legge istitutiva della Commissione approvata nella XVII legislatura e alla proposta di legge C. 336 Anzaldi, analoga alla legge istitutiva del 2013, le proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini introducono – all’articolo 1 – nuove disposizioni che riguardano i poteri della Commissione.
In primo luogo, si stabilisce (art. 1, comma 3 C. 513 e art. 1, comma 4 C. 664) che la Commissione antimafia possa chiedere al Governo una relazione di valutazione degli effetti che “specifici” progetti di legge in discussione presso le Camere possono determinare rispetto alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione.
La proposta di legge C. 664 specifica che tale richiesta possa essere effettuata con particolare riferimento ai compiti di cui alle lettere a): verifica attuazione leggi per il contrasto alla mafia; b): verifica attuazione norme sui collaboratori di giustizia e predisposizione di proposte normative al Parlamento; c) e d): verifica attuazione norme per la tutela delle vittime dell’estorsione, dell’usura e delle mafie e dei familiari e predisposizione di proposte normative al Parlamento; h): accertamento dei mutamenti della composizione criminalità organizzata e delle nuove modalità di azione; l): indagine sul riciclaggio denaro sporco; m): verifica dell’impatto negativo della criminalità organizzata sul sistema produttivo.
La possibilità di richiedere una valutazione degli effetti al Governo riprende quanto prospettato nella citata Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura dove si richiama la possibilità che la Commissione possa richiedere al Governo di predisporre un’apposita relazione tecnica di “valutazione di impatto antimafia”, che contenga l’analisi dei fattori di rischio e dell’impatto delle misure proposte ai fini del contrasto alla criminalità organizzata, quanto meno con riferimento a progetti di legge di particolare rilievo in discussione presso uno dei rami del Parlamento.
Attualmente, gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa, fatti salvi i casi di esclusione e di esenzione, sono accompagnati dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica sugli effetti finanziari, da una relazione tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). Quest’ultima è intesa come un percorso che le amministrazioni devono seguire al fine di valutare l’impatto atteso delle opzioni di intervento considerate e consiste in una analisi ex ante degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In tale quadro l’amministrazione competente svolge una analisi delle motivazioni che richiedono un intervento normativo, identifica gli obiettivi che intende perseguire, elabora e valuta una serie di opzioni (inclusa l’opzione di non intervento), con particolare attenzione agli effetti attesi su cittadini ed imprese, e motiva la scelta finale. Nel corso dell’AIR l’amministrazione svolge consultazioni “con i vari stakeholders” al fine di raccogliere dati, opinioni e suggerimenti. I risultati dell’analisi e la descrizione del percorso logico seguito dall’amministrazione proponente sono riassunti nella “Relazione AIR”, i cui contenuti sono definiti dal Dpcm 11 settembre 2008, n. 170
La disciplina dell’AIR è dettata dall’articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” e dal Dpcm 11 settembre 2008, n. 170 “Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)”. Ulteriori disposizioni in materia di AIR sono state introdotte dallo Statuto delle imprese (Legge 11 novembre 2011, n. 180) e dal decreto-legge 5 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
A differenza delle relazioni attualmente previste dalla normativa vigente – che devono accompagnare tutti i disegni di legge di iniziativa governativa, gli atti normativi del Governo, i provvedimenti interministeriali - la previsione in esame contempla dunque un’ipotesi di relazione “su richiesta” della Commissione e relativa a profili specifici (effetti che si possono determinare rispetto alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali), che si verrebbe ad innestare nell’ambito del procedimento legislativo (in cui la Commissione non è coinvolta direttamente).
Analoga relazione può essere chiesta dalla Commissione – in base a quanto previsto dalle proposte di legge C. 513 Nesci (art. 1, comma 3) e C. 664 Verini (art. 1, comma 4) - all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con riferimento agli effetti rispetto alle modalità di difesa delle procedure di affidamento degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi. La proposta di legge C. 664 specifica che tale richiesta può essere effettuata ai fini previsti dalla lettera l): riciclaggio di denaro sporco.
Nel quadro vigente, l'ANAC è tenuta a riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e all'illegalità e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno (art. 1, co. 2, lett. g), L. 190/2012). In tale relazione, l'Autorità dà altresì conto dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione (art. 19, co. 5-ter, D.L. 90/2014).
Inoltre, sulla base dell'art. 1, co. 2, lett. g), della legge 190 del 2012 e dell'art. 213, co. 3, lettere c) e d), del Codice degli appalti, l'Autorità può inviare al Parlamento e al Governo segnalazioni sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia e su possibili interventi normativi, per chiarire dubbi interpretativi o superare criticità applicative riscontrate dall'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le segnalazioni sono pubblicate, oltre che sul sito istituzionale dell'ANAC, nell'allegato A al resoconto stenografico dell'Assemblea e sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari.
E’ altresì previsto dalle proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini che la Commissione antimafia possa chiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un’amministrazione locale.
A tale fine prevedono (art. 1, comma 4 C. 513 e art. 1, comma 5 C. 664) che il Governo sia tenuto a comunicare ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione antimafia l’avvio delle procedure di verifica ai fini dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
L’art. 143 del TUEL disciplina lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Il comma 2 prevede che, al fine di verificare la sussistenza degli elementi richiesti dalla legge, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
Le proposte C. 513 Nesci e C. 664 Verini prevedono altresì che la Commissione possa chiedere al Governo specifiche relazioni sull’azione di ripristino della legalità svolta nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del medesimo articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 146, comma 2, del TUEL il Ministro dell’interno presenta al Parlamento (DOC. LXXXIII) una relazione annuale sull'attività delle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (obbligo introdotto dal DL 50/2003).
Nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura si ricorda che la Commissione ha dedicato nell’ultimo quinquennio una particolare attenzione alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle istituzioni locali. Per rafforzare l’attività di monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali nella Relazione si evidenzia l’utilità di prevedere espressamente il potere della Commissione di richiedere al Governo relazioni circostanziate sull’attività di gestione straordinaria di alcuni comuni sciolti ovvero su singoli casi in cui appare necessario approfondire il concreto rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata sulla vita democratica delle istituzioni locali e, a quest’ultimo riguardo, si prospetta la possibilità di prevedere che il Governo debba comunicare ai Presidenti delle Camere - e al presidente della Commissione Antimafia - anche l’avvio delle procedure di accesso presso l’ente interessato per la verifica degli elementi sulle possibili infiltrazioni, mentre attualmente l’articolo 143 del TUEL prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale solo del decreto di scioglimento o del decreto di archiviazione in seguito ad esito negativo della procedura di verifica.
E’ prevista altresì la facoltà per la Commissione di chiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche di dati di cui all’articolo 117 del codice di procedura penale (richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero), limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo. Nella proposta di legge C. 513 si richiamano le finalità connesse ai compiti di cui al comma 1, lettere e): verifica dell’adeguatezza normativa vigente su banche dati per il contrasto alla criminalità organizzata; f): (rapporto su mafia e politica; g): mutamenti del fenomeno mafioso; h): forme di accumulazione di patrimoni illeciti e riciclaggio; o): monitoraggio sui tentativi di infiltrazione negli enti locali e iniziative normative e amministrative.
Nella proposta di legge C. 664 si richiamano le finalità connesse ai compiti di cui al comma 1, lettere e): verifica delle norme sull’applicazione dell’art. 41-bis della L. 354/1975; g): verifica dell’adeguatezza normativa vigente su banche dati per il contrasto alla criminalità organizzata; q): verifica dell’adeguatezza delle strutture predisposte sul territorio e rapporti con i soggetti istituzionali competenti.
L’art. 117 c.p.p. dispone che quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dalla legge accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Le previsioni recate dalle due proposte di legge introducono una base normativa di rango legislativo ad una prassi già consolidata a seguito della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 5 maggio 2016. Il CSM - in risposta ad un quesito da parte del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA) e ad una nota della Presidente della Commissione antimafia - ha affermato la possibilità per il primo di trasmettere alla citata Commissione i dati relativi all'accesso ai registri e banche dati limitatamente ai dati non più coperti dal segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p. Il CSM ha argomentato che, nell'ambito dell'attività di semplificazione e collaborazione istituzionale tra il PNAA e la Commissione antimafia, ben possano essere messe a disposizione di quest'ultima dati in merito a soggetti per i quali sia stata già esercitata l'azione penale o sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. In tali casi si deroga, quindi, alla titolarità di tali dati in capo ai procuratori della Repubblica. Va osservato, conclude la delibera del CSM, che si tratta comunque di dati che sarebbero in ogni caso a disposizione della Commissione antimafia tramite i registri dei carichi pendenti cui, ai sensi dell'art. 28 del DPR 313/2012, la Commissione antimafia ha accesso.
Le proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini prevedono infine, in capo alla Commissione, la facoltà di adottare iniziative volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione della cittadinanza sui temi della lotta alle mafie e della cultura della legalità.
In particolare, la proposta di legge C. 513 Nesci (art. 1, comma 6) attribuisce alla Commissione la facoltà di promuovere la realizzazione e di valutare l’efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all’attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, che ha individuato nel 21 marzo la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all’interno del sistema pubblico di istruzione.
La legge n. 20/2017 ha istituito la «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie», individuata nel 21 marzo di ogni anno, in cui gli istituti scolastici sono chiamati a promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. La legge prevede altresì che al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie
La proposta di legge C. 664 Verini (art. 1, comma 7) attribuisce alla Commissione la facoltà di promuovere nelle scuole, nei mezzi di comunicazione e nella rete internet iniziative volte a diffondere la cultura della legalità e a “stimolare la consapevolezza” (della legalità), la partecipazione e la cittadinanza attiva. In tale quadro, la Commissione è chiamata a valorizzare la responsabilità individuale e quella sociale, con particolare attenzione al mondo giovanile e in sinergia con le associazioni “più impegnate” nel settore, anche favorendo campagne informative e iniziative che prevedano la collaborazione tra lo Stato, nelle sue articolazioni, la cittadinanza e il settore privato sociale. Infine, con una formulazione in parte analoga alla proposta di legge C. 513 (v. supra) si attribuisce alla Commissione la facoltà di promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione alla verifica dell'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, e delle relative finalità.
L’articolo 2 delle proposte di legge riguarda la composizione della Commissione.
Per quanto riguarda il numero dei componenti (comma 1) mentre la proposta di legge C. 336 Anzaldi riprende il testo della legge n. 87/2013, istitutiva della Commissione antimafia nella XVII legislatura, confermando il numero di 50 componenti (25 senatori e 25 deputati) le proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini ne riducono la composizione a 40 componenti, tenendo conto di quanto prospettato nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura.
Nella citata Relazione viene evidenziato come, nel caso di riduzione del numero dei gruppi parlamentari costituiti in seno alle nuove Camere, “potrebbe essere nuovamente esaminata l’ipotesi, già praticata dalla III alla X legislatura, contenuta anche in due delle proposte di legge discusse all’inizio della XVII legislatura, che preveda una riduzione, in diversa misura, del numero dei componenti della Commissione rispetto al passato; un emendamento analogo presentato in Aula alla Camera era stato respinto, in ragione dell’esigenza di assicurare un’adeguata rappresentanza ai gruppi più piccoli. Un numero inferiore - 30 o 40 componenti - faciliterebbe indubbiamente lo svolgimento dei lavori della Commissione. Tale riduzione dovrebbe essere valutata, alla luce della possibile contrazione del numero dei gruppi parlamentari per effetto della nuova legge elettorale, ai fini del rispetto dei principi di cui all’articolo 82 della Costituzione sull’applicazione del principio della ripartizione proporzionale dei parlamentari in relazione alla consistenza numerica dei rispettivi gruppi, garantendo, al contempo, un’adeguata rappresentanza dei gruppi minori” (pag. 395).
Come previsto nella L. 87/2013 viene stabilito da tutte le proposte di legge che i componenti sono scelti dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo; la nomina avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
Analogamente a quanto stabilito dalla legge istitutiva della XVII legislatura – che recava un’analoga formulazione facendo riferimento alla relazione da ultimo approvata allora (18 febbraio 2010) – i componenti la Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia con la Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Per quanto riguarda la formulazione testuale, la proposta di legge C. 336 richiama la relazione precedente, approvata il 18 febbraio 2010, la proposta di legge 513 fa riferimento alla “proposta di autoregolamentazione” mentre la proposta di legge C. 664 richiama il “codice di autoregolamentazione”.
Il codice di autoregolamentazione è stato proposto dalla Commissione antimafia con la finalità – evidenziata nella relazione – di impegnare i partiti e i movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e anticipare la soglia di allerta, con altre gravi condotte. “In questo ambito è stato ritenuto di riferimento alle più gravi fattispecie di reato, ferma restando la previsione di incandidabilità contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna” (codice di regolamentazione, pag. 4).
Ad esempio, il codice di autoregolamentazione richiama già la fase del decreto che dispone il giudizio (il c.d. rinvio a giudizio) così facendo retrocedere l’incandidabilità ad una fase anteriore rispetto all’adozione della sentenza di condanna prevista dal citato D.Lgs. 235/2012.
Analogo documento era stato adottato dalla Commissione nella XVI legislatura (18 febbraio 2010) e nella XV legislatura (3 aprile 2007) relativamente ai criteri cui attenersi per la designazione dei candidati alle elezioni regionali e amministrative, rivolto alle formazioni politiche e alle liste civiche, che vi aderiscono volontariamente e che, al momento dell’adesione, si impegnano a non presentare o appoggiare candidati nei cui confronti ricorrano le condizioni ivi previste.
Qualora una delle situazioni previste nel codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, è previsto l’obbligo di informarne immediatamente il presidente della Commissione e il Presidente delle Camere. La proposta di legge C. 513 aggiunge che tale comunicazione avviene “ai fini della sostituzione” del componente.
Nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura si evidenzia come non appaia “allo stato percorribile – per coerenza con i principi generali dell’ordinamento parlamentare e con gli articoli 1 e 67 della Costituzione – l’ipotesi di attribuire alle Presidenze di Camera e Senato un “potere sanzionatorio” nei confronti dei parlamentari la cui posizione risultasse in contrasto con il codice di autoregolamentazione, ma tale disciplina potrebbe essere opportunamente integrata, prevedendo la successiva comunicazione da parte del Presidente della Camera interessata anche al presidente della Commissione. In merito alla qualità di componente della Commissione, occorre infatti ricordare che durante i lavori sono occorse vicende giudiziarie che hanno lambito l’attività di singoli commissari, che hanno posto l’esigenza di una ulteriore riflessione sul tema della composizione della Commissione, che non è nella disponibilità di quest’ultima, e sullo status di componente rispetto alle generali prerogative del parlamentare”.
La sola proposta di legge C. 336 Anzaldi prevede il rinnovo biennale della composizione della Commissione (i cui membri possono essere confermati), come stabilito dalla legge n. 87/2013. Diversamente, le proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini non prevedono il rinnovo biennale, riprendendo quanto evidenziato nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura.
Nella relazione si evidenzia come nelle ultime legislature le leggi istitutive abbiano “altresì previsto il rinnovo dei componenti al termine del primo biennio, fatta salva ovviamente la loro riconferma. Tenuto conto delle particolari competenze attribuite alla Commissione e al fine di assicurare l’indispensabile continuità della sua azione, appare invece opportuno estendere la durata dell’incarico all’intera legislatura - ovvero a un periodo anche più lungo ma comunque predeterminato - e garantire analoga durata anche ai membri dell’ufficio di presidenza, come già previsto da alcune proposte di legge presentate nelle passate legislature”. Nella Relazione si evidenzia che, d’altro canto, le procedure di rinnovo, pur avviate dopo un biennio dalla costituzione della Commissione, non sono state portate a conclusione né nella XVI né nella XVII legislatura” (pag. 395).
Le proposte di legge C. 336 Anzaldi (art. 2, commi 4, 5 e 6) e C. 513 Nesci (art. 2, commi 3, 4 e 5) prevedono le medesime modalità di costituzione e di formazione dell’Ufficio di presidenza, già stabilite dalla L. 87/2013 e analoghe alla composizione degli Uffici di presidenza delle Commissioni permanenti. In particolare, in base a tali proposte l’Ufficio di presidenza è composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Il Presidente è eletto da parte della Commissione, a scrutinio segreto, ed è eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; qualora nessun candidato raggiunga tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età. E’ previsto inoltre il voto limitato per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari: ciascun componente della Commissione esprime un solo voto, e vengono eletti i due candidati che riportano il maggior numero di voti. Nel caso in cui si verifichi la parità dei voti, si applicano le disposizioni previste per l’elezione del presidente. Le medesime disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
Diversamente, la proposta di legge C. 664 Verini prevede (art. 2, comma 2) che il Presidente della Commissione antimafia sia scelto dai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari e al di fuori dei componenti la Commissione. Per l’elezione dei due Vicepresidenti e due Segretari sono previste le medesime disposizioni stabilite dalla L. 87/2013 (e riprese dalla altre proposte di legge).
Tale impostazione riprende quanto prospettato nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura dove si evidenzia che, considerando che la nuova legge elettorale ha un impianto prevalentemente proporzionale, si potrebbe prendere in considerazione, in alternativa all’elezione in seno alla Commissione, il ritorno al sistema di nomina del presidente della Commissione già adottato nelle legislature X, XI e XII, allorquando il sistema elettorale era su base proporzionale.
Viene ricordato che in quel tempo, la scelta era affidata ai Presidenti delle Camere ai quali competeva la designazione, d’intesa fra loro, del presidente tra i parlamentari di Camera e Senato, al di fuori dei componenti la Commissione. “Il ritorno al vecchio sistema potrebbe consentire di agevolare il rapido avvio dei lavori, qualora fosse necessario considerare il rischio di impasse, legato a probabili difficoltà nel trovare un accordo tra le forze politiche ai fini dell’elezione del presidente”.
Audizioni e richiesta di atti e documenti
L’articolo 4 delle tre proposte di legge disciplina le audizioni a testimonianza in maniera analoga con quanto stabilito nella XVII legislatura, mantenendo comunque ferme le competenze dell’autorità giudiziaria.
Si prevede, in particolare l’applicazione degli artt. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (art. 4, comma 1), nonché l’applicazione dell’art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale (art. 4, comma 4).
L’art 366 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 al perito, interprete, o custode di cose sottoposte a sequestro che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio e, in generale ai testimoni e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
L’art. 372 c.p. punisce la falsa testimonianza con la reclusione da due a sei anni.
L’art 203 c.p.p. prevede che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di informazione a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
In tema di segreto professionale e bancario, le proposte di legge richiamano le norme vigenti in materia (art. 4, comma 2), precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ex art. 103 c.p.p. (art. 4 comma 4). Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 207, n. 124.
Il segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (L. 124/2007) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Si ricorda che il segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (art. 201 c.p.p.).
Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti (segreto professionale ex art. 200 c.p.p.).
Per quanto riguarda il segreto bancario si applicano le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali che prevedono che la comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (art. 23 del Codice della privacy, D.Lgs. 196/2003) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso (art. 24 del Codice). Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate. Parziali deroghe sono previste per le indagini tributarie.
In nessun caso, in base a tutte le proposte di legge in esame, è opponibile il segreto d’ufficio. La sola proposta di legge C. 513 Nesci prevede, nonostante aver richiamato l’applicazione delle norme vigenti in materia, anche la non opponibilità, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, del segreto professionale e del segreto bancario (art. 4, comma 2, ultimo periodo).
La non opponibilità del segreto professionale e di quello bancario, è stata prevista da altri provvedimenti di istituzione di commissioni di inchiesta. Si veda, ad esempio, la legge 107/2017 di istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ed in particolare l’art. 4:
”1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124”.
L'articolo 5 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione scorsa legislatura.
In particolare, si prevede che la Commissione possa acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all’articolo 329 c.p.p. che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria [fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 1), nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 5) e copie di documenti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni (comma 3).
Per quanto riguarda le richieste di documenti dell'autorità giudiziaria, questa vi provvede con le stesse modalità delle richieste formulate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale (comma 1).
L'art. 117 c.p.p., come accennato, L’art. 117 c.p.p. dispone che quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
Si tratta di una formula non presente nella legge 87/2013, ma utilizzata in passato negli atti istitutivi di commissioni di inchiesta monocamerali.
Si veda ad esempio: Camera dei deputati, Del. 4 novembre 2015, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri; Camera dei Deputati, Del. 30 giugno 2015, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni; Camera dei Deputati, Del. 25 settembre 2013, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.
Le ulteriori disposizioni dell’articolo 5, recate dalle tre pdl, riproducono il testo delle 87/2013. In particolare è specifica che, l’autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione degli atti solo per motivi di natura istruttoria (comma 4).
La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto (comma 2) e stabilisce quali atti non devono essere divulgati (comma 6).
Viene previsto come di consueto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (art. 326 c.p.), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d’ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti (articolo 6).
Le proposte in esame (articolo 7) demandano ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione da approvare prima dell’avvio delle attività di inchiesta.
Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno (art. 7, comma 2).
La Commissione può inoltre avvalersi (a titolo gratuito come specificato dalla sola pdl C. 513 Nesci) dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di collaboratori interni o esterni alle p.a. (art. 7, comma 3). Le proposte di legge C. 513 Nesci e C. 664 Verini prevedono la facoltà di assumere anche collaborazioni da parte di soggetti pubblici (quali università ed enti di ricerca) e privati.
Le proposte di legge C. 336 Anzaldi e C. 664 Verini (ma non la pdl C. 513 Nesci) demandano, alla stregua della legge 87/2013, al regolamento interno la fissazione di un numero massimo di collaboratori.
Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, l'art. 5, al comma 4, prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera.
L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 7, comma 5, è pari, a 150.000 (C. 336 Anzaldi e C. 664 Verini) e 100.000 (C. 513 Nesci) euro per il 2018 e a 300.000 (C. 336 Anzaldi e C. 664 Verini) e 250.000 (C. 513 Nesci) euro per ciascun anno successivo.
La legge 87/2013 (promulgata in luglio) prevedeva per il primo anno una autorizzazione di spesa di 150.000 euro per il primo anno e di 300.000 per gli anni successivi.
Resta confermata la previsione secondo la quale i Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
La fissazione di un “tetto” alle spese della Commissione bicamerale è una innovazione per l’Antimafia, introdotta la prima volta con la legge 277/2006. Anche in questo caso come per la limitazione dei poteri si tratta di una modifica originata da una proposta dei relatori in sede referente alla Camera e fondata sulla considerazione dell'eccessivo volume “delle spese affrontate dalle Commissioni d'inchiesta negli ultimi tempi, che rendono perciò necessaria l'adozione di opportune misure atte a frenarne i costi per la finanza pubblica”.
Già nel corso della XV legislatura disposizioni analoghe erano già state adottate per altre commissioni di inchiesta.
La sola proposta di legge C. 336 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fissandola al giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 3

Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.
L’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, affida alla Commissione stessa il compito di « indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso ».
L’articolo 1, comma 1, lettera n) della medesima legge ha, altresì, affidato alla Commissione il compito di « svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali ».
La Commissione parlamentare antimafia, quindi, in vista della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, ritiene opportuno portare nuovamente all’attenzione delle forze politiche una proposta di autoregolamentazione che impegni i partiti politici, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche all’atto della designazione dei candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, nonché per la designazione di organi rappresentativi e di amministrazione di enti pubblici, del consiglio di amministrazione dei consorzi, del consiglio e delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere e presidente delle aziende speciali.
I partiti, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano in occasione di qualunque competizione elettorale a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati che non rispondano ai requisiti del presente codice.
La presente deliberazione si colloca in un solco di continuità con la scelta già effettuata nel corso di precedenti legislature. Vanno qui ricordate: la Relazione illustrativa per un codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative, comprendente il testo predisposto per il suddetto codice (Doc. XXIII n. 30, X legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nella seduta del 23 gennaio 1991); la Relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative (Doc. XXIII n. 1, XV legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007); la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 2010).
Successivamente è stato emanato, con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale decreto prevede cause di incandidabilità, oltre che di sospensione e decadenza, alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nei confronti di coloro che hanno riportato condanne per specifiche ipotesi di reato ivi indicate, che siano stati sottoposti a misure di prevenzione e di applicazione di misure coercitive, operando una diversificazione tra le ipotesi di incandidabilità alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento nazionale (articolo 1) e del Parlamento europeo (articolo 3), di incandidabilità alle cariche elettive regionali (articolo 7) e di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (articolo 10).
Anche alla luce di tali modifiche normative, la Commissione ritiene opportuno ritornare sulla materia, proponendo, da un lato, che vi sia un sistema unico valevole per tutti i casi di elezione di organi rappresentativi; dall’altro, che la soglia di autotutela da parte dei partiti e dei movimenti politici contro il rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere ulteriormente elevata aderendo alle previsioni del codice di autoregolamentazione predisposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta antimafia.
Tale codice amplia il novero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica; conferma la necessità di anticipare il livello di attenzione alla fase del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio; prevede l’incandidabilità a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, estendendo a tutte le competizioni elettorali la causa di incandidabilità già prevista dal decreto legislative 18 agosto 2000, n. 267, per le sole elezioni degli enti locali.
Il codice anticipa la fase di incandidabilità all’atto dell’emanazione del decreto di applicazione della misura personale o patrimoniale; introduce come condizione ostativa alla candidabilità la condanna in primo grado, ancorché non definitiva, per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva.
Si afferma, inoltre, l’incandidabilità in ogni competizione elettorale, quanto meno per una tornata elettorale, di coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. In tal senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della condanna definitiva, prevista dall’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, alla fase del decreto che dispone il giudizio, aderendo sul punto al codice di autoregolamentazione approvato nella XVI legislatura.
La politica deve così assumere il ruolo centrale di garante anticipato della collettività, già nella fase di individuazione dei candidati, contro il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque assemblea elettiva.
Il codice di autoregolamentazione qui proposto intende impegnare i partiti e i movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e altre gravi condotte. In questo ambito la Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta, come sopra indicato, con riferimento alle più gravi fattispecie di reato, ferma restando la previsione di incandidabilità contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna.
Il presente codice è soggetto ad adesione volontaria e la mancata osservanza delle disposizioni o anche la semplice mancata adesione allo stesso non dà luogo a sanzioni, semmai comporta una valutazione di carattere strettamente etico e politico nei confronti dei partiti e formazioni politiche.
La Commissione reputa necessario verificare la rispondenza della composizione delle liste elettorali alle prescrizioni del presente codice, nei confronti di chi vi aderisce, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva.
La Commissione, pertanto, nel richiamare e condividere il lavoro svolto nel corso di precedenti legislature, anche in presenza di diverse maggioranze parlamentari, propone il seguente codice di autoregolamentazione:
ART. 1.
1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:
a) delitti consumati o tentati di cui all’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (articolo 317 c.p.); corruzione per l’esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.); istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.); delitti di cui all’articolo 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;
c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’or- dinamento penitenziario (articolo 391-bis c.p.);
d) scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.);
e) estorsione (articolo 629 c.p.), usura (articolo 644 c.p.);
f) riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
g) fraudolento trasferimento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356);
h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove dispo- sizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);
i) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi- ficazioni);
j) nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convoca- zione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;
b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di sciogli- mento non sia ancora definitivo.
ART. 2.
Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.
ART. 3.
I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l’adesione al presente codice di autoregolamentazione.
ART. 4.
La Commissione parlamentare di inchiesta, nell’ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()