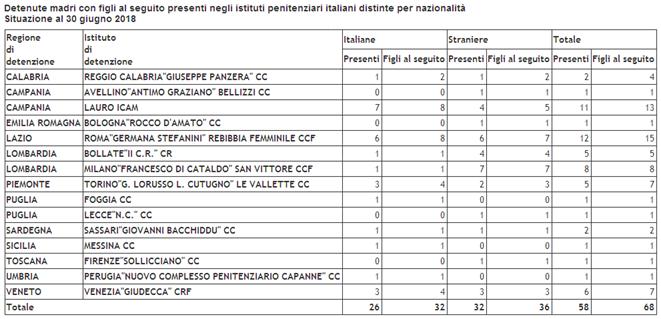Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
|
| Autore: |
Servizio Studi - Dipartimento Giustizia |
| Titolo: |
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario |
| Serie: |
Atti del Governo Numero: 39 |
| Data: |
07/09/2018 |
| Organi della Camera: |
II Giustizia |
SIWEB
A.G. 39 - Schema di decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento penitenziario

Servizio Studi
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi
@SR_Studi
Dossier n. 51

Servizio Studi
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it -  @CD_giustizia
@CD_giustizia
Atti del Governo n. 39
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Gi0023
Lo schema di decreto legislativo (A.G. 39) è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (cd. riforma Orlando), nella parte relativa alle modifiche all’ordinamento penitenziario (art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. a), d), i) l), m) o), r), t) e u)).
Lo schema è stato trasmesso alle Camere e assegnato alle Commissioni competenti per l’espressione del parere il 3 agosto 2018, termine di scadenza della delega.
Si ricorda che il 16 gennaio 2018 è stato trasmesso alle Camere un primo schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario (AG 511); su di esso, le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si sono espresse entrambe con pareri favorevoli con condizioni e osservazioni (7 febbraio 2018).
L’art. 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che i pareri sugli schemi di decreti legislativi ivi previsti sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
Dunque, dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Governo - ancora in carica, durante il periodo in regime di prorogatio delle Camere, - ha trasmesso, il 23 marzo, ai sensi del citato comma 83 dell’art. 1 della citata legge 103 - un nuovo schema di decreto legislativo (AG 17) contenente modifiche rispetto al precedente, ai fini dell’espressione del c.d. secondo parere. Su di esso le Commissioni Giustizia di Senato (11 luglio 2018) e Camera (12 luglio 2018) – costituitesi nella nuova legislatura ed espressione della nuova maggioranza parlamentare - hanno reso parere contrario.
Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame (AG 39) il Governo sottolinea che lo stesso rappresenta “un testo diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente, con conseguente superamento dell’assetto complessivo della riforma reso oggetto dei pareri contrari”. La relazione precisa inoltre che il Governo ha inteso «elaborare un nuovo testo del decreto legislativo e trasmetterlo alle Camere così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente attivazione, per la prima volta, della proroga di sessanta giorni del relativo termine» (articolo 1, comma 83).
Lo schema di decreto si caratterizza – secondo quanto specificato nella relazione illustrativa - per la “scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi”.
Il riferimento della relazione del Governo alla parte della delega di cui alla legge n. 103 del 2017 non attuata è quella volta eliminare gli automatismi e le preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale (art. 1, co.85, lett. e).
L’intero Capo III dell’AG 17 era volto all’attuazione di tale principio di delega.
Di seguito si dà sinteticamente conto del contenuto dell’A.G. 39.
Una più ampia disamina delle specifiche disposizioni dello schema di decreto legislativo sarà svolta nei paragrafi seguenti.
L’Atto del Governo n. 39 consta di 12 articoli suddivisi in 4 capi.
Il Capo I (artt. 1 e 2) detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario. In particolare, la riforma:
§ adegua l’ordinamento penitenziario ai principi di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente il riordino della medicina penitenziaria, confermando in particolare l’operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari;
§ amplia le garanzie dei reclusi modificando la disciplina della visita medica generale all’ingresso in istituto; il medico deve, in particolare, annotare nella cartella clinica tutte le informazioni riguardo a eventuali maltrattamenti o a violenze subite;
§ estende la gamma dei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a proprie spese, in particolare includendo gli interventi chirurgici nei reparti clinici interni al carcere, previ accordi con la Asl competente;
§ prevede controlli sanitari in carcere da parte della Asl anche a seguito delle segnalazioni ricevute.
Il Capo II (artt. 3-8) reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti disciplinati tanto dall’ordinamento penitenziario quanto dal codice di procedura penale. Tra gli interventi di maggior rilievo, la riforma:
§ distingue le competenze dell’autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva prevedendo, prima della condanna definitiva l’intervento del giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito) e dopo, a seconda dei casi, del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza. Nell’ordinamento attuale, invece, il magistrato di sorveglianza provvede anche nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado;
§ amplia casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato;
§ introduce una nuova procedura semplificata e a contraddittorio eventuale per la concessione in via provvisoria delle misure alternative richieste, quando la pena da scontare, anche residua, non sia superiore a un anno e sei mesi;
Il Capo III (artt. 9 e 10) detta disposizioni sulle competenze degli uffici di esecuzione penale esterna e della polizia penitenziaria. In particolare, la riforma prevede:
§ l’ampliamento delle competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna, chiamati a svolgere le attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione;
§ l’estensione dei compiti della polizia penitenziaria, chiamata a vigilare sul rispetto delle prescrizioni impartite dalla magistratura di sorveglianza.
Il Capo IV (artt. 11 e 12) è relativo alla vita all’interno del carcere.
Il provvedimento detta misure volte ad integrare i reclusi stranieri, tra le quali la garanzia ad un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso nonché l’inserimento, tra il personale dell’amministrazione degli istituti penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti. Ulteriori disposizioni sono volte invece a considerare gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute. La riforma, inoltre, integra le disposizioni dell’ordinamento penitenziario con la finalità di garantire il rispetto della dignità umana e la conformità della vita penitenziaria a quella esterna. Vanno in questa direzione le previsioni circa l’ampliamento delle ore minime che i detenuti possono trascorrere all’aperto, la richiesta prossimità tra l’istituto penitenziario e la famiglia del recluso, le specifiche tutele per i reclusi esposti a minaccia di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, l’ampliamento dei diritti di informazione e comunicazione.
Capo I
(Disposizioni per la riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario)
Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2 dello schema, detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario, in attuazione dell’articolo 1, comma 85, lettera l) della norma di delega.
Si ricorda, infatti, che la legge n. 103 del 2017 delega il Governo alla revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (art. 1, co. 85, lett. l).
L’articolo 1, adegua l’Ordinamento penitenziario ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria. Lo schema in esame non prevede invece specifiche disposizioni connesse alla necessità, espressa dalla delega, di potenziare l’assistenza psichiatrica in carcere.
Il contenuto dell’articolo 1 riproduce sostanzialmente quanto previsto nell’articolo 2, comma 1, limitatamente alla lettera a), comma 2 e comma 3 dell’AG 17.
Non risultano, invece, riproposte le previsioni, di cui all’articolo 1, nonché all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) dell’ AG 17. Con tali disposizioni tramite la novella dell’art. 65 OP, era stata prevista l’istituzione in carcere di sezioni per detenuti con infermità psichica. Era inoltre stato esteso il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena anche ai casi di grave infermità psichica sopravvenuta (art. 147 c.p.). Per coordinamento era disposta l’abrogazione dell’art. 148 c.p. che impone al giudice in tali casi il ricovero del soggetto in OPG.
In particolare, il comma 1 detta una nuova formulazione dell’articolo 11 OP, ribadendo, in primo luogo, l’operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari (comma 1).
Al riguardo si precisa che spetta al servizio sanitario l’organizzazione di un servizio medico e di un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati (comma 2).
E’ previsto (comma 3) che sia messa a disposizione, con adeguata pubblicità, una carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati (secondo quanto già stabilito dal decreto legislativo 230/1999).
Inoltre, si interviene sulla disciplina della competenza per il rilascio delle autorizzazioni in materia di ricoveri in strutture esterne di diagnosi e cura, modificando la norma sulle autorizzazioni a cure e accertamenti sanitari che non possono essere garantiti dal servizio sanitario all’interno degli istituti. La regolamentazione attuale è ripartita tra le disposizioni contenute nell’ordinamento penitenziario e quelle delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articolo 240).
L’individuazione dell’autorità competente segue il principio della posizione giuridica in cui si trovano i soggetti detenuti all’atto della prestazione richiesta. La norma dispone, infatti, che prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il GIP e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, sino alla presentazione dell'imputato in udienza, per la contestuale convalida dell’arresto in flagranza; se è proposto ricorso in cassazione procede il giudice di cui è impugnato il provvedimento. Procede invece il magistrato di sorveglianza nei casi in cui il processo si sia già concluso (comma 4).
Lo schema AG 39 non prevede – diversamente dall’ AG 17 – la possibilità per il magistrato di sorveglianza di delegare l’adozione del provvedimento di autorizzazione al direttore dell’istituto.
Un’ulteriore modifica dell’ordinamento vigente concerne la possibilità di evitare la sottoposizione a piantonamento dei detenuti e degli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e cura in assenza del pericolo di fuga (comma 5 del medesimo articolo 11 OP). La novità consiste nella specificazione che il piantonamento può essere evitato quando il controllo del degente non sia necessario per tutelare, oltre che la sua incolumità personale, anche quella di altri.
Viene quindi modificata (comma 6) la disposizione che prevede l’allontanamento ingiustificato del detenuto o dell’internato dal luogo di cura, ampliando la fattispecie anche al luogo dove è svolta la diagnosi ed eliminando il riferimento all’eventualità che non sia previsto piantonamento.
E’ inoltre oggetto di modifica la disciplina della visita medica generale all’ingresso in istituto, con particolare riferimento al diritto dei detenuti di ricevere informazioni circa lo stato di salute e alla formazione della cartella clinica. E’ quindi previsto che il medico che compie l’ispezione debba annotare, avvalendosi di rilievi fotografici se necessari, tutte le informazioni riguardo ad eventuali maltrattamenti o violenze subite, dandone comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. E’ esplicitato il diritto di ciascun detenuto o internato di ricevere informazioni complete sullo stato di salute personale (comma 7) e viene garantita la continuità terapeutica, con le indagini e le cure specialistiche necessarie persino riguardo alla medicina preventiva o connessa a patologie già esistenti (comma 9).
Inoltre è previsto che il medico del servizio sanitario nazionale garantisca quotidianamente la visita degli ammalati e di coloro che ne facciano richiesta. E’ confermata la vigente previsione che negli istituti penitenziari per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere (comma 8).
Una disposizione specifica è introdotta per i detenuti e gli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico di transizione sessuale (di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164), al fine di assicurare loro la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico (comma 10).
Con riferimento ai detenuti e agli internati sospetti o affetti da malattie contagiose, resta non modificata la previsione dell’isolamento immediato. E’ introdotto al riguardo l’obbligo per il direttore dell’istituto di darne comunicazione al magistrato di sorveglianza (comma 11).
Oggetto di modifica è altresì l’estensione dell’ambito dei trattamenti sanitari che detenuti ed internati possono richiedere a proprie spese (comma 12): essi possono infatti richiedere non solo la visita dell’esercente una professione sanitaria di loro fiducia, ma anche trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dei medesimi istituti.
Sono, di fatto, trasferite a livello di normativa primaria le disposizioni del regolamento penitenziario (DPR 230 del 2000) che già prevedono tale possibilità (art. 17, comma 7).
E’ specificato, al riguardo, che l’autorizzazione per gli imputati prima della sentenza di primo grado è data dal giudice che procede, mentre per i condannati in primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore dell’istituto. Laddove il detenuto usufruisca, a proprie spese, di trattamenti eseguiti all'interno dell'istituto prestati da medico di fiducia sono necessari i previ accordi con la competente azienda sanitaria.
Con riguardo ai trattamenti sanitari a spese dei detenuti, la relazione del Governo fa riferimento all’introduzione di una disposizione che prevederebbe la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza nel caso del diniego del direttore alla richiesta del detenuto di visite e trattamenti sanitari a proprie spese. Tale disposizione non sembra però essere contenuta nel testo dello schema.
Infine, si interviene individuando la competenza non più nel medico provinciale, ma nel direttore generale dell'azienda unità sanitaria a svolgere almeno due volte l’anno la visita generale dell’istituto penitenziario al fine di valutare l’adeguatezza delle misure di profilassi adottate (commi 13 e 14). E’ specificato altresì che il diritto di visita del dirigente dell'azienda sanitaria è riferito alle condizioni sanitarie e igieniche degli istituti e non dei reclusi. Dei risultati delle visite è data informazione anche ai competenti uffici comunali.
L’articolo 1, comma 2, reca alcune modifiche al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria). In particolare, all’articolo 1 del citato decreto legislativo, relativo al diritto alla salute dei detenuti e degli internati, è introdotto il riferimento:
· alla tempestività, tra i requisiti delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione cui i detenuti e gli internati hanno diritto al pari degli altri cittadini in stato di libertà;
· e alla marginalità sociale, tra gli ambiti di intervento che il Servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti e agli internati (il riferimento recepisce una indicazione in tal senso del Garante nazionale delle persone detenute, contenuta nel parere al Ministro della giustizia).
Sono poi abrogate alcune disposizioni del regolamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) incompatibili con le nuove disposizioni introdotte (si tratta di norme relative a visite ed altri trattamenti sanitari che detenuti ed internati possono richiedere a proprie spese).
L’articolo 2 abroga l’articolo 240 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., recante la disciplina relativa al trattamento sanitario del detenuto. Tale abrogazione è consequenziale all’introduzione delle nuove norme di riforma della medicina penitenziaria, secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 230 del 1999.
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 1 |
| L. 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà |
| Articolo 11 Servizio sanitario |
| Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria. |
1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria. |
| |
2. Garantisce a ogni istituto un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati. |
| |
3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità |
| Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione. |
4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell’imputato in udienza per la contestuale convalida dell’arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato. |
| L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale. |
5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui. |
| Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale. |
6. Il detenuto o l’internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale. |
| All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. |
7. All’atto dell’ingresso nell’istituto il detenuto e l’internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica del detenuto o internato il medico annota immediatamente, anche mediante comunicazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o maltrattamenti e, fermo l’obbligo di referto, dà comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all’atto della rimessione in libertà. L’assistenza sanitaria è prestata, durante la permanenza nell’istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e si uniforma ai princìpi di globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica. |
| (v. infra) |
8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita degli ammalati e di coloro che ne facciano richiesta; segnala immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; inoltre, controlla periodicamente l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. |
| |
9. Ai detenuti e agli internati è garantita la necessaria continuità con gli eventuali trattamenti in corso all’esterno o all’interno dell’istituto da cui siano stati trasferiti. |
| |
10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico. |
| I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale. |
11. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Il direttore dell’istituto, immediatamente informato, ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza. |
| In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. |
Soppresso
(v. sopra l’identico comma 8, ultimo periodo) |
| Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili-nido. |
Soppresso
(v. infra, art. 14, quinto comma) |
| L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità. |
Soppresso |
| I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede sino alla pronuncia della sentenza di primo grado. |
12. I detenuti e gli internati, a tutela del diritto alla salute, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L’autorizzazione, per gli imputati è data dal giudice che procede e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell’istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente. |
| Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti. |
13. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l’anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti. |
| Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza. |
14. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della salute e al Ministero della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e comunali, il magistrato di sorveglianza. |
| |
|
| Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419 |
| Articolo 1 Diritto alla salute dei detenuti e degli internati |
| 1. I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. |
1. I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. |
| 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: |
2. Identico: |
| a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi; |
a) identica; |
| b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute; |
b) identica; |
| c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere, durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; |
c) identica; |
| d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale; |
d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e della marginalità sociale; |
| e) l’assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate; |
e) identica; |
| f) l’assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari. |
f) identica. |
| 3. Ogni Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unità sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini. |
3. Identico |
| 4. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica. |
4. Identico |
| 5. Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. |
5. Identico |
| 6. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale. |
6. Identico |
| |
|
| D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. |
| Articolo 17 Assistenza sanitaria |
| 1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa |
1. Identico |
| 2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in àmbito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa. |
2. Identico |
| 3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge. |
3. Identico |
| 4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici. |
4. Identico |
| 5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge. |
5. Identico |
| 6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore. |
Abrogato |
| 7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti. |
Abrogato |
| 8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. |
8. Identico |
| 9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica |
9. Identico |
|
|
|
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 2 |
| Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale |
| Articolo 240 Trattamento sanitario del detenuto |
Abrogato |
| 1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza. 2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1 |
Abrogato |
|
|
|
Capo II
(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti)
Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti, in attuazione di quanto previsto dalla legge di delega.
La legge n. 103 del 2017 delega il Governo a prevedere la semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (art. 1, co. 85, lett. a).
In particolare, l’articolo 3 interviene sull’ordinamento penitenziario realizzando semplificazioni procedurali nonché distinguendo le competenze dell’autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva: prima della condanna definitiva è sempre competente il giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito), dopo la condanna sono competenti, a seconda dei casi, il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza.
In primo luogo sono apportate modifiche in relazione ad alcune limitazioni dei diritti (in particolare quelli relativi alla corrispondenza e ai permessi).
Il comma 1, lettera a), modifica la competenza (articolo 18-ter OP) ad adottare i provvedimenti di limitazione della corrispondenza, in coerenza con la disciplina sulla competenza introdotta all’art. 11 OP.
Viene, quindi, precisato che tali provvedimenti sono adottati dal magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati in via definitiva e degli internati (nell’ordinamento attuale il magistrato di sorveglianza provvede anche nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado), e dal giudice procedente nei confronti degli imputati. Si specifica, inoltre, che in caso proceda un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.
Il comma 1, lettera b) apporta modifiche concernenti la competenza per la concessione dei cd. permessi di necessità (di cui all’articolo 30 OP), relativi all’imminente pericolo di vita di un familiare o del convivente. In particolare, si dispone che per gli imputati tale permesso sia concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura, ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinamento penitenziario (così come modificato dallo schema in esame). Come sopra illustrato, si tratta del giudice procedente: prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell’imputato in udienza; se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il comma 1, lettera c), modifica l’ordinamento penitenziario (articolo 35-bis) con riguardo ai reclami giurisdizionali, ossia ai reclami dei detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa;
b) l'inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dall’OP e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti.
Le modifiche attengono alle modalità di avviso della fissazione dell’udienza per il procedimento relativo al reclamo, alla previsione della possibilità per l’amministrazione di comparire con un proprio dipendente, oltre che, come già previsto, di trasmettere osservazioni e richieste.
Il comma 1, lettera d), abroga poi il comma 5 dell’art. 69-bis OP che prevede attualmente la possibilità che il tribunale di sorveglianza trasmetta al magistrato di sorveglianza un’istanza di concessione della liberazione anticipata presentata durante un procedimento di sua competenza.
L’AG 17, diversamente dallo schema in esame, prevedeva la soppressione del reclamo al tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, con la conseguente sola ricorribilità in cassazione della decisione dello stesso magistrato.
Analogamente, non sono riproposte dal provvedimento in esame: le modifiche dell’art. 47 OP in tema di modifica delle prescrizioni dell’affidamento in prova al servizio sociale, quella che stabilisce un termine minimo di 15 gg dalla richiesta di parere al PM per la decisione del magistrato di sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 2, OP) nonchè le modifiche all’art. 78 OP concernente gli assistenti volontari, disposizioni - queste ultime - di specifica attuazione della lett. h) della norma di delega (previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna).
L’articolo 4 apporta modifiche agli articoli 656 e 678 del codice di procedura penale. Si tratta di modifiche che mirano a semplificare e snellire i procedimenti di esecuzione delle pene.
Il nuovo schema di decreto legislativo non riproduce le numerose novelle all’art. 656 c.p.p. previste dal precedente AG 17. La relazione illustrativa dello schema in esame precisa che la scelta di non incidere organicamente sull’art. 656 deriva dal fatto che tale intervento appariva necessario nel precedente testo, oggetto dei pareri parlamentari negativi, in quanto connesso alla complessiva rivisitazione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (non più oggetto del testo in esame). Analogamente, rispetto all’AG 17, non sono previste le modifiche agli artt. 667 (relative alla procedura da seguire in caso di dubbio sull’identità fisica della persona detenuta) e 677 c.p.p. (in materia di dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato richiedente una misura alternativa).
In particolare, il comma 1, lettera a) dell’art. 4 modifica il solo comma 6 dell’articolo 656 c.p.p., introducendo un termine dilatorio di trenta giorni (dalla ricezione dell’istanza di sospensione della pena detentiva) per la decisione del tribunale di sorveglianza. Attualmente la decisione del tribunale può arrivare anche prima, essendo fissato solo un termine massimo di 45 gg dalla ricezione della richiesta.
La relazione illustrativa motiva questo intervento con il necessario adeguamento a quanto stabilito dalla delega nell’articolo 1, comma 85, lett. d), dove si prescrive che, in sede di attuazione della delega, venga prevista come obbligatoria l’osservazione scientifica della personalità, da condurre nei confronti del condannato in libertà, e che ne vengano contestualmente fissati i tempi.
Il comma 1, lettera b), apporta poi numerose e rilevanti modifiche all’articolo 678 c.p.p., relativo al procedimento di sorveglianza:
· in ordine al comma 1, si conferma che il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del PM, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. L’unica modifica attiene all’aggiunta della specificazione che gli stessi procedono “se non diversamente previsto”.
Secondo la relazione illustrativa l’introduzione di tale inciso mira a fare salve sia le ipotesi in cui il giudice, anziché adottare il procedimento di sorveglianza, si avvalga, per le decisioni in tema di misure alternative, di un rito “semplificato”, sia le non marginali diversità di regolamentazione, sul piano delle garanzie processuali, rispetto a quella stabilita nell’articolo 666 c.p.p.. Pur considerando il rapporto di specialità intercorrente tra gli articoli 678 e 666 c.p.p., che dovrebbe rendere superfluo il suddetto inciso, la relazione illustrativa ritiene preferibile il suo inserimento ai fini di una maggiore chiarezza.
· con la modifica al comma 1-bis, per esigenze di economia processuale, sono ampliati i casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato, a norma dell’articolo 667, comma 4, c.p.p. (secondo il quale il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato). In particolare, la procedura semplificata è estesa alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e all’ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza si pronunci sul differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal comma 1, numeri 1) e 2), dell’articolo 146 c.p. (ossia se deve aver luogo nei confronti di donna incinta o se deve aver luogo nei confronti di madre di un bambino di età inferiore ad un anno);
· viene valorizzata la funzione monocratica nell’ambito delle competenze del tribunale di sorveglianza con l’inserimento del comma 1-ter, con il quale, nelle ipotesi relative a un tetto di pena (anche residua) non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le misure alternative di cui all’art. 656 c.p.p., comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza designa un magistrato relatore, al quale è consentito, ove ne sussistano i presupposti, concedere in via provvisoria, con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta; in tale evenienza l’ordinanza è comunicata al PM e notificata all’interessato e al difensore, i quali sono legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni; l’ordinanza resta sospesa durante il termine per proporre opposizione e fino alla decisione definitiva del tribunale; il tribunale, quindi, interviene in seconda battuta per decidere se confermare (senza formalità di procedura) la decisione del magistrato designato, ovvero dare avvio al rito ordinario (articoli 666 e 678 c.p.p.), al cui esito verrà adottato il provvedimento definitivo. Nel caso di opposizione avverso l’ordinanza del magistrato è obbligatorio il ricorso al rito ordinario (articoli 666 e 678 c.p.p.). La disposizione dà specifica attuazione a quanto richiesto dalla norma di delega in ordine al semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza (lett. a);
· sono, infine, aggiunti due commi immediatamente dopo il comma 3, per garantire il diritto alla pubblicità dell’udienza e alla presenza dell’interessato.
Tali disposizioni attuano il principio di delega di cui al comma 85, lett. c) nella sola parte in cui prevede “che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza”.
E’ infatti previsto (comma 3.1) che quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472 c.p.p. (che disciplinano la pubblicità dell’udienza e i casi in cui essa si debba svolgere a porte chiuse ). Inoltre è previsto (comma 3.2) che l’avviso di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contenga, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. E’ in ogni caso specificato che si applicano le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta (quindi anche se si trovi in istituto penitenziario all’interno della circoscrizione del giudice procedente) o quando, come attualmente, lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla indicata circoscrizione. In ogni caso è consentito al giudice che lo ritenga opportuno disporre la traduzione dell’interessato. Sul punto la riforma dà attuazione a un ulteriore principio di delega, relativo all’utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa (lett. i).
Diversamente dall’AG 17, non viene modificato dallo schema di decreto in esame l’articolo 680 c.p.p. nel quale veniva precisata la forma di impugnazione (cioè l’appello) su cui il tribunale di sorveglianza deve pronunciarsi riguardo ai provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 3 |
| Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. |
| Articolo 18-ter Limitazioni e controlli della corrispondenza |
| 1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. |
1. Identico |
| 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte. |
2. Identico |
| 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: |
3. Identico: |
| a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; |
a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; |
| b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. |
b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell’articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise. |
| 4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. |
4. Identico |
| 5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati. |
5. Identico |
| 6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. |
6. Identico |
| 7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato. |
7. Identico |
| |
|
| Articolo 30 Permessi |
| Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello. |
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11. |
| Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. |
Identico |
| Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. |
Identico |
| L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare. |
Identico |
| |
|
| Articolo 35-bis Reclamo giurisdizionale |
| 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. |
1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all’amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste. |
| 2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. |
2. Identico |
| 3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice. |
3. Identico |
| 4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. |
4. Identico |
| 4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. |
4-bis. Identico |
| 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. |
5. Identico |
| 6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito; c) [se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;] d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. |
6. Identico |
| 7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. |
7. Identico |
| 8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. |
8. Identico |
| |
|
| Articolo 69-bis Procedimento in materia di liberazione anticipata |
| 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. |
1. Identico |
| 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. |
2. Identico |
| 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. |
3. Identico |
| 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. |
4. Identico |
| 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza. |
Abrogato |
|
|
|
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 4 |
Codice di procedura penale |
| Articolo 656 Esecuzione delle pene detentive |
| 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. |
1. Identico |
| 2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato |
2. Identico |
| 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato. |
3. Identico |
| 4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277. |
4. Identico |
| 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. |
4-bis. Identico |
| 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. |
4-ter. Identico |
| 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. |
4-quater. Identico |
| 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. |
5. Identico |
| 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. |
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. |
| 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. |
7. Identico |
| 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. |
8. Identico |
| 8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica. |
8-bis. Identico |
| 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c) [nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale»]. |
9. Identico |
| 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza. |
10. Identico |
| |
|
| Articolo 678 Procedimento di sorveglianza |
| 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. |
1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma 4. |
| 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. |
1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell’articolo 667, comma 4. |
| |
1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all’articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell’articolo 656, comma 5. L’ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l’opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa. |
| 2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. |
2. Identico. |
| 3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. |
3. Identico. |
| |
3.1. Quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472. |
| |
3.2. L’avviso di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell’interessato. |
| 3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna. |
Identico |
|
|
|
L’articolo 5 detta alcune modifiche all’art. 51-bis OP in materia di nuovi titoli di privazione della libertà sopravvenuti ad una misura alternativa.
L’articolo riproduce il contenuto dell’art. 17 dell’AG 17.
In particolare si stabilisce (comma 1, lett. a):
§ che il procedimento da seguire riguarda l’esecuzione di ogni misura alternativa (attualmente, il riferimento è a titoli esecutivi di pena che sopravvengano al solo affidamento in prova al servizio sociale);
§ che il PM competente ad informare il magistrato di sorveglianza è quello individuato per l’esecuzione delle misure del giudice in base alle regole generali di cui all’art. 655 c.p.p.;
§ che la valutazione del magistrato di sorveglianza si concentra sulla permanenza delle condizioni di applicabilità della misura alternativa;
§ che spetta a questi, oltre che ordinare l’eventuale cessazione della misura, ordinare l’accompagnamento in istituto del condannato (non è, quindi, necessario l’intervento del PM).
Lo stesso articolo 5 comma 1, lett. b) sostituisce l’art. 51-ter OP, oltre che per alcune modifiche di coordinamento con l’art. 51-bis (ci si riferisce anche qui a tutte le misure alternative), anche in relazione al procedimento di sospensione cautelativa delle misure. Si prevede, infatti, che lo stesso magistrato di sorveglianza possa, anziché sospendere la misura, attivare direttamente il tribunale di sorveglianza perché decida sulla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.
L’articolo 6 aggiunge all’ordinamento penitenziario un nuovo articolo 51-quater in attuazione del principio di delega in materia di pene accessorie.
La legge n. 103 del 2017 delega il Governo alla revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione di ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla pena principale (art. 1, co. 85, lett. u).
L’art. 51-quater detta una regola generale che prevede, in caso di applicazione di una misura alternativa, la possibilità per il giudice (che ha emesso la sentenza di condanna) di sospendere l’applicazione delle pene accessorie in considerazione delle esigenze di reinserimento sociale del condannato. Le pene accessorie già in corso di applicazione, se la misura alternativa è revocata, sono sospese ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.
L’articolo 6 del provvedimento in esame riproduce il contenuto dell’articolo 18, commi 1 e 2, dell’AG 17. In materia di pene accessorie, il comma 3 dell’articolo 18, il cui contenuto non è stato riprodotto, prevedeva una disposizione volta all’introduzione di una disciplina più favorevole per l’affidamento in prova ex artt. 47 e 47-septies OP che stabiliva che, all’esito positivo del periodo di prova, conseguisse l’estinzione delle pene accessorie non ancora eseguite.
Gli articoli 7 e 8 (come i successivi 9 e 10) dello schema di decreto costituiscono applicazione del principio di delega di cui al comma 85, lett. d).
La legge n. 103 del 2017 delega il Governo alla previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici di esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria (art. 1, co. 85, lett. d).
L’articolo 7, con la lettera a), novella l’art. 47, comma 2, OP, stabilendo che, in caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto in stato di libertà, l’osservazione scientifica della personalità (per almeno un mese) è di competenza degli Uffici per l’esecuzione penale esterna. Come noto, il risultato di tale osservazione è alla base della decisione del tribunale di sorveglianza sulla misura nel caso di soggetto in stato di detenzione.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 riproduce il contenuto dell’articolo 14, comma 1, lett. a) n. 2 dell’ AG 17. La lettera b) del medesimo articolo 7 riproduce invece il contenuto dell’articolo 20, comma 1, lettera a) dell’AG 17.
La novella appare connessa sia alla modifica all’art. 656 c.p.p. che prevede che il tribunale di sorveglianza decida sulla concessione dell’affidamento non prima di un mese dalla richiesta (cfr. art. 4) sia a quella dell’art. 72 OP, sulle nuove competenze degli UEPE (cfr. art. 9).
L’articolo 8 integra la formulazione dell’articolo 58 OP, relativo alle comunicazione all’attività di pubblica sicurezza dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.
L’articolo 8 riproduce il contenuto dell’articolo 21 dell’AG 17.
Le nuove disposizioni prevedono il possibile coinvolgimento nell’attività di controllo dell’esecuzione penale esterna del corpo di polizia penitenziaria (attualmente, il controllo è in capo ai servizi sociali, ex art. 96 e 118, regolamento penitenziario).
Tale controllo – inerente le sole prescrizioni sulla dimora, la libertà di locomozione, il divieto di portare armi e frequentare locali - può essere richiesto su indicazione del direttore dell’UEPE, in coordinamento con l’autorità di PS. Le attività di controllo devono essere informate al principio del minor pregiudizio per il reinserimento sociale e l’attività lavorativa dell’interessato nonché nel rispetto dei diritti dell’interessato e della sua famiglia
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 5 |
| Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà |
| Articolo 51-bis Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà |
| 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione. |
1. Quando, durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell’articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto. |
| 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis. |
2. Identico |
| |
|
| Articolo 51-ter Sospensione cautelativa delle misure alternative |
| 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. |
1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. |
| 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. |
|
|
|
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 6 |
| Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. |
| |
Articolo 51-quater Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative |
| |
1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione. |
| |
2. In caso di revoca della misura, ove disposta l’applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l’esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata. |
|
|
|
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 7 |
| Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. |
| Articolo 47 Affidamento in prova al servizio sociale |
| 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. |
1. Identico. |
| 2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. |
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. |
| 3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. |
3. Identico. |
| 3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. |
3-bis. Identico. |
| 4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. |
4. Identico. |
| 5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. |
5. Identico. |
| 6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. |
6. Identico. |
| 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. |
7. Identico. |
| 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10. |
8. Identico. |
| 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. |
9. Identico. |
| 10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. |
10. Identico. |
| 11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. |
11. Identico. |
| 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. |
12. Identico. |
| 12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3. |
12-bis. Identico. |
| |
|
| Articolo 57 |
| Legittimazione alla richiesta dei benefici |
Legittimazione alla richiesta di misure |
| 1. Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina |
1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53, 54 nonché all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento. |
|
|
|
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 8 |
| Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. |
| Articolo 58 Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza |
| Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria. |
Identico |
| |
Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi. |
| |
Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative. |
|
|
|
Capo III
(Modifiche all’ordinamento penitenziario in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria)
Il Capo III dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli 9 e 10, interviene sull’ordinamento penitenziario e sulla disciplina del corpo di polizia penitenziaria.
L’articolo 9 interviene sull’ordinamento penitenziario per ampliare le competenze degli uffici locali di esecuzione esterna, attuando così la lettera d) della norma di delega.
La legge n. 103 del 2017 delega il Governo alla previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici di esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria (art. 1, co. 85, lett. d).
In particolare, rispetto alla normativa vigente, la riforma modifica l’art. 72 della legge 354/1975 ampliando le competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna. E’, infatti, attribuita loro - oltre che la competenza per le indagini socio-familiari – anche quella per le attività di osservazione del comportamento ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.
L’AG 17 prevedeva (all’articolo 23, comma 1, lettera c), n. 1) identica modifica all’art. 72 OP. Lo schema di decreto in esame non ha invece riproposto le modifiche agli artt. 16 e 17 dell’ordinamento penitenziario – attuative del comma 85, lett. h) della norma di delega e contenute nel citato articolo 23 dell’AG 17 - volte a permettere un maggior coinvolgimento del volontariato sociale nel trattamento penitenziario esterno ed esterno al carcere.
L’attuazione della indicata norma di delega è integrata dall’articolo 10 dello schema, che interviene sulla legge che disciplina il corpo di polizia penitenziaria (legge 395 del 1990.
In particolare, la disposizione modifica l’art. 5 della legge n. 395 del 1990 per estendere i compiti della polizia penitenziaria, ricomprendendovi anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni date dalla magistratura di sorveglianza.
L’articolo 10 riproduce il contenuto dell’articolo 24 dell’AG 17.
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 9 |
| Legge n. 354 del 26 luglio 1975 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà |
| Capo III esecuzione penale esterna ed assistenza Articolo 72 Uffici locali di esecuzione penale esterna |
| 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. |
1. Identico |
| 2. Gli uffici: |
2. Identico |
| a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; |
a) identica |
| b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; |
b) svolgono le indagini socio-familiari e l’attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; |
| c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; |
c) identica |
| d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; |
d) identica |
| e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; |
e) identica |
| f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento. |
f) identica. |
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 10 |
| Legge n. 395 del 15 dicembre 1990 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. |
| Articolo 5 Compiti istituzionali |
| 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti. |
1. Identico |
| 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. |
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza |
| 3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto. |
3. Identico |
| 4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato. |
4. Identico |
| 5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche |
5. Identico |
|
|
|
Capo VI
(Disposizioni in tema di vita penitenziaria)
Il Capo IV, composto dall’articolo 11 e dall’articolo 12 (il quale riguarda le sole disposizioni finanziarie) modifica numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario. Tali disposizioni sono adottate - secondo quanto riportato nella relazione illustrativa - nella prospettiva “del rafforzamento dei diritti di detenuti e internati”.
Le novelle di cui all’art. 11 costituiscono attuazione prevalente dei principi di delega di cui alle lettere o), r) e t) della norma di delega.
La legge n. 103 del 2017 delega il Governo a prevedere norme:
- che favoriscano l’integrazione delle persone detenute straniere (lett. o);
- volte al rispetto della dignità umana, attraverso la responsabilizzazione dei detenuti e la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lett. r);
- che considerino gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute (lett. t).
Con riguardo alla lett. r), va segnalata – come esplicitato nella relazione - la rinuncia da parte del Governo all’esercizio della delega relativa alla cd. sorveglianza dinamica dei detenuti.
In particolare, con la modifica dell’articolo 1 OP, che detta i principi base sui quali si fonda il trattamento penitenziario con finalità di rieducazione, la riforma:
§ ribadisce la garanzia dei diritti fondamentali e il divieto di ogni violenza in danno delle persone private della libertà personale; particolare rilievo assume la specificazione che il trattamento penitenziario è improntato anche alla non discriminazione per ragioni di sesso, di identità di genere, di orientamento sessuale;
§ afferma fin da subito che il reinserimento sociale cui tende il trattamento si realizza non solo con i contatti con l’ambiente esterno al carcere ma anche attraverso l’accesso alle misure alternative alla detenzione;
Risulta soppressa, rispetto all’AG 17, la previsione secondo la quale la sorveglianza dei detenuti è improntata al rispetto delle regole dettate dal Consiglio d’Europa e richiede che questi possano trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle celle così da favorire i rapporti interpersonali e l’osservazione del comportamento e della personalità dei reclusi.
La modifica dell’articolo 9, sull’alimentazione in carcere, è volta a garantire ai reclusi una alimentazione rispettosa del loro credo religioso; delle diverse abitudini e culture alimentari, invece, si terrà conto «ove possibile».
In relazione alla permanenza all’aperto, con la modifica dell’articolo 10 la riforma porta le ore d’aria a un minimo di 4 (attualmente il minimo è di 2 ore). Tale ampliamento appare bilanciato dalla possibilità del direttore di riduzione delle ore d’aria per giustificati motivi (anziché “soltanto per motivi eccezionali”); la riduzione è comunque prevista fino a 2 ore (attualmente una sola ora) e viene comunicata dal direttore dell’istituto sia al magistrato di sorveglianza che al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria).
Anche in tal caso (cfr. nuovo art. 11, comma 12, OP) disciplinando con legge quanto già previsto a livello regolamentare (art. 16, comma 4, DPR 230/2000), si stabilisce che gli spazi all’aria aperta degli istituti penitenziari devono offrire la possibilità di proteggersi dagli agenti atmosferici.
Per quanto riguarda l’individualizzazione del trattamento, con la modifica dell’articolo 13 la riforma specifica che attraverso l’osservazione della personalità del recluso si intende anche offrirgli la possibilità di riflettere sul fatto criminoso e sulle conseguenza prodotte, in particolare sulla vittima.
Tale disposizione concerne la disposizione di delega finalizzata a favorire la “responsabilizzazione dei detenuti” (comma 85, lett. r). La stessa previsione appare connessa, inoltre, all’attuazione della delega sulla giustizia riparativa (comma 85, lett. f), di cui appare necessaria premessa.
Si ricorda peraltro che in attuazione del principio di delega di cui alla lettera f), in materia di giustizia ripartiva e di mediazione reo-vittima, il Governo ha presentato uno specifico schema di decreto legislativo (AG n. 29), attualmente all’esame delle Camere per l’espressione del parere.
Si afferma, inoltre, che le indicazioni sul trattamento rieducativo, frutto dei risultati dell’osservazione, devono essere redatte entro 6 mesi dall’ingresso in istituto: saranno poi periodicamente aggiornate e seguiranno il recluso negli eventuali spostamenti ad altri istituti.
L’articolo 11 modifica anche l’articolo 14 dell’ordinamento penitenziario, relativo all’assegnazione dei reclusi, affermando da subito il principio – che sarà poi specificato dall’art. 42 OP (v. infra) – di prossimità dell’istituto penitenziario cui il recluso è assegnato alla dimora stabile della famiglia.
Tale previsione, che rimuove - secondo la relazione illustrativa - uno dei principali ostacoli ai contatti con la famiglia è volta “ad assicurare l’effettivo esercizio dell’affettività (criterio n) della delega)”.
Va segnalato che tale previsione risulta solo parzialmente attuativa della disposizione di delega che – con il riconoscimento del diritto all'affettività dei detenuti - richiede al Governo “la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio” (comma 85, lett. n).
In presenza di reclusi esposti a minaccia o a soprusi in ragione della propria identità di genere o del proprio orientamento sessuale, la riforma consente l’assegnazione, per categorie omogenee, in sezioni apposite degli istituti penitenziari che dovranno essere distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale. In tal caso, però, l’assegnazione potrà essere effettuata soltanto previo consenso dell’interessato (in alternativa il recluso potrà essere inserito in una sezione ordinaria) e dovrà essere comunque garantita la partecipazione ad attività trattamentali eventualmente insieme agli altri detenuti (evitando così forme di ghettizzazione).
Specifiche disposizioni sono dettate sulle donne recluse, che – come già previsto – sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituti misti. La riforma aggiunge che l’assegnazione a sezioni deve garantire che il numero delle recluse sia «tale da non compromettere le attività trattamentali».
Per coerenza sistematica viene, inoltre, spostata nell’art. 14 OP la disposizione di cui all’art. 11, comma 9 dello stesso OP (soppresso dall’art. 1 dello schema) che prevede che alle detenute madri sia consentito tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni, predisponendo all’interno del carcere asili nido per la cura e l’assistenza dei minori.
Al 30 giugno 2018, il Ministero della giustizia ha censito 68 bambini nelle carceri italiane.
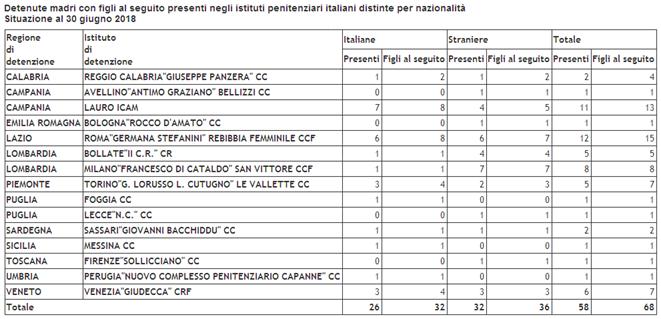
Con la modifica dell’articolo 15 OP, lo schema di decreto legislativo introduce la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità agli elementi sui quali può fondarsi il trattamento rieducativo, che vanno ad aggiungersi all’istruzione, al lavoro, alla religione ed alle attività ricreative, culturali e sportive.
In tema di colloqui, corrispondenza e informazione, la riforma modifica l’articolo 18 OP prevedendo, tra le novità:
§ il diritto dei reclusi a conferire con il difensore sin dall’inizio della misura restrittiva (la previsione costituisce, peraltro, attuazione della sentenza n. 212 del 1997 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato, in tal senso, la parziale illegittimità dell’art. 18 OP);
§ il diritto dei reclusi a una libera informazione (garantita tramite l’accesso a quotidiani e siti informativi, con le cautele che saranno dettate dal regolamento attuativo) e alla libera espressione delle proprie opinioni;
§ che i locali destinati ai colloqui debbano essere preferibilmente collocati all’ingresso dell’istituto e debbano favorire, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio. La riforma specifica che particolare cura debba essere dedicata ai colloqui che coinvolgano minori di 14 anni.
In ordine alla formulazione del testo, si valuti la correzione della lettera g), n. 3, dell’articolo 11 che attualmente così dispone: «I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto….».
La riforma, inoltre, attribuisce al direttore dell’istituto penitenziario la competenza ad autorizzare i colloqui, la corrispondenza telefonica e gli altri tipi di comunicazione degli imputati dopo la sentenza di primo grado; attualmente, dopo tale sentenza il direttore è competente solo per i colloqui, restando tutte le altre forme di comunicazione sottoposte all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Con una modifica dell’articolo 19 OP, sull’istruzione, la riforma intende garantire la parità di accesso alla formazione culturale e professionale delle donne recluse e l’integrazione dei detenuti stranieri, per i quali è previsto l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza della Costituzione.
Alla possibile frequenza di corsi universitari è aggiunta la frequenza di corsi tecnici superiori e la riforma favorisce l’ammissione di detenuti ai tirocini formativi e di orientamento previsti dalla legge Fornero (legge n. 92 del 2012).
Inoltre, la commissione competente per l’organizzazione delle attività culturali, ricreative o sportive, prevista dall’articolo 27 OP, è integrata con la partecipazione di mediatori culturali, al fine di meglio integrare i reclusi stranieri.
Viene poi riformulato l’articolo 31 OP, sulle rappresentanze dei reclusi, per specificare che negli istituti che ospitano sezioni femminili deve essere assicurata rappresentanza anche a una detenuta o internata
Il nuovo contenuto degli artt. 19, 27 e 31 OP appare specificamente riferito alle disposizioni di delega di cui al comma 85, lett. o) e t).
L’articolo 11 modifica inoltre le seguenti, ulteriori disposizioni dell’ordinamento penitenziario:
§ l’articolo 33, sul regime di isolamento, per specificare che la misura può riguardare oltre che gli imputati, gli indagati sottoposti a custodia cautelare solo se vi sono ragioni di cautela processuale (attualmente la norma prevede“fino a che ciò sia ritenuto necessario dall’autorità giudiziaria”).
Altra novità riguarda l’obbligo, da parte dell’autorità giudiziaria competente, di indicare la durata e le ragioni della misura.
Inoltre, la riforma demanda al regolamento di esecuzione (DPR 230/2000) per la specificazione delle modalità di attuazione dell’isolamento, che dovranno comunque garantire le normali condizioni di vita del recluso e l’accesso ai colloqui visivi con gli autorizzati.
Si segnala che la relazione illustrativa riferisce di un adeguamento formale dell’art. 33 alla nomenclatura processuale (in relazione alla sostituzione del termine “istruttoria” con quello attuale di “indagini preliminari”) che non trova, tuttavia, riscontro nel testo dello schema di decreto.
§ gli articoli 36 e 40, sul procedimento disciplinare, per specificare che nell’applicazione della sanzione disciplinare si deve tenere conto del programma di trattamento in corso e per modificare la composizione del consiglio di disciplina, eliminando il sanitario e inserendo al suo posto un professionista esperto in psicologia, servizio sociale, psichiatria o criminologia clinica (ex art. 80 OP). La riforma dà così attuazione alla lett. m) della norma di delega.
La legge n. 103 del 2017 delega espressamente il Governo ad escludere il sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario (art. 1, co. 85, lett. m).
§ l’articolo 42, sui trasferimenti, per ribadire il principio di prossimità tra il recluso e la famiglia di origine o il suo centro di riferimento sociale, chiedendo all’amministrazione penitenziaria di motivare la deroga a tale principio (attualmente si deve solo “favorire” il criterio di prossimità alla residenza della famiglia). Inoltre, la riforma prevede che quando il trasferimento è chiesto dal detenuto, l’amministrazione deve rispondere con atto motivato entro 60 giorni;
§ l’articolo 43, in tema di dimissioni dal carcere, per specificare che i reclusi devono essere dimessi con documenti di identità validi;
§ l’articolo 45, sull’assistenza alle famiglie, per aggiungere anche le finalità di aiuto economico sociale, disponendo che per consentire la programmazione degli interventi e delle risorse da parte dei servizi sociali (come richiesto dalla legge n. 328 del 2000), il recluso privo di residenza anagrafica sia iscritto nei registri della popolazione residente nel comune ove è situato il carcere mentre gli altri possono comunque spostare in tale comune l’originaria residenza.
§ l’articolo 80, in tema di personale, per specificare che - per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento - l’amministrazione carceraria può avvalersi anche di mediatori culturali e interpreti, cui corrispondere onorari proporzionati alle prestazioni professionali effettuate.
Sul punto, la relazione del Governo considera il mediatore come lo “strumento principale per supplire al deficit di comprensione del sistema giudiziario e all’assenza di legami col mondo esterno”, cause principali delle difficoltà di integrazione dello straniero.
Rispetto a quanto previsto dall’AG 17, la riforma in esame non modifica:
- l’articolo 30 OP, in tema di permessi. Tale disposizione, come novellata dall’AG 17, consentiva l’uscita dal carcere in presenza di eventi familiari non solo gravi ma anche di particolare rilevanza. Dall’ambito applicativo del nuovo art. 30 erano esclusi i reclusi in regime di 41-bis OP.
- l’articolo 34 OP che prevedeva che le perquisizioni personali dovessero svolgersi nel rispetto, oltre che della personalità, anche della dignità della persona. Delle modalità di esecuzione e delle ragioni delle stesse (con particolare riferimento al denudamento) doveva essere dato conto nel verbale delle operazioni.
L’articolo 12 dello schema di decreto reca, infine disposizioni di natura finanziaria.
Alla regola generale della complessiva invarianza finanziaria della riforma, fanno eccezione due disposizioni dell’articolo 11 (sulla vita in carcere) dello schema di decreto, per le quali è disposta specifica copertura:
§ la prima (comma 1, lett. c) riguarda le disposizioni dell’art. 10 OP sul diritto dei detenuti alle ore d’aria (sembra ci si debba riferire alle necessità derivanti dall’obbligo di protezione dagli agenti atmosferici);
§ la seconda (comma 1, lett. s) riguarda la presenza di mediatori culturali e interpreti negli istituti penitenziari (art. 80 OP), cui vanno corrisposti onorari proporzionati alle prestazioni rese.
Per entrambe le finalità è autorizzata una spesa di 2.490.000 euro nel biennio 2018-2019 nonché di 1.440.000 euro annui a decorrere dal 2020.
| Normativa vigente |
A.G. 39, art. 11 |
| Legge n. 354 del 26 luglio 1975 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà |
| Articolo 1 Trattamento e rieducazione |
| Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. |
1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione. |
| Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. |
| (v. infra, sesto comma) |
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. |
| |
3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. |
| Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. |
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. |
| 5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. |
| I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. |
6. Identico |
| Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. |
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. |
| Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. |
(vedi sopra, comma 2) |
| |
|
| Articolo 9 Alimentazione |
| Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. |
Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso. |
| Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati. |
Identico |
| I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile. |
Identico |
| La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. |
Identico |
| Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria. |
Identico |
| Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. |
Identico |
| Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto |
Identico |
| |
| Articolo 10 Permanenza all’aperto |
| Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali. |
Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. |
| Per giustificati motivi la permanenza all’aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell’istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. |
| |
Gli spazi destinati alla permanenza all’aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici. |
| La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici. |
Identico |
| |
| Articolo 13 Individualizzazione del trattamento |
| Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. |
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. |
| Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. |
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. |
| |
Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. |
| Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. |
L’osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dall’esecuzione. |
| Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. |
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l’interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. |
| Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento |
Identico |
| |
| Articolo 14 Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati |
| |
I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari. |
| Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. |
Identico. |
| L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 42. |
L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. |
| E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione. |
Identico |
| E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza. |
Identico |
| Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto. |
Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali. |
| (v. sopra, art. 11 OP, ottavo comma) |
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. |
| |
L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E’ in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta. |
| |
|
| Articolo 15 Elementi del trattamento |
| Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. |
Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. |
| Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. |
Identico. |
| Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica. |
Identico. |
| |
|
| Articolo 18 Colloqui, corrispondenza e informazione |
| I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. |
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici. |
| |
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui con i garanti dei diritti dei detenuti. |
| I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. |
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. |
| Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. |
Identico |
| L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. |
Identico |
| Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. |
Identico |
| I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. |
Identico |
| |
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. |
| |
L’informazione è garantita per mezzo dell’accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento |
| Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto. |
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell’articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell’istituto. |
| |
| Articolo 19 Istruzione |
| Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. |
Identico |
| Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. |
Identico |
| |
Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. |
| |
Speciale attenzione è dedicata all’integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei princìpi costituzionali. |
| Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. |
Identico |
| E' agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. |
Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l’ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92. |
| E’ favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture. |
Identico. |
| |
| Articolo 27 Attività culturali, ricreative e sportive |
| Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. |
Identico. |
| Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale. |
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale. |
| |
| Articolo 31 Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati |
| Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto. |
1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto. |
| |
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata. |
| |
| Articolo 33 Isolamento |
| Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: |
1. Identico: |
| 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie; |
1) identico; |
| 2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; |
2) identico |
| 3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria. |
3) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell’autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell’isolamento. |
| |
2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell’isolamento. |
| |
3. Durante la sottoposizione all’isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato. |
| |
4. L’isolamento non preclude l’esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati. |
| |
| Articolo 36 Regime disciplinare |
| Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti. |
Identico. |
| |
Nell’applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso. |
| |
| Articolo 40 Autorità competente a deliberare le sanzioni |
| Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore. |
Identico |
| Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore |
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall’impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80. |
| |
| Articolo 42 Trasferimenti |
| I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. |
Identico |
| Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie. |
Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. |
| |
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. |
| I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. |
Identico |
| |
| Articolo 43 Dimissione |
| La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. |
Identico |
| Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione. |
Identico |
| Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto. |
Identico |
| Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta. |
Identico |
| I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile. |
Identico |
| |
I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L’amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali |
| |
| Articolo 45 |
| Assistenza alle famiglie |
Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali |
| Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. |
Identico |
| Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale. |
Identico |
| E’ utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale |
Identico |
| |
Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del Comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata. |
| |
| Articolo 80 Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena |
| Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72. |
Identico |
| L'amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro. |
Identico |
| Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. |
Identico |
| Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. |
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. |
| Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. |
Identico |
| A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. |
Identico |
| Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione. |
Identico. |
|
|
|

![]() @SR_Studi
@SR_Studi
![]() @CD_giustizia
@CD_giustizia