
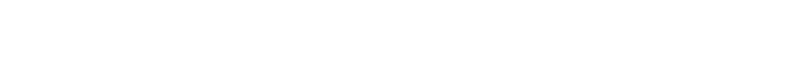
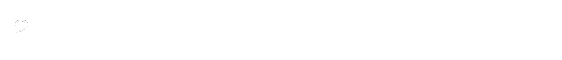
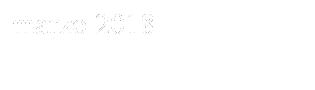
| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione | |
|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri |
| Titolo: | Partecipazione alla LXXIII Assemblea generale delle Nazioni Unite (New York, 25-28 settembre 2018) |
| Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 17 |
| Data: | 21/09/2018 |
| Organi della Camera: | III Affari esteri |
| Nota: | Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca) |

Servizio degli Affari Internazionali
Tel. 06 6706-3666 – segreteriaAAII@senato.it
Dossier n. 5

Servizio Studi
Dipartimento Affari esteri
Tel. 06 6760-4172 - * st_affari_esteri@camera.it - ![]() @CD_esteri
@CD_esteri
Ha collaborato il Servizio Rapporti Internazionali
Documentazione e ricerche n. 17
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ES038.docx
I N D I C E
Il rapporto dell’UNODC sul traffico di migranti (a cura del Servizio Studi della Camera)
I recenti sviluppi della crisi in Libia (a cura del Servizio Affari Internazionali del Senato)
La conclusione del conflitto tra Eritrea ed Etiopia (a cura del Servizio Studi della Camera)
SCHEDE PAESE (OMISSIS)
Yury Fedotov, Direttore Esecutivo UNODC
Jean-Pierre Francois Renaud Lacroix Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations (DPKO)
Vera Songwe, Segretaria esecutiva della Commissione Economica per l'Africa delle Nazioni Unite
Ibrahim Thiaw, Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahel
Dall'inizio del suo mandato nel 2017, il Segretario Generale Guterres si è dedicato al rilancio del ruolo politico dell'ONU, avviando un'ambiziosa riforma interna che si articola lungo 3 direttrici: riforma del management, riforma del settore pace e sicurezza e riforma del sistema di sviluppo.
In tale quadro è maturata l'esigenza di affinare lo strumento delle operazioni di peacekeeping, per porre l'ONU al centro di un sistema di sicurezza in cui le organizzazioni regionali e sub-regionali e la società civile possano dare un contributo in partenariato con le Nazioni Unite.
Le principali sfide derivano dall'insufficienza o l'assenza di soluzioni politiche, dalla stratificazione dei mandati e dalla mancanza di priorità chiare, dalle minacce complesse che mettono a rischio la vita dei peacekepers[1] e per fronteggiare le quali sarebbero necessari personale ed equipaggiamenti più adatti, dalla possibilità o meno di contribuire alla protezione dei civili, dalla possibilità o meno di contribuire ad una pace sostenibile nel lungo periodo e di operare con maggiore coerenza con gli atri attori che operano nei medesimi contesti
A tale riguardo, Guterres, in occasione del 70° anniversario del peacekeeping, ha lanciato il 28 marzo 2018 l'Action for Peacekeeping (A4P), un'iniziativa volta a sviluppare una Dichiarazione di impegni condivisi da tutti gli attori e gli stakeholders del peacekeeping che testimoni il rinnovo dell'impegno politico verso le operazioni di peacekeeping, con l'obiettivo di finalizzare un accordo formale entro la fine del 2018.
Tale Dichiarazione, frutto delle consultazioni svolte a New York nei mesi di giugno-luglio 2018 tra Stati membri, Segretariato e organizzazioni internazionali e regionali, è stata presentata dal Segretario Generale il 16 agosto 2018 e da allora è stata adottata da 117 Paesi. L'Italia è stata tra i primi ad adottarla. il 31 agosto 2018.
Gli impegni condivisi che figurano nella Dichiarazione mirano a : avanzare soluzioni politiche ai conflitti e ad accrescere l'impatto politico del peacekeeping, a rafforzare la protezione fornita dalle operazioni di peacekeeping, a migliorare la sicurezza dei peacekeepers, a sostenere una performance efficace e l'accountability delle componenti del peacekeeping, a rafforzare l'impatto del peacekeeping sul mantenimento della pace, a migliorare i partenariati nel peacekeeping, a rafforzare la condotta delle operazioni e del personale.
Tali questioni erano state in gran parte sollevate in altri documenti precedenti, dal Rapporto HIPPO del 2015[2]al Rapporto Cruz del 2017[3], ma la sfida attuale è di portarle all'attenzione dei capi di stato e di governo per far sì che vi sia un investimento politico del massimo livello nel far funzionare le operazioni di peacekeeping dell'ONU.
Tale iniziativa si ricollega strettamente allo sforzo di Guterres di riforma del pilastro di pace e sicurezza del Segretariato e di riforma del management.
Per quanto riguarda la riforma del pilastro di pace e sicurezza, il Segretario generale, all'esito dell'istruttoria di un team di revisione interna (IRT) presieduto da Tamrat Samuel da lui stesso istituito, ha presentato nell'ottobre 2017 un Rapporto all'Assemblea Generale (A/72/525) -successivamente da essa approvato con Risoluzione. 72/199 - in cui sottolinea che gli obiettivi portanti della riforma del pilastro sono di rendere prioritaria la prevenzione e il sostegno della pace, accrescere l'efficacia e la coerenza delle operazioni di peacekeeping e delle missioni politiche speciali, rendere il pilastro maggiormente coerente tramite un approccio whole of pillar.
Secondo la proposta Guterres, le strutture andrebbero conseguentemente modificate in Dipartimento degli affari politici e del Peacebuilding (DPPA) - che combinerebbe le funzioni degli attuali Dipartimento per gli Affari politici (DPA) e Peacebuilding support office (PBSO)- e Dipartimento delle Operazioni di pace - che integrerebbe il Dipartimento delle operazioni di peacekeeping (DPKO) e le missioni politiche speciali UNAMI[4] e UNAMA[5], nonché l'Ufficio Affari militari - e inoltre vi sarebbe la creazione di una struttura politico-operativa, che nascerebbe dalla fusione delle divisioni regionali del DPA e DPKO, a capo della quale porre 3 Assistant Secretary General con responsabilità regionali.
Le risoluzioni gemelle del 2016 dell'Assemblea Generale (A/RES/70/262) e del Consiglio di Sicurezza (s/RES/2282(2016) sulla revisione dell'architettura del peacebuilding hanno inaugurato un nuovo approccio detto sustaining peace che mira a promuovere decisamente lo sforzo internazionale di prevenzione dello scoppio , dell'escalation, della continuazione, della ricorrenza del conflitto.
Si tratta di un approccio integrato che ingloba 4 dimensioni: spostare l'azione primaria a sostegno della pace dal livello internazionale a quello nazionale e locale; fare leva su tutte le aree funzionali delle Nazioni Unite - diritti umani, diritto umanitario, questioni di genere, sviluppo, peacebuilding, operazioni di pace e affari politici - per sostenere la pace ; allargamento della responsabilità istituzionale della pace dal Segretariato all'intero sistema delle Nazioni Unite; potenziamento della capacità di risposta rapida ai conflitti emergenti. L'elaborazione del concetto di sustaining peace ha preso le mosse dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Alle risoluzioni gemelle è seguito il Rapporto del Segretario Generale di gennaio 2018 su peacebuilding and sustaining peace e - sulla scia dell'incontro di alto livello su peacebuilding and sustaining peace - l'adozione nell'aprile 2018 di altre due risoluzioni, da parte dell'Assemblea generale (A/RES/72/276) e del Consiglio di Sicurezza 2413 (2018) sui seguiti operativi del Rapporto.
Nelle priorità dell'UE nel contesto della 73^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, si legge che: "l'UE appoggerà e informerà l'azione delle Nazioni Unite per integrare la prevenzione dei conflitti, la governance e lo stato di diritto, lo sviluppo, i diritti umani e la responsabilità di fornire protezione (responsibility to protect) nelle azioni volte ad affrontare le sfide del mantenimento della pace. In tale contesto si dovranno anche affrontare i fattori di instabilità collegati ai cambiamenti ambientali e climatici. Sarà inoltre fondamentale rafforzare la resilienza, la titolarità e la cooperazione regionale".
Il budget per il peacekeeping per l'anno finanziario che va da luglio 2018 a giugno 2019 è di 6,7 miliardi di dollari ed è stato approvato dall'Assemblea generale dell'ONU a luglio del 2018.
Si ricorda che l'Italia è il primo contributore di Caschi blu tra i Paesi occidentali e l'ottavo contributore al bilancio regolare e del peacekeeping.
I precedenti
Le operazioni di peace-keeping istituite dalle Nazioni Unite sono comunemente oggetto di sistemazione dottrinaria che le distingue in operazioni di prima, seconda e terza generazione. Tale distinzione concerne non soltanto il periodo storico in cui queste sono state istituite, ma anche i compiti cui esse sono state votate e la natura stessa della missione cui erano chiamate a rispondere.
Appartengono alle c.d. operazioni di prima generazione (o di peace-keeping puro) quelle istituite tra il 1948 e il 1987. Caratteristiche di tali operazioni erano: la necessità di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU autorizzante la missione; il consenso dello Stato in cui veniva effettuata l’operazione; il ricorso all’uso della forza armata da parte del personale militare impiegato nella missione nel solo caso di legittima difesa, nonché nei soli casi di conflitti internazionali.
Con la fine della Guerra fredda, si assiste al sorgere delle operazioni di pace c.d. di seconda generazione, che si ispirano al documento An Agenda for Peace pubblicato nel 1992 dall’allora Segretario generale dell’ONU Boutros Boutros-Ghali. Le operazioni di seconda generazione, definite anche di peacemaking e/o peacebuilding, implicano il maggiore rilievo attribuito alla ‘componente civile’ delle operazioni, cioè la collaborazione con le forze appartenenti ad organizzazioni regionali, l’amministrazione del territorio, il monitoraggio elettorale, l’assistenza umanitaria, la ricostruzione economica e finanziaria, nonché la protezione dei diritti umani.
Eventi quali il genocidio in Ruanda nel 1994 e il massacro di Srebrenica nel 1995 spinsero molti tra i paesi membri delle Nazioni Unite a chiedere all’Organizzazione di rivedere la propria politica di peacekeeping e contribuirono al superamento delle operazioni di cosiddetta seconda generazione.
Il terzo punto di svolta è rappresentato dal c.d. Brahimi Report pubblicato nel 2001, ovvero il documento finale del Panel on United Nations Peace Operations istituito per volontà dell’allora Segretario generale Kofi Annan, allo scopo di rivedere il sistema di funzionamento e il quadro giuridico delle missioni di pace ONU. Il citato Brahimi Report analizzava le diverse operazioni per la pace poste in essere dalle Nazioni Unite, evidenziando allo stesso tempo le difficoltà che il personale, civile e militare, ha incontrato e che hanno determinato l’insuccesso delle medesime.
I suggerimenti che il Report forniva erano in particolare due: dare al mandato delle Nazioni Unite maggiore chiarezza, credibilità e realizzabilità, nonché l’importanza di migliorare la cooperazione ed il dialogo con i paesi che contribuiscono alle peacekeeping operations attraverso l’invio di truppe. Altro nodo cruciale è rappresentato dalla c.d. Responsibility to Protect, principio derivante dalle lessons learned rappresentate dalle missioni in Rwanda e in Bosnia negli anni Novanta.
Alcune operazioni più recenti, quelle che si dicono "di terza generazione", si collocano nella categoria del c.d. peace enforcing e peace support operations, categorie ibride rispetto al passato, la cui base giuridica non trova riferimento nella Carta dell’ONU ma negli sviluppi del processo di riforma e crescita di questo importante settore delle attività dell’ONU.
Con il documento conclusivo del World Summit 2005, e soprattutto con la Risoluzione A/RES/60/1, le Nazioni Unite si sono dotate di un documento strategico fondato su un approccio multidimensionale alla pace e sicurezza mondiale, in cui due paragrafi sono dedicati rispettivamente al peacekeeping e al peacebuilding. In esso viene sottolineata l’importanza della cooperazione civile e militare nei teatri operativi, così come l’apporto fornito, in accordo al Capitolo VIII della Carta, da parte delle organizzazioni regionali per la sicurezza (soprattutto con riferimento all’Unione Europea e l’Unione Africana).
Nel corso della stessa Sessione dell’Assemblea Generale, nell’ambito del World Summit 2005, è stata istituita una apposita Commissione per le missioni di peace-building con la risoluzione 30 Dicembre 2005, A/RES/60/180. Scopo di tale Commissione è quello di proporre strategie integrate post-conflict, sostenere i finanziamenti per la realizzazione delle missioni, fornire alle missioni stesse una prospettiva di medio e lungo periodo, nonché sviluppare le c.d. best practices.
La Commissione ha una composizione mista, presentando al proprio interno 7 membri del Consiglio di Sicurezza, 7 dell’ECOSOC (Comitato Economico e sociale), rappresentanti di 5 Paesi tra i 10 che più contribuiscono al budget dell’ONU, dei 5 tra i 10 che forniscono più truppe, ed infine 7 membri a rotazione. Alla Commissione viene attribuito un ruolo di indirizzo strategico, e non operativo, come invece è quello attribuito al DPKO.
Nel corso del decennio 2000 - 2010 il processo di riforma e di aggiornamento della struttura preposta alle operazioni di peacekeeping è continuato. Nel 2009 il DPKO ha pubblicato il documento New Parthership Agenda: Charting a new Horizon for UN Peacekeeping, nel quale vengono fissati nuovi, aggiornati termini di impegno delle Nazioni Unite di fronte alle sfide del mondo attuale.
Una fase rilevante del processo di riforma dell’architettura di peacekeeping si è registrata nel giugno 2007, quando il Segretario generale ha promosso una ristrutturazione del Dipartimento sostanzialmente dividendolo in due con la creazione di un separato Dipartimento per il sostegno logistico (Department of Field Support), sostenendo l’iniziativa di assegnare nuovi compiti al DPKO, incrementando le risorse finanziarie assegnate ai due Dipartimenti e agli altri uffici del Segretariato generale coinvolti nelle attività di peacekeeping e peacebuilding. Il Department of Field Support fornisce sostegno alle missioni per la promozione della pace e della sicurezza relativamente alle aree del finanziamento, della logistica, dell’informazione, comunicazione e tecnologia, delle risorse umane e dell’amministrazione generale .
L’11 settembre 2015 il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon ha presentato il rapporto "Il futuro delle operazioni di pace delle Nazioni Unite" che individua tre cambiamenti, definiti "fondamentali", che si richiedono per adattare le operazioni alle nuove realtà.
Il primo riguarda la necessità di rendere prioritaria la prevenzione e la mediazione, in modo da evitare risposte tardive e costose alle crisi; il secondo cambiamento riguarda la pianificazione e lo svolgimento delle operazioni, che devono essere più rapidi, rispondenti alle necessità e responsabili nei confronti dei paesi e popoli in conflitto; il terzo cambiamento, infine, consiste nel porre in essere un quadro globale-regionale per affrontare le sfide attuali alla pace ed alla sicurezza, a partire da una partnership rafforzata con l’Unione Africana.
Il contributo italiano
Si ricorda che l'Italia è il primo contributore di Caschi blu tra i Paesi occidentali e l'ottavo contributore al bilancio regolare e del peacekeeping
L’Italia partecipa attualmente a 4 missioni di pace ONU: con circa 1100 unità alla missione UNIFIL in Libano (il cui comandante è il Generale di Divisione Stefano Del Col), con 7 unità alla missione MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission)in Mali , con 4 unità alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping force in Cyprus) a Cipro e con 2 unità alla missione UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan.
Cenni storici
L’Organizzazione delle Nazioni Unite nasce il 24 ottobre 1945, dopo la ratifica del suo Statuto da parte dei cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti) e da parte della maggioranza degli altri quarantasei Paesi firmatari.
Tuttavia, l’idea di un’organizzazione internazionale per la promozione e il mantenimento della pace e della sicurezza tra i popoli affonda le sue radici in un precedente tentativo: la Società delle Nazioni. Frutto dell’intreccio di progetti americani, britannici e francesi, la Società delle Nazioni fu fondata alla Conferenza di pace di Versailles (1919) alla fine della Prima Guerra mondiale. I suoi organi erano l’Assemblea degli Stati membri, il Consiglio e il Segretariato Permanente. Il Consiglio era costituito da 4 membri permanenti (Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone) e 4 temporanei, eletti dall’Assemblea ogni 3 anni.
La Società delle Nazioni, che non riuscì a prevenire il secondo conflitto mondiale, espulse l’URSS nel dicembre 1939 per l’aggressione alla Finlandia, ma cessò subito dopo di funzionare: fu formalmente sciolta il 18 aprile del 1946 e sostituita dall’ONU. La creazione di una nuova organizzazione a tutela della sicurezza collettiva era già stata prevista nella Carta atlantica, sottoscritta da Churchill e Roosevelt nell’agosto del 1941 e nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del gennaio 1942.
Un progetto concreto, elaborato e discusso dai due leader con Stalin nei vertici di guerra a Mosca, Dumbarton Oaks e Yalta, fu infine approvato alla conferenza di San Francisco il 25 giugno 1945 dai delegati di 50 Stati. Le Nazioni Unite nacquero ufficialmente il 24 ottobre 1945, con la ratifica dello Statuto da parte dei 5 membri fondatori.
Nel dicembre 1945 il Senato e la Camera dei Rappresentanti americani, con voto unanime, chiesero che la sede delle Nazioni Unite fosse negli Stati Uniti. La richiesta fu accettata e la prima e principale sede fu costruita a New York, sulle rive dell’East River, su un terreno acquistato anche tramite una donazione di 8,5 milioni di dollari di John D. Rockefeller Jr. Lo Statuto delle Nazioni Unite è un trattato che, secondo le normative di diritto internazionale, è vincolante per tutti gli Stati che lo hanno ratificato, e dal momento che quasi tutti i paesi del mondo vi hanno ormai aderito, la sua validità è pressoché universale.
In Italia lo Statuto è stato ratificato con la legge n. 848 del 17 agosto 1957. Attualmente gli stati membri delle Nazioni Unite sono 193.
Assemblea Generale
Composizione. L’Assemblea Generale è il principale organo deliberativo, politico e rappresentativo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ne fanno parte tutti i paesi membri delle Nazioni Unite. Ogni Stato membro dispone di un voto.
Mandato. L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione o argomento che rientri nei fini dello Statuto delle Nazioni Unite. Le sue competenze riguardano: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; l’elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza; l’elezione dei membri del Consiglio Economico e Sociale; l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria; l’ammissione di nuovi membri; la sospensione dei diritti e dei privilegi o l’espulsione di un membro; le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
Procedure. Le decisioni dell’Assemblea Generale sulle questioni più rilevanti (mantenimento della pace e della sicurezza, elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, ammissione, sospensione o espulsione di membri), sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti; peraltro l’elenco non è tassativo e la prassi ammette una sua estensione. Le decisioni su altre questioni sono prese a maggioranza semplice (frequenti le decisioni adottate per consensus, anche se tale metodo non è espressamente previsto dalla Carta).
L’Assemblea si riunisce in una sessione ordinaria annuale che comincia il terzo giovedì di settembre e dura fino a metà dicembre. Se le circostanze lo richiedono possono essere effettuate anche delle sessioni speciali convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei membri delle Nazioni Unite. Alla sessione ordinaria annuale la delegazione governativa italiana è per prassi integrata da membri del parlamento in qualità di osservatori.
Altri compiti dell’Assemblea comprendono l’analisi delle questioni relative ai poteri e alle funzioni degli organi dell’Organizzazione e l’esame dei principi generali di cooperazione tra i paesi. L’Assemblea inoltre discute ogni problema rilevante a livello mondiale relativo a disarmo, problemi umanitari e sociali, politiche speciali e in generale tutte le questioni legate al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le siano sottoposte dagli Stati membri. Riguardo a tali questioni l’Assemblea adotta raccomandazioni indirizzate sia ai singoli Stati membri che al Consiglio di Sicurezza.
L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Inoltre esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite, e approva il bilancio delle Nazioni Unite.
L’Assemblea elegge i membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, esprime un voto per l’elezione dei membri della Corte Internazionale di Giustizia e, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, nomina il Segretario Generale.
All’interno dell’Assemblea sono istituite sei commissioni principali: disarmo e sicurezza internazionale; questioni economiche e finanziarie; questioni sociali, umanitarie e culturali; politiche sociali e decolonizzazione; amministrazione e budget; questioni legali.
Le commissioni analizzano i temi a loro assegnati e preparano raccomandazioni e bozze di risoluzioni da sottomettere all’Assemblea riunita in sessione plenaria. Tutti i paesi hanno diritto di avere propri rappresentanti nelle commissioni e al loro interno le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti.
Dall’Assemblea Generale dipendono organi sussidiari, come il Consiglio per i Diritti umani, Alto Commissario Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Programmi e Fondi (Undp, Unicef, UN-Women etc.), Istituti formativi e di ricerca, Organizzazioni correlate (WTO, AIEA) e altri enti.
Consiglio di Sicurezza
Composizione: si compone di 15 membri di cui 5 permanenti (Regno Unito, Cina, Francia, Russia e Stati Uniti). I restanti 10 sono eletti dall’Assemblea Generale fra i paesi membri delle Nazioni Unite e restano in carica per 2 anni. Il Presidente del Consiglio di Sicurezza cambia con una turnazione mensile tra i membri seguendo l’ordine alfabetico dei paesi. Sono attualmente membri non permanenti del Consiglio: Bolivia (2018); Costa d’Avorio (2019); Guinea (2019); Etiopia (2018); Kazakhstan (2018); Kuwait (2019); Paesi Bassi (2018); Peru (2019); Polonia (2019); Svezia (2018).
Mandato: al Consiglio di Sicurezza compete l’esercizio, in via principale, della più importante funzione assolta dalle Nazioni Unite: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ha dunque la competenza a compiere le azioni necessarie per il mantenimento dell’ordine e della pace tra gli Stati, compreso l’uso della forza a fini di polizia internazionale. Il centro intorno al quale ruota il fondamento giuridico è dato dal Cap. VII della Carta (artt.39 e ss).
Procedure. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza che riguardando questioni sostanziali - come per esempio l’utilizzo di misure dirette per la risoluzione di conflitti - richiedono il voto positivo di nove membri inclusi i 5 permanenti che hanno diritto di veto. L’astensione non è considerata pari al veto.
Segretariato
Composizione. Il Segretariato costituisce l’apparato amministrativo permanente delle Nazioni Unite. A capo di questa struttura è il Segretario Generale, nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza, per un mandato di 5 anni rinnovabile. L’attuale Segretario Generale è il portoghese António Guterres, eletto il 1° gennaio 2017.
Mandato. Il Segretariato svolge le attività quotidiane dell’Organizzazione con lo scopo di amministrare i progetti e le politiche pianificate dall’Organizzazione. I compiti svolti dal Segretariato sono vari quanto lo sono i problemi affrontati dalle Nazioni Unite. Vanno dall’amministrazione di operazioni di pace alla mediazione di dispute internazionali, dall’analisi di processi economici e sociali alla preparazione di studi sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile.
Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC)
Composizione. Il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) conta 54 membri con mandato triennale che vengono nominati a gruppi di diciotto ogni anno.
Mandato. Il Consiglio è l’organo consultivo e di coordinamento dell’attività economica e sociale delle Nazioni Unite e delle varie organizzazioni ad esse collegate ed è responsabile per la promozione di migliori condizioni di vita, impiego lavorativo e progresso economico e sociale. Inoltre si occupa della promozione della cooperazione internazionale in campo culturale ed educativo, della definizione di soluzioni a problemi internazionali in campo economico, sociale e sanitario, della promozione del rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Procedure. Si tengono due sessioni all’anno. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Nello svolgimento delle sue attività, il Consiglio si è spesso avvalso della facoltà, concessagli dalla Carta, di istituire commissioni per lo studio di specifiche problematiche; fra queste figurava, fin dal 1946, la Commissione per i diritti umani, sostituita dal 2006 dal Consiglio per i diritti umani, istituito dall’Assemblea come suo organo sussidiario, con l’obiettivo di rendere più incisiva l’azione delle Nazioni Unite in questo delicatissimo e fondamentale ambito.
Il Consiglio per i diritti umani è composto da 47 Stati membri, eletti dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta, con voto segreto e con rotazione triennale; fra i suoi compiti ha anche quello di procedere a un esame periodico di ciascuno stato membro per verificare il rispetto dei suoi obblighi in materia di diritti umani. Così come per la Commissione che lo ha preceduto, anche il Consiglio per i diritti umani è stato oggetto di critiche soprattutto in considerazione del fatto che ne farebbero parte anche stati notoriamente poco inclini al rispetto dei diritti umani.
Dal Consiglio Economico e sociale dipendono anche le Agenzie specializzate quali FAO, IFAD, UNESCO etc. Si veda il prospetto allegato.
Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)
Composizione. La Corte è composta da 15 giudici di nazionalità diversa eletti per un periodo di nove anni rinnovabile dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dal Consiglio di Sicurezza. Essi agiscono, al pari del personale che compone il Segretariato, a titolo individuale e in piena autonomia e, come prevede lo Statuto della Corte annesso alla Carta, godono dei medesimi privilegi e immunità diplomatiche.
Mandato. La Corte Internazionale di Giustizia ha sede nel Palazzo della Pace dell’Aja (nei Paesi Bassi) ed è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Fondata nel 1945, principalmente ha la funzione di risolvere, in accordo con le leggi internazionali, le dispute legali portate alla sua attenzione dagli Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione. La giurisdizione della Corte, infatti, deve essere accettata caso per caso dagli stati interessati.
Ne consegue che lo stato che non intenda far giudicare una determinata controversia internazionale dalla Corte, potrà limitarsi a non accettarne la giurisdizione, paralizzando qualunque potere dell’Organo di pronunciarsi sul punto. Accanto alle funzioni contenziose, la Corte svolge anche una funzione consultiva a beneficio dell’Assemblea e del Consiglio su questioni legali sottoposte da organi ed agenzie internazionali delle Nazioni Unite.
Manca alla Corte qualunque potere di interpretare il contenuto della Carta in modo vincolante per gli Organi delle Nazioni Unite o per gli stati membri, o di statuire circa la legittimità degli atti emessi dagli Organi delle Nazioni Unite.
Nessun paese può avere più di un giudice. I Membri della Corte non rappresentano i loro governi, ma siedono a titolo personale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
La Corte Internazionale di Giustizia non va confusa con la Corte Penale Internazionale (che siede ugualmente all’Aja), istituita con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998 ed entrata in vigore nel 2002. La CPI è un tribunale per i crimini che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme e cioé: il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (cosiddetti crimina iuris gentium), e di recente anche il crimine di aggressione (art. 5, par. 1, Statuto di Roma).
La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo se e solo quando gli Stati non vogliono o non possono agire per punire crimini internazionali. La Corte penale internazionale non è un organo dell’Onu. Ha però alcuni legami con le Nazioni Unite: ad esempio il Consiglio di sicurezza ha il potere di deferire alla Corte situazioni che altrimenti non sarebbero sotto la sua giurisdizione (art. 13(b), Statuto di Roma).
La questione dei cosiddetti “caschi blu della cultura” è stata rilanciata[6] in tempi recenti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini nel marzo 2015, dopo la constatazione degli attacchi intenzionali di miliziani dell’ISIS contro elementi di inestimabile valore del patrimonio culturale mondiale nel Medio Oriente.
Secondo Franceschini, infatti, era tempo di dar vita a una forza delle Nazioni Unite che, in parallelo ai caschi blu impegnati nelle operazioni di peacekeeping, potesse attendere alla tutela dei siti del patrimonio culturale dell’umanità per difenderli dai gravi attacchi intenzionali del terrorismo, di fronte ai quali i tradizionali strumenti per la tutela del patrimonio culturale durante i conflitti armati appaiono in parte superati.
Su queste proposte il Ministro Franceschini riceveva immediato sostegno da parte della direttrice generale dell’UNESCO Irina Bokova, che concordava sulla necessità di dar vita con immediatezza ad ulteriori passi per la realizzazione del progetto - proprio in sede UNESCO, ricordava del resto l’on. Franceschini, l’Italia aveva già presentato una risoluzione per la salvaguardia del patrimonio culturale nelle aree di conflitto. Pochi giorni dopo, il 23 marzo 2015, la ministra tedesca della cultura Monika Gruetters appoggiava con convinzione la proposta italiana, nel corso di un incontro con lo stesso ministro Franceschini a Berlino.
A livello parlamentare va segnalata il 31 marzo 2015 l’approvazione da parte dell’Assemblea della Camera di un ordine del giorno - in un testo riformulato nel corso della seduta - d’iniziativa dell’on. Roberto Rampi, con il quale si impegnava il Governo a promuovere la costituzione e l’impiego di appositi contingenti multinazionali di personale, da impiegare dopo la stabilizzazione del paese interessato e su richiesta esplicita di quest’ultimo, in attività di tutela del patrimonio artistico e culturale e nel contrasto del traffico di opere d’arte finalizzato al finanziamento del terrorismo internazionale, affidando, per quanto riguarda le forze italiane, all’Arma dei Carabinieri la responsabilità dei nuclei operativi, composti anche da appositi reparti dell’Esercito operanti nelle missioni internazionali di pace e di stabilizzazione.
Successivamente, il 19 maggio 2015, la Commissione Cultura del Senato ha a sua volta approvato una risoluzione nella quale, oltre ad unirsi nell’impegnare il Governo a proseguire nell’iniziativa di costituzione dei caschi blu della cultura, inseriva lo specifico profilo della necessità di una elevata qualificazione di questi operatori, tra i quali andava inserito personale dei dipartimenti universitari per la conservazione e il restauro dei beni culturali, nonché di istituti di eccellenza nel settore.
La risoluzione, inoltre, auspicava le opportune iniziative da parte delle Nazioni Unite per il blocco della vendita di reperti archeologici trafugati dai paesi in guerra, anche allo scopo di prevenire il finanziamento del terrorismo; e, sul versante nazionale, mirava a valorizzare il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
La grave questione della minaccia dell’ISIS per l’inestimabile patrimonio culturale delle regioni siriane e irachene cadute nelle mani del "Califfato" ha costituito l’oggetto della risoluzione 7-00694 dell’on. Amendola, discussa nelle sedute del 16 luglio e del 5 agosto 2015 delle Commissioni riunite Affari esteri e Cultura della Camera.
La discussione si è conclusa con l’approvazione della risoluzione conclusiva 8-00130, nella quale si impegna il Governo, tra l’altro, “a promuovere un’efficace attuazione della convenzione dell’Aja sulla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato anche non internazionale con la possibile istituzione di ‘zone culturali protette’ e di una task force specializzata che ne possa assicurare l’effettiva protezione, sul modello dei ‘caschi blu per la cultura’ attualmente in discussione all’UNESCO” ed “a verificare con rigore l’attuazione dei protocolli internazionali e della normativa vigente in materia di traffico illecito transnazionale di beni culturali”, nonché a promuovere “ogni sforzo teso a preservare dalle operazioni militari i siti di particolare interesse archeologico e artistico”.
Sul tema in esame è tornato alla fine di settembre 2015 anche il Presidente del Consiglio pro tempore Matteo Renzi, durante una delle iniziative a margine dell’inaugurazione della Sessione annuale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: in particolare, Matteo Renzi ha inquadrato la costituzione dei caschi blu della cultura all’interno degli sforzi con cui l’Italia intendeva contribuire a una più efficace azione del peacekeeping dell’ONU.
Sull’onda dell’ennesimo intollerabile attentato al patrimonio culturale dell’umanità perpetrato dall’ISIS nella città siriana di Palmira all’inizio di ottobre del 2015, il 17 dello stesso mese il Consiglio esecutivo dell’UNESCO approvava la risoluzione italiana per la salvaguardia del patrimonio culturale nelle aree di conflitto, appoggiata da altri 53 paesi e dai membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Ris. 197 EX/10).
Questa risoluzione, nota come Strategia per il rafforzamento dell'azione dell'UNESCO per la protezione della cultura e la promozione del pluralismo culturale in caso di conflitti armati, è stata successivamente adottata in via definitiva dalla Conferenza generale dell'Unesco il 2 novembre 2015 (Strategia 38 C/49). La risoluzione approvata dall’UNESCO, in particolare, dava impulso al lavoro diplomatico in sede ONU per includere la componente culturale nelle missioni di pace.
L’allora Ministro Franceschini, che aveva esortato ad accelerare i tempi in questa direzione dopo l’attacco ai monumenti di Palmira, esprimeva soddisfazione e richiamava anche l’approvazione in margine all’Expo di Milano della Dichiarazione sulla protezione del patrimonio culturale da parte di 83 paesi, il 1° agosto 2015.
Un altro passaggio essenziale nella creazione di una forza multilaterale per la tutela del patrimonio culturale mondiale si è avuto a Roma il 16 febbraio 2016 con la firma di un Memorandum d’intesa tra il Governo italiano e l’UNESCO relativo alla task force nazionale italiana nel contesto della coalizione globale dell’UNESCO denominata “United for Heritage”.
In base al Memorandum, la task force italiana, composta da personale specializzato civile e carabinieri operanti nella tutela del patrimonio culturale, deve essere in grado di valutare i rischi e quantificare i danni al patrimonio culturale, ideare piani di azione, formare personale nazionale e locale, rafforzare la lotta contro il danneggiamento, il saccheggio e il traffico illecito di reperti. Nella cerimonia istitutiva della task force italiana svoltasi a Roma il 16 febbraio 2016, in occasione della firma del Memorandum, l'allora Ministro degli esteri Gentiloni ha evidenziato lo specifico contributo italiano nella lotta al terrorismo che la costituzione della task force rappresenta, in considerazione del fatto che obiettivo degli attacchi terroristici negli ultimi anni sono stati in modo deliberato elementi fondamentali del patrimonio culturale mondiale. Nel corso della cerimonia svoltasi alle terme di Diocleziano la direttrice generale dell’UNESCO Irina Bokova ha salutato con entusiasmo e gratitudine l’istituzione della task force italiana, ed è stato altresì sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Torino per l’istituzione nel capoluogo piemontese di un centro di formazione relativo al personale della task force.
La prima occasione di intervento della task force non è stata però all’estero, ma in seguito al devastante terremoto del 24 agosto 2016, nelle zone colpite del Lazio, dell’Umbria e delle Marche, e soprattutto ad Amatrice.
A livello politico merita una particolare menzione l'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 2347 del 2017, promossa dall'Italia con l'appoggio francese, che per la prima volta include la tutela del patrimonio culturale fra le azioni umanitarie, le politiche di sicurezza globale e le misure di costruzione e mantenimento della pace.
Fra le iniziative italiane di promozione della salvaguardia del patrimonio culturale si inserisce anche la prima riunione del G7 della cultura, che ha avuto luogo a Firenze nel marzo del 2017, dal quale è emerso un accordo che impegna gli stati membri alla protezione del patrimonio culturale danneggiato o minacciato da terrorismo o calamità naturali.
Sempre a marzo 2017 un Piano d'Azione[7] per l'attuazione della summenzionata Strategia è stato presentato al Comitato esecutivo dell'UNESCO, che ha chiesto agli Stati membri di sostenerne la realizzazione. Tale piano prevede la creazione di un elenco di esperti nazionali nel campo della protezione del patrimonio culturale, pronti ad essere mobilitati nelle aree dove è richiesto il loro intervento, su decisione del segretariato UNESCO e di concerto con lo Stato interessato.
Alla XXXIX Conferenza generale dell'UNESCO, che si è svolta nel novembre 2017, la Strategia è stata integrata con un allegato che, accogliendo un'impostazione italiana, estende la protezione del meccanismo di reazione rapida dalle minacce al patrimonio culturale derivanti da situazioni di guerra o conflitto alle minacce poste da fenomeni di origine naturale, come i terremoti.
· La tutela e la promozione dei diritti delle donne, dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment femminile sono temi prioritari dell'azione dell'Italia a livello internazionale.
· L'Italia è fortemente impegnata sia in ambito multilaterale che bilaterale. Il nostro Paese è parte della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), partecipa attivamente ai lavori della Commissione ONU sulla condizione femminile (CSW) e sostiene le numerose iniziative che ogni anno vengono promosse su tali temi in ambito ONU.
· L'Italia ha svolto un ruolo attivo per consentire l'entrata in vigore (agosto 2014) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e continua a incoraggiare in tutte le sedi la più ampia adesione a questa Convenzione.
· L'Italia è attivamente impegnata, sia sul piano diplomatico-negoziale, sia su quello della cooperazione allo sviluppo, nelle campagne internazionali per l'eradicazione delle mutilazioni genitali femminili (MGF) e dei matrimoni precoci e forzati, promuovendo e partecipando attivamente ai negoziati sulle risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Diritti Umani dell'ONU su questi temi.
· L'Italia sostiene le iniziative internazionali per la prevenzione della violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e di emergenza.
· L'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 riflette in maniera integrata la tutela dei diritti delle donne. All'uguaglianza di genere e all'empowerment femminile è dedicato l'obiettivo 5, ma il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo è riconosciuto trasversalmente anche nei target di altri obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare: l'obiettivo 1 sulla lotta a tutte le forme di povertà ovunque, l'obiettivo 8 sulla promozione della crescita economica, l'occupazione e il lavoro dignitoso per tutti, e l'obiettivo 11 su città e insediamenti urbani sicuri e sostenibili.
· L'azione internazionale dell'Italia in materia di empowerment femminile e sviluppo è incentrata sulle seguenti considerazioni:
- L'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile sono un obiettivo "trasformativo": occorre affrontare le cause strutturali delle disuguaglianze tra uomini e donne, modificando le istituzioni e le norme sociali discriminatorie che vi stanno alla base e che le perpetuano.
- La promozione della soggettività politica, economica e sociale delle donne implica: il riconoscimento della capacità di decidere della propria vita e del proprio corpo e di prendere decisioni sulla famiglia; l'accesso alle risorse, in primo luogo naturali ed economiche; il controllo sulla proprietà e sulla terra, e il potere decisionale in ambito economico; la possibilità di avere voce e influenza politica nella società; la possibilità di svolgere un'azione collettiva in quanto donne; la libertà dal rischio di violenza e il pieno accesso alla giustizia.
- La violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce la capacità delle donne di godere dei propri diritti: la violenza contro le donne è un problema globale e un fenomeno che si verifica, in varia misura, in tutti i Paesi, società e culture, colpendo le donne indipendentemente dal loro reddito, classe, razza o etnia.
· Nel 2016, in attuazione di questo impegno, il nostro Paese ha stanziato 22,88 milioni di euro per progetti di cooperazione allo sviluppo in materia di uguaglianza di genere e di empowerment femminile e ha sostenuto numerose iniziative multilaterali sul tema, soprattutto nell'ambito del sistema ONU. Nel 2017 l'importo delle iniziative multilaterali e multi-bilaterali è ammontato a 22,11 milioni di euro.
· I programmi per l'empowerment delle donne sono principalmente dedicati all'empowerment economico, soprattutto nel settore dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare, anche a seguito della partecipazione della nostra Cooperazione a EXPO 2015, e si concentrano principalmente in Afghanistan, Albania, Etiopia, Libano, Palestina , Myanmar, Senegal e America centrale.
· In Afghanistan, in particolare, la presenza italiana a favore delle tematiche di Genere risale al 2003. Attualmente sono in corso di realizzazione iniziative multilaterali e bilaterali di lotta alla violenza di genere contro le donne e a sostegno al Ministero degli Affari delle Donne, per la promozione di imprenditorialità femminile e l'iniziativa italiana ha dato vita a alcune imprese innovative nell'area di Kabul e Baghlan.
· La Cooperazione italiana in Afghanistan ha, inoltre, avviato (tra il 2014 e il 2015) un lavoro di mainstreaming di genere in tutte le altre iniziative settoriali, al fine di assicurare che gli interessi e i bisogni delle donne vengano adeguatamente presi in considerazione nelle attività che l'Italia realizza nel Paese, dal sostegno allo sviluppo rurale, alla micro-finanza, all'agricoltura.
· La Cooperazione Italiana interviene anche per assicurare la protezione delle donne nelle situazioni di conflitto e di catastrofe naturale. Sono state intensificate le attività rivolte alle sofferenze legate agli atti di barbarie perpetrati dalle milizie jihadiste nei contesti del conflitto siriano ed iracheno. Simili attività di prevenzione della violenza di genere ed empowerment economico sono state promosse in Giordania e in Yemen.
Empowerment e uguaglianza di genere nelle politiche di sviluppo e cooperazione[8]
Il punto di partenza per affrontare il tema dell'uguaglianza di genere anche nell'ambito della cooperazione internazionale è l'analisi delle dinamiche che si potrebbero definire di "sessismo protettivo" per cui negare alle donne e alle ragazze l'accesso ai diritti si giustifica con la volontà di proteggerle, "per il loro bene". E si ricorre a tale giustificazione nel caso di matrimoni precoci, provazione dell'istruzione, restrizioni fisiche, mutilazioni genitali femminili o di altre violazioni di diritti.
Anche in contesti di emergenza, spesso i progetti partono dal presupposto che donne e ragazze siano oggetti bisognosi di protezione e non soggetti portatori di diritti. Il rischio è che si indirizzino le azioni di empowerment verso occupazioni ritenute più adatte alle donne riproponendo mansioni tipiche del lavoro domestico, non pagato, abitualmente svolto in casa come se fossero gli unici lavori che le donne siano in grado di fare. Si finisce così, implicitamente, per rafforzare gli stereotipi e la disuguaglianza di genere.
Anche alla luce dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 5 (parità di genere)[9], l'empowerment delle donne non può che passare attraverso programmi che portino le donne a essere agenti di cambiamento in prima persona, a definire in maniera consapevole soluzioni che partano dai bisogni effettivi nel contesto sociale, economico e culturale in cui vivono. Senza tralasciare l'obiettivo, parallelo, di raggiungere una piena ed effettiva partecipazione a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica e istituzionale.
Fondamentale in questo senso è unire all'Obiettivo 5 quanto si persegue con l'Obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide)[10], attraverso un lavoro di advocacy mirato.
Queste le priorità nelle azioni di sviluppo e cooperazione su cui la conferenza, promossa dalla sen. Emma Bonino, fondatrice della Ong Non c'è pace senza giustizia, cui prenderà parte anche il ministro degli esteri italiano Moavero Milanesi, intende portare l'attenzione:
1. Combattere violenze e violazioni nei confronti delle donne commesse "per il loro bene";
2. Proporre programmi di empowerment che superino gli stereotipi sul lavoro "femminile";
3. Promuovere la consapevolezza dei propri diritti e la capacità di advocacy politica per amplificare la voce delle donne;
4. Dare vita ad azioni di empowerment economico che tengano conto del contesto sociale e culturale in cui donne e ragazze si muovono, allargando l'ambito dei diritti umani.
L’evoluzione del quadro internazionale
Negli anni '60 del secolo scorso, quando nella maggior parte dei paesi era ancora in vigore la pena di morte, i primi passi per la sua abolizione nel diritto internazionale vennero compiuti dai paesi firmatari della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR-International Covenant on Civic and Political Rigths), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed in vigore dal 23 marzo 1976 (l’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 881/1977).
L’articolo 6 dell'ICCPR, infatti, se permette l'uso della pena di morte in circostanze limitate, stabilisce anche che "nulla in questo articolo sarà invocato per ritardare o impedire l'abolizione della pena capitale da parte di qualsiasi Stato parte della presente Convenzione".
Il 15 dicembre 1989, a 33 anni dall'adozione della stessa Convenzione, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il Secondo protocollo facoltativo all’ ICCPR finalizzato all’abolizione della pena di morte, che ha dato all'abolizione un nuovo impulso decisivo. Gli Stati membri Onu che sono diventati parti del Secondo protocollo, in vigore dal 1991, hanno concordato di non eseguire nessuna pena capitale all'interno delle loro giurisdizioni. L’Italia ha ratificato l’atto pattizio il 14 febbraio 1995.
Le risoluzioni dell’Assemblea Generale
La prima di una serie di risoluzioni per una moratoria nell’uso della pena di morte adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni risale al 2007 ed è stata riconosciuta merito, in particolare, dell’attività e dell’impegno dell’Italia. La risoluzione 62/149, adottata il 18 dicembre 2007, ha avuto il voto favorevole di 104 Stati membri, mentre 59 sono stati i contrari e 29 gli astenuti. Con la risoluzione l’Assemblea Generale invita gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva della sua abolizione.
Le due successive risoluzioni hanno visto crescere ulteriormente il livello dei consensi. In particolare, la risoluzione 63/168 (18 dicembre 2008), ha avuto il voto favorevole di 106 Paesi e la risoluzione 65/206 (adottata il 21 dicembre 2010) ha visto 109 Stati membri votare a favore della moratoria, a riprova di un forte orientamento abolizionista sottolineato anche dall’allora Segretario Generale Ban Ki-moon.
Tale orientamento si è confermato con la quarta risoluzione, 67/176 adottata il 20 dicembre 2012 nell’ambito della 67a Sessione dell’Assemblea Generale, quando la votazione ha visto salire a 111 il totale dei voti favorevoli alla moratoria; tale successo è stato propiziato da un allargamento del gruppo dei paesi co-sponsors, ancora una volta sostenuto dall’impegno italiano insieme ai partners dell’Unione Europea. Tale impegno oltre a puntare all’ampliamento della platea dei sostenitori e dei co-patrocinatori della risoluzione, operava anche per un irrobustimento dei contenuti.
Il successo di tale azione si manifestava nell’evoluzione del testo, dove per la prima volta veniva rammentato l’obbligo di non applicare la pena capitale nei confronti di minorenni e donne in gravidanza, ed introdotto un appello alla ratifica del Secondo Protocollo opzionale (che prevede, come detto dianzi, l’abolizione della pena di morte) al Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Va segnalato che le ratifiche al Secondo Protocollo intervenute successivamente al 2012 hanno portato ad 85 il numero complessivo dei Paesi membri delle Nazioni Unite che sono parte del Protocollo medesimo.
Il percorso verso l’adozione della quinta moratoria, intervenuta con la risoluzione 69/186 (18 dicembre 2014) ha visto ancora l’Italia in posizione di leadership. L’azione italiana si è concretizzata sia nelle attività riferibili alla 'task force' istituita presso il MAECI e composta da rappresentanti dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino, della Comunità Sant’Egidio e di Amnesty Italia, sia nell’impegno presente nel programma della Presidenza italiana del Consiglio dell’UE per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014.
Nel programma della Presidenza veniva esplicitato che, in vista della 69a Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite, l’Italia avrebbe sostenuto l’UE nella sua posizione in merito alla quinta risoluzione per una moratoria sulle pene capitali, con l’obiettivo di rafforzare l’orientamento internazionale a favore dell’abolizione della pena di morte incrementando ulteriormente il numero dei voti favorevoli.
L’esito del voto ha visto salire il numero dei Paesi a favore a 117 (6 in più rispetto al 2012) e registrando anche il più basso numero dei voti contrari, 38, tre in meno rispetto al 2012; invariato il numero degli astenuti, fermo a quota 34. In particolare, hanno per la prima volta votato a favore della risoluzione Niger, Eritrea, Figi, Guinea Equatoriale e Suriname mentre Bahrein, Myanmar, Tonga e Uganda sono passati dal voto contrario all’astensione.
Quanto al contenuto, la risoluzione risulta rafforzata nella parte in cui chiede agli Stati di “rendere disponibili le informazioni rilevanti circa l’uso della pena di morte” (quali il numero delle condanne a morte e delle esecuzioni, il numero dei detenuti nel braccio della morte e delle sentenze capitali rovesciate o commutate in appello o per le quali è intervenuta un’amnistia o concessa la grazia).
Ribadita la necessità di limitare progressivamente l’uso della pena di morte e non imporla per reati commessi da persone minori di 18 anni, donne incinte, viene inserita la previsione di estendere tali limitazioni anche ai confronti di disabili mentali. Gli Stati membri sono stati invitati ad assicurare il diritto all’assistenza consolare ai cittadini stranieri coinvolti in processi in cui rischiano la pena di morte.
Il voto in Assemblea Generale della risoluzione 71/187 (19 dicembre 2016), la sesta moratoria, ha visto confermati i 117 voti a favore, un leggero aumento dei contrari, che salgono a 40, e 31 astensioni. Nel testo della risoluzione si accenna ad una nuova risoluzione, sullo stesso tema, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale nel corso della 73esima sessione (2018-2019).
L'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani (OHCHR-High Commissioner for Human Rights), di cui è titolare dal 1° settembre 2018 Michelle Bachelet, nell’ambito di un mandato volto a promuovere e proteggere tutti i diritti umani, sostiene l'abolizione universale della pena di morte. Tale posizione si fonda sulla natura fondamentale del diritto alla vita; sul rischio inaccettabile rappresentato dal giustiziare persone innocenti; sulla mancanza di prove dell’effetto deterrente esercitato dalla pena di morte per il crimine.
In linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale che chiedono una graduale eliminazione della pena capitale, l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite sostiene gli Stati membri, i rappresentanti della società civile e gli stakeholders nella campagna per una moratoria sulla pena di morte e, in definitiva, per la sua abolizione a livello mondiale.
Le associazioni contro la pena di morte
Amnesty International, che annovera la lotta alla pena di morte tra i temi principali della propria attività in difesa dei diritti umani, oltre a mantenere accesi appelli ed azioni urgenti legati alla campagna abolizionista, pubblica annualmente un rapporto sulla pena di morte nel mondo.
Il report 2018 (Condanne a morte ed esecuzioni nel 2017), con specifico riferimento alle questioni relative alla moratoria, evidenzia che, nell’area Europa-Asia Centrale, Kazakistan, Russia e Tagikistan hanno continuato a osservare la moratoria sulle esecuzioni. In Russia, in particolare, Vasily Piskaryov, presidente del Comitato di sicurezza della Duma (la camera bassa del parlamento), e Ramzan Kadyrov, presidente della Repubblica cecena, hanno chiesto pubblicamente a giugno e novembre la reintroduzione della pena di morte per crimini legati al terrorismo; tuttavia, a giugno, il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha confermato che il governo non ha discusso della possibilità di sospendere la moratoria sull’uso della pena di morte.
Il report segnala che in Bielorussia sarebbero state eseguite almeno due sentenze capitali ed emesse almeno quattro condanne a morte e rammenta, inoltre, la decisione adottata a ottobre dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che ha ribadito l’invito urgente alle autorità bielorusse ad istituire una moratoria sulle esecuzioni e a commutare tutte le condanne a morte[11].
Nel quadrante Medio Oriente-Nord Africa Amnesty registra nel 2017 una riduzione complessiva dell’uso della pena di morte. Il numero di esecuzioni è sceso da 856 nel 2016 a 847 nel 2017, con una diminuzione di circa l’1%. Iran, Arabia Saudita e Iraq si confermano i primi tre paesi per numero di esecuzioni: l’Iran – si legge nel Rapporto -ha messo a morte almeno 507 persone, il 60% di tutte le sentenze capitali eseguite nella regione; l’Arabia Saudita ha eseguito 146 condanne a morte (17%) e l’Iraq ha messo a morte almeno 125 persone, pari al 15% di tutte le esecuzioni avvenute nella regione.
Quanto all’area dell’Africa sub-sahariana, il rapporto di Amnesty sottolinea che se il numero dei paesi che hanno eseguito condanne a morte è diminuito, passando da 5 nel 2016 a 2 (Somalia e Sudan del Sud) nel 2017, dall’altro il numero delle sentenze capitali è aumentato salendo da 22 a 28 (24 in Somalia e 4 nel Sudan del Sud). Diminuito il numero delle condanne a morte, scese da 1.086 nel 2016 a 878 (di cui 621 nella sola Nigeria) nel 2017.
La Guinea ha abolito la pena capitale per tutti i reati, e la Corte suprema del Kenya ha abolito la pena di morte con mandato obbligatorio per il reato di omicidio; Madagascar e Sao Tomè e Principe – due paesi che avevano già abolito la pena di morte - hanno ratificato il II Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, finalizzato all’abolizione della pena di morte, mentre il Gambia lo ha firmato. Il Burkina Faso e il Ciad, tramite iniziative legislative stanno compiendo progressi verso l’abolizione della pena capitale.
Nell’area Asia e Pacifico Amnesty International ha registrato 93 esecuzioni con un decremento del 28% rispetto alle 130 del 2016. Tale numero, tuttavia, non include, a causa del limitato accesso alle informazioni, le migliaia di sentenze capitali che Amnesty ritiene siano state eseguite in Cina, in Corea del Nord e in Vietnam.
Complessivamente, si legge nel rapporto di Amnesty, oltre due terzi dei paesi al mondo ha abolito la pena di morte per legge o nella pratica. In totale 142 paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica e 56 paesi mantengono in vigore la pena capitale, ma il numero di quelli dove le condanne a morte sono eseguite è assai inferiore.
Amnesty International è membro fondatore della Coalizione mondiale contro la pena di morte, network internazionale abolizionista sorto all’inizio del Duemila con l’obiettivo prioritario di lanciare una Giornata mondiale contro la pena di morte, celebrata ogni 10 ottobre con lo svolgimento di iniziative ed azioni di mobilitazione contro la pena capitale.
Dal 1998, Nessuno tocchi Caino, lega internazionale di cittadini e di parlamentari per l’abolizione della pena di morte nel mondo, fondata a Bruxelles nel 1993, pubblica il Rapporto sulla pena di morte nel mondo nel quale vengono riportati i fatti più rilevanti relativi alla pena capitale e all'evoluzione del dibattito sulla questione, nonché rapporti tematici sui vari aspetti dell’applicazione della pena capitale. L’associazione cura anche una banca dati aggiornata sulla pena di morte nel mondo.
Il 27 novembre 2017 presso la Camera dei deputati si è svolto il X Congresso Internazionale dei ministri della giustizia intitolato "Un mondo senza la pena di morte", organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, insieme al MAECI e alla Confederazione Elvetica. Al Congresso hanno preso parte ministri e rappresentanti dei governi di paesi sia abolizionisti sia mantenitori della pena di morte, per un dialogo che, nel giudizio degli organizzatori, ha segnato una segna una tappa importante nel cammino verso l'abolizione.
E’ altresì da segnalare che il 2 agosto scorso papa Francesco ha indirizzato un rescritto alla Congregazione per la dottrina della fede, inteso a modificare il testo del Catechismo della Chiesa cattolica, che definisce la pena capitale “inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona” ed afferma l’impegno della Santa Sede per la sua abolizione in tutto il mondo.
Le mutilazioni genitali femminili (MGF) sono un fenomeno vasto e complesso, che include pratiche tradizionali che vanno dall’incisione alla asportazione, in parte o in tutto, dei genitali femminili esterni. Bambine, ragazze e donne che le subiscono devono affrontare rischi gravi e irreversibili per la loro salute, oltre a pesanti conseguenze psicologiche. Le MGF sono internazionalmente riconosciute come una violazione dei diritti delle donne e una forma di abuso sui minori.
Al pari di altre violenze di genere, le MGF configurano “una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla dignità, alla parità tra donne e uomini, alla non discriminazione e all’integrità fisica e mentale”, secondo quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e costituiscono una violazione dei diritti dei minori quali sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Secondo il rapporto dell’UNICEF dal titolo Female genital mutilation/cutting: a global concern, pubblicato il 6 febbraio 2016 in occasione della Giornata ONU di Tolleranza Zero verso le MGF, sono almeno 200 milioni le donne e bambine, in 30 Stati di Asia e Africa, che hanno subito mutilazioni genitali femminili. Secondo i dati, tra le vittime delle mutilazioni, circa 44 milioni sono bambine e adolescenti con meno di 14 anni.
L’incidenza maggiore del fenomeno in questa fascia d’età si riscontra in Gambia (56% delle bambine), Mauritania (54%) e in Indonesia, dove circa metà delle bambine sotto gli 11 anni hanno subito questo tipo di pratiche. I paesi in cui è più alta la prevalenza delle MGF tra ragazze e donne adulte (dai 15 ai 49 anni) sono rispettivamente: Somalia (98%), Guinea (97%) e Gibuti (93%). In generale, nella gran parte dei paesi in cui il fenomeno sussiste, le MGF vengono praticate di norma sulle bambine sotto i 5 anni.
Le stime contenuto nel nuovo rapporto globale sulle MGF riportano una cifra superiore di 70 milioni rispetto a quelle dell’analogo rapporto 2015 (su dati 2014). Tale differenza è dovuta in parte alla crescita demografica, ma soprattutto ai dati più aggiornati e affidabili forniti dagli Stati coinvolti dal fenomeno, in particolare dal governo dell’Indonesia.
Il rapporto rileva tuttavia che anche nei paesi più interessati da tale pratica la mobilitazione sociale sta producendo degli effetti: i tassi di prevalenza delle MGF fra le adolescenti (15-19 anni) sono in calo rispetto a 30 anni fa: -41% in Liberia, -31% nel Burkina Faso, - 30% in Kenya e - 27% in Egitto. Inoltre dal 2008 a oggi, oltre 15.000 comunità locali in 20 Stati hanno dichiarato pubblicamente l’abbandono delle MGF, oltre 2.000 comunità solamente nel 2015 e cinque Stati hanno varato leggi nazionali per la messa al bando della pratica. Tuttavia, l’attuale tasso di abbandono delle mutilazioni genitali non è abbastanza elevato da controbilanciare la crescita della popolazione, e quindi i casi assoluti di MGF rischiano di aumentare nei prossimi 15 anni.
Sono in aumento anche casi simili in Europa (v. più avanti), Australia, Canada e negli Stati Uniti, soprattutto fra gli immigrati provenienti dall’Africa e dall’Asia sud-occidentale.
Nella definizione di "mutilazioni genitali femminili" rientrano, secondo la classificazioni dell’OMS, quattro tipi di pratiche di asportazione o alterazione di una parte dell’apparato genitale esterno della donna, da forme più superficiali (escissione del prepuzio della clitoride) a interventi molto invasivi come l’infibulazione. Secondo l’OMS, il tipo più comune è l’escissione della clitoride e delle labbra, che rappresenta più dell’80% di tutti i casi; la forma più estrema, l’infibulazione, consiste nel 15% di tutte le pratiche.
Il fenomeno si caratterizza per le sue finalità non terapeutiche e dunque per la valenza fortemente culturale che affonda le radici in un tessuto di credenze secolari, così da fare del rispetto per il costume e la tradizione il principale movente per la perpetuazione delle pratiche sia nei contesti di origine sia, nonostante i numerosi ostacoli frapposti dalla legislazione, nei contesti migratori.
Alla base si riscontrano motivazioni di varia origine: esigenza di controllo della sessualità femminile percepita come esuberante e sregolata, ma anche, presso alcune culture, incremento della fertilità o, al contrario, misura di tipo contraccettivo; credenza nella conformità con la religione islamica; “rito di passaggio” nelle cerimonie che scandiscono il ciclo della vita della donna e segno di appartenenza alla comunità (in assenza del quale la donna rischia di condannarsi all’emarginazione e alla ripulsa); garanzia dell’inviolabilità e salvaguardia della castità delle figlie destinate al matrimonio, nel complesso sistema di strategie matrimoniali fondato sul “prezzo della sposa”; infine, motivazioni estetiche e igieniche.
Le MGF, in misura differente e in una varietà di pratiche legata alla molteplicità delle etnie e delle culture, sono diffuse in un gran numero di paesi dell’Africa subsahariana, dalle coste del Senegal e della Mauritania fino al Corno d’Africa, e interessano anche la penisola arabica. In alcune regioni più del 90 per cento delle donne è mutilato. La pratica è più diffusa nelle aree rurali. Si nota anche una correlazione tra istruzione e tasso di mutilazioni: minore è l’istruzione, più si ricorre a questa pratica.
Il fenomeno migratorio non porta automaticamente all’abbandono di questa norma sociale: anche in Europa, in un ambiente culturalmente ostile alle mutilazioni genitali femminili, alcune comunità di migranti continuano a praticarle come è d’uso nel loro paese d’origine, nell’ottica di un eventuale ritorno in patria oppure di un matrimonio all’interno della comunità. Le ragazze non mutilate sono considerate «impure» e vengono spinte ai margini della comunità, non trovano marito e screditano le loro famiglie. L’escissione può di conseguenza rivelarsi un ostacolo in più per l’integrazione nel paese di accoglienza.
Nel sistema delle Nazioni unite si osservano vari organismi competenti, con molteplici strumenti utilizzati per sviluppare il tema della difesa dei diritti delle donne contro tali pratiche. Il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione insieme all’UNICEF guida il principale programma globale per l’eliminazione delle MGF. Il programma congiunto, iniziato nel 2008, si focalizza su 17 paesi africani e supporta anche iniziative regionali e globali. Il programma è strettamente collegato all’obiettivo di sviluppo sostenibile 5.3 che mira a porre fine a tali pratiche entro il 2030. A tale scopo gli operatori lavorano sia sul territorio per cambiare le norme sociali delle comunità, sia in collaborazione con i governi per realizzare modalità di contrasto del fenomeno sostenibili a livello nazionale.
Nel 2016 il programma ha completato il terzo anno della fase II (2014-2017), registrando progressi sostanziali sulle principali aree d’intervento, in particolare tutti i paesi sostenuti dal programma hanno istituito un meccanismo di coordinamento nazione e hanno continuato ad attuare un approccio integrato e globale volto a diffondere la nuova norma sociale di mantenere intatte le ragazze. Nello Yemen, la drammatica situazione politica e umanitaria ha invece limitato la possibilità di intervento.
Gli obiettivi della terza fase del programma prevedono che:
· 8 milioni di ragazze e donne riceveranno servizi di assistenza adeguati relativi alla FGM;
· 19 milioni di persone in oltre 10.000 comunità dichiareranno pubblicamente l’abbandono di MGF;
· 16 paesi avranno una linea di bilancio nazionale e un meccanismo di monitoraggio
· Organizzazioni politiche regionali e subregionali saranno mobilitate per intensificare gli sforzi nazionali;
· La realizzazione di un portale informativo.
L’UNFPA e l’UNICEF hanno accolto con favore gli impegni di finanziamento da parte del settore pubblico e privato per raggiungere un obiettivo di risorse di 77 milioni di dollari, per il periodo 2018 - 2021, necessarie per conseguire gli obiettivi del programma.
Il 20 dicembre 2012 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione ”Intensificazione degli sforzi mondiali per l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili” (A/RES/67/146) nella quale, tra l’altro,: “chiede agli stati, al sistema delle Nazioni Unite, alla società civile e a tutte le parti interessate di continuare a considerare il 6 febbraio come la Giornata Internazionale per la Tolleranza Zero sulle Mutilazioni Genitali, di usare questo giorno per promuovere le campagne di sensibilizzazione e di intraprendere azioni concrete contro le mutilazioni genitali femminili per sostenere il processo di abolizione nel minor tempo possibile.”
Nel dicembre 2014 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una nuova risoluzione in materia, lanciando un appello agli stati membri per sviluppare, supportare e attuare strategie globali e integrate per la prevenzione delle MGF, comprendenti la formazione del personale medico, degli assistenti sociali, dei leader della comunità e dei leader religiosi per garantire che essi forniscano servizi competenti e d’aiuto e si prendano cura delle donne e delle ragazze che sono a rischio o che sono già state sottoposte alle MGF.
La risoluzione riconosce anche la necessità di intensificare gli sforzi per eliminare le MGF e, a tale proposito, l’importanza di tenere debitamente conto della questione nell’elaborazione dell’Agenda di Sviluppo Post 2015.
Il 19 dicembre 2016, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato per consenso, la terza Risoluzione in materia, presentata dal Gambia a nome del Gruppo Africano (con il Burkina Faso quale facilitatore negoziale) e sostenuta da 133 Stati. Nell’occasione, l’Italia ha svolto le funzioni di facilitatore negoziale per conto dell’UE.
La Convenzione di Istanbul, entrata in vigore l’1 agosto 2014 impone agli stati una serie di obblighi per adempiere alla prevenzione, protezione e denuncia di qualsiasi forma di violenza basata su una discriminazione di genere. L’articolo 38 si occupa espressamente del problema delle MGF e impone agli Stati di adottare “le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.”
Nel 2010 l’OMS ha pubblicato il volume Global Strategy to Stop Health Care Providers from Performing Female Genital Mutilation in collaborazione con altre importanti agenzie delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali. Le Mgf di qualunque tipo sono state riconosciute come pratiche dannose e attuate in violazione dei diritti delle donne e delle bambine. I diritti dell’uomo, siano civili, culturali, economici, politici o sociali, sono stati codificati in numerose convenzioni regionali e internazionali. Il quadro giuridico viene completato da una serie di dichiarazioni consensuali quali le conclusioni di vertici o conferenze che riaffermano i diritti dell’uomo e impegnano i governi a mettere in pratica i principi proclamati.
La posizione italiana
L’Italia è sempre stata attivamente impegnata, sia sul piano politico che su quello della cooperazione allo sviluppo, per l’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile, distinguendosi nella campagna internazionale contro tali pratiche e conquistando il ruolo di interlocutore privilegiato con i Paesi africani che presentarono la richiamata risoluzione sulle MGF all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Il nostro Paese ha inoltre supportato la realizzazione della campagna europea “END FGM” promossa da Amnesty International, che ha sostenuto la forte richiesta fatta dal Parlamento europeo per porre fine alle mutilazioni dei genitali femminili attraverso una risoluzione congiunta adottata il 14 giugno 2012. A causa dell’aumento dei flussi migratori, infatti, il fenomeno ha inevitabilmente coinvolto anche l’Europa, e sebbene i dati sulla diffusione di tali pratiche nei paesi europei non siano noti, il Parlamento europeo stima che circa 500.000 tra donne e ragazze convivano con le MGF.
Il perpetrarsi di questa pratica continua a costituire una grave violazione dei diritti umani a danno di milioni di donne e bambine in tutto il mondo, diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione, e il Governo e Parlamento italiani, da anni impegnati su questo fronte, hanno promosso e sostenuto diverse azioni di contrasto al fenomeno.
L’Italia è uno dei maggiori donatori impegnati nella lotta all’eradicazione delle MGF. Tale impegno italiano è stato accompagnato da un’erogazione di fondi pari a circa 20 milioni di Euro nel periodo 2004-2015.
In particolare, l’Italia ha finanziato a partire dal 2004 un fondo fiduciario UNICEF che è stato alla radice dell’azione multilaterale da cui è nata in seguito la collaborazione tra UNICEF e UNFPA e il programma congiunto “Female Genital Mutilation Cutting: Accelerating Change” rivolto soprattutto ad azioni da realizzare in 17 Paesi africani. L’Italia fa parte dello Steering Committe del Fondo sin dalla sua fase iniziale per questo ruolo di promotore e contribuisce all’azione del Fondo con erogazioni annuali.
Altri specifici progetti nel settore includono:
L’iniziativa BanFGM: per l’eliminazione delle MGF, promossa dall’ong No Peace Without Justice nei paesi dell’Africa francofona e cofinanziate nel 2014 con un contributo del valore di 1,5 milioni di Euro, per il rafforzamento del quadro politico, istituzionale e giuridico dei paesi in Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mauritania, Niger e Senegal.
Gibuti - “Sostegno ai programmi gibutini per la salute della donna” per un importo complessivo di oltre 2 milioni di Euro in collaborazione con l’Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà (in corso dal 2010).
Sudan - “Finanziamento a favore di UNFPA per Migliorare i servizi di salute riproduttiva e di risposta alle violenze contro le donne attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali, la mobilizzazione delle comunità e la riduzione dello stigma tra i rifugiati e le comunità ospitanti nel Sudan Orientale” di 600.000 Euro (in corso dal 2015)
Etiopia – Finanziamento a favore di UNFPA “Protezione adolescenti ed eliminazione Traditional Harmful Practices (HTPs) nella regione dell’ Afar di 600.000 Euro (in programmazione 2016 e attualmente allo studio)
Il 30 e 31 gennaio 2017, si è tenuta presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la conferenza “Worldwide Ban on Female Genital Mutilation”, organizzata alla Farnesina, dall’ONG “Non c’è pace senza giustizia”, e dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. L’evento rientra nel progetto Ban FGM, finanziato nel 2014 dalla Cooperazione allo sviluppo italiana per il rafforzamento del quadro politico, istituzionale e giuridico volto all’eradicazione delle MGF nei Paesi dell’Africa francofona (Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mauritania, Niger, Senegal).
Il 31 ottobre 2000 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la risoluzione 1325 su donne, pace e sicurezza, primo documento del Consiglio che menziona esplicitamente l’impatto dei conflitti armati sulle donne e sottolinea il contributo femminile per la risoluzione dei conflitti e per la costruzione di una pace durevole. L’Italia, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza nel biennio 2007-2008, aveva profuso un intenso impegno in fase negoziale, con particolare riguardo al riconoscimento del nesso tra sicurezza internazionale e violenza sessuale nei casi in cui questa viene impiegata come tattica di guerra.
La risoluzione, considerata “madre” di risoluzioni ONU successive dal contenuto più specifico (cfr. infra), delinea un sistema ampio di obiettivi a garanzia della prevenzione, della partecipazione e protezione delle donne nei contesti di conflitto (paradigma delle 3”P”), focalizzando tre elementi:
· le donne ed i fanciulli rappresentano i gruppi più colpiti dai conflitti armati;
· le donne svolgono un ruolo imprescindibile sia nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, sia nelle attività di ricostruzione della pace;
· gli Stati membri dell’Onu sono invitati ad assicurare una più ampia partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali, con particolare riferimento ai meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto.
Il principio ispiratore della risoluzione - la “tolleranza zero” rispetto a tali forme di violenza che violano le norme internazionali e costituiscono comportamenti di rilievo penale - si applica ai militari, alle parti in conflitto nonché al personale militare e civile dell’Onu responsabile di abusi sessuali nelle aree di conflitto.
Il 19 giugno 2008 è stata adottata la risoluzione 1820 nella quale si afferma che la violenza sessuale in situazioni di conflitto armato può costituire crimine di guerra, crimine contro l’umanità e prefigurare genocidio.
Con la risoluzione 1888 , del 30 settembre 2009, il Consiglio di Sicurezza, tra le misure atte a fornire protezione a donne e bambini contro la violenza sessuale in situazioni di conflitto, chiede al Segretario generale di nominare un rappresentante speciale sulla violenza sessuale durante i conflitti armati. L’ufficio del Rappresentante Speciale ONU per le violenze sessuali in situazioni di conflitto è stato istituito nell’aprile 2010 e la prima Rappresentante è stata Margot Wallström; le è succeduta nella carica, dal 22 giugno 2012, Zainab Hawa Bangura, cittadina della Sierra Leone. Dall’aprile 2017 rappresentante speciale sulla violenza sessuale durante i conflitti armati è stata nominata Pramila Patten, della Repubblica di Maurizio. I focal points del mandato della Rappresentante Speciale sono costituiti dal contrasto all’impunità dei responsabili, dall’empowerment delle donne colpite al fine di ristabilire il godimento dei loro diritti, dall’implementazione di politiche idonee a sostenere un approccio globale alla violenza sessuale, dall’armonizzazione su scala internazionale della risposta alle violenze e dal miglioramento della comprensione della violenza sessuale nella sua dimensione di tattica di guerra. La Rappresentante, inoltre, metterà in risalto la necessità che sia condotta a livello nazionale titolarità, leadership e responsabilità nel contrasto della violenza sessuale.
La successiva risoluzione 1889 (2009) si incentra, in particolare, sul rafforzamento della partecipazione delle donne nei processi di pace, nonché sullo sviluppo di indicatori adatti a misurare i progressi nella realizzazione della risoluzione madre 1325.
Una ulteriore risoluzione 1960 (2010) è stata adottata all’unanimità il 16 dicembre 2010 dal Consiglio di Sicurezza, il quale ha chiesto alle parti coinvolte in conflitti armati di assumere specifici impegni ed indicare precise scadenze della lotta alla violenza sessuale. Le parti sono state sollecitate, sul lato della prevenzione, a proibire tali crimini attraverso la somministrazione di ordini precisi alle catene di comando e l’imposizione di codici di condotta e, sul versante giudiziario, ad indagare i presunti abusi affidandone tempestivamente alla giustizia i responsabili. Il Segretario generale è tenuto a monitorare il perfezionamento di tali impegni nonché, sulla base di una analisi più approfondita, a favorire una migliore cooperazione tra tutti gli attori dell’ONU finalizzata a fornire una risposta sistemica alla questione della violenza sessuale, nel frattempo procedendo a più nomine femminili tra i protection advisers delle missioni di peacekeeping.
La risoluzione 2106 (2013) del 24 giugno 2013, è specificamente focalizzata sul tema della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato. Il documento aggiunge ulteriori dettagli operativi alle precedenti risoluzioni sul tema e ribadisce la necessità di sforzi più intensi da parte di tutti gli attori, non solo il Consiglio di Sicurezza e le parti di un conflitto armato, ma tutti gli Stati membri e gli enti delle Nazioni Unite, per l’attuazione dei mandati promananti dal complesso delle risoluzioni sul tema e per la lotta all’impunità per questi crimini.
La risoluzione 2122 (2013) rafforza le misure che consentono alle donne di partecipare alle varie fasi di prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché della ripresa del paese interessato, ponendo agli Stati membri, alle organizzazioni regionali ed alle stesse Nazioni Unite, l’obbligo di riservare seggi alle donne nei tavoli di pace. La risoluzione, inoltre, riconosce la necessità di una tempestiva informazione ed analisi dell’impatto dei conflitti armati su donne e ragazze e sollecita i Paesi che contribuiscono alle missioni ad aumentare la percentuale di donne nelle forze armate e nelle forze di polizia in esse impiegate. Viene infine sottolineata la necessità di continuare gli sforzi per eliminare gli ostacoli all’accesso delle donne alla giustizia in situazioni di conflitto o post conflitto.
Con la risoluzione 2242 (2015) viene riconosciuto il ruolo centrale della partecipazione delle donne nell’impegno globale per costruire la pace e la sicurezza, compresi i contributi strategici per contrastare la crescita dell’estremismo violento e trovare soluzioni alla complessa crisi della sicurezza internazionale. La risoluzione è stata adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza nell’ambito di una valutazione complessiva sul livello di implementazione, su scala regionale e nazionale, della Risoluzione 1325 a 15 anni dalla sua adozione. In tale ricorrenza, il Global Study Preventing conflict, transforming justice, securing the peace commissionato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e condotto dalla ex Rappresentante speciale per i bambini nei conflitti, Radhika Coomaraswamy, ha individuato nella partecipazione femminile il fattore chiave per determinare operazioni efficaci nella mediazione della pace, nel peacekeeping e nella prevenzione dei conflitti.
A fronte dell’ampiezza del mandato della risoluzione 1325 e della mancanza di indicazioni precettive in ordine all’attuazione delle sue disposizioni, e mentre si continuavano a registrare numerosi casi di violenza sessuale nelle aree di conflitto armato e post conflitto, il Consiglio di Sicurezza ha previsto, nel Presidential Statement del 28 ottobre 2004, la possibilità che gli Stati membri proseguissero sulla strada dell’attuazione della Risoluzione 1325 anche attraverso lì adozione di “National Action Plans”. Un rapporto del Segretario generale Onu dà conto ogni anno dei progressi compiuti.
Si segnala che attualmente sono 78 gli Stati membri (su un totale di 193, pari al 40,4%) che hanno adottato un piano d’azione nazionale. In particolare, da ultimo, hanno adottato un piano d’azione nazionale la Moldova (marzo 2018), la Tunisia (maggio 2018) e il Mozambico (giugno 2018).
L’Italia ha adottato, il 15 dicembre 2016, il Terzo Piano Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza per il periodo 2016-2019, focalizzato sulla situazione delle donne e delle minori in situazioni di conflitto e post-conflitto, così come negli Stati fragili, in quanto sopravvissute alla violenza e, soprattutto, quali “agenti per il cambiamento”. Il Piano mira, inoltre, a migliorare la qualità dell’impegno italiano, per sostenere le popolazioni colpite in tutte le fasi delle operazioni di pace (prevenzione del conflitto e mediazione; peace-keeping; peace-making; peace-building; relief e recovery). Ai fini dell’attuazione dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza, si riafferma l'impegno per una sua esecuzione efficace, attraverso un approccio multi-stakeholder, integrato e olistico, con il pieno coinvolgimento delle Organizzazioni della società civile, del mondo accademico, delle ONG, del settore privato e delle organizzazioni sindacali, nella consapevolezza di poter far avanzare l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza, rafforzando il ruolo delle donne in tutti i settori economici e sociali, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare il punto 5 del Piano è dedicato alla protezione dei diritti umani delle donne e delle minori, in aree di conflitto e post-conflitto, nell’ambito del quale l’Italia si impegna a:
a) Accrescere i propri sforzi per prevenire e proteggere da tutte le forme di discriminazione e violenza, le donne e le minori colpite da conflitto e post-conflitto, e di perseguirne i responsabili;
b) Contribuire ad eliminare la violenza sessuale in situazioni di conflitto e post-conflitto;
c) Proteggere i diritti umani delle donne, dei minori e delle categorie più vulnerabili, colpiti da conflitto e post-conflitto, per aiutare ad assicurarne la sicurezza, la salute mentale e fisica, il benessere, la sicurezza economica e l’uguaglianza.
Si segnala inoltre l’iniziativa UN Action Against Sexual Violence che riunisce 13 organismi delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di porre fine alla violenza sessuale nei conflitti in uno sforzo concertato per migliorare il coordinamento e la responsabilità, ampliare la programmazione e sostenere gli sforzi nazionali per prevenire la violenza sessuale, rispondendo in modo efficace alle esigenze dei sopravvissuti. E’ promotore della International Campaign to Stop Rape & Gender Violence in Conflict (http://www.stoprapenow.org/take-action/).
Il 23 marzo 2018, il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha presentato il Rapporto sulla violenza sessuale relazionata alle situazioni di conflitto, per il periodo gennaio-dicembre 2017. In particolare la relazione ha esaminato la situazione in: Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Colombia, Repubblica democratica del Congo, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Somalia, Sudan del sud, Sudan (Darfur), Siria, Yemen.
La relazione ha evidenziato che nel 2017 la violenza sessuale ha continuato a essere usata come tattica di guerra, terrorismo, tortura e repressione e le vittime hanno continuato a essere perseguitate sulla base della loro origine etnica reale o percepita, delle loro convinzioni religiose, della loro affiliazione politica o della loro appartenenza a un clan. In molti casi, questo tipo di violenza ha avuto l'intenzione e l'effetto di spostare e disperdere con la forza la comunità perseguitata, con conseguenze distruttive per la coesione sociale.
Tale allarmante tendenza risulta comune a una serie di conflitti diversi tra loro, come in Iraq, Mali, Myanmar, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Sud Sudan. Alcuni progressi sotto il profilo della lotta contro la cultura dell’impunità sono stati registrati in Afghanistan, Somalia e Sudan in cui i relativi codici penali sono stati armonizzati alle norme internazionali in materia.
Una parte del rapporto è dedicata alle misure per far fronte ai delitti di violenza sessuale in situazioni post belliche, esaminando in particolare le situazioni di Bosnia-Erzegovina, Costa d’Avorio, Nepal e Sri Lanka, cui segue l’analisi delle situazioni di Burundi e Nigeria.
Il primo studio globale dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) dedicato al traffico di migranti, Global Study on Smuggling of Migrants, evidenzia che le rotte del traffico di migranti si diramano in ogni parte del mondo. Lo studio, che si basa sull’analisi di un’ampia messe di dati e letteratura esistenti, offre informazioni dettagliate sulle principali rotte del traffico di migranti, quali l’ampiezza del fenomeno, i profili dei trafficanti e dei migranti, il modus operandi dei trafficanti e i rischi affrontati dai migranti stessi.
L’UNODC–UN è l’Agenzia dell’ONU incaricata di assistere gli Stati membri e coordinare le attività internazionali di controllo della droga e la criminalità internazionale. Istituita nel 1997 attraverso una fusione tra il Programma di controllo delle droghe delle Nazioni Unite e il Centro per la prevenzione della criminalità internazionale, UNODC opera in tutte le regioni del mondo attraverso una vasta rete di uffici sul campo. I tre pilastri del programma di lavoro dell’UNODC sono:
1 - progetti di cooperazione tecnica sul campo per rafforzare la capacità degli Stati membri di contrastare le droghe illecite, la criminalità e il terr orismo;
2 - ricerca e analisi per aumentare la conoscenza e la comprensione delle questioni relative alla droga e alla criminalità, e per ampliare la base di evidenze per le decisioni politiche e operative;
3 - lavoro normativo per assistere gli Stati nella ratifica e nell’attuazione dei trattati internazionali in materia, nello sviluppo della legislazione nazionale in materia di droga, criminalità e terrorismo.
Di seguito vengono sintetizzate le principali evidenze emergenti dallo studio.
Il traffico dei migranti interessa tutte le regioni del mondo
Sono state individuate 30 rotte di traffico determinate da flussi che dalla parte interna del continente africano vanno verso l’Africa settentrionale e meridionale, dall’Asia verso Europa e Medio Oriente e verso i paesi ricchi dell’Asia sud orientale e del Pacifico; rotte marine nel Mediterraneo e terrestri tra le Americhe del sud e del nord; una miriade di passaggi aerei affrontati con documenti falsi e viaggi rischiosi via terra attraverso deserti e montagne.
Il traffico di migranti è un grande affare che genera alti profitti.
Vi sono prove che almeno 2,5 milioni di migranti sono stati oggetto di traffico per un giro di affari valutabile almeno tra i 5,5 e i 7 miliardi di dollari USA nel 2016. Si tratta di una somma equivalente a quelle spese dagli Stati Uniti d’America (circa 7 miliardi di dollari) o dall’Unione europea (circa 6 miliardi di dollari) per aiuti umanitari complessivi nello stesso anno 2016. I profitti dei trafficanti derivano dalle tariffe applicate ai migranti secondo criteri determinati per lo più dalla lunghezza del percorso, dal numero di frontiere, dalle condizioni geografiche, dai mezzi di trasporto, dall’uso di documenti di viaggio o di identità false, dal livello di rischio di essere intercettati. Le tariffe, inoltre, variano in base ai profili dei migranti e al loro livello di ricchezza.
Domanda e offerta
Il traffico di migranti segue le stesse dinamiche degli altri mercati criminali organizzati transnazionali ed è guidato dall’equilibrio tra la domanda di migrare e l’offerta di una fornitura di servizi capaci di aggirare il sistema regolatorio esistente. Dal lato dell’offerta, l’azione di reclutamento – che nello studio viene definita “proattiva” – associata alla non corretta informazione sui rischi, determinano l’aumento della domanda, ossia del numero di migranti che sono disposti ad acquistare tali servizi. L’informazione sulla disponibilità di tali servizi è capillare ed è in grado di raggiungere i potenziali migranti, ad esempio, nelle comunità della diaspora, nei campi profughi e anche attraverso i social network. La domanda di tali servizi irregolari può essere determinata dalle condizioni socio-economiche, da motivazioni familiari di ricongiungimento, da mancanza di sicurezza nei paesi di origine; essa è potenziata dalla limitatezza dei canali legali, che non sono in grado di soddisfare la domanda complessiva di migrazione regolare. La domanda di servizi irregolari è particolarmente alta tra i rifugiati, privi altri mezzi per raggiungere una destinazione sicura.
I percorsi cambiano
Geografia, controllo delle frontiere, politica migratoria nei paesi di destinazione, collegamenti tra trafficanti sono i fattori chiave che determinano il costo del pacchetto offerto ai migranti. Quando la geografia lo consente, le rotte terrestri vengono preferite, in quanto più economiche, alle vie marittime ed aeree. La stragrande maggioranza di migranti dal Corno d’Africa verso il sud africano, ad esempio, usa le rotte terrestri. Le misure per aumentare o diminuire i controlli di frontiera, con il conseguente aumento o diminuzione dei rischi per i migranti di essere scoperti, se non sono condivise tra gli Stati portano tipicamente al rapido mutamento dei percorsi, senza peraltro influenzare il numero dei migranti. Misure più severe di controllo alle frontiere, peraltro, spesso aumentano i rischi per i migranti fornendo opportunità di maggiori profitti ai trafficanti. Nel periodo 2009-2015, ad esempio, una grande parte dell’attività di traffico registrata tra la Turchia e l’Unione Europea si è spostata dalla via terrestre al mare, in risposta a maggiori controlli posti ad alcune frontiere.
Gli hub sono stabili
Mentre i percorsi possono cambiare, i luoghi di incontro di domanda e offerta mostrano stabilità nel tempo. Gli hub, che in quanto luoghi di incontro e di stipula di accordi sono la chiave per il traffico di migranti, si trovano spesso presso capitali o grandi città, sebbene possano anche essere città remote, l’economia delle quali è sostanzialmente legata ai traffici di migranti. Agadez in Niger, ad esempio, è un punto di transito per gli attuali flussi, che constano di alcune centinaia di migliaia di soggetti; già nel 2003, peraltro si stima che circa 65.000 migranti abbiano lasciato Agadez per il Nord Africa.
Esiste un legame etnico o geografico tra trafficanti e migranti
Sebbene esistano alcune grandi organizzazioni transnazionali coinvolte nel traffico dei migranti che possono o meno avere legami etnici con il territorio in cui operano o i migranti che contrabbandano, a livello di modello generale i trafficanti su piccola scala o sono etnicamente collegati ai territori in cui operano, o condividono legami etnici o linguistici con i migranti. Ciò è vero, in particolare, a livello di reclutamento, promozione e vendita dei “pacchetti”. Inoltre, l’urgenza della necessità di partire e l’impossibilità di attingere a informazioni certe e complete mettono i migranti in condizione di decidere facendo affidamento sul parere delle loro comunità, delle persone loro vicine e, non ultimo, delle informazioni disponibili sui social network.
L’organizzazione del contrabbando di migranti
Si tratta di un panorama vario, che spazia dall’offerta di servizi minimi (quali, ad esempio l’attraversamento di un fiume o il passaggio su di un truck o servizi di telecomunicazione per i migranti) dai quali tuttavia spesso dipende l’economia di intere comunità specialmente nelle zone di confine e di transito, alle reti libere di trafficanti - che non comportano gerarchie rigide - alle grandi reti criminali con collegamenti transnazionali e sofisticate capacità di organizzative.
Contrabbandieri, altre organizzazioni criminali e corruzione
Generalmente, le reti di traffico di migranti non sembrano essere coinvolte in altre forme di grande crimine organizzato transnazionale. Tuttavia, in alcune parti del mondo il collegamento con grandi organizzazioni criminali è necessario, soprattutto quando è necessario pagare per il "diritto" al passaggio sicuro per i migranti (è il caso, ad esempio, del confine tra gli Stati Uniti e il Messico); in altri casi, i trafficanti cedono i migranti a tali gruppi a scopo di estorsione. Il ricorso alla corruzione è sistematico da parte delle reti di traffico di migranti, al fine di garantire la praticabilità dei traffici stessi.
I migranti di contrabbando sono principalmente giovani e anche bambini non accompagnati
La maggior parte dei migranti sono relativamente giovani e, su alcuni percorsi - in particolare in alcune parti del Sud-Est asiatico - le donne rappresentano una grande parte dei migranti vittime di traffico. La composizione di genere dei flussi migratori illegali è influenzata anche dalle circostanze che la provocano: tra i cittadini siriani migranti - la maggior parte dei quali in fuga dal conflitto armato - ci sono molte più famiglie che negli altri gruppi di migranti. Molti flussi di includono bambini non accompagnati, particolarmente vulnerabili: numeri considerevoli di minori non accompagnati sono stati rilevati lungo le rotte del Mediterraneo verso l’Europa e lungo le rotte terrestri verso il Nord America.
Il contrabbando di migranti può essere mortale
La tabella che segue riporta il numero di migranti deceduti nel 2017 e le cause del decesso:
| Causa del decesso |
Numero delle vittime |
% sul totale delle vittime |
| Annegamento o presunto annegamento |
3.597 |
58% |
| Condizioni climatiche/malattia |
1.165 |
19% |
| Incidenti con veicoli su gomma o su ferro |
482 |
8% |
| Omicidi |
382 |
6% |
| sconosciuta |
406 |
7% |
(UNDOC, elaborazione dati International Organization for Migration)
Il quadro politico-istituzionale libico
Il processo politico libico ha fatto registrare a lungo uno stallo tra il Parlamento (Camera dei Rappresentanti - HOR) che ha sede a Tobruk, nell’est del paese, e il Governo di accordo nazionale (GNA) a guida al-Sarraj a Tripoli che è rimasto sospeso in un limbo giuridico, in attesa di una piena approvazione della Camera dei Rappresentanti.
Si ricorda che il Dialogo politico libico mediato dal Rappresentante Speciale dell’ONU aveva condotto all’Accordo politico libico concluso a Skhirat il 17 dicembre 2015 e alla formazione di un Governo di accordo nazionale guidato da al-Sarraj; tale Governo consiste in un Consiglio presidenziale (composto di 9 membri e svolgente anche le funzioni di Capo dello Stato) e un Gabinetto, sostenuto da altre istituzioni statali, tra cui una Camera dei Rappresentanti con sede a Tobruk e un Consiglio di Stato (che avrebbe dovuto riassorbire i membri del Congresso Generale Nazionale di Tripoli).
Tuttavia, negli ultimi mesi il Governo di accordo nazionale, riconosciuto dalle Nazioni Unite, installatosi il 30 marzo 2016 a Tripoli, era apparso sempre più debole, insidiato dal generale Haftar e dallo schieramento di Tobruk a est e dall’ex premier tripolino Khalifa al-Ghwell, reinsediatosi a Tripoli. Il generale Haftar, forte dei successi militari (riconquista di Bengasi da DAESH) e politici (occupazione dei campi petroliferi della Mezzaluna e riconsegna alla National Oil Company, NOC), si è adoperato per un logoramento della leadership di al-Sarraj: agendo sul Parlamento di Tobruk perché posticipasse a tempo indeterminato un’approvazione del governo di al-Sarraj, mirava a costringere la Comunità internazionale a prendere atto del fallimento di al-Sarraj e valutare opzioni alternative.
A che punto è il processo politico-diplomatico in Libia?
Nella primavera 2017 il processo politico a guida ONU che ha portato all’accordo di Skhirat sembrava destinato ad esaurirsi e ad essere superato nei fatti dai nuovi colloqui tenutisi negli Emirati Arabi Uniti (EAU). Ma nel giugno 2017 il nuovo Inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ex Ministro della Cultura libanese, ha raccolto la sfida di ripensare e rilanciare il processo negoziale dell’ONU.
E’ bene ricordare come in questo contesto critico, a seguito dell’intensa azione politica e diplomatica di EAU, Egitto e Russia, si fosse aperto un processo parallelo a guida emiratina. "Una loro particolare convergenza relativa alla predilezione per un ruolo di leadership di Haftar in Libia, percepito come affine alla loro battaglia anti-islamista, insieme alla contemporanea assenza politica dei paesi occidentali in questa fase della crisi libica, ha permesso di spostare l’asse delle trattative internazionali ricalcando in parte ciò che è successo relativamente alla crisi siriana, dove un processo di negoziazione si è aperto ad Astana parallelamente a quello ufficiale delle Nazioni Unite a Ginevra".[12]
L’Inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, intenzionato a rilanciare la guida dell’ONU e a contrastare il proliferare delle iniziative, ha intrapreso una politica di outreach verso tutti gli attori libici che attraversino l’intero spettro politico e lo spazio geografico libico, ai fini di includere tutti nella riconciliazione nazionale e ha reso pubblico il suo Action plan in occasione della 72a Assemblea generale dell’ONU, lo scorso 20 settembre 2017.
Il Segretario generale dell’ONU Guterres ha presentato la strategia delle Nazioni Unite per la Libia, basata su 7 priorità:
1) rilanciare un processo politico inclusivo
2) costruire credibilità
3) rafforzare gli accordi di sicurezza e l’architettura nazionale di sicurezza
4) coordinare le iniziative internazionali in un’unica agenda comune
5) migliorare le condizioni socio-politiche e la fornitura di beni e servizi
6) sostenere i migranti
7) assicurare sostegno all’assistenza umanitaria
Nel presentare all’ONU l’Action plan, Salamé ha premesso che non si tratta di un piano disegnato da lui, bensì dal popolo libico che chiede un processo inclusivo, con fasi e obiettivi chiaramente definiti entro una cornice temporale stringente, ovvero:
I. la prima fase del processo sarà dedicata ad emendare l’Accordo Politico libico di Skhirat: gli emendamenti saranno formulati da una Commissione redigente, composta di delegati della Camera dei Rappresentanti e del Consiglio di Stato, che hanno iniziato a lavorare a Tunisi il 26 settembre 2017;
II. una volta approvati gli emendamenti, la fase due sarà la convocazione di una Conferenza per la riconciliazione nazionale, che dovrà includere membri della Camera dei Rappresentanti, del Consiglio di Stato e molti altri non rappresentati adeguatamente in questi due organi. Su base consensuale si procederà all’individuazione dei membri delle istituzioni esecutive riconfigurate;
III. nella terza fase, dopo la Conferenza, la Camera dei Rappresentanti e l’Assemblea costituente lavoreranno in parallelo: la Camera dei Rappresentanti darà priorità alle leggi che disciplinano il referendum costituzionale e le elezioni presidenziali e parlamentari; l’Assemblea costituente rivedrà e rifinirà il suo lavoro[13], tenendo in considerazione le osservazioni e le indicazioni espresse durante la Conferenza nazionale;
IV. entro 1 anno da ora dovrà essere raggiunta la fase finale del processo con il referendum costituzionale, le elezioni del Presidente e le elezioni parlamentari - che segneranno la fine della transizione.
Il Rappresentante Speciale Salamé ha evidenziato che nel processo è importante registrare progressi concreti sul dialogo con i gruppi armati, ai fini di un’eventuale integrazione dei membri entro il processo politico e la vita civile. Il Segretario generale ha fatto appello agli Stati membri a partecipare ad un nuovo round di raccolta fondi per il Fondo di stabilizzazione dell’ONU.
Nella fase attuale, UNSMIL sta lavorando con l’ONG ginevrina Center for Humanitarian Dialogue (HD) sulla Conferenza Nazionale, conducendo consultazioni inclusive che finora hanno coinvolto 7.000 libici in una serie di iniziative di riconciliazione a livello locale in 73 sessioni in 43 città libiche che sono andate avanti per 14 settimane anche durante il Ramadan. Nel frattempo UNSMIL ha elaborato una strategia di sicurezza sul tema dello smantellamento e della reintegrazione nel medio periodo delle milizie, al fine di stabilizzare la situazione di sicurezza nel Paese, che è stata illustrata in Consiglio di sicurezza il 21 maggio 2018 dallo stesso Rappresentante Speciale. Sono inoltre in corso le preparazioni tecniche da parte del GNA per le elezioni, è stato completato con successo un primo round di registrazione dei votanti.
Le iniziative francesi
Si deve ricordare anche, in questa sede, l’iniziativa del presidente francese Macron, di convocare a Parigi al-Sarraj e Haftar il 25 luglio 2017, alla presenza dell’Inviato Speciale dell’Onu Salamé. A conclusione del vertice di Parigi, al-Sarraj e Haftar hanno emesso una dichiarazione congiunta, che tuttavia non è stata sottoscritta bensì adottata come dichiarazione di principi, in 10 punti. Tra questi figura anche l’impegno, a rendere operativo l’Accordo politico libico e a perseguire il dialogo politico.
I due leader libici hanno concordato anche sull’indizione di elezioni presidenziali e parlamentari appena possibile a partire dal 25 luglio 2017. L’incontro di Parigi ha avuto l’effetto di collocare sullo stesso piano i due interlocutori libici, nei fatti accordando così al generale Haftar quella legittimità internazionale finora riconosciuta al solo governo presieduto da al-Sarraj.
Una nuova Conferenza a Parigi su iniziativa del Presidente Macron si è tenuta il 29 maggio 2018 con la partecipazione di al-Sarraj, Haftar, Saleh (Presidente della Camera dei Rappresentanti) e Meshri (Presidente del Consiglio di Stato) ed ancora una volta la dichiarazione congiunta in 8 punti non è stata sottoscritta ma adottata come dichiarazione di principi: potrebbe servire come piattaforma per allargare il consenso a tutti i leader libici sotto la guida del Rappresentante Speciale dell’ONU. In essa, le parti si impegnano a predisporre le previsioni costituzionali sulle elezioni e la legge elettorale entro il 18 settembre 2018 e a tenere le elezioni il 10 dicembre 2018.
La posizione del nostro Paese
Come illustrato dal Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, il 10 luglio 2018 in occasione dell’esposizione delle linee programmatiche del suo Dicastero innanzi alle Commissioni Esteri del Parlamento, l’Italia, nel segno della continuità con l’azione del governo precedente, è impegnata nella stabilizzazione della Libia, nel sostegno al governo di al-Sarraj, nel dialogo inclusivo, nel sostegno al Rappresentante Speciale Salamè e crede che, in un’ottica di ownership, spetti alla Libia decidere la data delle proprie elezioni.
La linea politica dell’Italia è rimasta nel tempo coerente con alcuni principi cardine: (a) ricerca di una soluzione politica alla crisi; (b) sostegno alle Istituzioni previste dall’Accordo Politico Libico e al governo al-Sarraj; (c) appoggio all’azione delle Nazioni Unite per promuovere, nel rispetto dell’ownership libica, un processo inclusivo di riconciliazione nazionale.
Si ricorda che l’Italia agli inizi di gennaio 2017 ha proceduto alla riapertura dell’Ambasciata italiana a Tripoli, l’unica ambasciata occidentale operativa.
Sempre nel 2017 l’azione italiana nello scenario libico si era adoperata per abbinare ad interventi di gestione dei flussi migratori alcuni sforzi volti alla stabilizzazione della Libia e a tenere viva l’attenzione della comunità internazionale sulla crisi: dal Memorandum d’intesa italo-libico relativo all’immigrazione[14] del 2 febbraio 2017, alle azioni di mediazione tra le tribù nel sud del paese (Awlad Suleiman, Tuareg, Tebu), all’iniziativa dell’allora ministro dell’Interno Marco Minniti di creare un Gruppo di Contatto permanente, nel tentativo di coinvolgere la Libia ed i partner nordafricani in un’azione strategica condivisa che porti i suoi frutti nel medio-lungo periodo.
Il Memorandum d’intesa italo-libico relativo all’immigrazione è intervenuto a definire i comuni impegni in vista della stabilizzazione del paese e del governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti. Tra i principali contenuti del Memorandum, l’impegno delle parti ad avviare iniziative di sostegno alle istituzioni di sicurezza e militari al fine di arginare i flussi di migranti illegali.
L’Italia si impegna a fornire supporto tecnico e tecnologico alla Guardia di frontiera e alla Guardia costiera del Ministero della Difesa e agli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell’Interno. Le parti si impegnano al completamento del sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia secondo quanto previsto dall’art. 19 del Trattato di Amicizia del 2008, nonché all’adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza temporanei in territorio libico e alla formazione del personale libico ivi impiegato[15].
Convenute a Roma nel maggio 2017, le tribù meridionali della Libia hanno firmato un’intesa per favorire lo sviluppo economico e sociale del Sud del Paese. Sempre a Roma a fine agosto 2017 si è svolto l’incontro con i sindaci delle città libiche del Sud che hanno ottenuto un piano triennale di finanziamenti dall’UE per piani dettagliati di sviluppo, alternativi al traffico di esseri umani e al contrabbando.
Il Gruppo di contatto si è riunito per la prima volta a Roma il 19 e 20 marzo 2017, nel formato di un vertice dei Ministri dell’Interno delle due sponde del Mediterraneo per governare i flussi migratori. Oltre all’Italia vi partecipano Germania, Francia, Austria, Slovenia, Svizzera, Malta, Libia, Tunisia e Algeria nonché l’UE - tramite il Commissario dell’UE Avramopoulos. Il Gruppo di contatto si è riunito per la seconda volta a Tunisi il 24 luglio 2017, in formato allargato a Ciad e Niger. I Ministri dell’Interno dei paesi delle due sponde hanno deciso di coordinare meglio i propri sforzi per gestire le migrazioni nel Mediterraneo centrale, a partire da alcune aree chiave: cooperare sui rimpatri; rafforzare azione e collaborazione contro il traffico e la tratta dei migranti; affrontare le cause profonde delle migrazioni irregolari. La terza volta si è riunito a Roma il 28 agosto 2017, all’indomani dell’incontro con i sindaci delle città libiche del Sud e nello stesso giorno del vertice di Parigi sull’immigrazione tra i leader di Francia, Italia, Germania e Spagna e di Libia, Ciad, Niger e con l’Alto rappresentante dell’UE.
Nell’estate 2017 il governo ha agito, su diversi piani, per attivare un’azione politica dell’Europa, sia con il piano Minniti di interventi di capacity building per la Libia - tra cui la costituzione di un MRCC[16] libico - sia con la preparazione dell’Action Plan della Commissione dell’UE per sostenere l’Italia nel governo dei flussi migratori (poi approvato dal Consiglio Affari esteri del 17 luglio 2017)[17]; ha inoltre posto la questione della "regionalizzazione degli sbarchi" avviando la revisione del piano operativo di Triton, piano richiamato anche da EUNAVFOR-MED/Sophia[18]che, come è noto, prevedeva che i migranti soccorsi fossero condotti nei porti italiani, chiedendo una distribuzione più sostenibile degli oneri derivanti dalla gestione delle persone soccorse in mare.
L’approvazione dell’Action plan dell’UE è stata costruita a partire dalle proposte italiane, tra cui quella di un Codice di condotta per le ONG impegnate nei salvataggi nel Mediterraneo centrale[19].
Sempre nell’estate 2017, agendo invece su un piano bilaterale, il governo ha deliberato[20] una missione di supporto alla Guardia costiera libica che si avvale del dispositivo aeronavale nazionale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale (cosiddetta operazione Mare sicuro)[21], rispondendo ad una richiesta di assistenza da parte del Governo di Accordo nazionale libico, in linea con Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2259 (2015) e 2312 (2016).
In un’ottica di sostegno al dialogo inclusivo rilanciato da Salamé, dopo il ministro degli Esteri francese Le Drian e quello britannico Johnson, anche il ministro dell’Interno pro tempore Marco Minniti, il 6 settembre 2017, di ritorno dall’Algeria, ha incontrato il generale Haftar a Bengasi. È stata la prima volta che un esponente di primo piano del Governo italiano, da sempre coerente al sostegno dato all’esecutivo al-Sarraj, ha incontrato il Generale. Successivamente il 26 settembre 2017 il generale Haftar è stato ricevuto a Roma dall’allora Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.
A ribadire l’importanza del dossier libico per l’Italia, il ministro dell’Interno e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini si è recato a Tripoli il 25 giugno 2018 e ha incontrato il vice presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Ahmed Maitig, per discutere dei temi migratori. Si è recato a Tripoli anche il ministro degli Esteri Moavero Milanesi il 7 luglio 2018 e ha incontrato il Presidente del Consiglio Presidenziale Fayez Al Sarraj, il vice primo ministro Ahmed Maitig, il ministro degli Esteri Mohammed Taher Siyala, nonché il Presidente dell’Alto Consiglio di Stato Khaled Al Meshri.
Il ministro Moavero - oltre a confermare la vicinanza dell’Italia alle istituzioni legittime e al popolo libico ad assicurare il pieno sostegno al quadro istituzionale previsto dall’Accordo Politico Libico, all’unità e all’integrità del Paese, al rilancio dell’azione del Rappresentante Speciale delle Nazione Unite per la Libia Ghassan Salamé - ha rinnovato l’auspicio di un rilancio del partenariato strategico, facendo leva sui meccanismi del Trattato di Amicizia del 2008. Egli ha confermato inoltre la disponibilità da parte italiana ad approfondire la collaborazione nel settore delle infrastrutture cruciali per il rilancio del sistema economico libico.
L’11 luglio 2018 il ministro Matteo Salvini ha incontrato a Roma il vice primo ministro libico Maitig; i due si sono intrattenuti sui temi della lotta all’immigrazione clandestina e al terrorismo e su accordi economici. Il ministro Salvini ha dichiarato che l’asse Italia-Libia è «strategico, fondamentale e irrinunciabile» per i due Paesi. Il ministro Salvini ha dichiarato la disponibilità dell’Italia ad aiutare il Paese nordafricano anche fornendo i mezzi indispensabili per il pattugliamento (il D.L. n. 84/2018 Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici, su cui v. dossier n. 41 Servizio Affari internazionali/Servizio Studi), nonché ha preso nota delle difficoltà della Libia a dotarsi dei mezzi necessari alle guardie costiere per il pattugliamento, né quanto occorre alla polizia per garantire la sicurezza del territorio, pur disponendo di mezzi economici, a causa dell’embargo.
I ministri Moavero e Salvini hanno altresì avuto incontri a Roma con il Rappresentante Speciale dell’ONU Salamé rispettivamente il 9 e 10 luglio 2018.
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando in conferenza stampa ai margini del vertice NATO il 12 luglio 2018 ha annunciato la disponibilità dell’Italia ad organizzare una Conferenza sulla Libia in autunno "per dar seguito a quella di Parigi".
Il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 è stato nuovamente dedicato principalmente al tema delle migrazioni. I leader europei hanno convenuto che si tratta di una sfida, non solo per il singolo paese dell’UE, ma per l’Europa tutta.
Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, i leader UE hanno convenuto di:
· intensificare gli sforzi per porre fine alle attività dei trafficanti dalla Libia o da altri paesi
· continuare a sostenere l’Italia e gli altri paesi UE in prima linea
· rafforzare il sostegno a favore della regione del Sahel, della guardia costiera libica, delle comunità costiere e meridionali, e per condizioni di accoglienza umane e rimpatri umanitari volontari
· potenziare la cooperazione con altri paesi di origine e transito e aumentare i reinsediamenti volontari
I capi di Stato e di governo dell’UE hanno inoltre sottolineato l’importanza di un partenariato con l’Africa, che richiederà non solo maggiori finanziamenti allo sviluppo ma anche misure intese a creare un nuovo quadro che consenta di accrescere gli investimenti privati degli africani e degli europei.
I capi di Stato o di governo dell’UE hanno convenuto altresì che nel territorio dell’UE coloro che vengono salvati dovrebbero essere presi in carico sulla base di uno sforzo condiviso e trasferiti in centri sorvegliati. Tali centri, da istituire negli Stati membri unicamente su base volontaria, consentirebbero un trattamento rapido e sicuro per distinguere i migranti irregolari, che sarebbero rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale, cui si applicherebbe il principio di solidarietà.
Richiamandosi alle conclusioni del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Conte in data 14 luglio 2018, ha indirizzato una lettera ai capi di Stato e di governo dell’UE, sollecitandoli a farsi carico di parte dei migranti sulla nave della GdF Sperone e sul pattugliatore Protector di FRONTEX fatti sbarcare a Pozzallo (451 migranti). In risposta a tale appello, Francia, Malta, Germania, Spagna e Portogallo hanno offerto la loro disponibilità ad accogliere ciascuno 50 migranti.
Dal 27 agosto 2018 la Settima Brigata di Tarhuna legata a Salah Badi[22] ha sferrato un’offensiva a Tripoli contro le milizie tripoline rivali che sostengono il Governo di Accordo Nazionale guidato da al-Sarraj. Gli scontri hanno registrato almeno 60 morti, inclusi numerosi civili, e decine di feriti. Nel tentativo di porre un freno alle violenze e ristabilire l’ordine, al-Sarraj ha dichiarato lo stato di emergenza e ha richiesto l’intervento della Forza anti terrorismo di Misurata.
La missione UNSMIL delle Nazio-ni Unite guidata dal Rappresentante Speciale Salamé, dal canto suo, ha riunito le va-rie parti coinvolte nello scontro inducendole a sottoscrivere una tregua, nel tentativo di preservare il governo internazionalmente riconosciuto.
Il 5 settembre 2018 i capi milizia ed il governo al Sarraj hanno sottoscritto un accordo in 7 punti che prevede che tutte le parti firmatarie si impegnino a trovare una soluzione politica, alla cessa-zione delle ostilità e alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco; prevede anche la protezione dei civili, la garanzia che le proprietà pubbliche e private non verranno violate e la riapertura dell’aeroporto di Mitiga.
La partita economica tra le milizie
Secondo numerosi osservatori[23] sembra che l’iniziativa militare capeggiata dalla Settima Brigata miri a rompere l’oligopolio di milizie che oggi prevale a Tripoli per ottenere la propria quota di business avvantaggiandosi dalle relazioni privilegiate con il governo in carica. Com’è noto, da quando il governo al Sarraj si è insediato a Tripoli, quattro fra le più rilevanti milizie locali – riunite in una sorta di unico “cartello” – si sono progressivamente divise il controllo della capitale libica.
Secondo alcuni analisti[24] ciò ha consentito loro di radicarsi gradualmente nel territorio e di infiltrarsi nei gangli della pubblica amministrazione, fino ad arrivare a gestire buona parte delle istituzioni e a controllare nodi importanti nella capitale quali, ad esempio, le banche, cui forniscono sicurezza in cambio di importanti compensi. La VII Brigata fa parte di quelle milizie che prima erano presenti nella capitale libica e che ora sono invece “periferiche”. All’origine dell’attacco vi sarebbe dunque la necessità di superare questa situazione di marginalità che ostacola le attività della milizia stessa e ne penalizza il posizionamento sullo scacchiere interno. [25]
Dal momento che la VII Brigata non sembra in grado di prendere Tripoli contando solo sulle proprie forze, dipenderà dal posizionamento di alcune impor-tanti milizie come quelle di Zintan e di Misurata il successo o meno dell’iniziativa militare promossa da tale milizia.
La partita politica delle milizie
Ma la competizione tra milizie non mirerebbe solo alla conquista di una quota di business bensì ad evitare la loro esclusione dal processo politico. Alcuni commentatori[26] fanno osservare che la Conferenza di Parigi del 29 maggio promossa dal Presidente Macron e le elezioni libiche entro il 10 dicembre che essa prevede sono da molti percepite in Libia come uno strumento che esclude alcuni protagonisti e prepara una spartizione di potere solo fra quelli che hanno partecipato alla Conferenza di Parigi e prelude ad un rafforzamento del generale Haftar.
Questa percezione è alla base della forte opposizione che la realizzazione delle elezioni sta incontrando ed è destinata a risvegliare i conflitti che stanno alla radice della crisi libica. L’attacco della milizia di Tarhuna a Tripoli si muove in questa logica, anche se oggi è prematuro sapere se riflette manovre di Haftar o prepara alleanze contro Haftar.
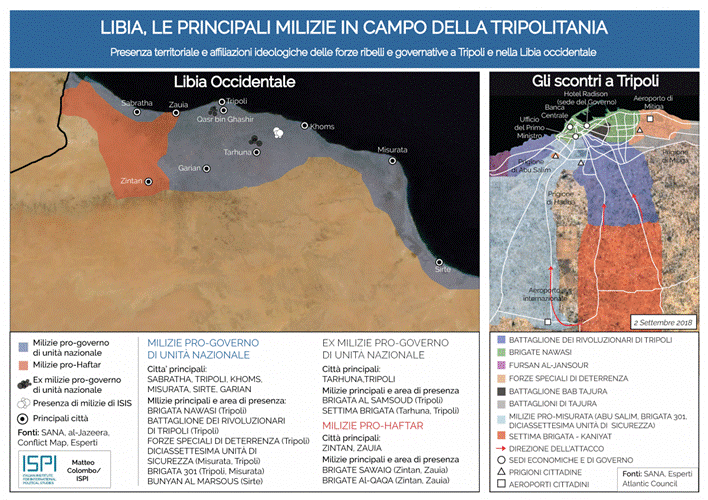 Figura 1. Le principali milizie in campo (fonte: ISPI)
Figura 1. Le principali milizie in campo (fonte: ISPI)
Le iniziative italiane
Il governo italiano considera la data indicata dalla Conferenza di Parigi[27] per tenere le elezioni in Libia entro il 10 dicembre come un obiettivo verso cui tendere, non in maniera prescrittiva[28] e sottolinea la necessità di legarle alla preparazione di un consenso costituzionale che porti a elezioni credibili.[29]
Su questa base l’Italia sta preparando, secondo quanto preannunciato ai margini del vertice NATO il 12 luglio 2018 e ribadito dal presidente del Consiglio Conte durante la sua visita a Washington del 30 luglio scorso, una Conferenza – che dovrebbe svolgersi a novembre a Sciacca – alla quale saranno invitate per trovare un’intesa tutte le parti libiche, non solo quelle che si sono incontrate a Parigi. Come precisato dal Ministro Moavero nel colloquio telefonico con il presidente al-Sarraj del 4 settembre, nella Conferenza sulla Libia, che l’Italia intende ospitare in autunno, il tema prioritario sarà la sicurezza, precondizione per lo svolgimento delle elezioni, obiettivo cardine del piano delle Nazioni Unite. Saranno, inoltre, affrontati i temi della riconciliazione e del rispetto dei diritti umani. Sul punto, l’Ambasciatore dell’Italia presso l’ONU, Zappia, ha ulteriormente precisato che l’Italia intende promuovere una Conferenza a Sciacca maggiormente inclusiva degli attori locali e degli attori internazionali.
Sempre in chiave inclusiva e in un’ottica di coinvolgimento degli attori internazionali nella soluzione politica della crisi libica, andrebbe vista la recente visita (28-30 agosto 2018) del Vice Presidente del Consiglio Di Maio al Cairo – seguita a quella del Ministro degli Esteri Moavero Milanesi e dell’altro Vice Presidente del Consiglio Salvini - durante la quale c’è stato l’incontro con il Generale Al Sissi, principale sostenitore di Haftar, e nella quale è stata ufficialmente rilanciata la tradizionale relazione speciale tra Italia ed Egitto[30].
Ancora in un’ottica di dialogo inclusivo e in vista della Conferenza di Sciacca s’inquadra l’incontro del ministro degli Esteri Moavero Milanesi del 10 settembre 2018 a Bengasi con il generale Haftar
Il ministro Maovero Milanesi ha ribadito che “i cittadini libici devono essere messi in grado di esercitare la propria sovranità e di poter decidere liberamente il proprio destino. Il percorso politico avviato va portato a termine, in particolare, attraverso elezioni ordinate e trasparenti, che si svolgano in condizioni di adeguata sicurezza”.
Nell’incontro sono state esaminate le modalità attraverso le quali intensificare la collaborazione in campo umanitario e rafforzare il contrasto al terrorismo e ai trafficanti di ogni tipo, nonché agli sfruttatori di esseri umani. Il Ministro Maovero Milanesi ha inoltre incontrato a Roma sia il vice-presidente del Consiglio libico Maitig il 14 settembre, sia il suo omologo il 19 settembre con cui ha condiviso i possibili obiettivi della conferenza sulla Libia a cui il Ministro Siyala ha assicurato la sua personale motivazione e determinazione.
Frattanto, a fronte del deteriorarsi della situazione libica, il governo italiano ha ritenuto necessario evacuare parte del personale diplomatico e tecnico, benché la sede diplomatica resti comunque operativa.
Da ultimo, il 13 settembre 2018 il Consiglio di sicurezza dell’ONU con la Risoluzione n. 2434 (2018) ha prorogato la missione politica speciale integrata UNSMIL, di un ulteriore anno e ha incaricato il Segretario Generale di includere, nell’assessment degli obiettivi dettagliati per l’attuazione del mandato di UNSMIL, un focus particolare sui passaggi necessari a definire le basi costituzionali per le elezioni, nonché per far progredire il processo di pace. Nel testo della Risoluzione predisposto dal Regno Unito non è stata accolta la formulazione che sarebbe stata proposta dalla Francia di includere l’indicazione della data del 10 dicembre per le elezioni libiche[31].
Il conflitto confinario tra Etiopia ed Eritrea risale al periodo 1998-2000. L’Eritrea, il cui territorio si distende lungo il confine settentrionale dell’Etiopia, aveva conquistato l’indipendenza (24 maggio 1993) dopo una lotta trentennale prima contro l’Etiopia del Negus Hailè Selassie (deposto nel 1974) e poi quella del "negus rosso" Menghistu Hailè Mariàm, al potere dal 1977 al 1991. L’indipendenza dell’Eritrea era anche frutto della sua alleanza politica e militare con il gruppo etnico dei tigrini etiopi, andati poi al potere ad Addis Abeba.
All’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, pertanto, sembravano esserci le condizioni per una proficua collaborazione tra Eritrea ed Etiopia. Del resto il presidente eritreo, Isaias Afewerki, e il premier etiopico, Meles Zenawi, erano stati compagni di lotta nella guerra di liberazione. L’ipotesi di un cammino comune nella ricostruzione dei due Paesi era sostenuta anche dalla loro stretta interconnesione economica.
L’Eritrea, ex colonia italiana (1890-1941), ha infatti un ruolo strategico importante per l’Etiopia per la sua complementarietà culturale, economica e geopolitica; i porti eritrei di Massaua e Assab, inoltre, costituiscono lo sbocco naturale per i commerci etiopici.
Tuttavia i due movimenti d’estrazione etnica tigrina, che avevano combattuto fianco a fianco durante gli anni della lotta armata contro il regime socialista, si sono trasformati in nemici dopo la loro istituzionalizzazione in partiti di governo. Ed è stato proprio la radicata ostilità tra il Fronte popolare per la democrazia e la giustizia (FPDG) del presidente eritreo Isaias Afewerki e il Fronte popolare di liberazione del Tigray (TPLF) dell’ex primo ministro etiopico Meles Zenawi l’origine del conflitto divampato nel 1998 come disputa confinaria che si è concentrata in particolare su Badme, piccola città simbolo situata sulla linea di confine tra i due Paesi. In due anni di guerra (1998-2000) tra 60 e 70mila militari hanno perso la vita.
I combattimenti sono cessati nel 2000, quando le due capitali hanno acconsentito alla creazione di una commissione indipendente delle Nazioni Unite chiamata a definire i confini. Venne stabilito che i territori contesi appartengono all’Eritrea, ma sebbene i due Paesi avessero accettato i risultati dei lavori della commissione, l’Etiopia non ritirò i suoi uomini dalle zone contese. In tal modo si è instaurata per anni una situazione di "né guerra né pace" costellata dal susseguirsi di incidenti tra reparti militari etiopi ed eritrei.
Le prime tensioni tra l’Etiopia e l’Eritrea indipendente risalgono, in realtà, ad alcuni mesi prima dello scoppio ufficiale delle ostilità, quando il governo eritreo decise di introdurre una propria moneta nazionale – il Nakfa – in luogo del Birr etiopico ancora in uso. Quest’affermazione di sovranità monetaria venne accolta in ambienti del TPLF tigrino come un tentativo di danneggiare l’Etiopia settentrionale, sfruttando la leva valutaria per dettare le condizioni di transito delle merci etiopiche; il governo di Addis Abeba rispose approntando una serie di misure restrittive al commercio transfrontaliero, cui seguirono le vibranti proteste di Asmara.
Nel corso degli anni, il conflitto tra Etiopia ed Eritrea è divenuto il perno degli equilibri di politica interna in entrambi i Paesi.
In Eritrea la resistenza dell’Etiopia nell’applicare gli accordi di pace firmati ad Algeri nel 2000, e dunque ritirarsi dai territori occupati, sono stati utilizzati come prova della non accettazione dell’indipendenza dell’ex colonia italiana da parte di Addis Abeba; pertanto, essendo necessario il prolungamento della lotta di liberazione, lo stato di "né guerra né pace" ha spianato la strada alla sospensione ad libitum della Costituzione e all’introduzione del servizio militare permanente.
Il perdurare dello stato d’emergenza ha modificato gli equilibri interni alla società eritrea, consegnando il potere politico ed economico assoluto all’establishment militare e alle strutture di partito. Il sostegno accordato dalle cancellerie occidentali all’Etiopia e l’imposizione di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza Onu ha legittimato ulteriormente la svolta autoritaria, consentendo alle autorità eritree di marchiare come complotto esterno contro la propria sovranità ogni deviazione dal discorso governativo ufficiale.
In Eritrea il servizio militare obbligatorio indefinito dura dal 18 anno di età e termina in teoria a 50 anni
L’Etiopia ha addossato la responsabilità della guerra e la ritrosia ad applicare gli accordi di Algeri all’avventurismo politico di Asmara. La disputa del 2008 tra Eritrea e Gibuti - risolta con un arbitrato internazionale e la mediazione del Qatar - per la demarcazione del confine orientale, e il presunto e non provato sostegno di Asmara a gruppi d’opposizione come al-Shabaab in Somalia, hanno consentito ad Addis Abeba di rappresentare il vicino come un regime "canaglia" irrispettoso del diritto internazionale.
Secondo alcune analisi, queste formule diplomatiche nascondono la necessità di venire a patti con la base elettorale del partito tigrino TPLF, il quale ha utilizzato la questione eritrea per consolidare la presa sulle istituzioni e ristrutturare l’economia nazionale in modo funzionale agli interessi della regione settentrionale del Tigray.
Dopo aver pronunciato, nel discorso di insediamento, parole concilianti nei confronti dell’Eritrea, il 6 giugno 2018 il premier Abiy Ahmed ha deciso l’abolizione dello stato di emergenza e ha dichiarato di accettare l’Accordo del 2000; il 26 giugno, una delegazione eritrea guidata dal ministro degli Esteri Osman Sale si è recata in Etiopia per il primo round di colloqui e il 9 luglio sono stati firmati gli accordi che hanno stabilito la fine dello ‘stato di guerra’, la ripresa formale delle relazioni diplomatiche, dei collegamenti aerei e l’uso dei porti eritrei per Addis Abeba.
A questo primo Accordo, si è aggiunto, lo scorso 16 settembre a Gedda, in Arabia saudita, un nuovo Accordo di pace con la mediazione del Paese ospitante, dell’Onu, rappresentato dal segretario generale Antonio Guterres, dell’Unione africana e degli Emirati arabi uniti. Il trattato, articolato in sette punti, integra e approfondisce quello firmato il 9 luglio e prevede, secondo quanto riportato da un comunicato stampa del governo saudita, il ripristino di normali relazioni fra i due Paesi, sulla base degli stretti legami geografici, storici e culturali fra le nazioni e i rispettivi popoli.
Inoltre il 5 settembre, i presidenti di Eritrea e Somalia, Isaias Afwerki e Mohamed Abdullahi "Farmajo", e il premier etiope Abiy Ahmed hanno firmato un Accordo tripartito di cooperazione che prevede il rilancio della cooperazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza fra i tre paesi. Nella medesima giornata i ministri degli Affari esteri di Somalia, Etiopia ed Eritrea si sono riuniti a Gibuti nel tentativo di allentare le tensioni tra Eritrea e Gibuti. Eritrea e Gibuti sono divisi da una annosa disputa relativa all’arcipelago di Dumeira, nel Mar Rosso, che Gibuti sostiene sia illegalmente occupato dall’Eritrea.
Le tensioni hanno raggiunto il loro culmine nel 2008, quando le forze armate dei due paesi si sono scontrate lungo il confine nel giugno 2008 prima che entrambe le parti accettassero l’offerta di mediazione da parte del Qatar e lo spiegamento di una forza internazionale di mantenimento della pace. Durante l’incontro, secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri etiope Workneh Gebeyehu, si sarebbe raggiunto un accordo per normalizzare le relazioni diplomatiche tra i due paesi.
A spingere verso la pace il giovane premier etiopico è un disegno di stabilizzazione del Paese che passa attraverso la liberazione dei prigionieri politici, la riapertura dei media sottoposti a censura, la ripresa economica e la necessità di attrarre investimenti internazionali. Una strategia che non può non considerare il problema dei profughi eritrei: centinaia di migliaia di persone in fuga da condizioni economiche drammatiche e dalla violazione sistematica dei diritti umani sono ammassati nei campi dell’Etiopia e costituiscono un ulteriore fattore di destabilizzazione.
L’ascesa di un primo ministro di etnia oromo e il ridimensionamento del potere del TPLF nella coalizione di governo determina lo spostamento dell’asse di potere dall’élite del Nord verso quella delle regioni centro-meridionali, incidendo sulla disponibilità dell’amministrazione federale a sostenere le istanze del blocco sociale tigrino. Nella prospettiva del nuovo governo di Addis Abeba, la fine della disputa confinaria è finalizzata alla messa in sicurezza delle porte d’accesso al mare, in un paese che ha bisogno di rafforzare la rete di collegamenti con i mercati internazionali.
Non mancano, tuttavia, elementi di criticità nel nuovo corso etiope. La decisione accettare gli Accordi di Algeri del 2000 e di lasciare Badme ha provocato proteste nello stesso villaggio e tensioni all’interno dell’TPLF, che ha chiesto una riunione d’emergenza per meglio definire i passaggi della distensione con il vicino. La stessa capacità del premier Abiy Ahmed di imporre la propria agenda - è stato rilevato dagli osservatori - non può prescindere dalla considerazione che la tenuta della coalizione di governo si fonda su un equilibrio delicato.
Talune analisi indicano quale elemento di maggiore criticità del processo negoziale lo scarso coinvolgimento dell’élite politica del Tigray nel processo di pace, mentre il ripristino delle relazioni diplomatiche appare al momento più come il risultato dell’allineamento tra Asmara e il partito oromo del premier che come un’autentica rappacificazione con la coalizione di governo etiopica nel suo complesso.
Inoltre la violenza interetnica non accenna a diminuire. Un rapporto delle Nazioni Unite e del governo etiope, pubblicato il 4 luglio scorso, ha reso noto che, da giugno 2018, la violenza interetnica diffusa nelle regioni meridionali dell’Etiopia ha costretto oltre 800.000 persone a fuggire dalle loro case. Le tensioni sarebbero esplose ad aprile, a circa 400 km a sud della capitale, Addis Abeba, causando dall’inizio di giugno, oltre 642.152 sfollati interni nella zona di Gedeo e 176.098 sfollati interni nella zona di West Guji, nella regione di Oromia.
Nuovi violenti scontri si sono verificati a partire dal 16 settembre e avrebbero provocato – secondo quanto riportato dal governo – 23 morti. Il bilancio delle vittime tuttavia, secondo quanto riportato da osservatori internazionali, sarebbe assai più alto. L’Ambasciata degli Stati Uniti, il 19 settembre, a causa del perdurare della situazione di violenza, ha deciso “ a scopo preventivo” la chiusura della sede diplomatica.
Lo scorso 26 marzo, a tre anni dall’inizio dell’intervento militare guidato dall’Arabia Saudita, lo Yemen è entrato nel quarto anno di guerra. Secondo le Nazioni Unite, lo Yemen, già il paese più povero dell’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa), vive l’emergenza umanitaria più grave al mondo: oltre 10 mila vittime e 3 milioni di sfollati interni.
I dati sono inequivocabili: su una popolazione di 27 milioni di abitanti, 22 milioni di yemeniti necessitano di assistenza umanitaria, 17 milioni vivono una condizione di insicurezza alimentare (malnutrizione cronica e/o malnutrizione acuta), mentre i casi di colera hanno superato il milione. I bombardamenti della coalizione militare araba hanno distrutto le principali infrastrutture, con pesanti conseguenze sulle importazioni di generi alimentari, da cui prima del conflitto lo Yemen dipendeva per il 90%. L’economia di guerra, gestita da capi tribali che spesso sono anche comandanti militari, prospera grazie alle reti di contrabbando: il commercio informale e il deprezzamento del rial yemenita fanno impennare i prezzi al consumo.
La banca centrale non è più un organo indipendente, ormai ´sdoppiata` fra la sede di Sana’a, gestita dagli insorti, e quella del governo riconosciuto, trasferita ad Aden, oltre a entità bancarie autonome su base regionale (Mareb e Hadhramaut).
Nel giorno dell’anniversario dell’inizio dell’intervento militare a guida saudita, gli huthi del movimento Ansarullah (“partigiani di Dio”, ovvero gli insorti sciiti zaiditi[32] del nord, autori del colpo di stato del gennaio 2015), hanno lanciato sette missili in territorio saudita, tre dei quali intercettati sulla capitale Riyadh: è la prova che le implicazioni dell’irrisolto conflitto civile yemenita gravano sempre di più sulla sicurezza regionale.
Inoltre, l’irrigidimento della politica statunitense nei confronti dell’Iran, che sostiene militarmente gli huthi (come confermato da un recente rapporto delle Nazioni Unite[33]), riduce le già esigue possibilità di mediazione interna, dopo tre negoziati diplomatici falliti (due in Svizzera, uno in Kuwait). Al contrario, lo Yemen, divenuto teatro di un confronto indiretto fra Arabia Saudita, che appoggia il governo riconosciuto del presidente ad interim Abd Rabu Mansur Hadi, e Iran, è un potenziale casus belli fra Riyadh, Teheran e Washington: un conflitto diretto fra sauditi e iraniani rimane improbabile, ma la leadership saudita continua a stigmatizzare le “attività destabilizzatrici dell’Iran” in Yemen e in Medio Oriente.
Lo scorso febbraio, la nomina del nuovo inviato dell’Onu in Yemen, l’inglese Martin Griffiths, ha ridato fiato alla prospettiva negoziale. Tuttavia, gli unici colloqui diplomatici recenti sarebbero avvenuti al di fuori della cornice delle Nazioni Unite (come già nel 2016): i contatti, informali ma diretti, tra gli huthi e i sauditi, facilitati dal neutrale Oman, avrebbero per di più escluso il governo riconosciuto.
Tre governi. Cronologia e attori della crisi
Dal marzo 2015, una coalizione araba di nove paesi, guidata da Arabia Saudita (concentrata su nord dello Yemen e operazioni aeree) ed Emirati Arabi Uniti (sud dello Yemen, operazioni terrestri e di contrasto al terrorismo di matrice jihadista)[34], interviene militarmente nel paese per ripristinare le istituzioni riconosciute dalla comunità internazionale (ora basate ad Aden), in seguito al colpo di stato, nella capitale Sana’a, degli huthi e del blocco di potere dell’ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh, dimessosi nel 2011. Definire il conflitto in Yemen come uno scontro binario tra “filo-governativi” e “ribelli” è semplicistico e fuorviante: gli attori coinvolti sono molti e cambiano spesso campo, poiché il tessuto sociale di questo paese, fortemente tribale, favorisce la fluidità delle alleanze.
Gli esempi sono numerosi. L’allora presidente Saleh combatté aspramente gli huthi tra il 2004 e il 2010 (durante le cosiddette sei battaglie di Sa’da, provincia d’origine degli huthi): nel 2004, le forze di sicurezza yemenite, su ordine del presidente, uccisero Husayn al-Huthi, leader e fondatore del movimento per l’autonomia delle terre del nord dallo stato centrale.
Nel 2014, Saleh si è invece alleato con gli huthi per provare a riguadagnare il potere, per poi sciogliere questa “convergenza tattica” nel dicembre 2017, provocando la vendetta degli huthi, che lo hanno assassinato il 4 dicembre. Inoltre, solo una minima parte di coloro che si oppongono agli insorti huthi sostengono, in realtà, il presidente riconosciuto Hadi, figura politica debole e dallo scarso seguito militare. Nelle regioni meridionali dello Yemen, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (Eau) hanno combattuto insieme gli insorti, per sostenere poi fazioni yemenite rivali: i sauditi appoggiano i filo-Hadi e il partito Islah, che raggruppa i Fratelli Musulmani dello Yemen e alcune correnti salafite, mentre gli emiratini sostengono altri gruppi salafiti, nonché i secessionisti del sud, riuniti nel Movimento Meridionale (al-Hiraak al-Janubi).
Al momento, tre governi coesistono, di fatto, in Yemen: quello riconosciuto del presidente Hadi, rilocato ad Aden dopo il golpe (anche se i suoi esponenti, in primis il presidente, trascorrono più tempo a Riyadh), l’autoproclamato governo degli huthi a Sana’a, nonché il Consiglio di transizione del Sud (Stc), l’organo istituzionale dei secessionisti meridionali creato ad Aden nel maggio 2017 e sostenuto informalmente anche dagli Eau.[35]
Mappa politico-territoriale: oltre il divario nord/sud
Yemen del nord e Yemen del sud sono giunti alla riunificazione solo nel 1990. Questa contrapposizione, sfociata in una breve guerra civile nel 1994, ha contrassegnato la presidenza autoritaria di Saleh (1978-2011): un regime che ha centralizzato potere e risorse a Sana’a, escludendo gli huthi e il sud da redistribuzione della rendita energetica e delle terre, inclusione politica, nonché da esercito e settore pubblico. In realtà, “nord” e “sud” non sono due blocchi coesi.
Le identità regionali, spesso su base tribale, sono fondamentali per comprendere lo Yemen e prevederne le faglie di crisi: per esempio, esistono forti differenze tra le stesse regioni meridionali, già protagoniste di una feroce guerra civile (1986, 10 mila morti in tre mesi). La mappa politico-territoriale dello Yemen in guerra fotografa un paese estremamente frammentato e complesso. Gli huthi controllano il nord ovest, ovvero la roccaforte Sa’da, la capitale Sana’a e la costa occidentale del Mar Rosso, tra cui il porto di Hodeida: questa è un’area a forte penetrazione tribale, in cui le forze filo-emiratine stanno lentamente avanzando in direzione Hodeida.
Il partito Islah e le tribù che sostengono il governo riconosciuto hanno il predominio sui governatorati settentrionali di Al-Jawf e Mareb: qui l’influenza saudita è ancora forte. Periferica rispetto ai combattimenti, la regione di Mareb è diventata il fulcro delle reti del contrabbando, dell’immigrazione illegale, nonché il centro di coordinamento dell’esercito regolare, guidato dal vice presidente e vice comandante delle forze armate Ali Mohsin al-Ahmar, generale già vice di Saleh. Aden, seconda città del paese, è di fatto contesa tra filo-sauditi e filo-emiratini. Sede provvisoria delle istituzioni riconosciute e, al contempo, del pro-indipendentista Stc, Aden è stata teatro di scontri armati tra le due fazioni (28-30 gennaio 2018): solo la tregua mediata da Riyadh e Abu Dhabi ha tamponato la crisi, da cui è emersa la netta superiorità militare dei secessionisti.
Il cosiddetto “sud tribale”, come le regioni di Abyan e Shabwa, è altrettanto diviso fra unità militari e comitati popolari fedeli al presidente Hadi (originario dell’area) e milizie formalmente istituzionalizzate, come le Security Belt Forces (dispiegate anche ad Aden e Lahj) e le Shabwani Elite Forces (della regione di Shabwa), appoggiate dagli Emirati Arabi e dalle aspirazioni autonomiste. Il governatorato dell’Hadhramaut, il più ricco di petrolio dello Yemen, è anch’esso attraversato da interessi geopolitici rivali, che si intrecciano alle storiche pulsioni separatiste della regione: la parte settentrionale e semi-desertica, a nord delle valli del Wadi Hadhramaut, è controllata da unità militari legate a Saleh, a Islah e all’Arabia Saudita, mentre il sud costiero, tra cui il capoluogo Mukalla, è ormai sfera d’influenza emiratina, anche grazie al dispiegamento delle Hadhrami Elite Forces.
Infine, la regione più orientale dello Yemen, Al-Mahra, risparmiata finora dai combattimenti e dalle infiltrazioni jihadiste, è oggetto di una crescente competizione regionale fra Arabia Saudita, Emirati Arabi e il confinante Sultanato dell’Oman. Questo è il principale snodo del contrabbando verso l’interno: le armi di fabbricazione iraniana destinate agli huthi (come le parti dei missili da assemblare) entrerebbero da qui.[36]
Implicazioni per la sicurezza regionale
L’Arabia Saudita non è in grado di vincere la guerra, mentre crescono i costi economici e umani: non solo gli huthi controllano ancora gran parte del nord dello Yemen, ma la sicurezza nazionale del regno è oggi più in pericolo di quanto lo fosse tre anni fa. Il confine saudita-yemenita è teatro di guerriglia e incursioni da parte degli insorti del nord, mentre navi da guerra statunitensi, emiratine e saudite, nonché navi commerciali, sono state oggetto di attacchi huthi (con missili, razzi, mine e imbarcazioni-drone), fra lo stretto del Bab el-Mandeb e il Mar Rosso, mettendo a rischio la sicurezza marittima ed energetica nell’area.
Seppur finora imprecisi, i missili ripetutamente lanciati dagli huthi in territorio saudita sono un fattore di destabilizzazione regionale: secondo Riyadh, gli huthi ne hanno scagliati più di novanta dall’inizio della guerra. Il 4 novembre scorso, l’Arabia Saudita ha intercettato e distrutto un missile sull’aeroporto internazionale di Riyadh. Anche i sette missili lanciati nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso (tre su Riyadh, gli altri su Khamis Mushait, Jizan, Najran) sono stati intercettati e distrutti dai missili Patriot PAC-2 forniti dagli Stati Uniti al regno: un cittadino egiziano è morto e due sono rimasti feriti a causa dei detriti di un missile huthi, così come un cittadino indiano è rimasto ferito a Najran a seguito del missile del 30 marzo.
Gran parte dei missili sparati dagli insorti verso il regno sono Scud di fabbricazione sovietica, già in dotazione alla Guardia Repubblicana di Saleh e quindi parte dell’arsenale dell’esercito yemenita, oggi in frantumi. Tuttavia, alcuni Scud presentano modifiche di gittata attribuibili a Iran o Hezbollah (Qaher 1, Qaher 2, Burkan 1, Burkan 2) che gli huthi non avrebbero potuto operare senza l’assistenza tecnica di terzi.[37] Gli esperti delle Nazioni Unite hanno identificato in Yemen e in Arabia Saudita resti di missili, materiale militare e droni di origine iraniana: armi, si legge nel rapporto del Panel degli esperti, entrate in Yemen dopo l’imposizione dell’embargo.
Pertanto, secondo il rapporto, l’Iran non ha preso le misure necessarie per prevenire la fornitura/vendita diretta o indiretta di armi agli huthi, in violazione così delle relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu.[38] L’asse fra Iran e Russia è ormai evidente anche in Yemen: Mosca ha posto il veto in Consiglio di Sicurezza su una proposta di risoluzione anglo-franco-americana che condannava la fornitura di armi iraniane agli huthi.
Nel sud dello Yemen, il ruolo delle milizie tribali organizzate, finanziate e addestrate dagli Emirati Arabi Uniti è sempre più centrale e, al contempo, controverso. Le Security Belt Forces/al-Hizam Brigades, responsabili dell’area di Aden e dispiegate anche in Abyan e Lahj, nonché le Forze d’élite delle regioni di Hadhramaut e Shabwa, svolgono operazioni di contro-insorgenza nei confronti degli huthi e al-Qaeda nella penisola arabica (Aqap), sotto la guida delle Forze speciali della Guardia presidenziale emiratina.
Esse sono il perno della ricostruzione del settore della sicurezza yemenita: dal 2016, le Security Belt Forces sono formalmente affiliate al ministero dell’interno, le Hadhrami e le Shabwani Elite Forces sono parte dell’esercito. In realtà, queste unità, seppur efficaci nel controllo del territorio, agiscono da milizie, perpetrando arresti e detenzioni arbitrarie, e di fatto rispondono agli Emirati Arabi e al Stc, non al governo riconosciuto dello Yemen, come evidenziato anche dal recente rapporto del Panel degli esperti dell’Onu, che le definisce come “proxy forces” degli Eau.[39]
Inoltre, crescenti episodi di intolleranza religiosa si registrano nelle aree in cui operano milizie anche filo-emiratine: imam salafiti e religiosi sufi (questi ultimi appartenenti alla corrente mistica e dialogante dell’Islam) sono stati uccisi, spesso a colpi di armi da fuoco, in misteriosi raid rimasti impuniti. Di certo, i confini tra salafiti e jihadisti yemeniti sono sempre più labili e confusi. Oltre al contenimento degli huthi, gli obiettivi principali dell’intervento di terra degli Emirati Arabi Uniti in Yemen sono tre: l’indebolimento della Fratellanza Musulmana, il contrasto ad Aqap e la creazione di un’area di influenza geostrategica nel sud del paese, al fine di rafforzare la proiezione commerciale e/o militare su Corno d’Africa e Oceano Indiano.
Proprio gli emiratini sono protagonisti, insieme a unità yemenite e consiglieri statunitensi, delle operazioni anti-Aqap, la formazione jihadista storicamente più forte in Yemen: nel 2017, gli Stati Uniti hanno sferrato più di 120 attacchi droni contro postazioni jihadiste. Avvantaggiandosi del vuoto di sicurezza seguito alla rivolta anti-governativa del 2011, Aqap riuscì a creare sette proto-emirati, sotto le insegne di Ansar al-Shari‘a, sulle coste meridionali dell’Abyan, tra le città di Jaar e Zinjibar, poi sciolti dopo l’intervento dell’esercito yemenita.
Tra il 2015 e il 2016, Aqap ha controllato Mukalla (Hadhramaut), terza città del paese, fino alla ritirata strategica innescata dall’intervento emiratino, arricchendosi grazie a depositi bancari, tasse portuali e contrabbando verso nord. Rispetto all’esperienza in Abyan, i jihadisti (qui ribattezzatisi “Figli dell’Hadhramaut”) hanno optato per un modello di governance diverso: meno applicazione rigida e punitiva della shari‘a, più inclusione delle tribù locali, welfare e sicurezza del territorio. Questo approccio pragmatico e comunitario, insieme a storiche alleanze matrimoniali con clan tribali locali, ha permesso ad Aqap di egemonizzare la galassia jihadista in Yemen, a discapito delle cellule del sedicente Stato Islamico. In Yemen, IS non ha mai controllato territori significativi, tranne alcuni quartieri di Aden poi liberati, e l’area di Yakla nella regione centrale di Al-Bayda.
Dal mese di febbraio, gli Eau sono impegnati in tre campagne parallele di terra contro Aqap, con l’obiettivo di eliminare i jihadisti non solo dai centri urbani, ma anche dalle retrovie, che rappresentano i bacini di reclutamento, addestramento e progettazione degli attacchi terroristici. Con l’appoggio di milizie yemenite locali, gli Emirati Arabi hanno avviato “Decisive Sword” (in Shabwa, distretto di Al-Sayed, con le Shabwani Elite Forces), “Faysal” (in Hadhramaut, valle di Mesini a ovest di Mukalla, con le Hadhrami Elite Forces), “Sweeping Torrent” (in Abyan, Al-Mahfad, Wadi Hamara, con le Security Belt Forces).[40]
Al momento, gli attacchi droni e soprattutto le campagne terrestri organizzate dagli emiratini hanno indebolito Aqap. Tuttavia, i qaedisti hanno fatto della capacità di adattamento a contesti mutevoli la loro cifra: i troppi dissidi interni fra regioni e/o tribù, così come la rivalità regionale fra Arabia Saudita ed Emirati Arabi, potrebbero offrire nuovi spazi di manovra alla galassia jihadista in Yemen, favorita inoltre dal settarismo sprigionato dal conflitto con gli huthi.
(Estratto da: Focus Mediterraneo allargato, n. 7 dell'aprile 2018)
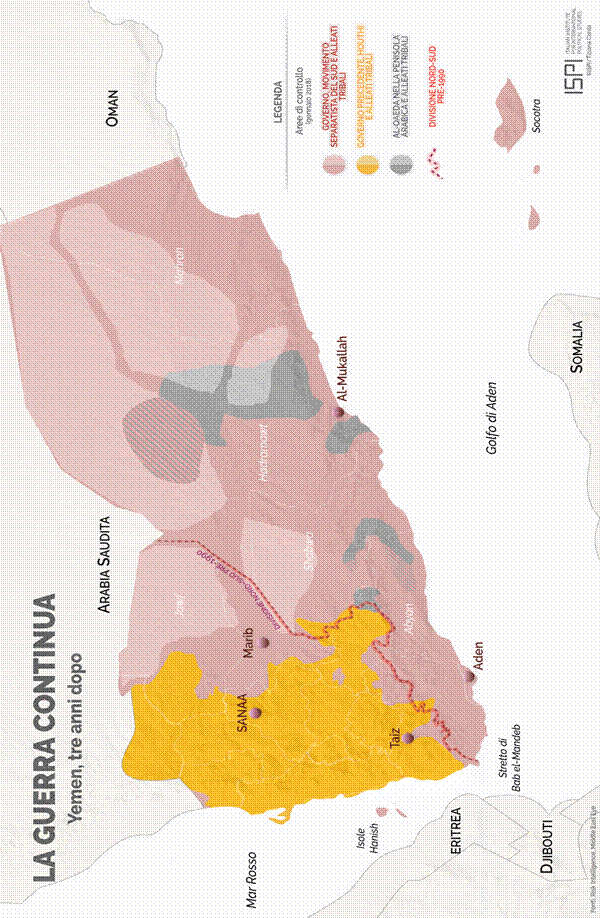

Yury Fedotov (Federazione russa) occupa dal 2010 la carica di Vice Segretario generale delle Nazioni Unite e Direttore Esecutivo dell'Ufficio sulla Droga e il Crimine (UNODC), nonché Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite di Vienna.
E' inoltre membro del Consiglio direttivo delle Nazioni Unite, strumento di cooperazione e coordinamento tra tutte le agenzie dell'ONU, e presiede la Task Force sulla Criminalità Organizzata Transnazionale ed il Traffico di Droga.
In qualità di Direttore Esecutivo dell'UNODC, Fedotov si è fatto promotore della lotta al traffico di droga puntando alla messa a punto di iniziative regionali e fornendo assistenza tecnica, promuovendo al tempo stesso una strategia equilibrata per il controllo della droga, partendo da una riduzione della domanda. A tal fine ha invitato gli Stati membri a ratificare e attuare tutte le convenzioni delle Nazioni Unite su droga, criminalità e corruzione. Fedotov è fortemente impegnato anche nella promozione del Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tratta di essere umani, gestito dall'UNODC, nonché della Campagna "Blue Heart" contro la tratta di esseri umani.
Prima della sua nomina al vertice di UNODC, è stato Ambasciatore della Federazione russa a Londra per cinque anni e, dal 2002 al 2005, Vice Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, con delega per le organizzazioni internazionali.
Laureatosi presso l'Università Statale di Mosca per le Relazioni Internazionali (MGIMO), ha iniziato la carriera diplomatica nel 1972 come membro della delegazione dell’URSS presso il Comitato per il Disarmo di Ginevra.
(A cura del Servizio Affari internazionali del Senato)

Argentino, ricopre questa carica dal settembre 2014, quando è stato nominato dal Segretario Generale Ban Ki-moon.
Vanta più di 30 anni di esperienza nel sistema delle Nazioni Unite, maturata sia nei Quartieri generali che sul campo.
Dal 2009 al 2014, ha ricoperto l'incarico di Assistant Secretary-General per gli Affari Politici nel Dipartimeno Affari Politici (DPA).
Precedenti incarichi hanno riguardato, tra gli altri, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo UNDP ed il Programma di Assistenza al popolo palestinese in Cisgiordania e Gaza.
Nato nel 1957, si è laureto in Economia alla Cornell Univeristy ed in Pianificazione economica urbano-regionale presso il Massachussetts Insitute of Tecnology.
(A cura del Servizio Affari internazionali del Senato)

Konstantin Iosifovich Kosachev è Presidente della Commissione Affari Esteri del Consiglio della Federazione dell'Assemblea Federale della Federazione Russa.
Nato il 17 settembre 1962, è stato eletto senatore nel 2015 per la regione di Chuvashia (con mandato in scadenza nel settembre 2022).
Nel 1984 si è laureato presso l'Istituto statale per le relazioni internazionali del Ministero degli Affari esteri di Mosca
È stato insignito dell'Ordine dell'Amicizia nel 2003, dell'Ordine al merito per la patria, quarto grado, nel 2006 e dell'Ordine d'onore nel 2012.
(A cura del Servizio Affari internazionali del Senato)

Diplomatico francese, ricopre questa carica (la terza più alta delle Nazioni Unite) dal febbraio 2017 quando è stato nominato dal Segretario Generale Guterres.
Vanta 25 anni di esperienza diplomatica, prevalentemente nel campo delle organizzazioni internazionali e delle Nazioni Unite.
Dal 2014 al 2017 presso il Ministero degli Esteri francese ha ricoperto la carica di Direttore delle Nazioni Unite.
Precedentemente ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Ambasciatore di Francia presso la Svizzera, Capo del Cerimoniale di Francia, Vice-Rappresentante permanente della missione permanente di Francia presso le Nazioni Unite a New York.
Nato nel 1960, si è laureato presso l'Istituto di Scienze economiche e commerciali (ESSEC), Science Po Paris e la Scuola Nazionale di Amministrazione (ENA).
(A cura del Servizio Affari internazionali del Senato)

Il 10 luglio 2013, il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, dopo aver consultato gli Stati membri, ha annunciato la nomina di Phumzile Mlambo-Ngcuka del Sudafrica come direttore esecutivo dell'entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN- Donne). Mlambo-Ngcuka ha sostituito Michelle Bachelet.
Mlambo-Ngcuka vanta una vasta esperienza nella difesa delle questioni di genere e combina capacità di leadership strategica, di costruzione del consenso e di esperienza gestionale pratica.
È stata la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente del Sudafrica dal 2005 al 2008. È stata membro del parlamento sudafricano dal 1994, Vice Ministro del commercio e dell'industria (1996-1999), Ministro dei Minerali e dell'Energia (1999-2005) e Ministro delle arti, della cultura, della scienza e della tecnologia nel 2004.
Coordinatrice dell'Associazione Cristiana Mondiale delle Giovani Donne a Ginevra dal 1984 al 1986, è stata la prima Presidente dell'Organizzazione delle Donne Natal, affiliata del Fronte Democratico Unito, sin dalla sua costituzione nel dicembre 1983.
La signora Mlambo-Ngcuka ha istituito la Fondazione Umlambo nel 2008 per fornire supporto alle scuole in aree povere in Sud Africa attraverso il tutoraggio e il coaching per insegnanti e in Malawi attraverso il miglioramento della scuola con i partner locali.
Mlambo-Ngcuka ha conseguito un Master of Philosophy in pedagogia e politica dell'educazione presso l'Università di Cape Town (2003) e una laurea in Educazione presso l'Università del Lesotho (1980). Nel 2003, ha ricevuto una laurea honoris causa dall'università di Western Cape.
Nata nel 1955, la signora Mlambo-Ngcuka è sposata ed ha tre figli.
(A cura del Servizio Affari internazionali del Senato)

Il 12 aprile 2017, il segretario generale António Guterres ha nominato Pramila Patten della Repubblica di Mauritius alla carica di suo rappresentante speciale sulla violenza sessuale nei conflitti, carica di livello pari a quello di sottosegretario generale.
Patten, avvocato professionista, ha lavorato dal 2003 come membro del comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Apporta solide e diversificate competenze giudiziarie in materia di violenza sessuale e di genere. Dal 2014 è membro del Gruppo consultivo ad alto livello per lo studio globale sull'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1325 (2000) su donne, pace e sicurezza e, dal 2010, è membro del Comitato consultivo dell'Osservatorio sui diritti delle donne africane, in seno alla Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite.
Tra il 2012 e il 2014, Patten è stata membro del comitato consultivo del progetto Due Diligence Framework, in precedenza ha prestato servizio come consulente nel Ministero per i diritti delle donne, lo sviluppo del bambino e il benessere familiare del suo paese dal 2000 al 2004; è stata membro di International Women's Rights Action Watch dal 1993 al 2002; e commissario nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la Commissione internazionale d'inchiesta sul massacro in Guinea Conakry, nel 2009. È stata docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Mauritius tra il 1987 e il 1992, prestando servizio anche come Magistrato del tribunale distrettuale dal 1987 al 1988.
Nata nel 1958, Patten ha conseguito un master in giurisprudenza presso l'University College di Londra e una laurea in legge presso l'Ealing College of Higher Education nel Regno Unito.
(A cura del Servizio Affari internazionali del Senato)

Il 13 aprile 2017, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha annunciato la nomina di Vera Songwe del Camerun come prossima segretaria esecutiva della Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (ECA).
Prima della sua nomina, Songwe era direttrice regionale della Società finanziaria internazionale ove si occupava dell'Africa occidentale e centrale dal 2015, ed era membro anziano non residente al Brookings Institute nell'unità di Sviluppo Mondiale e iniziativa per la crescita dell'Africa dal 2011. È stata precedentemente direttrice nazionale della Banca Mondiale per il Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea-Bissau e Mauritania tra il 2012 e il 2015. Prima di ciò, Songwe ricopriva la carica di consigliere dell'amministratore delegato della Banca Mondiale per le regioni Africa, Europa e Asia centrale e le regioni dell'Asia meridionale dal 2008 al 2011, e di coordinatrice del settore del Paese Guida e economista esperta per le Filippine dal 2005 al 2008.
Nata nel 1968, Viviane Songwe ha conseguito un dottorato in economia matematica presso il Centro di ricerca operativa ed econometria, un Master in Diritto ed Economia e un Diplôme d'Etudes Approfondies in Scienze economiche e politiche all' Université Catholique de Louvain, in Belgio, e un Corso di laurea in Economia e Scienze politiche all'Università del Michigan, negli Stati Uniti. Si è anche laureata al College Nostra Signora di Lourdes in Camerun.
(A cura del Servizio Affari internazionali del Senato)

Ibrahim Thiaw (Mauritania) è stato nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il 21 marzo 2018, suo Special Adviser per il Sahel. Egli supporterà. Mohamed Ibn Chambas, Rappresentante speciale del Segretario generale e Capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel, negli sforzi in corso per la ricalibratura della strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel ed il Piano di Sostegno al Sahel.
Dall’agosto 2013 al 20 aprile 2018 Ibrahim Thiaw ha ricoperto la carica di Segretario generale aggiunto e vicedirettore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), svolgendo un ruolo fondamentale nel fornire leadership e plasmare la visione strategica e la direzione dell'organizzazione.
In precedenza Thiaw era stato Direttore della Divisione ambientale dell’ONU incaricata dell’implementazione delle politiche ambientali, dove è stato responsabile delle attività in due delle principali aree tematiche: gestione dell'ecosistema e conflitti e disastri.
Prima di fare ingresso nell’ambito delle Nazioni Unite nel 2007, Ibrahim Thiaw ha lavorato come direttore regionale dell'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura, associazione che dal 1999 ha lo status di osservatore presso l’Assemblea Generale ONU) per l'Africa occidentale e successivamente come direttore generale facente funzione dell'IUCN.
Thiaw, che ha conseguito una laurea specialistica in tecniche di prodotto forestali e forestali, ha pertanto una protratta e consolidata esperienza nei settori dello sviluppo sostenibile, della governance ambientale e della gestione delle risorse naturali a livello nazionale, regionale e internazionale.
(A cura del Servizio Studi della Camera)
[1] Si ricorda che nel 2017 hanno perso la vita 59 peacekeepers, un dato in crescita rispetto all'anno precedente in cui le perdite ammontavano a 34.
[2] L' High-level Independent Panel on Peace Operations (HIPPO) venne istituito dal precedente Segretario Generale Ban ki-moon nell'ottobre 2014 all'approssimarsi del 15° anniversario dal Rapporto Brahimi (v. box, infra) per verificare quale visione condivisa potesse elaborare l'ONU del peacekeeping per rispondere all'evoluzione delle aspettative al riguardo. Il Panel esaminò sia le operazioni di peacekeeping sia le missioni politiche speciali, riunendole sotto la denominazione di "operazioni di pace delle Nazioni Unite".
[3] Il Segretario Generale ha incaricato nel novembre 2017 il Generale brasiliano in congedo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, di studiare le cause dell'incremento di vittime tra i peacekeepers e di individuare raccomandazioni pratiche per accrescere la sicurezza dei peacekeepers Il rapporto intitolato Improving security of United Nations peacekeepers è stato pubblicato nel dicembre 2017. Il DPKO (Dipartimento per le operazioni di pace) e il DFS (Dipartimento per il supporto sul terreno) hanno tradotto le indicazioni del rapporto in un Piano di azione che affianca alle azioni immediate sul campo un impegno politico da parte degli Stati Membri.
[4] UN Assistance mission for Iraq.
[5] UN Assistance mission in Afghanistan.
[6] La questione trae origine da esigenze ormai più che decennali: infatti il 26 ottobre 2004 l’allora Ministro per i beni e attività culturali Giuliano Urbani firmava a Parigi una dichiarazione congiunta con il direttore generale dell’UNESCO, Koichiro Matsuura, dedicata alla mutua cooperazione per una risposta di emergenza volta alla messa in atto, in scacchieri internazionali di crisi, di interventi di salvaguardia e recupero dei beni culturali e naturali a rischio di conflitti o di calamità naturali.
La dichiarazione congiunta traeva origine dalla vasta esperienza che l’Italia aveva sviluppato nelle tecniche per il recupero del patrimonio culturale e storico danneggiato in seguito a conflitti o calamità naturali quali i terremoti, purtroppo frequenti nel nostro Paese.
Tra le più significative esperienze internazionali dell’Italia nella materia già allora si annoveravano gli interventi di archeologi e di carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale per la ricostruzione del patrimonio culturale iracheno sottoposto a distruzioni e saccheggi dopo la caduta di Saddam Hussein; come anche i restauri operati nella città iraniana di Bam devastata da un terremoto.
L’Italia era pertanto incaricata di dar vita all’asse portante di una forza di intervento capace di operare rapidamente in tutto il mondo. Per quanto concerne il nostro Paese, l’ossatura della task force era prevista con personale proveniente dal Ministero degli esteri, da quello dei beni e attività culturali, dalla Protezione civile e dai Carabinieri. Il gruppo d’azione di emergenza capitanato dall’Italia, si prevedeva, avrebbe avuto un assetto variabile in rapporto alle specifiche esigenze di volta in volta manifestate, e avrebbe agito su richiesta dei paesi bisognosi di intervento.
[7] Si veda l’Annex I (Action Plan for the Implementation of the Strategy for the Reinforcement of UNESCO’s Actions for the Protection of Culture and the Promotion of Cultural Pluralism in the Event of Armed Conflict and for the Protection of Culture in Emergency Situations related to Natural Disasters) in Report on the Implementation of the Strategy for the Reinforcement of UNESCO’s Action for the Protection of Culture and the Promotion of Cultural Pluralism in the Event of Armed Conflict, 201 EX/5 Part I(E), 24 marzo 2017, http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=247706.
[8] Evento organizzato da Non c'è pace senza giustizia e Avsi: From vulnerable to protagonist: empowering of women against human rights denial committed “for her own good”; martedì 25 settembre, Conference room n. 11, ore 13.15-14.30.
[9] Obiettivo 5 (https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/):
La disuguaglianza di genere è uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla riduzione della povertà. Grazie all’ OSM 3 sulla parità di genere e l'empowerment delle donne, i progressi nella possibilità alle bambine di iscriversi a scuola e l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro, sono stati stato considerevoli. L’OSM 3 ha dato alla questione della parità di genere grande visibilità, ma sono ancora sensibili questioni importanti come la violenza contro le donne, le disparità economiche e la bassa partecipazione delle donne al processo decisionale politico.
Il Goal 5 sostiene le pari opportunità tra uomini e donne nella vita economica, l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, l'eliminazione dei matrimoni precoci e forzati, e la parità di partecipazione a tutti i livelli.
Obiettivo 5. Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze
5.1: Terminare tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne e le ragazze in tutto il mondo
5.2: eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nelle sfere pubbliche e private, incluso il traffico e sessuale e altri tipi di sfruttamento
5.3: Eliminare tutte le pratiche dannose, come il matrimonio precoce e forzato e le mutilazioni genitali femminili
5.4: riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito attraverso la fornitura di servizi pubblici, le politiche infrastrutturali e di protezione sociale e la promozione della responsabilità condivisa all'interno della famiglia e a livello nazionale
5.5: Garantire al genere femminile piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità per la leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica
5.6: Garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi, come concordato in base al programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e la Piattaforma d'azione di Pechino ei documenti finali delle conferenze di revisione
5.a: intraprendere riforme per dare alle donne pari diritti alle risorse economiche, così come l'accesso alla proprietà e controllo del territorio e altre forme di proprietà, servizi finanziari, l'eredità e le risorse naturali, in accordo con le leggi nazionali
5.b: Migliorare l'uso della tecnologia, in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'empowerment delle donne
5.c: adottare e rafforzare le politiche e la normativa applicabile per la promozione della parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze a tutti i livelli.
[10] Obiettivo 16 (https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/):
E’ evidente che senza una comunità pacifica e inclusiva e una governance efficace, lo sviluppo non può essere sostenibile. Ad esempio, i paesi colpiti da conflitti sono i più lontani dal raggiungimento degli SDG, mentre in molti altri paesi il ristabilimento delle istituzioni di pace e responsabili ha contribuito notevolmente al raggiungimento degli SDG.
L’Obiettivo 16 entro il 2030 mira pertanto a promuovere società pacifiche e inclusive. Come tale, essa sostiene di ridurre ogni forma di violenza, comprese la tortura e la lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata. Inoltre, obiettivo 16 prevede di ridurre in modo significativo corruzione e concussione, così come flussi finanziari illeciti e di armi. Per garantire che le società siano pacifiche e inclusive, L’Obiettivo 16 ha anche lo scopo di promuovere le istituzioni inclusive e lo stato di diritto, e di garantire la parità di accesso alla giustizia.
Obiettivo 16: promuovere società pacifiche e inclusivi per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
16.1: ridurre in modo significativo tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità
16.2: eliminare l'abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le forme di violenza e torture verso i bambini
16.3: promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e di garantire parità di accesso alla giustizia per tutti
16.4: Entro il 2030, di ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti e di armi, rafforzare il ritorno dei beni rubati e combattere ogni forma di criminalità organizzata
16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le loro forme
16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
16.7: Assicurare un reattivo, inclusiva, partecipativo e rappresentativo processo decisionale a tutti i livelli
16.8: ampliare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni della governance globale
16.9: Entro il 2030, garantire per tutti un’identità legale e la registrazione delle nascite
16.10: Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali, in conformità della legislazione nazionale e degli accordi internazionali
16.a: Rafforzare la capacità delle istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, di prevenire la violenza e di combattere il terrorismo e la criminalità
16.B: Promuovere e far rispettare le leggi e le politiche non discriminatorie per uno sviluppo sostenibile.
[11] Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, Decision on abolition of the death penalty, 1298° incontro,
CM/Del/Dec(2017)1298/4.1, 25 ottobre 2017, par.8
[12] Focus Mediterraneo allargato, n. 4, luglio 2017, a cura dell'ISPI, in Osservatorio di Politica Internazionale.
[13] L'assemblea costituente libica ha presentato a fine luglio 2017 la bozza finale di Costituzione che dovrebbe essere sottoposta a referendum.
[14] Il testo del Memorandum è disponibile al seguente link http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf.
[15] Numerosi osservatori hanno evidenziato come la principale difficoltà di attuazione del piano riguarda la capacità del governo di al-Sarraj di garantire un controllo del territorio così esteso e capillare al di fuori della capitale.
[16] Maritime Rescue Coordination Centre.
[17] L'Action Plan dell'UE si basa su 5 fondamentali aree d'azione: 1) salvataggio delle vite umane (miglior coordinamento e Codice di condotta per tutti i soggetti coinvolti nelle attività SAR); formazione della Guardia Costiera libica, istituzione degli MRCC in Libia, Egitto e Tunisia); 2) lotta ai trafficanti in Libia; 3) cooperazione con i paesi partner (conclusione di accordi di riammissione con i paesi di origine e di transito; utilizzo di leve positive e negative, come la politica dei visti, per incoraggiare tale cooperazione; 4) accelerazione dei rimpatri; 5) solidarietà europea: relocation e accordo sulla necessità di riformare il sistema europeo di asilo. Dal canto suo, l'Italia si è impegnata a redigere il Codice di condotta per le ONG che conducono attività SAR; migliorare le procedure di relocation; aumentare le proprie capacità di accoglienza e trattenimento; accelerare i rimpatri.
[18] L'operazione Triton di FRONTEX a partire dal 1° febbraio 2018 è stata sostituita dalla operazione Themis: tra le principali novità vi è che i migranti soccorsi dovranno essere fatti sbarcare nel porto più vicino al punto in cui è stato effettuato il salvataggio in mare - e non più automaticamente nei porti italiani.
[19] Proposta emersa nel documento conclusivo, approvato all'unanimità, dell'Indagine conoscitiva sul "Contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative" condotta dalla Commissione difesa del Senato.
[20] Missione deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2017, autorizzata a seguito delle risoluzioni delle Camere in data 2 agosto 2017; successivamente ne è stata autorizzata la proroga con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 e l'approvazione degli atti di indirizzo rispettivamente del Senato della Repubblica del 15 gennaio 2018 e della Camera del 17 gennaio 2018.
[21] Autorizzata per la prima volta dal D.L. n. 7/2015.
[22] Ex leader di Alba Libica, raggruppamento di milizie islamiste che già in passato ha provato a prendere la capitale. La Settima Brigata sarebbe vicina al ex premier tripolino Khalifa al Gwell.
[23] Cfr. Aliboni, Roberto, Libia: l'Italia cerchi consenso europeo, non canea anti-francese, AffarInternazionali, 4 settembre 2018; Libia, crisi cronica, Focus Ispi 4 settembre 2018, Marinone, Lorenzo, Le possibili conseguenze politiche dei recenti scontri a Tripoli, CeSI, 5 settembre 2018.
[24] Cfr. Wolfram Lacher e Alaa al-Idrissi, Capital of Militias, Tripoli's Armed Groups Capture the Libyan State, report pubblicato da Small Arms Survey, giugno 2018; nonché Wolfram Lacher in WSP Report, aprile 2018.
[25] Cfr. Libia, crisi cronica, Focus Ispi 4 settembre 2018
[27] Su iniziativa del Presidente Macron si è tenuta una conferenza a Parigi il 29 maggio 2018 con la partecipazione di al-Sarraj, Haftar, Saleh (Presidente della Camera dei Rappresentanti) e Meshri (Presidente del Consiglio di Stato), al termine della quale la dichiarazione congiunta in 8 punti non è stata sottoscritta bensì adottata come dichiarazione di principi. In essa, le parti si impegnano a predisporre le previsioni costituzionali sulle elezioni e la legge elettorale entro il 18 settembre 2018 e a tenere le elezioni il 10 dicembre 2018.
[28] M. Zappia (intervista di P. Mastrolilli), In Libia non ci sono le condizioni di sicurezza. Le lezioni di dicembre devono essere rinviate, in La Stampa, 2 settembre 2018.
[29] Aliboni, ibidem
[30] Marinone, ibidem.
[31] F. Semprini, Schiaffo a Parigi, l'ONU boccia il voto in Libia, in La Stampa, 14 settembre 2018.
[32] Lo sciismo di rito zaidita praticato dagli sciiti dello Yemen (il 35-40% circa della popolazione) si differenzia, nella dottrina teologica e nella prassi del costume, dallo sciismo duodecimano professato in Iran. Ovviamente, sciiti yemeniti e iraniani si distinguono anche per appartenenza etnica: i primi sono arabi, i secondi persiani. Il 55-60% circa della popolazione dello Yemen è invece sunnita: la maggior parte di essi segue la scuola di giurisprudenza (madhab; plur. madhahib) sciafeita, che sintetizza la tradizione della scuola malikita con l’uso della ragione proprio della scuola hanafita. Dagli anni Ottanta, l’Arabia Saudita ha cercato di promuovere in Yemen, per fini di influenza politica, la dottrina wahhabita praticata nel regno, un’emanazione della scuola hanbalita, la più conservatrice e dogmatica fra le scuole di giurisprudenza dell’Islam sunnita.
[33] United Nations Security Council, “Panel of Experts on Yemen”, 26 gennaio 2018, S/2018/68
[34] Bahrain, Kuwait, Egitto, Giordania, Marocco fanno altresì parte della coalizione, con ruoli molto più marginali rispetto a sauditi ed emiratini. Il Sudan ha inviato un contingente di soldati. Il Qatar è stato costretto a ritirarsi dopo la rottura diplomatica con Riyadh e Abu Dhabi. Dall’inizio dell’intervento, gli Stati Uniti appoggiano la coalizione militare araba, cooperando su intelligence e rifornimenti in volo. Inoltre, un numero imprecisato di consiglieri militari e forze speciali Usa è presente in Yemen per il contrasto ad al-Qaeda nella Penisola Arabica (Aqap), radicata nel sud.
[35] Sulle cause e sugli attori della guerra in Yemen, si veda E. Ardemagni, “Yemen: regionalizzazione di una crisi interna”, Note dell’Osservatorio di Politica Internazionale, n° 78, novembre 2017, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale; E. Ardemagni , Yemen senza pace, sauditi senza vittoria, ISPI Commentary, 12 marzo 2018.
[36] Si veda P. Salisbury, “Yemen: National Chaos, Local Order”, Chatham House, 20 dicembre 2017.
[37] J. Binnie, “Yemeni rebels enhance ballistic missile campaign”, IHS Jane’s Intelligence Review, 2017.
[38] United Nations Security Council, “Panel of Experts on Yemen” (2018)
[39] Ibid, p.2.
[40] Sulle operazioni di counter-terrorism degli Emirati Arabi in Yemen, si veda S. Al-Batati, “Anti-Al Qaida operation in Abyan ends”, Gulf News, 12 marzo 2018; M. Horton, “Can the UAE and its Security Forces Avoid a Wrong Turn in Yemen?”, CTC Sentinel, febbraio 2018, vol.1, n. 2.