Documento di economia e finanza 2020
Doc. LVII, n. 3
Aprile 2020
| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
| Titolo: | Documento di economia e finanza 2020 |
| Serie: | Documentazione di Finanza Pubblica Numero: 13 |
| Data: | 27/04/2020 |
| Organi della Camera: | V Bilancio, Assemblea |

Servizio Studi - Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario
Tel. 06 6706 2451 * studi1@senato.it - ![]() @SR_Studi
@SR_Studi
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706 5790 * sbilanciocu@senato.it - ![]() @SR_Bilancio
@SR_Bilancio

Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760 2233 * st_bilancio@camera.it - ![]() @CD_bilancio
@CD_bilancio
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760 2174 – 06 6760 9455 * bs_segreteria@camera.it
Documentazione di finanza pubblica n. 13
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Parte I – Il quadro macroeconomico
2.2. Le prospettive dell’economia italiana per il 2020 e il 2021........................... 19
Parte II – La finanza pubblica
? Tavole DEF e confronti con Nota tecnico-illustrativa 2020.............................. 32
1.2. Le previsioni tendenziali per il periodo 2020-2021........................................ 44
2.2. La valutazione delle deviazioni significative e della regola della spesa........ 73
4.1. Le Raccomandazioni specifiche per Paese................................................... 103
4.2. Relazione per paese relativa all'Italia 2020 della Commissione europea..... 105
3. Le risorse destinate alla coesione territoriale e i fondi nazionali addizionali...... 115
Il Documento di economia e finanza
Il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall’Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC).
Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell’UE, il cd. Semestre europeo.
Il Semestre europeo fornisce un quadro, temporalmente scandito, per la gestione delle varie tappe della strategia di coordinamento delle politiche economiche tra i paesi dell’UE. In sintesi, esso si articola nelle seguenti fasi:
§ novembre: presentazione da parte della Commissione dell’Analisi annuale della crescita, della Relazione sul meccanismo di allerta per la prevenzione degli squilibri macroeconomici. Il Consiglio europeo elabora le Linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;
§ febbraio: la Commissione pubblica le Relazioni per Paese integrate, per i paesi selezionati nella relazione sul meccanismo di allerta che presentano squilibri macroeconomici, dall'esame approfondito[1];
§ dalla metà alla fine di aprile: gli Stati membri presentano alla Commissione e al Consiglio i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia per la crescita e l’occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;
§ maggio: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;
§ giugno/luglio: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;
§ seconda metà dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. In base alla disciplina del regolamento (UE) n. 473/2013 (uno dei due atti che compongono il c.d. Two-pack), la Commissione europea opera, di norma entro il mese di novembre, una valutazione del documento programmatico di bilancio (DPB) di ciascun Stato membro.
Il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma vanno inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea.
Secondo quanto dispone l’articolo 7 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il DEF deve essere presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l’invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile[2], del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).
A causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al diffondersi dell’epidemia da Covid-19, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020 del 6 aprile 2020[3].
In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) vengono rinviati a un momento successivo.
La struttura del DEF: la normativa vigente
La struttura del DEF è disciplinata dall’articolo 10 della legge di contabilità (legge .196 del 2009). Il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di allegati.
La prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.
La sezione espone gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l’indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosettori della PA, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. Ciò anche ai fini di dar conto del rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine (OMT), qualora si sia verificato uno scostamento dall’obiettivo medesimo. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.
La seconda sezione, “Analisi e tendenze della finanza pubblica” riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, al debito delle amministrazioni pubbliche ed al relativo costo medio, nonché all’ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.
La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale. In tale ambito sono indicati:
§ lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
§ gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
§ le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità;
§ i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.
Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la Relazione che illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, ai fini dell’autorizzazione parlamentare (a maggioranza assoluta) allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con tale Relazione il Governo richiede, in particolare, l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento per 55 miliardi di euro nell’anno 2020, per 24,85 miliardi di euro nel 2021 e per 32,75 miliardi nel 2022 (per l’analisi della Relazione si rinvia all’apposita sezione del presente Dossier).
Tale Relazione segue quella trasmessa dal Governo il 5 marzo 2020 (con la relativa integrazione dell’11 marzo 2020), che a seguito della approvazione parlamentare ha autorizzato uno scostamento di bilancio di 25 miliardi per il 2020 (utilizzati a copertura delle misure introdotte con il decreto-legge n.18/2020, cd. “Cura Italia”)
Si ricorda che a norma del Patto di stabilità e crescita (PSC), ciascuno Stato membro deve raggiungere e mantenere il proprio Obiettivo a medio termine per la finanza pubblica (OMT o MTO, medium term objective) oppure attuare un percorso di avvicinamento verso l’OMT stesso. L’OMT è definito in modo specifico per ciascun Paese sulla base del potenziale di crescita dell’economia, del livello del debito e delle passività implicite.[4] L’OMT è definito in termini strutturali: pertanto esso si calcola come il saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche corretto per l’impatto previsto del ciclo economico (saldo corretto per il ciclo) e al netto delle misure una tantum. Per l’Italia l’OMT è stato, fino a tutto il 2019, il pareggio di bilancio[5]. A seguito del recente aggiornamento, il nuovo OMT per l’Italia nel prossimo triennio 2020-2022 è il raggiungimento di un avanzo strutturale di 0,5% del PIL[6]. La revisione dell’OMT discende dalle mutate condizioni delle prospettive di crescita riviste al ribasso. Inoltre, il persistente elevato livello del debito e la dinamica demografica hanno determinato una rimodulazione dell’OMT in senso maggiormente restrittivo. L’impegno dell’Italia è pertanto quello di disegnare un percorso di finanza pubblica che assicuri nel medio termine l’avvicinamento all’OMT. Il nuovo percorso prevede che in ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il saldo strutturale di bilancio migliori rispetto all’anno precedente.
Quanto alla Relazione per l’autorizzazione allo scostamento di bilancio, l’articolo 6 della legge n.243/2012[7] prevede, in linea generale, che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico siano consentiti in caso di eventi eccezionali (comma 1). La disposizione considera eventi eccezionali “periodi di grave recessione economica” ed “eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese” (comma 2). In tali casi sono consentiti scostamenti temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all’obiettivo di medio termine (comma 3). Il comma 5, in particolare, prevede che il piano di rientro rispetto all’obiettivo di medio termine possa essere aggiornato (con le modalità di cui al comma 3) “al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali” ovvero qualora, in relazione all’andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
Infine, si segnala che la normativa vigente prevede che al DEF vengano allegati una serie di documenti, che nel DEF 2020 non risultano presenti. Si tratta di:
§ il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, previsto dall’articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità)
§ la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, previsto dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 88 del 2011;
§ la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto), di cui al comma 9 dell’articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità);
§ il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, previsto dall’articolo 10, comma 10, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità);
§ la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, previsto dall’articolo 2, comma 576, della legge n.244 del 2007;
§ la relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 (cd. spending review ministeriale), previsto dall’articolo 22-bis, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità);
§ il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, previsto dall'articolo 10, comma 10-bis, della legge 196/2009;
§ il documento "Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia", predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Parte I – Il quadro macroeconomico
Il DEF 2020, nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità, evidenzia come l’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19), che ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, ha determinato una battuta d’arresto della crescita globale, già indebolita nel corso degli ultimi due anni.
Il rallentamento dell’economia mondiale, iniziato nel 2018, è proseguito anche nel 2019 registrando il tasso di crescita più debole dell'ultimo decennio, 2,9 per cento, per effetto dell'acuirsi delle tensioni commerciali e della crescente incertezza a livello globale.
Le tensioni geopolitiche, le incertezze legate alla tempistica e alle modalità dell’uscita del Regno Unito dall’UE, il permanere di situazioni socio-economiche complesse in alcuni paesi emergenti, unitamente ai fattori ambientali, hanno ulteriormente eroso il contesto internazionale. L'incertezza complessiva si è anche tradotta in una diminuzione degli investimenti esteri globali (-1,0 per cento rispetto al 2018) che ha interessato in misura differente le diverse aree geoeconomiche.
Negli Stati Uniti, l’economia nel 2019 ha perso slancio, registrando un tasso di crescita del 2,3 per cento (rispetto al 2,9 del 2018), dovuto al debole andamento degli investimenti e dei consumi privati, influenzati negativamente dall’incertezza derivante dalle tensioni commerciali e dai maggiori costi delle produzioni interne per effetto dei dazi sui beni importati, cui si è affiancata la decelerazione della domanda estera.
In Cina, il 2019 si è chiuso con una crescita del PIL del 6,2 per cento, la più bassa dell’ultimo trentennio, in rallentamento di 6 punti percentuali rispetto al 2018. L’applicazione dei nuovi dazi da parte degli Stati Uniti ha influito sugli scambi commerciali. Gli investimenti in infrastrutture hanno supportato l’attività produttiva che ha tuttavia registrato il ritmo di espansione più lento degli ultimi dieci anni (5,7%).
In Giappone, l’attività economica ha accelerato moderatamente (allo 0,7 per cento dallo 0,3 del 2018), supportata principalmente dai consumi pubblici e dagli investimenti fissi lordi. Tuttavia la performance della produzione manifatturiera è stata negativa (-2,4 per cento dal +1,1 dell’anno precedente) per la prima volta negli ultimi quattro anni, per effetto del rallentamento dell’economia globale e della minore domanda da parte della Cina.
Nel complesso, tuttavia, le prospettive per lo scenario internazionale apparivano, all’inizio del 2020, in graduale miglioramento, grazie all’attenuazione delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, negli ultimi mesi del 2019, in virtù della sospensione delle nuove tariffe previste per metà dicembre del 2019 e dell’annuncio dell’accordo Fase 1, sottoscritto nel gennaio di quest’anno (cfr. al riguardo il focus “Commercio mondiale, dispute commerciali tra Cina e USA e politica commerciale europea”, contenuto nella Sez. I, Programma di stabilità, Cap. II).
È su tale scenario che si è innestata la crisi determinata dal diffondersi dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid-19, che ha prodotto un crollo senza precedenti dell’attività produttiva a marzo (il DEF riporta l’indice PMI composito globale, sceso a quota 39,4 a marzo), determinato principalmente dalla profonda flessione del terziario (maggiormente colpito dalle misure di chiusura delle attività commerciali e dal distanziamento sociale della popolazione) e dalla contrazione dell’attività produttiva della manifattura. Il brusco peggioramento delle prospettive di crescita è stato rapidamente accompagnato da forti cali nei mercati finanziari e dei corsi petroliferi.
La contrazione dell’attività risulta più ampia nell’Eurozona - diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina - seguita dal Regno Unito e dal Giappone. L’accelerazione dell’infezione sul territorio statunitense fa prospettare un ulteriore sensibile peggioramento anche nel mese di aprile.
Figura 1 – Indice PMI globale composito e per Paese
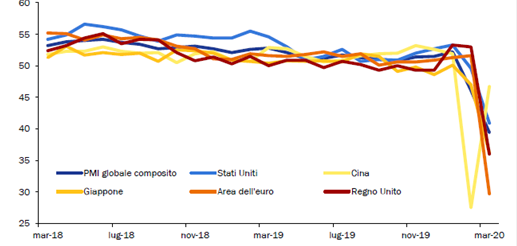
Fonte: Markit, Refinity
Fonte: DEF 2020, Sezione I: programma di Stabilità, Figura II.2
In un simile contesto, il DEF sottolinea l’elevata incertezza che rende assai difficile qualunque previsione anche nel breve periodo. Nel complesso le attese sono fortemente orientate al ribasso per l’anno in corso, assumendo un recupero per il 2021.
Secondo le stime più recenti, diffuse dal Fondo Monetario Internazionale ad aprile nel World Economic Outlook (WEO) – riportate nel DEF – a causa della pandemia l'economia globale dovrebbe contrarsi del 3% nel 2020, una contrazione peggiore di quella sperimentata durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Tali previsioni di crescita sono ridotte di oltre 6 punti percentuali rispetto alle proiezioni del WEO di ottobre 2019 e di gennaio 2020.
In tale scenario previsivo - che presuppone che la pandemia si interrompa nella seconda metà del 2020 e che gli sforzi di contenimento possano essere gradualmente assorbiti – l’FMI prospetta un rimbalzo dell'economia globale che porterebbe ad una crescita del 5,8 per cento nel 2021, man mano che l'attività economica si normalizza, aiutata dal sostegno politico.
In ogni caso, l’FMI sottolinea che, nonostante il recupero atteso per il 2021, anche con tassi di crescita superiori al previsto, il livello del PIL nel 2021 rimarrà comunque al di sotto del trend pre-virus.
I rischi per esiti ancora più gravi, tuttavia, sono sostanziali[8].
Le previsioni sul commercio internazionale sono ancora più pessimistiche, con una contrazione dell’11 per cento nel 2020, rivista al ribasso di quasi 14 punti percentuali rispetto alle proiezioni di gennaio. Nelle attese del FMI il commercio mondiale nel 2021 dovrebbe recuperare gran parte della contrazione di quest’anno, ma tale stima è estremamente incerta e dipende molto dall’ipotesi di regresso dell’epidemia nella seconda parte di quest’anno.
Tabella 1 - Prospettive dello scenario internazionale del FMI
(variazioni percentuali)
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Pil mondiale |
3,9 |
3,6 |
2,9 |
-3,0 |
5,8 |
| Commercio internazionale |
5,7 |
3,6 |
0,9 |
-11,0 |
8,4 |
| Prezzo del petrolio (Brent FOB dollari/Barile) |
54,4 |
71,1 |
64,0 |
36,9 |
39,5 |
Fonte: FMI, World Economic Outlook (aprile 2020), Database
Secondo quanto riportato nel World Economic Outlook (WEO) del FMI di aprile 2020, nel complesso, nel gruppo delle economie avanzate - in cui diversi Paesi stanno vivendo epidemie diffuse ed implementando misure di contenimento - la contrazione della crescita è prevista al –6,1 per cento nel 2020. Si prevede che la maggior parte delle economie quest'anno si contrarranno, compresi gli Stati Uniti (-5,9 per cento), il Giappone (–5,2 per cento), il Regno Unito (–6,5 per cento), la Germania (–7,0 per cento), la Francia (–7,2 per cento), l’Italia (–9,1 per cento) e la Spagna (–8,0 per cento). I blocchi e le restrizioni alla mobilità stanno pesando fortemente sull'attività economica, ed è probabile che gli effetti negativi sulla fiducia pesino ulteriormente sulle prospettive economiche.
Anche l’economia dei mercati emergenti è prevista contrarsi del -1,0 per cento nel 2020. Se si esclude la Cina, le proiezioni di crescita si riducono ulteriormente a -2,2 per cento. Secondo le stime del FMI, l'Asia emergente sembrerebbe essere l'unica regione con un tasso di crescita positivo nel 2020, sebbene più di 5 punti percentuali al di sotto della media del decennio precedente. In particolare, la Cina, dopo la forte contrazione dell'attività economica nel primo trimestre dell’anno (valutata nell’ordine di circa l'8% su base annua), è prevista crescere di un debole 1,2 per cento nel 2020, considerando un netto rimbalzo nel resto dell'anno e un notevole sostegno fiscale. Anche l'India è prevista crescere ad un tasso modesto nel 2020 (1,9 per cento). Altre economie emergenti subiranno gravi rallentamenti o contrazioni dell'attività economica, tra cui l'America Latina (–5,2 per cento), con le previsioni di crescita del Brasile al –5,3 per cento e del Messico al -6,6 per cento.
Per quel che concerne l’Area dell’euro, il DEF evidenzia la perdita di slancio dell’economia dell’Area anche prima dell'epidemia di COVID-19.
Il DEF sottolinea i segnali di marcato rallentamento del ciclo economico dell’eurozona nel corso del 2019, con una crescita del PIL che si è fermata all’1,2 per cento rispetto all’1,9 per cento del 2018. Al rallentamento ha contribuito, principalmente, il deterioramento della domanda estera, innescato dal venir meno della spinta propulsiva del commercio estero, nonchè il peggioramento del settore manifatturiero.
Ne sono risultati maggiormente interessati Paesi, quali la Germania e la Francia, le cui economie presentano un tessuto manifatturiero più orientato alle esportazioni, che hanno maggiormente subito gli effetti connessi alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e l’incertezza legata alla Brexit[9].
Per l’Eurozona – che è diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina – si prospetta per il 2020 una contrazione dell’attività economica particolarmente ampia. Le recenti previsioni del FMI, pubblicate nel WEO di aprile 2020 pongono la contrazione del PIL dell’Area dell’Euro a -7,5 per cento nel 2020, ipotizzando una ripresa al 4,7 per cento nel 2021.
Anche gli investimenti diretti esteri (IDE) saranno influenzati dall’evoluzione dell’epidemia. Il DEF riporta le recenti valutazioni dell’UNCTAD[10], secondo le quali gli IDE si ridurrebbero su scala globale in un intervallo dal 5 al 10 per cento nelle ipotesi che l’epidemia si stabilizzi nella prima parte del 2020 oppure che prosegua nella seconda parte dell’anno con effetti negativi soprattutto nel comparto dell’auto, dell’aviazione civile e dell’energia.
Per quanto concerne i rischi per la previsione, il DEF mette l’accento su un ulteriore fattore che si aggiunge al complesso contesto globale, ed è la crisi del settore petrolifero.
La riduzione della domanda globale ed il crollo del prezzo del petrolio potrebbero determinare un shock i cui effetti sull’economia globale potrebbero permanere più al lungo rispetto a quelli della epidemia. In particolare, le economie emergenti vedrebbero ridursi le entrate derivanti dalle esportazioni di materie prime, oltre ad effetti sui movimenti di capitale e a pressioni sul tasso di cambio.
Secondo l'ultimo rapporto dell'IEA (International Energy Agency), nel primo trimestre del 2020 la domanda mondiale è già diminuita di 2.500.000 barili al giorno su base annua, per la prima volta in oltre dieci anni. La difficoltà a raggiungere un accordo per il contingentamento dei quantitativi di produzione all'interno dell'OPEC plus, ha determinato il crollo del prezzo del petrolio, sceso a 25,7 dollari al barile a fine marzo, dimezzandosi rispetto alle quotazioni di inizio mese (pari a circa 51 dollari al barile).
Ad inizio aprile si è concordato per un taglio della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno a partire dal 1° maggio fino al 30 giugno, seguita da una riduzione di 7,7 milioni di barili nella seconda metà dell’anno. L’accordo tuttavia non è riuscito a sostenere il mercato, con il prezzo del petrolio che è sceso poco al di sotto dei 20 dollari al barile a metà aprile.
In prospettiva, secondo le recenti valutazione dell’IEA, per gli effetti derivanti dall’epidemia la domanda globale di petrolio nel 2020 si ridurrebbe di 90.000 barili al giorno per la prima volta dal 2009. Considerando uno scenario più pessimistico rispetto a quello base, la domanda potrebbe contrarsi di 730.000 barili al giorno, mentre in quello più ottimistico si avrebbe un incremento di 480.000 barili al giorno.
Di fronte a questa difficile situazione, le principali economie mondiali hanno varato una serie di misure, sia di politica monetaria che di natura fiscale, per limitare le conseguenze economiche e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della domanda interna e mondiale, conseguenti alle misure di contenimento alla diffusione del virus e prevenire la possibilità di esiti peggiori.
Il DEF 2020 espone l’analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all’anno 2019 e le previsioni tendenziali per l’anno in corso e per il 2021, che riflettono i segnali di pieno impatto dello shock rappresentato dal COVID-19 sull’economia italiana.
In merito alle previsioni, il Governo segnala che, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea - che con le Linee Guida del 6 aprile 2020[11] ha ridotto i contenuti obbligatori richiesti per i Programmi di Stabilità – le previsioni presentate nel Programma di Stabilità di questa edizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) si limitano al biennio 2020-2021, anziché spingersi fino al 2023.
Con riferimento al 2019, il DEF evidenzia come l’economia italiana abbia perso slancio durante l’anno, registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,3 per cento nel 2019, in discesa rispetto allo 0,8 per cento registrato del 2018.
La modesta crescita congiunturale che si era registrata nei primi tre trimestri del 2019 (+0,1 per cento nel I trimestre, invariata nel II e +0,1 nel III) è diventata negativa nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento.
Secondo i dati forniti dall’ISTAT[12], nel IV trimestre 2019 il prodotto interno lordo ha registrato una variazione negativa dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, pur segnando una variazione positiva dello 0,1% in termini tendenziali, nei confronti del quarto trimestre del 2018. Tutti i principali aggregati della domanda interna hanno segnato riduzioni rispetto al III trimestre, -0,2% i consumi finali nazionali e -0,1% gli investimenti fissi lordi. La domanda estera ha tuttavia fornito un ampio contributo positivo, derivante dalla lieve crescita delle esportazioni (0,3%) a fronte di una marcata riduzione delle importazioni (+1,7%).
Il risultato risulta comunque lievemente superiore a quanto previsto a settembre 2019 nella Nota di aggiornamento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime di crescita del 2019 dallo 0,2 allo 0,1 per cento, alla luce del peggioramento del contesto economico internazionale.
Sebbene in rallentamento, la crescita dell’economia è comunque proseguita su un sentiero positivo per il quinto anno consecutivo, come evidenziato nel grafico che segue:
Figura 2 - Andamento del PIL in volume
Anni 2005-2019 Valori concatenati in milioni di euro (anno di riferimento 2015) e variazioni percentuali annuali

Fonte: ISTAT, Comunicato “PIL e indebitamento AP” (2 marzo 2020)
La flessione del PIL nel 2019, sottolinea il DEF, è dovuta principalmente ad una caduta degli indici di produzione nell’industria e nelle costruzioni, probabilmente accentuata da effetti di calendario. Anche il contributo alla crescita della domanda interna è stato negativo, soprattutto per la componente delle scorte. Le esportazioni nette, invece, hanno dato un contributo positivo alla crescita, principalmente per effetto della decisa frenata delle importazioni, connessa alla debolezza della domanda interna.
Secondo quanto esposto nel Comunicato Istat del 2 marzo 2020[13] - il marcato rallentamento dell’economia nel 2019 è derivato principalmente da un netto ridimensionamento del contributo positivo della domanda interna e in particolare della componente dei consumi privati.
In particolare, nel 2019 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti ha dimezzato la crescita, aumentando in volume dello 0,4% (+0,9 nel 2018). All’interno delle sue componenti, la crescita del consumo di beni (0,1 per cento) è stata sensibilmente inferiore a quella di servizi (0,9 per cento).
L’indebolimento dei consumi, sottolinea il DEF, si è registrato nonostante l’attivazione, a partire dal mese di maggio, del Reddito di Cittadinanza, nonché a fronte di una dinamica moderatamente positiva del mercato del lavoro e di favorevoli condizioni di accesso al credito. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è incrementata nel corso dell’anno, attestandosi all’8,2 per cento in media d’anno, in lieve aumento dall’8,1 dello scorso anno.
Relativamente all’andamento della domanda interna, il DEF sottolinea in particolare come le scorte hanno sottratto 0,6 punti alla crescita, un calo molte forte che non si registrava dal 2012, quando le scorte avevano sottratto 1,2 punti percentuali alla crescita.
Figura 3 – Spese per consumi finali delle famiglie sul territorio economico per tipo di prodotto
Anni 2005-2019 Variazioni percentuali annuali, valori concatenati (anno di riferimento 2015)
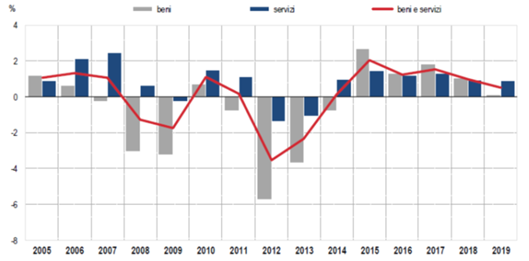
Fonte: ISTAT, Comunicato “PIL e indebitamento AP” (2 marzo 2020)-
Gli investimenti fissi lordi hanno rappresentato la componente più dinamica, seppure anch’essi in rallentamento, con un incremento dell’1,4% (+3,1 l’anno precedente). Negli investimenti si evidenzia, in particolare, il ridimensionamento della componente dei mezzi di trasporto, per i quali, in seguito alla forte contrazione dello scorso anno, dovuta al mercato dell’auto, si registra un +0,4 per cento rispetto al 2019 (rispetto a +8,4 del 2018 e +13,7 per cento del 2017). Molto modesto l’incremento degli investimenti in macchinari e attrezzature (+0,2 per cento), in forte decelerazione rispetto al 2018. Più lieve è stata, invece, la decelerazione di quelli in costruzioni, trainati, sottolinea il DEF, dalle abitazioni (in crescita del 3,2 per cento) mentre meno marcato è risultato l’incremento di quelli di natura infrastrutturale (2,0 per cento).
Il Comunicato ISTAT del 21 aprile 2020 sulla “Produzione delle costruzioni” rileva che a febbraio 2020 l’indice è stimato in diminuzione del 3,4% rispetto al mese precedente, un calo molto marcato dopo il considerevole aumento registrato il mese precedente (+7,9% su dicembre 2019). Nonostante il calo congiunturale l’indice destagionalizzato della produzione si mantiene su un livello elevato rispetto a quello medio dello scorso anno.
Riguardo al mercato immobiliare, il DEF sottolinea come nel IV trimestre del 2019 i prezzi delle abitazioni siano aumentati lievemente rispetto al corrispondente periodo del 2018 (+0,3%[14]). Tuttavia le rilevazioni più recenti confermerebbero segnali di rallentamento, a seguito della diffusione dell’epidemia. Nella media del 2019, i prezzi delle abitazioni esistenti sono scesi dello 0,4%, mentre quelli delle nuove abitazioni sono aumentati dell’1,1%.
L’andamento delle esportazioni ha segnato una decelerazione, dovuta all’incertezza derivante dalle tensioni commerciali internazionali; tuttavia, grazie al calo delle importazioni, legato alla debolezza della domanda interna, l’apporto della domanda estera netta al PIL è stato comunque positivo.
Per quel che riguarda i flussi con l’estero, i dati ISTAT indicano che le esportazioni di beni e servizi sono aumentate dell’1,2 per cento (in decelerazione rispetto ai dati del 2018, in cui si era registrato un incremento del 2,3 per cento) e le importazioni sono scese dello 0,4 (rispetto al +3,4% dello scorso anno).
Tabella 2 - Conto economico delle risorse e degli impieghi - anni 2017-2019
(variazioni percentuali)
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
| PIL |
1,7 |
0,8 |
0,3 |
| Importazioni |
6,1 |
3,4 |
-0,4 |
| Consumi finali nazionali |
1,2 |
0,7 |
0,2 |
| - spesa delle famiglie residenti |
1,5 |
0,9 |
0,4 |
| - spesa delle P.A. |
-0,1 |
0,1 |
-0,4 |
| - spesa delle I.S.P.* |
3,7 |
1,4 |
1,7 |
| Investimenti fissi lordi |
3,2 |
3,1 |
1,4 |
| - costruzioni |
1,5 |
2,8 |
2,6 |
| - macchinari, attrezzature |
4,7 |
2,9 |
0,2 |
| - mezzi di trasporto |
13,7 |
8,4 |
0,4 |
| Esportazioni |
5,4 |
2,3 |
1,2 |
* Istituzioni Sociali Private
Fonte: ISTAT, “PIL e indebitamento delle AP - Anni 2016-2019” (2 marzo 2020).
Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, il DEF sottolinea, in particolare, il calo dell’industria manifatturiera, che ha mostrato nel 2019 il primo segno negativo (-0,5 per cento) dopo sei anni di crescita (+2,1 per cento nel 2018, +3,6 per cento del 2017), e della produzione industriale, con una flessione dell’indice, nella media d’anno, a -1,4 per cento rispetto allo 0,6 per cento dell’anno precedente.
Dopo il recupero verificatosi a gennaio, l’indice ha mostrato una progressiva riduzione facendo registrare un brusco calo a dicembre (-2,7 per cento rispetto a novembre in termini destagionalizzati), con un calo in media d’anno della produzione indicato dall’Istat dell’1,3 per cento (Comunicato ISTAT, “Produzione industriale”, del 10 febbraio 2020). Il più recente Comunicato del 9 aprile 2020 rileva una ulteriore flessione nella produzione industriale sia su base congiunturale che in termini annui. In termini tendenziali, l’indice prosegue una lunga fase d contrazione che raggiuge il dodicesimo mese consecutivo.
Relativamente alle difficoltà registrate nella produzione, il DEF sottolinea peraltro come l’accentuarsi delle misure protezionistiche nel corso del 2019, che ha determinato una forte contrazione del commercio mondiale, abbia avuto ampie ricadute anche sull’andamento delle esportazioni italiane.
Commercio con l’estero
Dai dati Istat emerge nel 2019 una crescita dell’export del 2,3 per cento, in rallentamento rispetto ai due anni precedenti (3,6 per cento nel 2018 e 7,6 per cento nel 2017). La bilancia commerciale è in avanzo di 52,9 miliardi (in forte aumento dai 39 miliardi registrati nel 2018), un dato tra i più alti in Europa in rapporto al PIL dopo Germania, Paesi Bassi e Irlanda.
Il tasso di crescita delle esportazioni è più sostenuto verso i paesi extra europei, in particolare verso la Svizzera (+16,6 per cento) e gli Stati Uniti (+7,5 per cento), mentre è in flessione verso la Cina (-1 per cento), la Germania (-0,1 per cento) e la Spagna (-0,7 per cento). I settori trainanti sono gli articoli farmaceutici (+25,6 per cento), prodotti alimentari (+6,6 per cento), prodotti tessili e dell’abbigliamento (+6,2 per cento).
Prosegue la debolezza nel settore dei mezzi di trasporto che nel 2018 aveva rallentato dopo cinque anni di robusta espansione. Le vendite si riducono del 3 per cento, per effetto dell’ampia contrazione del comparto dell’auto (-8,0 per cento). La contrazione riguarda principalmente i mercati non europei (-10,3 per cento), in particolare gli Stati Uniti (-20,1 per cento), la Cina (-24 per cento) e la Turchia (-6 per cento). Rilevante la flessione all’interno dell’area dell’euro (-7,9 per cento), in particolare verso la Germania (-6,3 per cento) e la Spagna (-15,8 per cento).
Le prospettive per il 2020 apparivano più favorevoli in relazione all’impegno annunciato da Stati Uniti e Cina di sospensione dei dazi, previsti per la metà dello scorso dicembre, e alla firma dell’accordo Fase 1 avvenuta il 15 gennaio 2020. L’andamento del commercio estero italiano è, infatti, rimasto favorevole nei primi due mesi dell’anno. Tuttavia, l’emergere dell’epidemia di Covid-19 su scala globale avrà ripercussioni sugli scambi commerciali, come evidenzia l’indice PMI composito globale che a marzo ha registrato la flessione più ampia dal 2009.
Credito al settore privato: recenti andamenti in Italia
Il documento evidenzia l'andamento positivo dei prestiti alle famiglie nel 2019, determinato principalmente dai nuovi finanziamenti per l’acquisto di abitazioni, mentre è rimasta stabile la componente del credito al consumo. In particolare, il volume delle compravendite immobiliari è cresciuto del 5,5 per cento nei primi tre trimestri dello scorso anno rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre nell'ultimo trimestre l'aumento si è fermato allo 0,6 per cento.
I prestiti alle società non finanziarie sono invece diminuiti nel corso del 2019. Nel documento tale riduzione viene ricondotta a fattori legati a una flessione da parte della domanda (imprese) piuttosto che a dell'offerta (banche).
Prestiti bancari - tassi di variazione a 1 anno
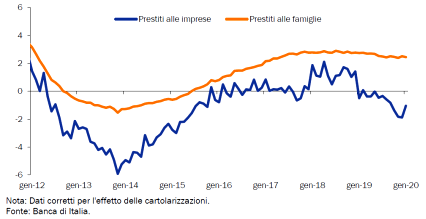
La flessione della domanda di credito dipenderebbe, in primo luogo, dal rallentamento degli investimenti: nel 2019 gli investimenti fissi lordi delle società non finanziarie sono cresciuti dell’1,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, quando erano aumentati del 4,9 per cento rispetto al 2017. Inoltre, secondo le indagini sul credito della Banca d’Italia, per sostenere tali investimenti le imprese hanno fatto maggior ricorso sia all’autofinanziamento che a canali di finanziamento alternativi al credito bancario.
Il ricorso all'autofinanziamento è stato determinato dal buon livello della redditività registrato nel 2018, oltre che da misure fiscali volte a favorire il reinvestimento degli utili in azienda.
Per quanto riguarda il ricorso a forme di finanziamento alternative al credito bancario, il documento evidenzia che, nei primi sette mesi del 2019, il volume dei collocamenti lordi sul mercato obbligazionario è aumentato del 25 per cento rispetto al quinquennio precedente. L'incremento ha riguardato principalmente le imprese caratterizzate da un minor grado di rischio, mentre quelle ritenute più rischiose hanno ridotto del 19 per cento la quota di emissioni. Inoltre, nel 2019, 35 società sono state ammesse per la prima volta alle negoziazioni da Borsa Italiana, portando il numero delle imprese quotate a 375 unità. Il numero totale di ammissioni a quotazione è stato il più elevato dal 2000.
Dal punto di vista dell'offerta, nel corso del 2019, il costo dei nuovi prestiti sarebbe rimasto relativamente stabile e su livelli molto prossimi ai minimi storici, anche per effetto degli interventi di politica monetaria adottati dalla BCE. I criteri di erogazione dei prestiti alle imprese sarebbero rimasti sostanzialmente invariati. Tale quadro sarebbe tuttavia il risultato di andamenti settoriali eterogenei, per cui, in base agli esiti delle intervistate realizzate in dicembre dall’Istat e dalla Banca d’Italia, le condizioni di accesso al credito sarebbero peggiorate rispetto alle imprese che offrono servizi e migliorate rispetto alle imprese manifatturiere.
Rispetto a tale ultimo dato, farebbero eccezione le aziende manifatturiere di piccola dimensione e quelle operanti nel comparto delle costruzioni, per le quali persiste una maggiore rischiosità connessa anche a una incidenza sui crediti deteriorati superiore alla media. In particolare, nelle costruzioni i crediti deteriorati rappresentano ancora il 23,2 per cento del totale dei prestiti, mentre i flussi di nuovi crediti deteriorati per micro, piccole e medie imprese rappresentano rispettivamente il 3,3, il 2 e l’1,8 per cento del totale.
Evoluzione delle sofferenze sul totale dei prestiti per settore
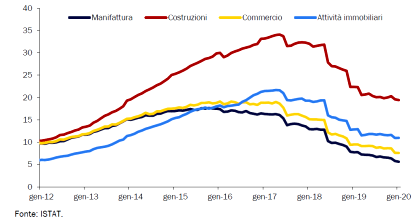
Nonostante il rallentamento dell’attività economica, nel 2019 il mercato del lavoro ha conservato un andamento favorevole: la crescita degli occupati, secondo il dato di contabilità nazionale, è stata dello 0,6 per cento (sospinta dall’occupazione dipendente mentre gli indipendenti hanno continuato a ridursi per l’ottavo anno consecutivo) e il tasso di disoccupazione si è ridotto di 0,6 punti percentuali rispetto al 2018, scendendo al 10 per cento. Sul mercato del lavoro, si rinvia al paragrafo 2.3.
Con riferimento, infine, all’evoluzione dei prezzi, nel 2019 l’inflazione si è dimezzata rispetto ai livelli dell’anno precedente (0,6 per cento rispetto all’1,2 per cento), comunque sospinta dalle componenti volatili; risulta infatti più contenuta e in lieve decelerazione la componente di fondo rispetto all’anno precedente (0,6 per cento dallo 0,7 per cento).
Quest’anno, si ricorda, la Commissione europea, in considerazione dell’elevata incertezza economica causata dalla diffusione del Covid-19 e delle urgenti incombenze che gli Stati membri stanno affrontando, ha adottato delle Linee guida[15] per ridurre i contenuti obbligatori richiesti per i Programmi di Stabilità.
Pertanto, l’orizzonte delle previsioni del presente Documento di Economia e Finanza 2020 viene presentato limitatamente al biennio 2020-2021 e con riferimento al solo andamento tendenziale.
Il Documento non presenta, dunque, il quadro programmatico, anche in considerazione del fatto che, coerentemente con l’orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione Europea, il Governo ha deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR).
Il nuovo quadro macroeconomico tendenziale 2020-2021 è stato validato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in data 16 aprile 2020.
Nel rispetto dei regolamenti europei[16], le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche presentate nel DEF sono sottoposte alla validazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), secondo quanto previsto dalla legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio del bilancio.
Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2020 riflette l’effetto dei drammatici eventi causati dalla pandemia di Covid-19 che, diffusasi su scala globale, ha interessato in misura più severa l’Italia nella seconda metà di febbraio.
Nel mese di marzo l’attività economica, che a inizio d’anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d’arresto del quarto trimestre del 2019, ha subìto una caduta senza precedenti.
In particolare, il DEF ricorda come, dopo la flessione registrata nel IV trimestre del 2019, i dati congiunturali dei primi due mesi dell’anno indicavano un moderato recupero dell’economia, soprattutto sul versante della produzione industriale, in particolare manifatturiera, e delle esportazioni. Secondo quanto riportato nel DEF, considerando anche la tendenza positiva della fiducia delle imprese dei servizi e del commercio, i dati disponibili a gennaio-febbraio consentivano di ipotizzare un ritmo di crescita dell’economia in graduale miglioramento nell’anno in corso, che avrebbe potuto portare ad una previsione di crescita del PIL reale nel 2020 prossima allo 0,6 per cento previsto nella NADEF dello scorso settembre.
I dati congiunturali diffusi dall’ISTAT relativi ai primi due mesi dell’anno in corso mostravano, sottolinea il DEF, timidi segnali di ripresa. A gennaio, l’indice destagionalizzato della produzione industriale registrava un forte rimbalzo (3,7% sul mese precedente), superiore alle aspettative (Comunicato Istat di marzo). Nonostante la flessione registrata a febbraio (-1,2%), nei primi mesi dell’anno la produzione ha fatto registrare una crescita dell’1,2 per cento in confronto al livello medio del quarto trimestre 2019 (Comunicato Istat di aprile). Particolarmente positiva era risultata la dinamica del settore delle costruzioni, con un buon recupero a inizio anno, arrivando a registrare un’espansione del 7,9% a gennaio sul mese precedente, favorita anche dalla particolare composizione del calendario dei giorni lavorativi (Comunicato Istat di marzo). Nonostante il calo registrato il successivo mese di febbraio (-3,4%), l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni si era mantenuto su un livello elevato rispetto a quello medio dello scorso anno (Comunicato Istat aprile).
Sul fronte dei consumatori, l’indagine ISTAT di gennaio segnalava un deciso miglioramento del clima di fiducia in tutte le sue componenti, facendo raggiungere all’indice complessivo il livello di 111,8. L’avanzamento della fiducia si era solo in parte ridimensionato nel mese successivo (111,4 il livello di febbraio), quando avevano iniziato a prospettarsi aspettative più deboli per la situazione futura. A febbraio, anche l’indice di fiducia delle imprese tornava a crescere, recuperando in parte il calo del mese precedente, rimanendo comunque al di sotto del valore 100.
Il repentino aumento dei contagi da COVID-19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente cambiato il quadro macroeconomico.
Le misure di contenimento e controllo dell’epidemia adottate a marzo hanno impattato in modo via via più marcato sull’attività economica, a causa della chiusura degli esercizi commerciali non essenziali e di molti stabilimenti, nonché delle misure di distanziamento sociale.
A riprova di un calo senza precedenti dell’attività economica, il DEF riporta il dato di Confindustria[17], che stima una caduta della produzione industriale in marzo del 16,6 per cento in confronto al mese precedente.
Le misure di contenimento hanno determinato uno shock congiunto di offerta e di domanda: al progressivo blocco di molte attività economiche sul territorio nazionale, necessario per arginare l’epidemia, che ha avuto un impatto molto forte soprattutto sul settore dei servizi, ed in particolare su quelli rientranti negli ambiti del trasporto del turismo e delle attività ricreative, del commercio al dettaglio, si è associato un inevitabile crollo della domanda di beni e servizi, sia dall’interno che dall’estero, vista la diffusione su scala globale dell’epidemia, soprattutto di alcune categorie di consumo, che potrebbe in parte continuare anche dopo il ripristino di condizioni di normalità a causa della diminuzione del reddito disponibile e di cambiamenti nei comportamenti dei consumatori.
Su questo ultimo punto, il DEF sottolinea che i volumi di spesa non effettuata in questa fase potrebbero non essere pienamente recuperabili in futuro (ad esempio, le attività turistiche perse durante la primavera 2020).
Tutte le indicazioni provenienti dalle ultime indagini congiunturali disponibili, tracciano un drastico calo dell’attività economica e un netto peggioramento del clima di fiducia di famiglie e operatori a partire dal mese di marzo, con un drastico peggioramento delle valutazioni sulla situazione corrente e delle aspettative per i mesi a venire Per le famiglie, la flessione dell’indice (a 101,0 punti rispetto ai 110,9 di febbraio) è stata maggiormente condizionata dal peggioramento delle valutazioni sul clima economico e sulle aspettative future. Per le imprese (il cui indice composito flette a 81,7 punti dai 97,8 di febbraio) si evidenzia un calo molto ampio della fiducia soprattutto nei servizi, nel commercio al dettaglio e nella manifattura, per i quali il fattore di maggiore vulnerabilità è rappresentato dalla caduta degli ordini (Comunicato Istat, 27 marzo 2020, dati rilevati tra il 2 ed il 13 marzo).
Figura 4 – Indici del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese italiane (IESI)
Gennaio 2011 – Marzo 2020 Indici destagionalizzati mensili e media mobile a 3 mesi (base 2010 = 100)
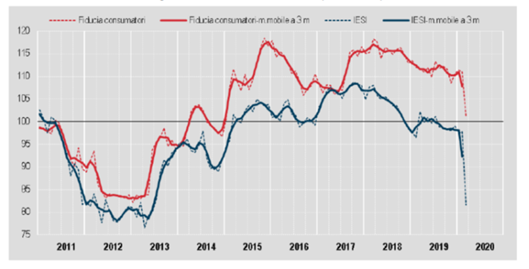
Fonte: Istat, Comunicato Istat “Fiducia dei consumatori e delle imprese, 27 marzo 2020
Analogo andamento evidenziano le rilevazioni degli indici PMI settoriali, riportate dal DEF. In particolare, l’indicatore del manifatturiero a marzo è crollato oltre le attese (a 40,3 punti dai 48,7 di febbraio), per effetto del netto peggioramento delle condizioni e del livello degli ordini. Il crollo degli ordinativi incide particolarmente sul settore dei servizi (il cui indice si attesta a 17,4 punti dai 52,1 di febbraio), superando ampiamente le aspettative di contrazione, e non risparmia neppure il settore delle costruzioni il cui indice settoriale perde quasi 35 punti (a 15,9 punti dai 50,5 di febbraio), con la flessione più acuta segnata dal comparto non residenziale. La fiducia delle imprese edili per quanto riguarda l’attività dei prossimi 12 mesi scende al livello del febbraio 2009, della crisi finanziaria globale.
Figura 5 - Clima di fiducia delle imprese per settore di attività economica
Gennaio 2011 – Marzo 2020 Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)

Fonte: Istat, Comunicato Istat “Fiducia dei consumatori e delle imprese, 27 marzo 2020
Nel quadro macroeconomico tendenziale, la caduta del PIL nel corso del mese di marzo è pertanto attesa molto accentuata ed un’ulteriore flessione si prevede anche per il mese di aprile, seguita da un miglioramento della situazione economica soltanto a partire dal mese di maggio.
Poiché – sottolinea il DEF - le misure precauzionali dovranno restare in vigore per un congruo periodo di tempo e la pandemia ha nel frattempo investito i principali Paesi partner commerciali dell’Italia, l’economia ne subirà gli effetti negativi per diversi mesi, dovendo probabilmente operare in regime di distanziamento sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni trimestri.
Nel complesso, in considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e delle difficili prospettive di breve termine, il DEF stima che l’economia registrerà una complessiva caduta del PIL reale nel 2020 di 8 punti percentuali in termini grezzi.
La contrazione del PIL nel 2020 viene spiegata – secondo quanto esposto nel DEF - per circa un terzo dalla caduta del commercio internazionale di beni e servizi e per la rimanente parte dalle politiche di distanziamento sociale e dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori a livello nazionale.
Ciò determina una marcata revisione dello scenario macroeconomico, in confronto sia a quello che si andava delineando a inizio anno, sia rispetto allo scenario prospettato a settembre nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF).
Nel DEF si prospetta, dunque, una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso, da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell’8 per cento.
Per il 2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento.
Tabella 3 - Confronto sulle previsioni di crescita del PIL
(variazioni percentuali)
|
|
Consuntivo |
NADEF |
DEF 2020 |
||
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
| PIL |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
-8,0 |
4,7 |
La nuova previsione sconta – si spiega nel DEF - una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e l’ipotesi di un successivo rimbalzo nella seconda metà dell’anno.
Il Governo sottolinea, infatti, che la previsione macroeconomica contenuta nel Documento è costruita in base all’ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio e l’impatto economico dell’epidemia si esaurisca completamente nel primo trimestre del 2021.
Nel sentiero ipotizzato, descritto nel DEF con cadenza mensile, il mese di marzo registrerebbe il più forte calo congiunturale, seguito da un’ulteriore contrazione in aprile tenuto conto della decisione di mantenere in vigore le misure di contrasto all’epidemia adottate nella seconda metà di marzo. A ciò seguirebbe un parziale recupero del PIL in maggio e giugno, consentito dal graduale rilassamento delle misure di controllo attualmente in vigore. La contrazione del PIL su base trimestrale sarebbe pari al -5,5 per cento nel primo trimestre e-10,5 per cento, nel secondo trimestre, più accentuata nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre, in ragione sia dell’evoluzione temporale della crisi epidemiologica e delle conseguenti misure di contenimento, sia del peso positivo, sul primo trimestre, dell’avvio ancora favorevole dell’anno. A queste fortissime cadute seguirebbe un rimbalzo del 9,6 per cento nel terzo trimestre e del 3,8 per cento nel quarto, in ragione delle misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del virus e proteggere le imprese e l’occupazione, che tuttavia lascerebbe il PIL dell’ultimo trimestre ad un livello inferiore del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.
Gli interventi adottati a sostegno dei redditi e dell’occupazione, già attuati alla data di chiusura della previsione, sono inclusi nello scenario a legislazione vigente. Le stime dei modelli econometrici (ITEM) sottostanti la previsione tendenziale attribuiscono agli interventi del decreto Cura Italia un impatto positivo sulla crescita di quasi 0,5 punti percentuali di PIL.
La crescita del PIL tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. Si tratta, comunque, di una previsione considerata dal DEF prudenziale, che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all’inizio del prossimo anno.
La previsione di crescita del 2021 implica – spiega il DEF - che nel quarto trimestre del 2021 il PIL sarà ancora inferiore di 3,2 punti percentuali al livello del quarto trimestre 2019, scontando, prudenzialmente, una bassa crescita congiunturale nel corso del 2021 e una persistente perdita di PIL, come già avvenuto a seguito delle profonde recessioni del 2008-2009 e del 2012-2013.
Il DEF sottolinea altresì che nella previsione tendenziale per il 2021 si sconta l’aumento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti previsto dalla normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2021, derivanti dalle c.d. clausole di salvaguardia[18].
Questo inasprimento delle aliquote provocherebbe un abbassamento della crescita del PIL reale rispetto ad uno scenario di invarianza delle imposte pari ad almeno 0,4 punti percentuali nel 2021 secondo le consuete stime ottenute con il modello ITEM, riportate nel DEF.
Nonostante il rimbalzo atteso dalla seconda metà dell’anno in corso, dunque, il DEF prevede tuttavia che il PIL non recupererà pienamente il livello di fine 2019 nel prossimo ano.
La tabella che segue riporta le previsioni tendenziali per gli anni 2020-2021 dei principali indicatori del quadro macroeconomico complessivo esposto nel DEF 2020, a raffronto con i dati di consuntivo del 2019.
Tabella 4 - Scenario macroeconomico tendenziale
(variazioni percentuali)
|
|
Consuntivo |
Previsioni tendenziali |
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
| PIL |
+0,3 |
-8,0 |
4,7 |
| Importazioni |
-0,4 |
-13,0 |
10,0 |
| spesa delle famiglie |
0,4 |
-7,2 |
4,0 |
| spesa delle P.A. |
-0,4 |
0,7 |
0,3 |
| Investimenti fissi lordi |
3,4 |
-12,3 |
4,3 |
| Esportazioni |
1,2 |
-14,4 |
13,5 |
|
|
|||
| Deflatore del PIL |
0,9 |
1,0 |
1,4 |
| Deflatore dei consumi privati |
0,5 |
-0,2 |
1,7 |
| Inflazione programmata* |
- |
-0,2 |
- |
|
|
|||
| PIL nominale (miliardi di euro) |
1.787,7 |
1.661,4 |
1.763,5 |
Fonte: DEF 2020, Sezione I: programma di Stabilità, Tavola II.2.a. Per il Pil nominale, Tavola I.2.
Come si evince dalla tabella, tutti gli indicatori macroeconomici manifestano nell’anno 2020 un forte calo rispetto al 2019.
In particolare, i consumi delle famiglie scenderebbero in misura lievemente inferiore al PIL (-7,2 per cento), per effetto sia delle misure di contenimento sociale ma anche per una riduzione del reddito disponibile. Essi manifestano un recupero contenuto a partire dal prossimo anno, posto che la previsione tendenziale sconta in ogni caso l’aggravio di pressione fiscale rappresentato dalle clausole IVA. Al contrario, i consumi pubblici sono attesi in moderato aumento nel 2020 e nel 2021, anche in conseguenza della risposta alla crisi.
Assai accentuato sarebbe il crollo degli investimenti (-12,3 per cento), maggiormente colpiti dalla sospensione delle attività produttive nonché dalle condizioni di elevata incertezza e dal crollo di aspettative e fiducia.
Le esportazioni sono previste in netto calo (-14,4 per cento) così come le importazioni. Il contributo della domanda estera netta, dopo la flessione nell’anno in corso, tornerà positivo nel 2021.
Il grafico seguente mostra l’andamento delle principali variabili del quadro macroeconomico, a partire dal 2008, sino alla fine del periodo di previsione indicato del DEF 2020.
Figura 6 - Conto economico delle risorse e degli impieghi – Previsioni tendenziali
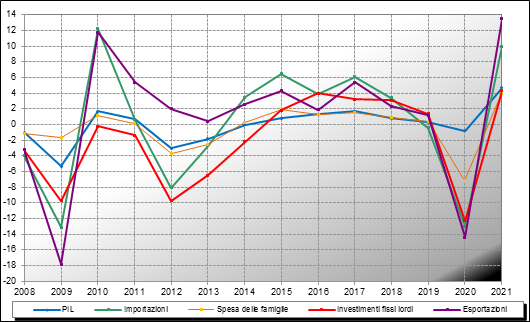 var. % a prezzi costanti
var. % a prezzi costanti
Quanto alla dinamica dei prezzi, la contrazione della domanda interna, unitamente al crollo del costo dei prodotti energetici, determina una flessione dello 0,2 per cento del deflatore dei consumi nel 2020. Il deflatore del PIL è stimato comunque pari all’1,0 per cento per effetto principalmente della marcata flessione di quello delle importazioni, anch’esso condizionato dal trend del prezzo del petrolio.
Atteso il contesto macroeconomico profondamente mutato rispetto allo scenario delineato nei documenti di programmazione dello scorso autunno, il DEF provvede inoltre ad aggiornare la stima dell’inflazione programmata per l’anno in corso, che è ora attesa pari al -0,2 per cento.
Rispetto allo scenario tendenziale descritto, i rischi della previsione si concentrano evidentemente sul possibile peggioramento della dinamica epidemica nell’anno in corso e su come questa possa eventualmente influenzare anche i risultati del prossimo anno. Il mantenimento, più a lungo termine, di misure di contenimento molto restrittive, determinerebbe una maggiore flessione dell’attività economica anche a maggio, con il conseguente aggravarsi della flessione del PIL attesa nel secondo trimestre. In alternativa, o in aggiunta a questo, una recrudescenza dell’epidemia nei mesi autunnali causerebbe un’ulteriore perdita di prodotto e ritarderebbe la fase di ripresa prevista nello scenario tendenziale.
Va considerata, inoltre, l’evolversi della situazione negli altri Paesi europei, tra cui rientrano molti dei principali partner commerciali italiani, che stanno sperimentando l’emergenza con un ritardo temporale rispetto all’Italia. Un ritardo nei tempi per il ripristino dell’ordinaria attività produttiva delle imprese ostacolerebbe la ripresa della domanda estera e potrebbe generare difficoltà negli approvvigionamenti. Il protrarsi della debolezza della domanda estera indebolirebbe il contributo positivo atteso delle esportazioni nette, condizionando la ripresa e peggiorando il trascinamento sull’anno prossimo.
In relazione ai suddetti rischi della previsione, il DEF considera anche uno scenario alternativo, in cui la ripresa sarebbe più graduale e non si radicherebbe fino al secondo trimestre del 2021.
Come richiesto dalle linee guida concordate a livello europeo, il documento presenta, infatti, anche alcune ipotesi di scenari di rischio, in cui l’andamento e la durata dell’epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione del PIL nel 2020 (fino a -10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica (cfr. al riguardo l’approfondimento dell’apposito riquadro “Un’analisi di rischio (o di sensitività) sulle variabili esogene”, contenuto nel DEF, Sezioni I, cap. II).
Tra le ipotesi, ad esempio, si valuta complessivamente che un nuovo lockdown nell’autunno 2020 a livello nazionale ed internazionale porterebbe ad un deteriorarsi della crescita di 2,7 punti nel 2020 e di 2,4 punti nel 2021.
Si ritiene utile, infine, riportare un confronto tra le previsioni tendenziali di crescita recate nel DEF 2020 con quelle elaborate dai principali istituti di ricerca nazionali e internazionali a marzo/aprile.
Tabella 5 - Previsioni degli istituti nazionali e internazionali sulla crescita del PIL italiano
(variazioni percentuali)
|
|
2020 |
2021 |
| GOVERNO (aprile ’20) |
-8,0 |
4,7 |
| REF.IRS (aprile ’20) |
-8,3 |
5,9 |
| CONFINDUSTRIA (marzo ’20) |
-6,0 |
3,5 |
| PROMETEIA (marzo ’20) |
-6,5 |
3,3 |
| CER (marzo ’20) |
-3,3 |
2,6 |
| FMI - WEO (aprile ‘20) |
-9,1 |
4,8 |
| OCSE – Interim Economic Outlook (marzo ’20) |
0,0 |
0,5 |
Fonte: elaborazione Servizio Studi
Nel 2019 il mercato del lavoro, nonostante il rallentamento dell’attività economica, ha conservato un andamento positivo: il numero degli occupati è aumentato in misura maggiore rispetto al PIL, con una dinamica della produttività sostanzialmente invariata. Nel complesso la crescita degli occupati è stata pari allo 0,6 per cento (dato Istat, Rilevazione delle Forze di Lavoro), sospinta dall’occupazione dipendente, mentre gli indipendenti hanno continuato a ridursi per l’ottavo anno consecutivo.
Nel secondo trimestre del 2019 si è raggiunto il massimo storico di occupati (23,4 milioni), ma la crescita si è arrestata nella seconda metà dell’anno. Il tasso di occupazione è salito fino a un massimo del 59,3 per cento in novembre, il livello più alto degli ultimi decenni. La dinamica in aumento degli occupati a tempo indeterminato (0,9 per cento) è stata favorita, tra le altre cose, dall’aumento del numero di trasformazioni contrattuali, che ha risentito delle innovazioni normative in tema di contrattazione.
Il lavoro a tempo pieno è cresciuto ad un ritmo inferiore rispetto a quello part-time, rispettivamente 0,1 per cento e 3,0 per cento. Il part-time involontario continua ad aumentare (occupati che dichiarano di aver accettato un lavoro part-time in assenza di opportunità di lavoro a tempo pieno) e rappresenta il 64,2 per cento del totale del tempo parziale.
Il miglioramento del mercato del lavoro si è riflesso nella riduzione del tasso di disoccupazione (circa 10 per cento, dal 10,6). Altro dato positivo è rappresentato dal calo degli inattivi (-0,6 per cento) e degli scoraggiati (-5,4 per cento).
Le ore lavorate sono aumentate dello 0,4 per cento, mentre vi è stata una riduzione delle ore lavorate pro-capite dello 0,3 per cento. Sebbene il numero di occupati abbia recuperato e superato i livelli pre-crisi, le ore lavorate per occupato si collocano ancora al di sotto di tale livello, sia in totale che per singoli settori, evidenziando come l’occupazione sia caratterizzata da una bassa intensità lavorativa.
Un focus di approfondimento del DEF sottolinea al riguardo come il conteggio dei sottoccupati e degli occupati in part-time involontario (concentrati in buona parte nelle regioni del mezzogiorno d’Italia e nei settori della ristorazione, degli alberghi e dei servizi alla persona) tra gli occupati nelle statistiche ufficiali, faccia aumentare il tasso di occupazione, ma non dia informazioni sul “grado di utilizzo” effettivo dei lavoratori occupati. Mettendo a confronto il dato degli occupati (in costante aumento dal 2013) con le ore lavorate pro-capite, sostanzialmente stabili nel periodo, emerge una evidente divaricazione.
Dopo la crescita del 2018, i redditi pro-capite hanno decelerato (1,6 dal 2,0 per cento). Conseguentemente è rallentato anche il costo del lavoro per unità di prodotto, tenuto conto della crescita nulla della produttività.
La tabella seguente riporta i dati di consuntivo dell’ultimo decennio dei principali indicatori del mercato del lavoro.
Tabella 6 - Mercato del lavoro anni 2009-2019
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Occupati |
22.699 |
22.527 |
22.598 |
22.566 |
22.191 |
22.279 |
22.465 |
22.891 |
23.073 |
23.200 |
23.262 |
| Occupati variazione % |
-1,7 |
-0,8 |
0,3 |
-0,1 |
-1,7 |
0,4 |
0,8 |
1,3 |
1,2 |
0,6 |
0,3 |
| Totale Unità di lavoro standard |
24.336 |
24.130 |
24.162 |
23.830 |
23.250 |
23.298 |
23.440 |
23.759 |
23.945 |
24.125 |
24.187 |
| Unità di lavoro standard variazione % |
-2,7 |
-0,8 |
0,1 |
-1,4 |
-2,4 |
0,2 |
0,7 |
1,4 |
0,8 |
0,8 |
0,3 |
| Tasso di attività |
62,3 |
62,0 |
62,1 |
63,5 |
63,4 |
63,9 |
64,0 |
64,9 |
65,4 |
65,7 |
65,5 |
| Tasso di occupazione |
57,4 |
56,8 |
56,8 |
56,6 |
55,5 |
55,7 |
56,3 |
57,6 |
58,0 |
58,6 |
58,9 |
| Tasso di disoccupazione |
7,7 |
8,4 |
8,4 |
10,7 |
12,1 |
12,7 |
11,9 |
11,7 |
11,2 |
10,5 |
9,7 |
Fonte: Consuntivi 2019: Comunicato ISTAT, Occupati e disoccupati (dati provvisori) (1 aprile 2020). Per le ULA 2015-2019, Comunicato ISTAT, PIL e indebitamento AP – Anni 2016-2019 (2 marzo 2020). Per gli anni precedenti, banca dati Istat (I.Stat).
La Nota dell’Istat “Il mercato del lavoro – IV trimestre 2019”, diffusa il 19 marzo 2020, effettua un’analisi sulle tendenze dell’occupazione relativa al quarto trimestre 2019.
L’input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) è diminuito dello 0,2% sotto il profilo congiunturale ed è cresciuto dello 0,1% su base annua; l’occupazione risulta invece stabile rispetto al trimestre precedente e in aumento su base annua. L’andamento del quadro occupazionale si è sviluppato in una fase di ulteriore indebolimento della dinamica dell’attività economica che, nell’ultimo trimestre, ha segnato una diminuzione congiunturale dello 0,3% del Pil; il tasso di occupazione destagionalizzato è pari al 59,2%, con una variazione nulla in confronto al trimestre precedente.
Le previsioni tendenziali per il mercato del lavoro riportate nel DEF[19] (esposte nella tabella sottostante) considerano per l’anno in corso (2020) una contrazione dell’occupazione rilevata dalla contabilità nazionale e delle forze lavoro nettamente più contenuta di quella dell’economia reale e di poco superiore al 2 per cento, grazie al ricorso agli ammortizzatori della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e soprattutto di quella in deroga, eccezionalmente estesa nel loro ambito di applicazione dal decreto n. 18 del 2020 (Cura Italia) e dai successivi interventi. Maggiore invece è la contrazione attesa per l’occupazione espressa in unità di lavoro equivalente (ULA) e per le ore lavorate, che non tengono conto degli ammortizzatori sociali, per le quali si prevede una riduzione rispettivamente del 6,5 e del 6,3 per cento. Si prevede un miglioramento graduale del mercato del lavoro nell’anno successivo (2021), in linea con la ripresa dell’attività economica.
Tabella 7 - Il mercato del lavoro
(variazioni percentuali)
|
|
Consuntivo |
Previsioni Tendenziali |
|
| 2019 |
2020 |
2021 |
|
| Occupazione (ULA) * |
0,3 |
-6,5 |
3,4 |
| Occupati di contabilità nazionale |
0,6 |
-2,2 |
3,7 |
| Tasso di disoccupazione |
10,0 |
11,6 |
11,0 |
| Monte ore lavorate |
0,4 |
-6,3 |
3,7 |
| Costo del lavoro |
1,6 |
0,7 |
1,0 |
* Unità di lavoro standard – variazione %
Fonte: DEF 2020
Il tasso di disoccupazione, che peggiora nel 2020 all’11,6 per cento, recupera parzialmente all’11,0 per cento nel 2021. Sul piano della produttività tale dinamica determina una flessione piuttosto ampia nell’anno in corso (-1,7 per cento), seguita da un rimbalzo nel 2021.
Parte II – La finanza pubblica
Il Documento di economia e finanza riporta l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente, per il periodo 2020-2021, integrato con le informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2019.
Per quanto riguarda i dati riferiti al consuntivo 2019, le informazioni riportate nel Documento tengono conto degli aggiornamenti dei dati diffusi dall’ISTAT con i seguenti comunicati:
· il comunicato “Pil e indebitamento AP”, del 2 marzo 2020;
· il comunicato “IV trimestre 2019 - Conto trimestrale delle AP”, del 3 aprile 2020;
· il comunicato “Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche”, del 22 aprile 2020.
Le tabelle di seguito riportate espongono quindi i dati, inclusi nel DEF, relativi al consuntivo 2019 e alle previsioni 2020-2021. In alcune tavole, il raffronto è esteso ai dati di consuntivo riferiti all’esercizio 2018.
Sono presentati, inoltre, elementi di raffronto con le precedenti stime formulate nella Nota tecnico illustrativa della legge di bilancio 2020 (NTI)[20], che incorporano gli effetti della legge di bilancio 2020.
Tabella 8 - Conto economico della PA a legislazione vigente
(importi in milioni di euro)
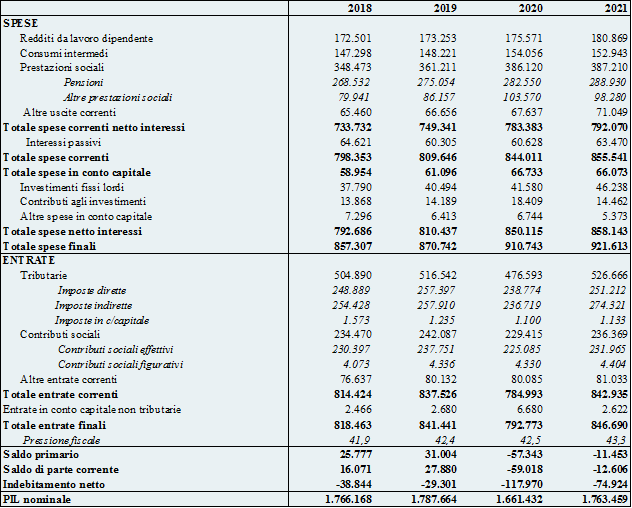
Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
| … |
Tabella 9 - Conto economico della PA a legislazione vigente
(% del PIL)
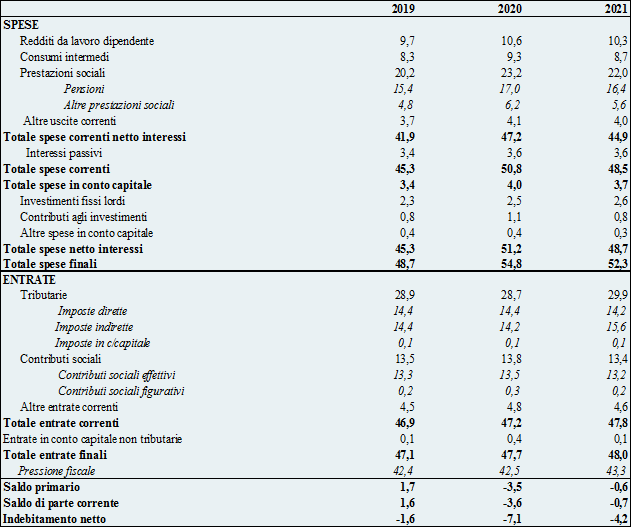
Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
| … |
Tabella 10 - Conto economico della PA a legislazione vigente – Variazioni rispetto all’anno precedente
(valori percentuali)
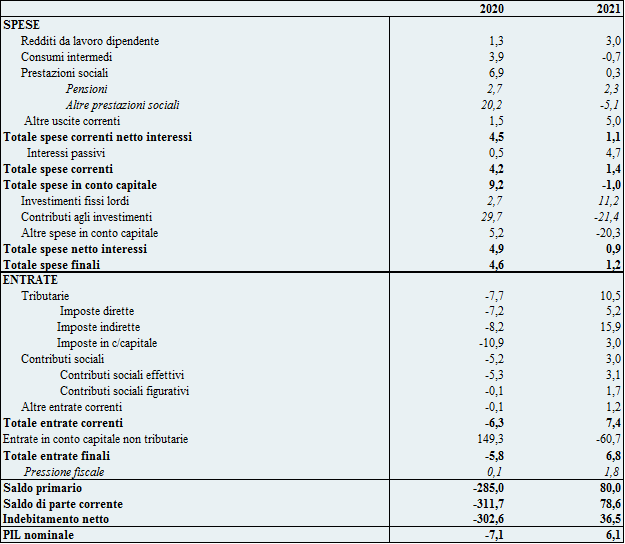
Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
| … |
Tabella 11 - Conto economico della PA a legislazione vigente – Variazioni rispetto all’anno precedente
(importi in milioni di euro)
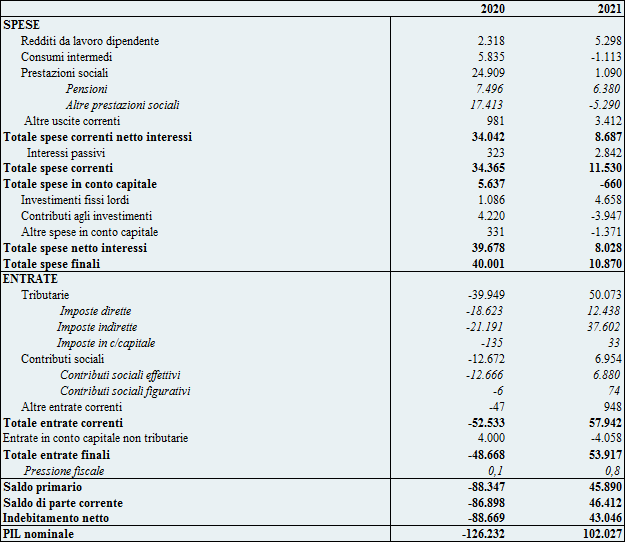
Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
| ... |
Tabella 12 - Conto economico della PA a legislazione vigente – Raffronto fra la Nota tecnico illustrativa (NTI) 2020 e il DEF 2020
(importi in milioni di euro)
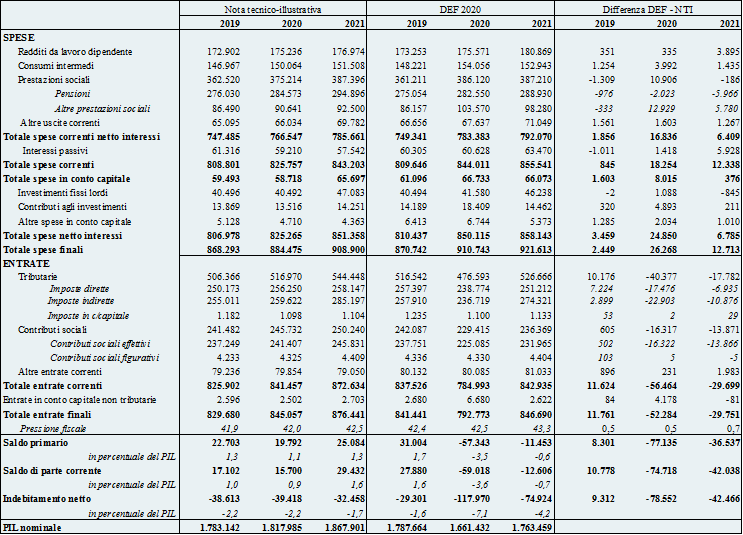
Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
I dati riferiti all’ultimo esercizio concluso, resi noti dall’ISTAT[21], attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per il 2019 pari, in valore assoluto, a 29,3 miliardi, corrispondente all’1,6 per cento del Pil.
Per quanto attiene al confronto con le precedenti stime, si evidenzia che la NTI 2020 (in linea con la NADEF 2019) prevedeva un indebitamento netto pari al 2,2 per cento in termini di Pil. Lo scostamento dalle stime è attribuibile prevalentemente alla revisione del saldo primario (per 8,3 miliardi), e vi concorre quella della spesa per interessi (per circa 1 miliardo); a sua volta, la revisione del saldo primario è dovuta per la quasi totalità al miglioramento delle entrate tributarie, che sono state superiori di oltre 10 miliardi rispetto alle precedenti previsioni.
Il dato indica un miglioramento rispetto all’anno 2018: in tale esercizio l’indebitamento è infatti risultato pari a 38,8 miliardi (2,2 per cento del Pil). Hanno contribuito a tale risultato sia un incremento del saldo primario (per 5,2 miliardi) sia una riduzione della spesa per interessi (per 4,3 miliardi). In termini relativi, fra il 2018 e il 2019 il saldo primario è aumentato dall’1,5 all’1,7 per cento del Pil, mentre la spesa per interessi è diminuita dal 3,7 per cento del 2018 al 3,4 per cento del Pil del 2019.
Limitando l’analisi ai principali aggregati del conto economico della p.a., si rileva che al miglioramento del saldo concorre principalmente un incremento delle entrate (per 23,0 miliardi), che determina effetti più che compensativi rispetto all’incremento registrato dal lato delle spese (per 13,4 miliardi). Tale effetto è peraltro coerente con quanto sopra evidenziato relativamente allo scostamento dalle stime.
Gli andamenti delle voci di entrata e di spesa sono esaminati distintamente nei successivi paragrafi.
Il DEF evidenzia, in via preliminare, che le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare quelle tributarie, registrano, nell’anno 2019 rispetto al 2018, valori significativamente superiori alle attese.
In particolare, le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche registrano un incremento in valore assoluto di circa 23 miliardi di euro (da 818,4 miliardi del 2018 a 841,4 miliardi nel 2019). In rapporto al Pil le entrate totali si attestano al 47,1 per cento rispetto al 46,3 per cento del 2018.
In particolare, le entrate tributarie aumentano, in valore assoluto, di circa 11,7 miliardi di euro (da 504,9 miliardi del 2018 a 516,5 miliardi nel 2019). In rapporto al Pil le entrate tributarie si attestano al 28,9 per cento rispetto al 28,6 per cento del 2018.
Concorrono a tale incremento i principali aggregati di entrata, come evidenziato nel seguente grafico.
Figura 7 - Principali componenti delle entrate (anni 2018 e 2019)
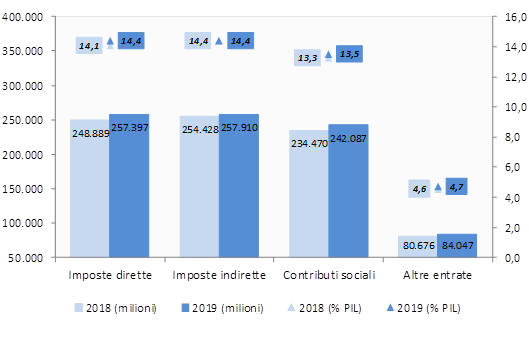
Il DEF evidenzia che nel 2019, il mercato del lavoro presenta un andamento positivo rispetto sia al numero di occupati che alle retribuzioni lorde pro-capite. Per tale motivo, si registra un incremento della base imponibile che determina effetti positivi in termini di imposte sui redditi e contributi.
Infatti, nell’ambito delle imposte dirette (+3,4 per cento rispetto al 2018), l’andamento positivo del gettito IRPEF, in base al Documento è determinato tra l’altro dalle maggiori ritenute sul lavoro dipendente che compensano la riduzione delle ritenute sui lavoratori autonomi.
Incrementi di gettito sono evidenziati anche rispetto all’IRES, alle imposte sostitutive, e all’imposta sul lotto e le lotterie.
Un andamento positivo viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che registrano, nel 2019, un incremento del 3,2 per cento rispetto al 2018.
Tra le imposte indirette (+1,4 per cento rispetto al 2018), viene rilevata la crescita del gettito IVA trainata dalla componente sugli scambi interni che compensa la riduzione dell’IVA sulle importazioni.
In proposito, il DEF segnala che l’andamento positivo dell’IVA sugli scambi interni non è spiegato da un significativo incremento della base imponibile; viene, invece, evidenziato il ruolo delle innovazioni normative introdotte, quali l’obbligo di fatturazione elettronica[22], in vigore dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati tra soggetti residenti.
Nell’apposito focus “Analisi del gettito IVA nel 2019”, attraverso due diverse metodologie di studio, si analizzano le motivazioni sottostanti l’incremento delle entrate IVA.
Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato nel focus, si segnala che:
- la prima metodologia si basa sul presupposto che l’andamento del gettito di un’imposta è correlato con l’andamento della relativa base imponibile. Illustrando criteri, ipotesi e procedure adottate, il focus afferma che, nel 2019, il tasso di crescita dell’IVA da scambi interni risulta notevolmente maggiore del tasso di crescita delle risorse interne. In particolare, i risultati dello studio evidenziano, rispetto al 2018, una correlazione tra incremento IVA e incremento di base imponibile limitatamente ad una quota (179 milioni) del maggior gettito IVA, mentre la restante quota (2.926 milioni) risulta giustificata da altre misure introdotte nel 2019 (in via prevalente, la fattura elettronica). Analogamente, rispetto alle previsioni della NADEF 2019, la quota di incremento giustificata dalla maggiore base imponibile è pari a 213 milioni, mentre i restanti 563 milioni rappresentano la quota non spiegata. Pertanto, in assenza di una corrispondenza tra andamento del gettito IVA e andamento della base imponibile; una parte rilevante del maggior gettito viene attribuito alle nuove misure introdotte, con particolare riferimento agli obblighi di emissione della fattura elettronica e comunicazione telematica degli scontrini;
- la seconda metodologia valuta gli effetti positivi della compliance basandosi sulle stime del gap IVA e della propensione al.gap (c.d. “metodo standard”). Illustrando i criteri, le ipotesi e le procedure adottate, il focus stima una riduzione del gap, cui corrispondono effetti positivi di gettito IVA, pari a 1,6 miliardi di euro nel 2019.
Nonostante la difformità in termini di ammontare dei risultati (rispetto alle quali il focus illustra le possibili motivazioni), lo studio afferma che entrambe le analisi evidenziano che le misure adottate per incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti hanno esercitato un impatto positivo sul gettito ordinario dell’IVA.
Le imposte in conto capitale indicate in 1.235 milioni nel 2019, registrano, rispetto al 2018, una variazione negativa del 21,5 per cento. Data la ridotta incidenza sul Pil dell’aggregato (0,1 percento) tale dinamica compensa in misura limitata l’aumento delle entrate correnti.
La pressione fiscale evidenzia un incremento attestandosi, nel 2019, al 42,4 per cento rispetto al 41,9 per cento dell’anno precedente (+0,5 punti percentuali). Considerando il beneficio degli 80 euro, il Documento segnala che la pressione fiscale del 2019 scenderebbe al 41,9 per cento.
Le entrate tributarie includono gli effetti dell’attività di contrasto all’evasione fiscale. Il Documento[23] segnala che l’azione del Governo è finalizzata non solo al recupero di gettito attraverso l’attività di accertamento e controllo, ma anche al miglioramento della propensione all’adempimento spontaneo dei contribuenti (tax compliance). Tuttavia, mentre gli effetti delle attività di accertamento e riscossione possono essere verificati in quanto riferiti a specifiche procedure e versamenti da parte dei soggetti interessati, gli effetti recati dalla tax compliance richiedono procedure di stima, in quanto, essendo determinati da adempimenti spontanei dei contribuenti, sono inclusi nell’ordinario gettito delle imposte.
Il DEF evidenzia che, nel corso del 2019, l’attività di recupero dell’evasione ha fatto registrare incassi per un ammontare pari a 19,9 miliardi, con un incremento del 3,4 per cento circa rispetto al 2018.
In merito agi effetti recati dalla tax compliance, il focus rileva che dalle stime effettuate dal Dipartimento delle finanze e dall’Agenzia delle entrate, per effetto dell’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria B2B, il maggiore gettito IVA è quantificato in 1,6 miliardi di euro, con un miglioramento della compliance di 1,1 punti percentuali nel 2019 (v. supra “Analisi del gettito IVA nel 2019”).
Peraltro, il Documento segnala anche che le ultime stime sull’evasione fiscale e contributiva[24], oltre a mostrare una dinamica di netto miglioramento della tax compliance, evidenziano anche valori di tax gap ancora molto significativi. In particolare, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al 2017, l’evasione tributaria e contributiva è stata stimata in 109.684 milioni (di cui 97.912 milioni per evasione tributaria); nel periodo 2015-2017, in media, l’evasione tributaria e contributiva è pari a 108.297 milioni (di cui la componente tributaria risulta pari a 96.871 milioni).
Rispetto alle stime per l’anno 2019 contenute nella NTI 2020 i dati del DEF rilevano un aumento delle entrate totali di circa 11,8 miliardi di euro. In rapporto al Pil, le entrate totali si attestano al 47,1 per cento rispetto al 46,5 per cento previsto.
Gli scostamenti di maggior rilievo si riscontrano soprattutto per le entrate tributarie (+10.176 milioni) il cui incremento è determinato dalla maggiore previsione di entrata delle imposte dirette (+7.224 milioni), delle imposte indirette (+2.899 milioni) e delle imposte in conto capitale (+53 milioni).
Per le imposte dirette, il DEF segnala che il differenziale rispetto alle previsioni incorpora un elemento di disomogeneità, dato dalle entrate relative alle componenti A2 e A5 delle tariffe sui servizi di fornitura di energia elettrica che, fino alle previsioni della NTI, non venivano considerate tra le entrate tributarie della P.A.
I contributi sociali, rispetto alle previsioni della NTI, sono risultati nel 2019 superiori alle stime attese per 605 milioni complessivi, per effetto sia di maggiori contributi sociali effettivi (+502 milioni), che di maggiori contributi figurativi (+ 103 milioni).
La revisione al rialzo interessa anche le altre entrate correnti indicate in 80.132 milioni rispetto al valore di 79.236 milioni indicato nella NTI (+896 milioni). Il DEF attribuisce lo scostamento alla revisione al rialzo del dato relativo alla vendita di beni e servizi, presumibilmente per l’inclusione nel perimetro della PA di nuove unità istituzionali.
Le spese finali si attestano nel 2019 a 870.742 milioni, in aumento dell'1,6 per cento rispetto al dato 2018, allorché l'analogo valore era stato di 857.307 milioni.
Il valore registrato a consuntivo è più alto (+2,5 miliardi circa) anche di quello indicato dalla Nota tecnico-illustrativa (NTI) 2020 che stimava un ammontare complessivo di 868.293 milioni di euro: la variazione rispetto alle precedenti stime è determinata da un incremento della spesa corrente primaria di 1.856 milioni e della spesa in conto capitale di 1.603 milioni, parzialmente compensato da una riduzione della spesa per interessi di 1.011 milioni di euro.
Nel complesso le spese finali aumentano anche in termini relativi, in quanto la loro incidenza rispetto al Pil passa dal 48,5 per cento del 2018 al 48,7 per cento del 2019. La variazione complessiva è dovuta sia della spesa in conto capitale sia della spesa corrente primaria che hanno registrato incrementi, rispetto al Pil, rispettivamente dello 0,1 per cento (dal 3,3 per cento del 2018 al 3,4 per cento del 2019) e dello 0,4 per cento (dal 41,5 per cento del 2018 al 41,9 per cento del 2019) mentre la spesa per interessi registra una diminuzione dello 0,3 per cento passando dal 3,7 per cento del 2018 al 3,4 per cento del 2019 (sulla spesa per interessi si rinvia all’apposito approfondimento).
Nel 2019 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata pari a circa 361 miliardi di euro, il 20,2 per cento del Pil, in aumento rispetto al 2018 (19,7%). In valori assoluti, la spesa in oggetto ha registrato un aumento, rispetto al 2018, del 3,7 per cento.
Rispetto a quanto stimato nella Nota tecnico-illustrativa, la spesa si contrae di circa 1,3 miliardi di cui un miliardo è attribuibile a una più contenuta spesa per pensioni.
L’incremento della spesa per prestazioni sociali in denaro è dovuto sia alla crescita della spesa pensionistica (+2,4 per cento) che all’aumento delle altre prestazioni sociali (+7,8 per cento).
Secondo le indicazioni del DEF la dinamica in aumento della spesa per pensioni è influenzata dall’indicizzazione dei trattamenti applicata dal 1° gennaio 2019, mentre ulteriori fattori residuali di incremento afferiscono al saldo, sia in termini numerici sia di importo, tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate – influenzato dal nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 di contributi) - nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati.
La spesa per le altre prestazioni sociali in denaro registra un incremento (+7,8%) rispetto al precedente esercizio.
Tale andamento è condizionato, tra l’altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (circa 2 miliardi in più rispetto al 2018) e della spesa per assegni e sussidi, a fronte di incrementi meno significativi delle altre componenti di spesa. Influenzano la dinamica rilevata rispetto alla media dei precedenti esercizi in particolare gli interventi normativi adottati nel 2019. In proposito il DEF chiarisce che il progressivo avvio del reddito di cittadinanza ha determinato una spesa di 3.825 milioni limitatamente ai ratei erogati nel 2019 (una parte dei ratei afferenti alle domande accolte nel 2019 è invece erogata nel 2020).
Nel medesimo esercizio 2019 la spesa per redditi da lavoro dipendente risulta sostanzialmente costante rispetto al dato 2018, con un incremento dello 0,4 per cento, attestandosi su di valore assoluto complessivo pari a 173.253 milioni di euro. L’incidenza in termini di Pil si attesta al 9,7 per cento, in lieve diminuzione (-0,1 per cento) rispetto all'anno precedente.
Il dato è inoltre sostanzialmente confermativo del valore proposto nella NTI 2020, pari a 172.902 milioni di euro; la differenza di 351 milioni è, in parte, dovuta al trascinamento della revisione del dato del 2018.
Dopo l’incremento (5,28 miliardi) già registrato nel 2018 rispetto al precedente esercizio per la sottoscrizione dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2016-2018, che hanno riguardato la gran parte dei settori del pubblico impiego, all’ulteriore incremento della spesa (+ 0,4 per cento) registrato nel corso del 2019 ha concorso anche la circostanza che sono stati siglati i contratti del personale dirigente dell’Area Sanità e dell’Area Istruzione e ricerca.
Con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2019-2021, per l’anno 2019 ha avuto effetto la sola spesa per l’anticipazione contrattuale decorrente dal mese di aprile (corrispondente all’indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) e per l’elemento perequativo decorrente dal mese di gennaio 2019[25]. Viceversa ha determinato un effetto di riduzione della spesa in esame il maggior numero di pensionamenti per effetto della c.d. “quota 100”.
L’aggregato dei consumi intermedi ha registrato nel 2019 un rialzo dello 0,6 per cento rispetto al 2018 (+923 milioni), raggiungendo un totale di 148.221 milioni. L’incidenza di tale voce in termini di Pil resta tuttavia inalterata all’8,3 per cento. Nel confronto con le precedenti stime fornite dalla NTI, il dato di consuntivo 2019 risulta comunque superiore di 1.254 milioni rispetto alle attese.
La voce altre uscite correnti evidenzia un incremento nel 2019 di 1.196 milioni, raggiungendo il livello di 66.656 milioni. Rispetto all’anno precedente la spesa aumenta dell’1,8 per cento. L’incidenza di tale voce in termini di Pil resta tuttavia inalterata rispetto all’anno precedente confermando il dato del 3,7 per cento.
Dal confronto con la NTI 2020 emerge una revisione del dato al rialzo di 1.561 milioni anche, secondo quanto riportato nel DEF, a causa dell’inclusione, a bilanciamento del conto, delle componenti tariffarie di energia elettrica, gas e acqua.
In proposito il DEF chiarisce che la quota di bolletta relativa alle spese per oneri generali di sistema necessari alla copertura dei costi di utilità generale è, dapprima, trasferita alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Gestore dei servizi energetici e ambientali e, successivamente, erogata a favore delle imprese: gli incassi pervenuti al Gestore e alla Cassa da parte delle compagnie elettriche relativi alle predette componenti sono, appunto, contabilizzati fra le entrate tributarie, mentre il corrispondente importo in uscita viene contabilizzato come trasferimento alle imprese. Viene inoltre evidenziato che le entrate relative alle componenti A2 e A5 delle tariffe sui servizi di fornitura di energia elettrica, fino alle previsioni della NTI, non venivano considerate tra le entrate tributarie della P.A.
Infine, la spesa in conto capitale del 2019 è risultata pari, in valore assoluto, a 61.096 milioni, con un incremento di 2.142 milioni rispetto al dato del 2018. L’incremento registrato su base annua è del 3,6 per cento mentre l’incidenza della voce di spesa rispetto al Pil passa dal 3,3 per cento del 2018 al 3,4 per cento del 2019.
Il dato esposto nella NTI è stato rivisto al rialzo di 1.603 milioni soprattutto in conseguenza della modifica dell’importo relativo alle altre spese in conto capitale.
Tali spese risultano incrementate di 1.285 milioni rispetto alle precedenti stime a causa, fra l’altro, della riclassificazione del prestito di 400 milioni ad Alitalia e di parte degli interventi di salvataggio delle banche Carige e Popolare di Bari. Viene inoltre rivisto al rialzo per 320 milioni il dato relativo ai contributi agli investimenti, voce il cui ammontare passa da 13.869 milioni a 14.189 milioni.
Il DEF espone l’andamento previsto dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel periodo 2020-2021.
La sezione II del DEF (analisi e tendenze della finanza pubblica) viene presentata quest’anno eccezionalmente in forma semplificata[26], limitando l’orizzonte di previsione all’anno 2021.
Rispetto alle precedenti stime (comunque riferite al triennio 2020-2022) incorporate nella NTI, il DEF formula le nuove previsioni sulla base:
· delle informazioni relative al consuntivo 2019 diffuse dall’ISTAT;
· del nuovo quadro macroeconomico rappresentato nella Sezione I del DEF medesimo (che contiene il Programma di stabilità dell’Italia), che scontano il significativo deterioramento del contesto macroeconomico dovuto alla diffusione della pandemia Covid-19;
· degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati a tutto aprile 2020 (vedi tabella seguente).
Tabella 13 – Impatto netto dei principali provvedimenti da gennaio ad aprile 2020 sull’indebitamento netto della p.a.
(in milioni di euro)
|
|
2020 |
2021 |
| DL 3/2020 (“cuneo fiscale”) |
0 |
269 |
| DL 18/2020 (“cura Italia”) |
-19.989 |
0 |
| DL 23/2020 (“liquidità”) |
0 |
0 |
Fonti: DEF 2020 – Sezione I, pagg. 115 e segg.; relazioni tecniche e prospetti riepilogativi ai provvedimenti.
Note: Il segno “-” indica un peggioramento del saldo. La tabella, in coerenza con l’impostazione seguita dal DEF, fa riferimento al solo biennio 2020-2021 in luogo dell’orizzonte triennale normalmente considerato.
Per quanto attiene al nuovo quadro previsionale, il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2020 un indebitamento netto pari al 7,1 per cento del Pil (117.971 milioni).
Le stime del DEF sono più contenute di quelle (richiamate dal Documento in esame) del Fondo Monetario Internazionale: nel Fiscal Monitor del 20 aprile 2020 il Fondo prevede un deficit della pubblica amministrazione dell’8,3 per cento. Il DEF (Sez. I, pag. 71) evidenzia che ciò sembra da attribuire alla contrazione più severa del PIL attesa dal Fondo. Il Fondo stima una caduta del PIL, per il 2020, del 9,1 per cento in termini reali (sezione Italy – At a glance del sito imf.org).
Rispetto al 2019, nel 2020 si determina quindi un peggioramento del saldo del 5,5 per cento in termini di Pil. Per quanto riguarda il numeratore del rapporto, l’incremento è attribuibile pressoché interamente a un peggioramento del saldo primario (per 88,35 miliardi), in sostanziale costanza della spesa per interessi (0,32 miliardi di maggiore spesa).
Si evidenzia infatti che il saldo primario cambia di segno e passa da positivo (avanzo dell’1,7 per cento sul Pil) a negativo (disavanzo del 3,5 per cento).
Per quanto riguarda il denominatore, si segnala la decrescita del Pil nominale, che nella stima per l’esercizio in corso si riduce di circa il 7,1 per cento (circa 126,2 miliardi in valore assoluto) rispetto al 2019, assumendo un’incidenza preponderante nel determinare la variazione del rapporto complessivo deficit/Pil.
Per il 2021 (ultimo esercizio considerato, quest’anno, nell’orizzonte previsionale), si stima invece un miglioramento dell’indebitamento netto rispetto al 2020, sia in valore assoluto sia in rapporto al Pil: il deficit tendenziale risulterebbe infatti pari a 74,92 miliardi (4,2 per cento del Pil).
In base al DEF, l’indicato miglioramento del saldo è determinato contemporaneamente dal miglioramento del saldo primario (per 45,89 miliardi, tale da compensare la crescita della spesa per interessi di 2,84 miliardi) e dalla crescita del Pil nominale (per circa 102 miliardi).
Con riferimento al biennio 2020-2021 è possibile operare un raffronto con le previsioni contenute nella NTI.
Rispetto alle stime di inizio anno (NTI 2020 ) l’indebitamento netto passa dal 2,2 per cento rispetto al Pil al valore, come visto, del 7,1 per cento: tale differenza è spiegata principalmente dall’aggiornamento delle stime del Pil nominale (-156,55 miliardi rispetto al precedente dato previsionale) e, in misura concorrente, dall’aggiornamento delle previsioni di deficit, in peggioramento per 78,55 miliardi (a sua volta derivante da una revisione peggiorativa sia nella spesa per interessi, per 1,42 miliardi, sia nel saldo primario, per 77,14 miliardi).
Anche per l’esercizio successivo si evidenzia un peggioramento rispetto alle precedenti stime: per il 2021, infatti, la previsione di indebitamento netto passa dall’1,7 per cento (NTI) al 4,2 per cento (DEF). Analogamente a quanto appena evidenziato per il 2020, la principale determinante è la revisione delle stime del Pil (-104,4 miliardi circa) alla quale va ad aggiungersi la revisione delle stime del deficit (-42,47 miliardi).
Il Documento di economia e finanza, per il periodo di previsione 2020-2021, stima un andamento delle entrate totali che presenta una iniziale contrazione nel 2020 rispetto al 2019 (- 48,7 miliardi, passando da 841,4 miliardi a 792,8 miliardi) e una ripresa di 53,9 miliardi nel 2021, anno in cui la previsione di entrata si attesta a 846,7 miliardi.
In termini di incidenza sul Pil, invece, le stime relative alle entrate totali della PA registrano incrementi sia nel 2020 (47,7 punti percentuali rispetto a 47,1 nel 2019) sia nel 2021 (48 per cento del Pil).
Per l’esercizio 2020 il dato in rialzo dell’incidenza sul Pil, nonostante la flessione che si registra in valore assoluto rispetto al precedente anno, è spiegato dalla contemporanea contrazione della stima di Pil.
Il Documento afferma che le stime considerano le variazioni del quadro macroeconomico, gli effetti dei provvedimenti legislativi con impatto differenziale sugli anni di riferimento e l’effetto di trascinamento dei risultati 2019 che si sono attestati al di sopra delle stime della NTI 2020. Il miglioramento del quadro macroeconomico incide, in particolare, nel 2021.
Figura 8 - Entrate della P.A. - anni 2019-2021
(importi in milioni di euro)
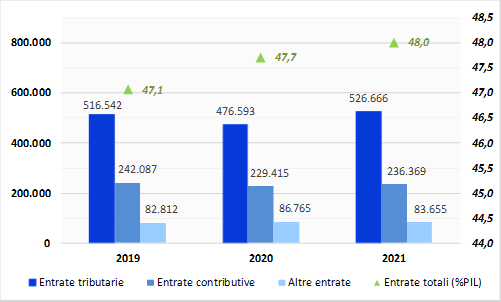
Tra i fattori che incidono sull’andamento crescente delle entrate totali in rapporto al Pil, il DEF segnala la tendenza delle entrate dalla UE, gli effetti delle clausole di salvaguardia su IVA e accise previste dalla normativa vigente a partire dal 2021, l’andamento delle altre variabili macroeconomiche rilevanti (in particolare quelle relative al mercato del lavoro) e l’evoluzione stimata per i dividendi, gli aiuti internazionali e i trasferimenti diversi in entrata.
In particolare, le entrate tributarie registrano, in valore assoluto, una contrazione di 39,9 miliardi nel 2020 (476,6 miliardi rispetto a 516,5 del 2019) ed una ripresa di 50,1 miliardi nel 2021 (raggiungendo l’importo di 526,7 miliardi).
In rapporto al Pil, l’aggregato diminuisce di 0,2 punti percentuali nel 2020 (da 28,9 nel 2019 a 28,7 p.p.) per poi aumentare di 1,2 punti percentuali nel 2021 (in cui il rapporto si attesta al 29,9 per cento del Pil).
Il DEF segnala l’andamento delle poste correttive del Bilancio dello Stato (che risentono della sospensione di accertamenti fiscali e delle verifiche disposta a seguito del DPCM 11 marzo 2020) e l’incremento di IVA e accise incluso nelle previsioni dal 2021 (in tale periodo d’imposta, alle clausole di salvaguardia sono ascritti effetti per circa 20 miliardi di euro (v. infra Clausole di salvaguardia).
Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni indicano un decremento del 5,2 per cento nel 2020 (229,4 miliardi circa rispetto ai 242 nel 2019), mentre nel 2021 è stimato un parziale recupero nell’ordine del 3 per cento (7 miliardi circa), con una previsione che aumenta a circa 236, 4 miliardi.
In rapporto al Pil, i contributi sociali mostrano un incremento di circa 0,3 punti percentuali nel 2020 (dal 13,5 al 13,8 per cento) per poi ridursi di 0,4 punti percentuali nel 2021 (dal 13,8 al 13,4 per cento).
Tale andamento riflette in particolare la dinamica del mercato del lavoro e delle altre variabili macroeconomiche rilevanti, ma anche l’effetto di interventi di agevolazione per le assunzioni di giovani introdotti con la legge di bilancio 2018 (si vedano in particolare gli sgravi contributivi permanenti per l’assunzione di giovani, di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 della L. 205/2017) e quelli della revisione delle tariffe dei premi INAIL. Il profilo previsionale tiene conto, inoltre, delle entrate connesse al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con i relativi effetti in termini di maggior gettito contributivo.
Le entrate in conto capitale non tributarie aumentano di 4 miliardi nel 2020 (rispetto al 2019) per poi ridursi all’incirca dello stesso importo nel 2021 per effetto principalmente dell’andamento delle risorse stimate in entrata per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in considerazione delle iniziative che si stanno definendo in ambito europeo circa l’utilizzo dei fondi strutturali per il contrasto del Coronavirus e il rilancio economico.
La pressione fiscale sale al 42,5 per cento nel 2020 e raggiunge il 43,3 per cento nel 2021.
Il Documento segnala che, al netto della misura riguardante l’erogazione del beneficio degli 80 euro mensili, innalzato a 100 euro per i titolari di reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro[27], la pressione fiscale passerebbe dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 del 2020 e al 42,5 per cento nel 2021.
Inoltre, il DEF evidenzia che il Governo intende includere nel nuovo decreto l’eliminazione degli aumenti dell’IVA e delle accise previsti dal 2021. Gli effetti di tale provvedimento non sono peraltro inclusi nelle predette stime, elaborate sulla base del criterio della legislazione vigente.
Rispetto alla NTI 2020, l’aggiornamento delle stime delle entrate totali evidenzia, in valore assoluto, una generale contrazione. In particolare, le previsioni sono riviste al ribasso per 52,3 miliardi nel 2020 e per 29,8 miliardi nel 2021.
In rapporto al Pil, invece, la nuova previsione riferita alle entrate totali – rispetto alle stime di inizio anno (NTI) - registrano incrementi negli anni 2020 e 2021 pari, rispettivamente, a 1,2 e a 1,1 punti percentuali.
Il seguente grafico considera le entrate finali in rapporto al Pil ed evidenzia il confronto fra le previsioni della NTI 2020 e quelle aggiornate indicate nel DEF 2020, in valore assoluto (milioni di euro) dei principali aggregati di entrata.
Figura 9 - Entrate totali: confronto tra NTI 2020 e DEF 2020
(importi in milioni di euro)
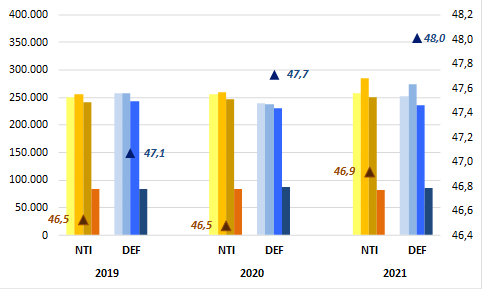
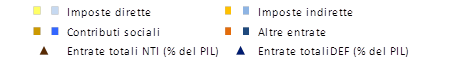
Riguardo ai fattori che, in linea generale, hanno determinato la revisione delle stime delle entrate rispetto a quelle indicate nella NTI, il DEF evidenzia che le nuove previsioni considerano, oltre alle variazioni del quadro macroeconomico e agli effetti dei provvedimenti legislativi con impatto differenziale sugli anni di riferimento, l’effetto di trascinamento dei risultati 2019.
Anche la componente delle entrate tributarie registra, in valore assoluto, una riduzione rispetto alle precedenti stime per ciascun anno del periodo di riferimento.
Si segnala in proposito che il DEF afferma che l’autorizzazione di spesa[28] destinata alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti è stata classificata, in sede di predisposizione della NTI, in termini di minori entrate fiscali e non di maggiore spesa per prestazioni. Il provvedimento attuativo intervenuto successivamente (DL 3/2020) ha utilizzato parte delle risorse stanziate per l’ampliamento del bonus 80 euro (intervento che viene qualificato come spesa corrente).
Nei seguenti grafici sono evidenziate le previsioni di entrata, in rapporto al Pil, relative al periodo 2019-2021, indicate nella NTI e nel DEF, riferite alle diverse voci che incidono sul livello della pressione fiscale (imposte dirette, imposte indirette, imposte in conto capitale e contributi sociali).
Figura 10 - Componenti della pressione fiscale: confronto tra Nota tecnico-illustrativa 2020 e DEF 2020
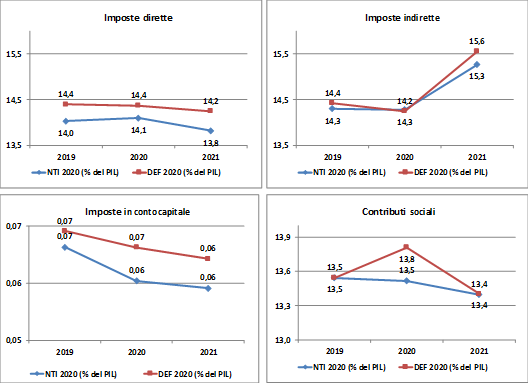
A decorrere dall’anno 2021, le previsioni riferite alle imposte indirette includono, tra l’altro, gli effetti dovuti all’operatività delle “clausole di salvaguardia” (cfr. specifico approfondimento).
Infine, in riferimento alla pressione fiscale si riportano, nel seguente grafico le stime relative all’andamento della pressione fiscale indicate nella NTI 2020 e nel DEF 2020. Nel grafico si riporta altresì l’andamento della pressione fiscale sulla base di valori, che, limitatamente al DEF, sono stati ricalcolati al netto degli effetti del bonus riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti (che, come segnalato, ai fini dei tendenziali, risulta invece iscritto tra le spese correnti).
Si fa presente, in proposito, che per i valori relativi agli anni 2020 e 2021 si considerano le modifiche introdotte dal DL 3/2020 che, dal 1° luglio 2020, che estende la platea dei beneficiari e aumenta a 100 euro la misura del beneficio (c.d. bonus 100 euro).
Figura 11 – Pressione fiscale (valori NTI e DEF e valori DEF ricalcolati al netto bonus 80 euro)
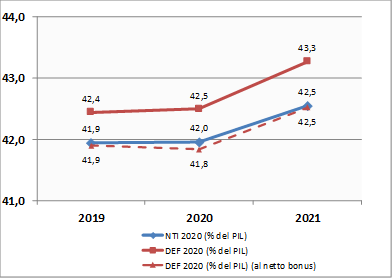
I risultati ottenuto ricalcolando la pressione fiscale al netto del bonus coincidono con le indicazioni del DEF, in base al quale, includendo il predetto beneficio, la pressione fiscale scende dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 per cento nel 2020 e al 42,5 per cento nel 2021.
IL DEF informa inoltre che, considerando anche gli effetti del nuovo provvedimento, in corso di preparazione - e non incluso quindi nel tendenziale - nel 2021 il valore scenderebbe ulteriormente al 41,4 per cento.
L’articolo 1, comma 626, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) hanno introdotto clausole di salvaguardia che prevedono meccanismi automatici per la realizzazione di effetti di maggior gettito fiscale (aumento delle aliquote IVA e delle accise). Tali norme sono state oggetto di numerosi interventi di modifica diretti, in via prevalente, ad evitare l’entrata in vigore, per determinati periodi di imposta, degli aumenti delle aliquote.
a) Normativa vigente (profili finanziari)
Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari di maggior gettito imputabile alle clausole di salvaguardia che, in base agli allegati tecnici alla legge di bilancio 2020, dovrebbero risultare attualmente inclusi nei tendenziali di finanza pubblica.
Tabella 14 - Clausole di salvaguardia
(importi in milioni di euro)
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
dal 2025 |
| Imposta sul valore aggiunto |
|
|
|
|
|
|
| Aliquota IVA ridotta |
10,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
| Gettito stimato per incremento aliquota |
0 |
5.793 |
5.793 |
5.793 |
5.793 |
5.793 |
| Aliquota IVA ordinaria |
22,0% |
25,0% |
26,5% |
26,5% |
26,5% |
26,5% |
| Gettito stimato per incremento aliquota |
0 |
13.110 |
19.665 |
19.665 |
19.665 |
19.665 |
| Totale IVA |
0 |
18.903 |
25.458 |
25.458 |
25.458 |
25.458 |
| Accise |
|
|
|
|
|
|
| Maggior gettito accise carburanti |
0 |
1.221 |
1.683 |
1.954 |
2.054 |
2.154 |
| Totale maggiori entrate |
0 |
20.124 |
27.141 |
27.412 |
27.512 |
27.612 |
Fonte: Elaborazione su dati delle relazioni tecniche riferite alle misure via via intervenute
I valori indicati nel tabella sono basati su parametri aggiornati dalla legge di bilancio 2019 e utilizzati anche dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2020.
In particolare, nella stima degli effetti finanziari per interventi sugli aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausola di salvaguardia) i parametri sono stati indicati in misura pari a 4,37 miliardi per ciascun punto percentuale di IVA ordinaria e a 2,896 miliardi per ciascun punto percentuale di IVA ridotta.
Il Documento segnala che il Governo intende includere nel nuovo decreto legge in corso di preparazione la disattivazione degli aumenti dell’IVA e delle accise previsti dal 2021. A tal fine, viene riportata (DEF- Sez. II) la seguente tabella.
Tabella 15 - Impatto sull’indebitamento del DL in corso di predisposizione
(in milioni di euro)
|
|
Previsioni a legislazione vigente |
Differenziale politiche invariate |
||
|
Impatto su indebitamento del DL in corso di predisposizione (*) di cui: disattivazione aumento IVA e accise |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
|
|
-55.326
0 |
-26.234
-19.821 |
|
(*) comprensivi del costo per il servizio del debito derivante dagli effetti del decreto legge.
Fonte: DEF 2020 – Sez. II
Il valore indicato in corrispondenza dell’esercizio 2021 è inferiore per circa 300 milioni rispetto a quello ottenuto attraverso l’elaborazione dei dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle diverse misure via via intervenute in materia e applicando i parametri, da ultimo aggiornati dalla legge di bilancio 2019. Non essendo ancora disponibile il testo e la relazione tecnica del nuovo provvedimento che conterrà la misura annunciata di disattivazione delle clausole, non è possibile verificare i fattori che determinano la predetta differenza. Non è chiaro inoltre se la complessiva revisione del quadro macroeconomico operata in conseguenza dell’emergenza COVID-19 abbia comportato anche un aggiornamento dei valori utilizzati per la stima del maggior gettito attribuito all’incremento delle aliquote IVA.
Per quanto concerne gli incrementi delle accise, invece, la variazione del quadro macroeconomico non dovrebbe comportare modifiche alle entrate attese in quanto la normativa individua l’ammontare del maggior gettito da realizzare mediante l’incremento delle aliquote d’imposta.
Si offre di seguito una ricostruzione normativa degli effetti finanziari attribuiti alle varie modifiche finora intervenute nella disciplina in esame.
b) Ricostruzione normativa
Nella seguente tabella si riportano le aliquote e gli effetti finanziari attribuiti alle clausole di salvaguardia nella versione originaria.
Tabella 16 - Introduzione degli aumenti di imposte – formulazione originaria
(milioni di euro)
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
dal 2018 |
| Normativa previgente legge n. 190/2014 |
|
|
|
|
| -Aliquota IVA ridotta ante legge n. 190/2014 |
10% |
10% |
10% |
10% |
| - Aliquota IVA ordinaria ante legge n. 190/2014 |
22% |
22% |
22% |
22% |
| Legge n. 190/14 (art. 1, co.718) – Testo originario |
|
|
|
|
| -Aliquota IVA ridotta |
10% |
12% |
13% |
13% |
| - Aliquota IVA ordinaria |
22% |
24% |
25% |
25,5% |
| - Maggior gettito variazione accise |
0 |
0 |
0 |
700 |
| Totale variazione entrate L.190/2014-Testo originario |
0 |
+12.814 |
+19.221 |
+21.965 |
Fonte: Elaborazione su dati delle relazioni tecniche.
Nella seguente tabella sono invece riepilogati i successivi interventi realizzati sulle aliquote aventi la finalità di neutralizzare, anche in misura parziale, le clausole di salvaguardia ed i relativi effetti finanziari.
Tabella 17 - Modifiche intervenute (2015-2019)
(importi in milioni di euro)
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Modifiche legge n. 208/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aliquota IVA ridotta |
10% |
13% |
13% |
13% |
13% |
13% |
13% |
13% |
| Aliquota IVA ordinaria |
22% |
24% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
| Maggior gettito variazione accise |
0 |
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
| Totale variazione entrate L. 208/2015 |
-12.814 |
-4.088 |
-2.394 |
-2.394 |
-2.394 |
-2.394 |
-2.394 |
-2.394 |
|
Modifiche legge n. 232/16 (art.1, co.631) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aliquota IVA ridotta |
|
10% |
13% |
13% |
13% |
13% |
13% |
13% |
| Aliquota IVA ordinaria |
|
22% |
25% |
25,9% |
25,9% |
25,9% |
25,9% |
25,9% |
| Maggior gettito variazione accise |
|
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
| Totale variazione entrate L. 232/2016 |
|
-15.133 |
0 |
+3.679 |
+3.679 |
+3.679 |
+3.679 |
+3.679 |
|
Modifiche DL n. 50/2017 (art.9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aliquota IVA ridotta |
|
|
11,5% |
12% |
13% |
13% |
13% |
13% |
| Aliquota IVA ordinaria |
|
|
25% |
25,4% |
24,9% |
24,9% |
25,0% |
25,0% |
| Maggior gettito variazione accise |
|
|
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
| Totale variazione entrate DL n. 50/17 |
|
|
-3.829 |
-4.363 |
-4.088 |
-4.088 |
-3.679 |
-3.679 |
|
Modifiche DL n. 148/2017 (art.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aliquota IVA ridotta |
|
|
11,14% |
12% |
13% |
13% |
13% |
13% |
| Aliquota IVA ordinaria |
|
|
25% |
25,4% |
24,9% |
24,9% |
25,0% |
25,0% |
| Maggior gettito variazione accise |
|
|
0 |
10 |
350 |
350 |
350 |
350 |
| Totale variazione entrate DL n. 148/17 |
|
|
-840 |
-340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Modifiche legge n. 205/17 (art.1, co.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aliquota IVA ridotta |
|
|
10% |
11,5% |
13% |
13% |
13% |
13% |
| Aliquota IVA ordinaria |
|
|
22% |
24,2% |
24,9% |
24,9% |
25,0% |
25,0% |
| Maggior gettito variazione accise |
|
|
0 |
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
| Totale variazione entrate L. 205/17 |
|
|
-14.908 |
-6.075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Modifiche legge n. 145/18 (art.1, co.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aliquota IVA ridotta |
|
|
|
10% |
13% |
13% |
13% |
13% |
| Aliquota IVA ordinaria |
|
|
|
22% |
25,2% |
26,5% |
26,5% |
26,5% |
| Maggior gettito variazione accise |
|
|
|
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
| Totale variazione entrate L. 145/18 (*) |
|
|
|
-12.472 |
+3.910 |
+9.182 |
+9.182 |
+9.182 |
|
Modifiche legge n. 160/19 (art.1, co3.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aliquota IVA ridotta |
|
|
|
|
10% |
12% |
12% |
12% |
| Aliquota IVA ordinaria |
|
|
|
|
22% |
25% |
26,5% |
26,5% |
| Maggior gettito variazione accise (**) |
|
|
|
|
0 |
1.221 |
1.683 |
1.954 |
| Totale variazione entrate L. 160/19 |
|
|
|
|
- 23.072 |
-8.629 |
-1.612 |
-1.341 |
(*) Per le stime riferite agli anni successivi al 2019, la relazione tecnica utilizza parametri aggiornati.
(**) Il maggior gettito atteso dalla variazione delle accise è fissato in 2.054 milioni nel 2024 e in 2.154 milioni annui dal 2025.
Fonte: Elaborazione su dati delle relazioni tecniche.
Rispetto a quanto considerato in sede di legge di bilancio 2020, le nuove previsioni di spesa scontano il deterioramento del contesto macroeconomico dovuto alla diffusione della pandemia Covid-19 e l’impatto diretto sulla finanza pubblica degli interventi adottati per sostenere l’economia e rafforzare il sistema sanitario e di gestione delle emergenze. I nuovi dati previsionali e il raffronto rispetto alle precedenti stime sono rappresentati nel seguente grafico.
Figura 12 - Spese finali: confronto tra Nota tecnico-illustrativa 2020 e DEF 2020
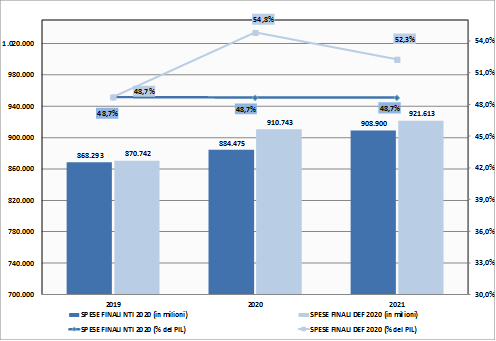
Le spese finali sono quindi riviste al rialzo di 26,3 miliardi per il 2020 e di 12,7 miliardi per il 2021 rispetto alle valutazioni contenute nella Nota tecnico-illustrativa. In valore assoluto i dati stimati per gli anni 2020 e 2021 sono, rispettivamente, pari a 910.743 milioni e 921.613 milioni; l’incremento annuo stimato è pari al 4,6 per cento nel 2020 (+40 miliardi) e all’1,2 per cento nel 2021 (+10,9 miliardi). L’incidenza delle spese rispetto al PIL si accresce di circa 6,1 punti percentuali nel 2020 rispetto al precedente esercizio, arrivando al 54,8 per cento per poi ridursi al 52,3 per cento nell’anno successivo. L’incremento del rapporto che si registra nel 2020 è dovuto soprattutto all’impatto diretto della riduzione del Pil (-126,2 miliardi circa rispetto al 2019) e, in misura più limitata, alle maggiori spese recate dal decreto legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) e agli effetti indiretti sulla spesa del peggioramento del quadro macroeconomico. In generale l’evoluzione delle principali componenti di spesa rispetto al PIL è fortemente influenzata dalla dinamica del denominatore; il PIL stimato per gli anni 2020 e 2021 si riduce, infatti, in confronto a quanto previsto dalla Nota tecnico-illustrativa (NTI 2020), rispettivamente dell’8,6 per cento (-156,6 miliardi) e del 5,6 per cento (-104,4 miliardi).
Riguardo alle principali componenti di spesa, si evidenzia che le spese correnti al netto degli interessi[29] (spese correnti primarie) sono riviste al rialzo di 16,8 miliardi per il 2020 e di 6,4 miliardi per il 2021 rispetto alle valutazioni contenute nella Nota tecnico-illustrativa. La revisione del dato 2020 è quasi interamente spiegata dalla modifica dei dati relativi alle altre prestazioni sociali (+12,9 miliardi) e ai consumi intermedi (+4 miliardi).
In valore assoluto i dati stimati per gli anni 2020 e 2021 sono rispettivamente pari a 783.383 milioni e 792.070 milioni, con incrementi su base annua pari al 4,5 per cento nel 2020 (+34 miliardi) e all’1,1 per cento nel 2021 (+8,7 miliardi). L’incidenza di tali spese rispetto al PIL si accresce di circa 5,3 punti percentuali nel 2020 arrivando al 47,2 per cento per poi parzialmente ripiegare al 44,9 per cento nel 2021. Nei grafici che seguono è evidenziato l’andamento delle principali componenti della spesa corrente primaria in termini di incidenza sul PIL, ponendo a raffronto le previsioni del DEF con quelle della NTI 2020.
Figura 13 - Componenti della spesa corrente primaria: confronto tra Nota tecnico-illustrativa 2020 e DEF 2020
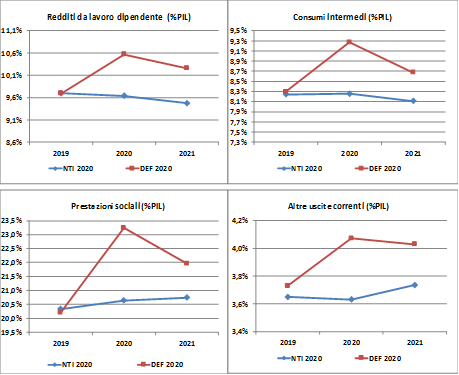
La spesa per redditi da lavoro dipendente vede sostanzialmente confermato il dato proposto dalla Nota tecnico-illustrativa per il 2020 (+0,3 miliardi) mentre il valore relativo al 2021 è rivisto in aumento di circa 3,9 miliardi. In valore assoluto i dati stimati per gli anni 2020 e 2021 sono rispettivamente pari a 175.571 milioni e 180.869 milioni. L’incidenza di tali spese rispetto al PIL si accresce di circa 0,9 punti percentuali nel 2020 arrivando al 10,6 per cento per poi parzialmente ripiegare al 10,3 per cento nel 2021.
Il DEF segnala che la previsione di incremento di tale voce di spesa per il 2020 assume le seguenti ipotesi: completamento della stagione contrattuale 2016-2018; sottoscrizione dei contratti relativi al triennio 2019-2021 del comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso pubblici; erogazione dell’anticipazione contrattuale a regime dal luglio 2020; corresponsione dell’elemento perequativo per i contratti che lo prevedono; finanziamento dell’organico di fatto della scuola. Le stime per il 2020 tengono anche conto delle maggiori spese di personale recate dal decreto legge n. 18/2020 e del fatto che le leggi di bilancio per il 2018, 2019 e per il 2020 hanno previsto graduali assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con un onere che andrà a regime dal 2024. La crescita della spesa nell’anno 2021 è dovuta principalmente all’ipotesi di conclusione nell’anno della tornata contrattuale 2019-2021. Gli incrementi descritti sono peraltro mitigati dalla riduzione delle unità di personale in servizio per effetto della c.d. “quota 100” mentre gli effetti di slittamento salariale sono stimati sulla base delle risultanze nell’ultimo quinquennio.
La spesa per consumi intermedi è rivista al rialzo per circa 4 miliardi nel 2020 e 1,4 miliardi nel 2021 rispetto alle previsioni della Nota tecnico-illustrativa (NTI) di inizio anno. In valore assoluto i dati stimati per gli anni 2020 e 2021 sono rispettivamente pari a 154.056 milioni e 152.943 milioni, con un incremento su base annua del 3,9 per cento nel 2020, mentre nel 2021 la voce di spesa si contrae dello 0,7 per cento. L’incidenza di tali spese rispetto al PIL si accresce di circa un punto percentuali nel 2020 arrivando al 9,3 per cento per poi parzialmente ridursi al 8,7 per cento nel 2021.
Il sensibile aumento della spesa per il 2020 risente sia del trascinamento dei risultati di consuntivo per il 2019 superiori alle attese (+1,3 rispetto a quanto stimato dalla Nota tecnico-illustrativa 2020), sia delle maggiori spese nell’anno 2020 recate dal decreto legge n. 18/2020, che vengono meno nell’esercizio successivo.
L’aggregato delle altre spese correnti è rivisto al rialzo, rispetto alla NTI, di 1,6 miliardi nel 2020 e di 1,3 miliardi nel 2021. In valore assoluto i dati stimati per gli anni 2020 e 2021 sono rispettivamente pari a 67.637 milioni e 71.049 milioni: l’incremento annuo stimato per il 2020 è pari all’1,5 per cento (+1 miliardo circa) mentre nel 2021 la voce di spesa registra un incremento del 5 per cento (+3,4 miliardi circa). L’incidenza di tali spese rispetto al PIL si accresce su base annua di circa di 0,4 punti percentuali nel 2020 arrivando al 4,1 per cento per poi ridursi al 4,0 per cento nel 2021.
Come emerge dalla precedente rappresentazione grafica, più evidente, rispetto alle altre voci di spesa corrente, è lo scostamento dalla NTI della nuova previsione di spesa per prestazioni sociali in denaro, che risentono, per il 2020, in modo rilevante degli effetti dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della conseguente adozione di misure di carattere straordinario per contrastare la situazione socio-economica determinatasi.
Le differenze, per il 2020, rispetto alle precedenti stime è riconducibile sostanzialmente agli interventi disposti per tale esercizio dal DL n. 18/2020 a tutela di lavoratori e famiglie per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria. La nuova previsione risente anche dell’inclusione degli oneri dovuti alle prestazioni di cui al decreto legge n. 3/2020 (cd “cuneo fiscale”): il DEF segnala che tali spese non erano state inglobate in sede di NTI nella spesa per prestazioni sociali in denaro, in quanto classificati, in tale sede, come minori entrate fiscali in assenza del provvedimento attuativo delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020.
Complessivamente, le nuove previsioni tendenziali stimano per l’aggregato delle prestazioni sociali in denaro una crescita del 6,9 per cento nel 2020 rispetto all’anno precedente (circa 25 miliardi in valore assoluto): la previsione complessiva di spesa passa infatti da 361.211 a 386.120 milioni di euro. Per il 2021 la crescita è più contenuta, con una variazione annua positiva dell’intero aggregato di 0,3 punti percentuali (circa 1,1 miliardi in valore assoluto).
L’incremento per il 2020 riguarda in modo prevalente la voce delle altre prestazioni sociali in denaro, interessata dal massiccio rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per contrastare gli effetti economici e sociali dell’emergenza sanitaria: in termini percentuali l’incremento su base annua di tale voce è stimato nel 2020 in circa il 20,2 per cento (17,4 miliardi di euro in termini assoluti). Dato il carattere temporaneo delle misure, la voce di spesa si ridimensiona nel 2021 del 5,1 per cento (in termini assoluti è prevista una flessione di circa 5,3 miliardi).
L’altra componente dell’aggregato delle prestazioni sociali in denaro, attiene alla spesa pensionistica che, nel 2020, si attesta sul valore di 282.550 milioni di euro, con una crescita rispetto all’anno precedente del 2,7 per cento. Un ulteriore aumento, più contenuto, del 2,3 per cento è previsto nel 2021 (6, 4 miliardi in più valore assoluto).
La previsione del DEF tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l’anno 2020, a 0,4 per cento), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Il DEF segnala, per il triennio 2019-2021, un andamento in aumento dell’accesso al pensionamento dovuto, oltre che alla maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011 e ai progressivi effetti delle tendenze demografiche in atto, anche ad innovazioni normative, quali l’introduzione di un canale ulteriore di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato. Le previsioni tengono conto altresì degli interventi contenuti nella legge di bilancio 2020 e degli elementi emersi nell’ambito dell’attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati i primi elementi disponibili per l’anno 2020.
Con specifico riferimento alla spesa sanitaria, il DEF indica per il 2020 una previsione di spesa pari a 119.556 milioni, con un tasso di crescita del 3,6 per cento rispetto all’anno precedente come rappresentato nella tabella che segue. Nel 2021 è previsto un ulteriore aumento dell’1,3 per cento, mentre il rapporto rispetto al PIL, dopo l’incremento registrato nel 2020 (+7,2%), collegato in larga parte agli interventi connessi all’emergenza sanitaria, registrerebbe nel 2021 una diminuzione attestandosi al 6,9 per cento.
Tabella 18 - Spesa sanitaria 2019-2021
(in milioni di euro)
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
| Spesa sanitaria In % del PIL Tasso percentuale di variazione |
115.448 6,5 1,4 |
119.556 7,2 3,6 |
121.083 6,9 1,3 |
Fonte: DEF 2020- Sez. II
Nel dettaglio, la previsione evidenzia, tra l’altro:
· per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa pari a 37.276 milioni. Il dato previsionale comprende anche le maggiori spese dovute al reclutamento e al lavoro straordinario del personale dipendente per garantire l’assistenza sanitaria in ragione delle esigenze connesse con la diffusione del virus COVID-19;
· per i consumi intermedi un livello di spesa pari a 36.647 milioni. La previsione mostra un incremento della spesa superiore a quello registrato nel 2019 (+5% contro +0,3%, rispettivamente), derivante soprattutto dalla componente farmaceutica, che è comunque calmierato dalla vigenza del tetto del 6,89 per cento della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Le altre componenti dei consumi intermedi, includono i maggiori oneri in ragione delle esigenze straordinarie connesse con l’emergenza del COVID-19;
· per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market un livello di spesa pari a 42.503 milioni. Tale importo è influenzato da incrementi della spesa per l’assistenza medico-generica, dovuti, tra l’altro alla maggiore spesa sostenuta per garantire l’attività di assistenza ordinaria legata all’emergenza epidemiologica del COVID-19, parzialmente attenuato dalle disposizioni connesse alle citate misure di anticipo pensionistico. Ulteriori incrementi riguardano altre prestazioni sociali in natura, il cui andamento risente in misura consistente dei maggiori oneri per l’acquisto da operatori privati di prestazioni di natura sanitaria per fronteggiare le attuali esigenze straordinarie.
La spesa in conto capitale è rivista al rialzo di circa 8 miliardi per il 2020 e di 0,4 miliardi per il 2021 rispetto a quanto previsto dalla Nota tecnico-illustrativa per il 2020. In valore assoluto i dati stimati per gli anni 2020 e 2021 sono rispettivamente pari a 66.733 milioni e 66.073 milioni, con un incremento annuo nel 2020 del 9,2 per cento (+5,6 miliardi) mentre nel 2021 la voce di spesa si contrae dell’1 per cento (-0,7 miliardi). L’incidenza di tali spese rispetto al Pil si accresce quindi di circa 0,6 punti percentuali nel 2020 arrivando al 4 per cento per poi ridursi al 3,7 per cento nel 2021, come evidenziato dalla seguente rappresentazione grafica.
Figura 14 - Spesa in conto capitale: confronto tra Nota tecnico-illustrativa 2020 e DEF 2020
(milioni di euro - %PIL)
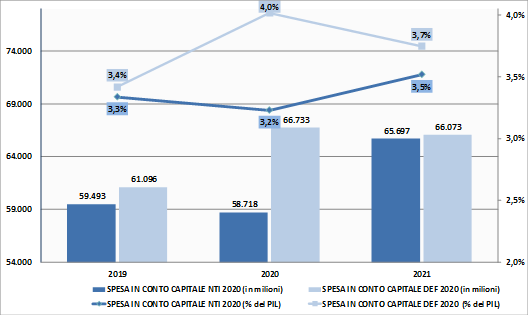
Rispetto alla NTI, nel 2020 lo scostamento più rilevante nella nuova previsione riguarda la voce dei contributi agli investimenti (+ 4,9 miliardi circa) e quella delle altre uscite in conto capitale (+2 miliardi circa), sulle quali incidono particolarmente gli interventi previsti dal DL 18/2020.
Con riferimento alle nuove previsioni formulate, il DEF segnala che, nell’ambito dell’aggregato complessivo delle spese in conto capitale la spesa per gli investimenti fissi lordi aumenta di 1,1 miliardi nel 2020 e di 4,7 miliardi nel 2021; in tal modo l’incidenza, rispetto al PIL, di tale voce di spesa passa dal 2,3 del 2019 al 2,6 per cento del 2021.
IL DEF evidenzia che la dinamica degli investimenti fissi lordi risente delle proiezioni per Anas e delle ulteriori risorse stanziate per il rilancio degli investimenti con la legge di bilancio per il 2020. Inoltre, la stima sconta gli introiti del piano straordinario di dismissioni contabilizzati a riduzione della spesa per investimenti per 987 milioni nel 2020 e 150 milioni nel 2021.
Su base annua è prevista dapprima una riduzione del ritmo di crescita (dal 7,2 per cento del 2019 al 2,7 per cento del 2020, cui segue un’accelerazione (+11,2 per cento) nel 2021. Il DEF rileva che l’andamento è sostanzialmente allineato alle ultime previsioni ufficiali della NADEF 2019.
Sarebbe peraltro utile un chiarimento riguardo agli scostamenti, in valore assoluto, rispetto alle stime NTI 2020, che vedono un aumento di circa 1,1 miliardi nel 2020, seguito nel 2021 da una riduzione per circa 0,8 miliardi.
I contributi agli investimenti, invece, dopo una crescita di circa 4,2 miliardi nel 2020 si contraggono di 3,9 miliardi nel 2021, per il venir meno delle misure di carattere temporaneo recate dal DL 18/2020. Al termine del periodo di previsione l’incidenza rispetto al PIL di tale voce di spesa rimane inalterata rispetto al dato del 2019 pari allo 0,8 per cento.
Le altre uscite in conto capitale registrano un contenuto aumento nel 2020 (+0,3 miliardi) per poi ridursi di quasi 1,4 miliardi nel 2021, con un’incidenza sul PIL che passa dall’0,4 per cento allo 0,3 per cento nel corso del biennio 2020-2021 per effetto sia degli interventi previsti dal decreto legge n. 18/2020, sia del venir meno di alcune voci temporanee di spesa presenti nell’anno 2019.
Dai dati di consuntivo per il 2019, la spesa per interessi risulta pari a 60.305 milioni, con una riduzione rispetto al dato del 2018, di circa 4,3 miliardi. In termini di Pil la spesa si colloca, nel 2019, al 3,4 per cento, rispetto al 3,7 per cento del 2018.
Dal confronto con le precedenti stime (NTI 2020) si osserva un valore inferiore di circa 1 miliardo rispetto a quello indicato per il 2019.
Il DEF precisa che la spesa per interessi si è confermata in riduzione per il settimo anno consecutivo: la riduzione rispetto alle precedenti stime riflette un andamento più favorevole dei tassi, in particolare nella seconda meta? dell’anno, e dell’inflazione. L’incidenza della spesa per interessi sul Pil è scesa dal 3,7 per cento del 2018 al 3,4 per cento nel 2019, al di sotto dell’obiettivo fissato nel DEF di aprile scorso (3,6 per cento del Pil).
Per quanto attiene alle previsioni per gli anni 2020 e 2021, l’andamento stimato indica un aumento su base annua della spesa per interessi più contenuto nel primo anno (circa 300 milioni) e di maggiore rilevanza (ulteriori 2,8 miliardi) nel 2021, anno nel quale la spesa raggiunge il valore di 63.470 milioni.
In termini di incidenza sul Pil, la spesa presenta un andamento costante, attestandosi su un valore di 3,6 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021, tenuto conto della dinamica relativa al denominatore del rapporto.
Il DEF precisa che la dinamica indicata riflette sia dell’andamento ipotizzato per i tassi di interesse, sia l’incremento delle emissioni nel corso del 2020.
Rispetto alle precedenti stime, si osserva che le nuove previsioni assumono, per tutto il periodo considerato, valori superiori rispetto a quelli della Nota tecnico illustrativa riferita al testo approvato della legge di bilancio 2020, sia in termini assoluti che di incidenza rispetto al Pil, come risulta dalla seguente tabella.
Tabella 19 - Spesa per interessi: confronto tra Nota tecnico illustrativa 2020 e Documento di economia e finanzia 2020
(Importi in milioni di euro. In corsivo i valori percentuali)
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
| DEF 2020 |
|
|
|
| Spesa per interessi |
60.305 |
60.628 |
63.470 |
| Variazione assoluta annua |
-4.316 |
323 |
2.842 |
| Variazione % |
-6,7 |
0,5 |
4,7 |
| In % del Pil |
3,4 |
3,6 |
3,6 |
| Pil nominale |
1.787.664 |
1.661.432 |
1.763.459 |
|
|
|
|
|
| NTI 2020 |
|
|
|
| Spesa per interessi |
61.316 |
59.210 |
57.542 |
| Variazione assoluta annua |
- 3.305 |
-2.106 |
- 1.668 |
| Variazione % |
-5,5 |
-3,4 |
-2,8 |
| In % del Pil |
3,4 |
3,3 |
3,1 |
| Pil nominale |
1.783.142 |
1.817.985 |
1.867.901 |
Fonte: elaborazione su dati della NTI e del DEF2020.
Nel grafico che segue si evidenzia l’andamento della spesa per interessi per tutto il periodo considerato (2019-2021) ed il raffronto, in termini assoluti ed in percentuale del Pil rispetto alla NTI 2020.
Figura 15 – Spesa per interessi confronto tra DEF 2020 e NTI 2020
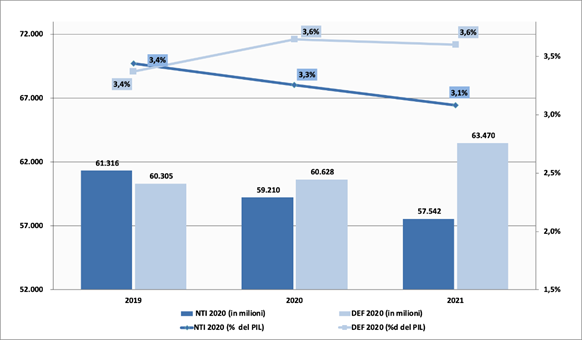
Nella seguente tabella si riportano i dati forniti dal DEF riferiti alle ipotesi utilizzate riguardo all’andamento dei tassi di interesse a breve e a lungo termine.
Tabella 20 - Ipotesi utilizzate per i tassi di interesse
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
| Tasso di interesse a breve termine |
n.d. |
0,37 |
0,92 |
| Tasso di interesse a lungo termine (media annuale) |
1,94 |
1,43 |
2,00 |
Fonte: DEF 2020
Nota: Per tasso di interesse a breve termine si intende la media dei tassi previsti sui titoli di Stato a 3 mesi in emissione durante l'anno. Per tasso di interesse a lungo termine si intende la media dei tassi previsti sui titoli di Stato a 10 anni in emissione durante l'anno.
Il Documento fornisce, infine, in soli termini di incidenza rispetto al Pil, i valori della spesa per interessi programmatica. In particolare, viene previsto che la stessa si attesti su un valore pari a 3,7 punti percentuali di Pil sia nel 2020 che nel 2021.
Non sono tuttavia forniti i dati in valore assoluto né elementi di dettaglio in merito allo scostamento rispetto ai valori tendenziali. Si ritiene che lo stesso derivi dal previsto andamento del debito in relazione alle nuove politiche introdotte, cui si rinvia (cfr. capitolo 2)
Il DEF 2020, in conformità all’art. 10 della legge n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, offre anche un quadro rappresentativo delle stime dei principali aggregati di finanza pubblica definite secondo il criterio delle “politiche invariate”, che sono così definite.
Tabella 21 - Scenario a politiche invariate (1)
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
| Livello (2) |
In % del PIL |
In % del PIL |
In % del PIL |
|
| Totale entrate a politiche invariate |
841.441 |
47,1 |
47,7 |
48,0 |
| Totale spesa a politiche invariate |
870.742 |
48,7 |
54,8 |
52,5 |
| Voci di dettaglio della spesa Spese correnti di cui: Redditi da lavoro dipendente Consumi intermedi
Spese in c/capitale di cui: Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti |
809.646
173.253 148.221
61.096
40.494 14.189 |
45,3
9,7 8,3
3,4
2,3 0,8 |
50,8
10,6 9,3
4,0
2,5 1,1 |
48,6
10,3 8,7
3,9
2,8 0,9 |
(1) La tabella espone solo l’impatto del rifinanziamento delle spese indifferibili.
(2) Valori in milioni.
Fonte: DEF 2020 – Sez. I
La valutazione degli andamenti a politiche invariate è effettuata in conformità ai criteri indicati dalla Commissione europea ed è funzionale alla verifica del rispetto delle regole del Patto di Stabilita? e Crescita. Resta fermo in ogni caso il riferimento al criterio della legislazione vigente per la definizione del quadro su cui si fondano le previsioni di bilancio e di finanza pubblica, e la valutazione della manovra necessaria a realizzare gli obiettivi stabiliti in sede europea.
La Commissione europea ha fornito indicazioni metodologiche (cfr. Report on Public Finances in EMU – 2016) per la definizione delle misure che rientrano nella definizione delle politiche invariate e per l’elaborazione delle relative stime. Per quanto attiene al primo aspetto, in base a tali criteri vanno considerate quelle misure che sono specificate con sufficiente dettaglio, sono state adottate o almeno credibilmente annunciate e hanno un impatto diretto incrementale sul bilancio. Per quanto attiene ai criteri di stima, si fa riferimento, tra l’altro, alla necessità di estrapolare trend storici di entrata e spesa e le loro interrelazioni, avendo dovuto riguardo per le recenti dinamiche delle variabili in considerazione, nonché all’esigenza che le ipotesi di politiche invariate si riflettano non solo nelle stime di finanza pubblica ma anche nel quadro previsivo macroeconomico.
In proposito, per quanto attiene alla tipologia di misure considerate, il Documento evidenzia che sono state considerate le misure che, benché non ancora finanziate, risultano prefigurate in modo credibile, rilevando in proposito che lo scopo delle stime a politiche invariate della Commissione è di indicare “la dimensione delle misure di policy che devono ancora essere specificate e credibilmente annunciate per raggiungere gli obiettivi di bilancio”.
Per quanto attiene ai criteri di formulazione delle previsioni, il DEF evidenzia che, rispetto ai prospetti solitamente presentati, l’orizzonte di previsione è limitato all’anno 2021. Inoltre, si prescinde dal confronto con gli andamenti storici delle entrate e delle spese, poco significativo considerato il particolare momento economico e gli interventi di sostegno messi in campo. Infine, il DEF segnala che le ipotesi di politiche invariate si dovrebbero riflettere anche nel quadro previsivo macroeconomico.
In termini differenziali rispetto alle previsioni a legislazione vigente, le stime a politiche invariate sono così rappresentate:
Tabella 22 - Conto economico delle Amministrazioni pubbliche nello scenario a politiche invariate
(in milioni di euro)
|
|
Previsioni a legislazione vigente |
Differenziale politiche invariate |
||
|
Totale entrate In % del PIL |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
| 792.773 47,7 |
846.690 48,0 |
0 0,0 |
0 0,0 |
|
| Totale spese In % del PIL |
910.743 54,8 |
921.613 52,3 |
0 0,0 |
4.753 0,3 |
| Spese correnti di cui Redditi da lavoro dipendente Consumi intermedi |
844.011
175.571 154.056 |
855.541
180.869 152.943 |
0
0 0 |
1.503
335 598 |
| Spese in c/capitale di cui Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti |
66.733
41.580 18.409 |
66.073
46.238 14.462 |
0
0 0 |
3.250
2.410 840 |
Fonte: DEF 2020 – Sez.II
A fronte degli andamenti a legislazione vigente prima esposti (cfr. capitolo 1.2), lo scenario a politiche invariate indica la necessità di finanziare incrementi di spese nella misura dello 0,3 per cento in termini di Pil: si tratta in prevalenza di spese in conto capitale (3,25 miliardi circa) mentre più contenuta è l’esigenza di finanziamento relativa alle spese correnti (1,5 miliardi).
Il conseguente impatto sul deficit non è univocamente determinabile in quanto condizionato dalle modalità di finanziamento che saranno individuate, potendo risultare nullo in caso di copertura delle predette spese a valere su riduzioni di altre spese o su maggiori entrate. Si rileva infatti che le previsioni a politiche invariate hanno carattere indicativo in quanto necessitano, per il relativo finanziamento, di specifiche decisioni da assumere in via legislativa, per lo più nell’ambito della manovra di finanza pubblica, sulla base del reperimento delle relative risorse e, comunque, in conformità agli obiettivi programmatici deliberati dal Parlamento.
Il DEF non indica in dettaglio i principali interventi da rifinanziare, ma precisa che si tratta di spese legate alla continuità di alcuni interventi pubblici o al funzionamento dell’amministrazione pubblica per le quali sia prevista una espressa previsione normativa.
I Documenti presentati nei precedenti esercizi fanno per lo più riferimento a rifinanziamenti cui dar corso in considerazione di impegni internazionali o fattori legislativi (generalmente missioni di pace, spese per pubblico impiego, investimenti). Per quanto attiene alle spese di personale, i relativi oneri sono definiti sulla base di ipotesi tecniche tenendo conto altresì dei c.d. “effetti indotti” di maggiore entrata per ritenute fiscali e contributive.
In proposito sarebbero utili indicazioni di maggior dettaglio riguardo alla tipologia di interventi considerati ai fini delle stime a politiche invariate: ciò anche al fine di verificare se la mancata indicazione di valori differenziali in termini di entrate rispetto allo scenario a legislazione vigente dipenda dalla mancata previsione di maggiori spese in materia di retribuzioni del pubblico impiego (cui sono generalmente associate maggiori entrate tributarie e contributive) ovvero se detti effetti siano stati considerati, ma portati a riduzione delle medesime spese (valori netti).
Il DEF precisa tuttavia che lo scenario a politiche invariate non include “le nuove politiche annunciate dal Governo per rafforzare le misure a sostegno di famiglie e imprese in risposta alla pandemia.”.
In proposito si rinvia al successivo capitolo relativo al quadro di finanza pubblica che include le nuove politiche.
Oltre alle nuove previsioni tendenziali, il DEF riporta il quadro di finanza pubblica “con le nuove politiche”, rappresentato nella tabella che segue:
Tabella 23 – Indicatori di finanza pubblica in percentuale del PIL(1)
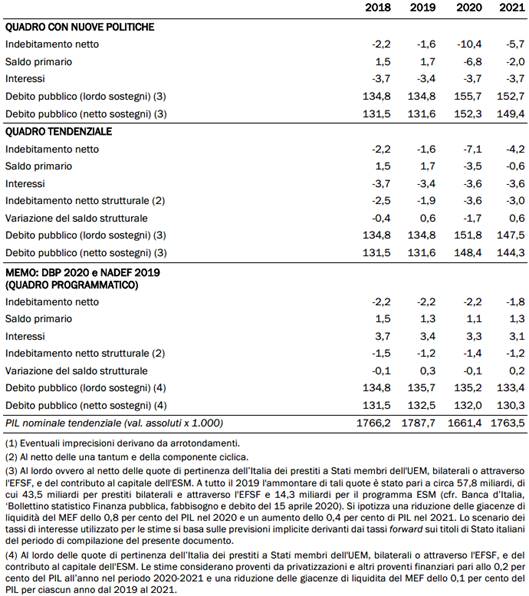
Fonte: DEF 2020 sezione I, tavola I.2, pag. 18.
I valori riportati nel quadro includono gli effetti dei prossimi provvedimenti che il Governo intende adottare. In conseguenza di tali misure l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche nel 2020 salirà al 10,4 per cento del PIL, rispetto al 7,1 per cento indicato nella previsione tendenziale aggiornata.
Nel 2021, per effetto delle nuove politiche, il saldo passerà dal valore tendenziale di 4,2 al 5,7 per cento in termini di Pil.
Il peggioramento del saldo corrisponde agli effetti stimati del nuovo provvedimento in fase di predisposizione, il cui impatto sull’indebitamento netto è indicato nel DEF in misura pari a circa 55,3 miliardi nel 2020 (3,3 per cento in termini di Pil) e in 26,2 miliardi nel 2021 (circa 1,5 per cento in termini di Pil).
La finanza pubblica è regolata dal cosiddetto braccio preventivo (preventive arm) del Patto di stabilità e crescita: in base a tale patto, gli Stati membri predispongono e aggiornano periodicamente i rispettivi programmi di stabilità, con i quali presentano il percorso di aggiustamento necessario per il conseguimento dell'obiettivo di medio termine (OMT) della finanza pubblica. Tale obiettivo è espresso in termini di valore del saldo di bilancio strutturale, il quale si calcola sottraendo dal saldo nominale del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni (indebitamento/accreditamento netto) la componente dovuta al ciclo economico, le misure temporanee e quelle una tantum[30].
La Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) 2019 ha rideterminato il piano di rientro verso l’OMT. Si ricorda che per l’Italia, l’OMT è il pareggio di bilancio. In particolare, il governo ha ridisegnato l’approccio di policy prevedendo un raggiungimento graduale dell’OMT a partire dal 2021. Nella NADEF 2019 l’indebitamento netto era fissato al 2,2% del PIL nel 2019, al 2,2% nel 2020 e all’1,8% nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante al -1,7% del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
Al fine di valutare la coerenza delle correzioni del saldo strutturale con le regole europee, si tiene conto dell'output gap, che misura la posizione ciclica di un’economia sulla base della differenza tra il tasso di crescita del PIL reale e quello del PIL potenziale. Il percorso di miglioramento progressivo del saldo di bilancio strutturale verso l’OMT si fonda sulle regole di aggiustamento fiscale definite dalla Commissione europea che tengono conto del calcolo effettivo dell’output gap, della crescita potenziale e del livello di debito.
A seguito dell’emergenza sanitaria per il COVID-19, il DEF 2020 prevede per gli anni successivi un drammatico ridimensionamento delle aspettative di crescita rispetto a quanto ipotizzato nel dicembre del 2019. I provvedimenti di restrizione all’attività produttiva, il successivo mantenimento del distanziamento sociale e la caduta del commercio internazionale provocheranno una diminuzione del PIL nel 2020 pari a -8%. L’anno successivo si prevede un aumento pari a +4.7% (Tabella 24).
Ciò ha portato all’attivazione della General Escape Clause, mai prima utilizzata. In particolare, è stata concessa per il 2020 piena flessibilità rispetto a tutte le spese legate all’emergenza in corso[31]. Tale evento modifica l’approccio consueto alla valutazione del percorso dell’Italia verso l’OMT (si veda il paragrafo 2.2).
L’ISTAT ha comunicato all’EUROSTAT a fine marzo che l’indebitamento netto della PA per il 2019 si attestava all’1,6% del PIL con un miglioramento di 0,6% rispetto al 2.2% fissato nella NADEF 2019 e di 0,8% rispetto al DEF 2019 per effetto delle migliorate entrate tributarie rispetto alle stime di settembre e la revisione del PIL nominale del 2019 di circa 3,8 miliardi. In assenza dell’emergenza sanitaria si sarebbe attestato nel 2020 a non oltre il 1,8% anche in virtù del buon andamento delle entrate tributarie dei mesi di gennaio e febbraio 2020. L’avanzo primario del 2019 è stato del 1,7% migliore di quanto previsto nella NADEF 2019 (1,3%).
Come si evince dalla Tabella 24, il quadro di finanza pubblica per il 2020 risente degli eventi della prima parte dell’anno. In conseguenza dell’emergenza sanitaria, per il 2020 si prevede che il maggior deficit raggiunga il 4,1% del PIL. Ne consegue che l’indebitamento netto tendenziale aumenterà al -7,1% e che il saldo primario si attesti a -3,5% del PIL. Nel 2021, complice la ripresa del PIL e la sospensione di alcuni provvedimenti di sostegno, l’indebitamento netto tendenziale migliorerebbe al -4,2 per cento del PIL, risultante da un deficit primario del -0,6%. In entrambi gli anni la spesa per interessi si attesterebbe al 3.6% del PIL.
Lo scenario potrebbe risultare ancor più sfavorevole a fronte dei consueti rischi, quali l’andamento del greggio, la variazione dei tassi di cambio oppure il deterioramento della dinamica del commercio internazionale. Il documento in esame prevede anche uno scenario di recrudescenza autunnale della pandemia (Tabella 23). Si renderebbero necessarie, in questo caso, nuove misure restrittive alle attività produttive ed alla mobilità degli individui. In questo scenario la caduta del PIL si attesterebbe al -10,6% per il 2020 e la ripresa del 2021 sarebbe ridotta al 2,3%. In termini di finanza pubblica, il nuovo scenario non fornisce una precisa stima del rapporto deficit/Pil che si realizzerebbe, ma ipotizza che questo peggiori di 0,4 p.p. per ciascun punto di PIL perso.
Il quadro tendenziale va integrato alla luce delle urgenti misure che il governo sta approntando per fronteggiare l’emergenza sanitaria e le sue conseguenze. In particolare le misure sono orientate all’esigenza di aumentare ulteriormente le risorse per il sistema sanitario, la protezione civile e la sicurezza pubblica. Inoltre si rifinanzieranno ed estenderanno i sostegni ai redditi dei lavoratori e degli imprenditori più colpiti dalla crisi, all’occupazione, alla liquidità delle imprese e all’erogazione di credito all’economia.
Sarà prevista, inoltre, la soppressione degli aumenti dell’IVA e delle accise previsti dalla legislazione vigente per il 2021 e gli anni seguenti. Va sottolineato che una volta inclusi gli effetti del nuovo decreto, la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 per cento nel 2020 e al 41,4 per cento nel 2021 al netto del beneficio degli 80 euro mensili (che diventeranno 100 con il taglio del cuneo fiscale sul lavoro già legiferato). Un ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale, sarà dedicato a una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati. In questo nuovo scenario, valutabile dalla Tabella 23, l’indebitamento netto aumenterebbe a -10,4% e il saldo primario al -6,8% nel 2020 per effetto anche di una rimodulazione del tasso di crescita del PIL tendenziale validato dall’UPB[32].
Tabella 24 - La finanza pubblica corretta per il ciclo (in percentuale del PIL)
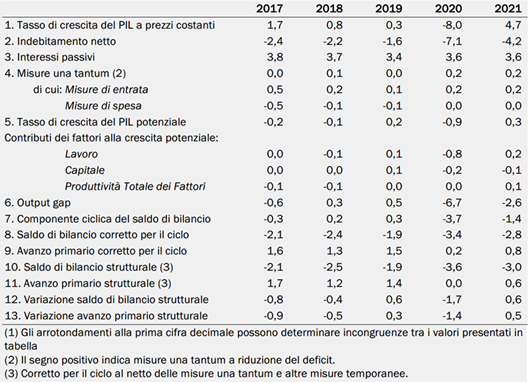
Fonte: DEF 2020, sezione I, tavola R.I pag. 84.
La sezione III.2 del DEF 2020 si apre con la premessa secondo cui è indubbio che l’analisi degli andamenti del saldo strutturale di bilancio e la valutazione di conformità rispetto alle regole fiscali europee quest’anno avvengano in un contesto nuovo e senza precedenti, anche se già contemplato dalle norme vigenti.
L’Italia è soggetta al braccio preventivo (preventive arm) del Patto di stabilità e Crescita (PSC). L’articolo 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è la base legale del braccio preventivo del PSC. Stabilisce una procedura di sorveglianza multilaterale basata sugli indirizzi di massima per le politiche economiche, che definiscono il contesto generale di valutazione delle politiche degli Stati membri. Politiche economiche che sono ritenute incoerenti con tali linee guida o che rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, possono portare a procedure di infrazione secondo l’articolo 121 (4) del TFUE.
In base alle regole del braccio preventivo ciascun paese ha un obiettivo di medio termine. Specificamente, l'Italia deve definire una strategia economico-finanziaria per raggiungere il pareggio di bilancio strutturale che rappresenta l’obiettivo di medio termine (OMT) del Paese. Questo percorso viene valutato sulla base della compliance dello stato membro rispetto a due criteri: la variazione del saldo strutturale e la regola di spesa. Essi variano in funzione della congiuntura economica, della deviazione dalla crescita potenziale e dal livello del debito pubblico. Sono pertanto criteri che possono variare nel tempo e tra paesi.
La valutazione della compliance si basa su un'analisi dei dati presentati nel Patto di Stabilità e Crescita e nei documenti programmatici di bilancio (DBP) e su una valutazione del rischio in base alle previsioni della Commissione Europea.
Per stabilire la coerenza del percorso che porta al pareggio di bilancio il primo criterio oggetto di valutazione è la variazione del saldo strutturale (di seguito: correzione) cioè la differenza tra il saldo strutturale dell'anno considerato rispetto al precedente.
La correzione richiesta è determinata attraverso una matrice che tiene conto del rapporto debito/Pil, del rischio di sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio periodo e della congiuntura economica del paese[33]. Livelli del rapporto debito/Pil maggiori del 60% impongono correzioni più marcate mentre le fasi congiunturali negative attenuano lo sforzo fiscale richiesto al Paese. A titolo esemplificativo, in presenza di una congiuntura neutrale e di un rapporto debito/Pil superiore al 60% la correzione richiesta è maggiore di 0,5 punti percentuali di Pil. In tal caso, l'indebitamento netto strutturale dovrebbe quindi ridursi rispetto al livello dell'anno precedente di oltre 0,5 p.p. di Pil. In caso di congiuntura negativa un paese con oltre il 60% di rapporto debito/Pil deve attuare una correzione di 0,25 p.p. se la crescita si trova al di sotto del potenziale oppure di 0,5 p.p. se si trova al di sopra del potenziale di crescita.
La correzione richiesta può essere ridotta nel caso in cui le istituzioni europee riconoscano in favore del paese: l'applicazione delle cosiddette "clausole di flessibilità" per tener conto delle riforme strutturali e degli investimenti (che nel medio/lungo termine dovrebbero migliorare le prospettive di crescita del paese che li pone in essere); la presenza di eventi non usuali al di fuori del controllo del paese, quali ad esempio gravi recessioni o calamità naturali, o ancora di fenomeni migratori di portata tale da determinare un aumento involontario della spesa del paese.
Tale regola varia in funzione della posizione relativa del paese rispetto all’OMT. Se il paese si trova sul suo OMT, la crescita della spesa annuale non dovrebbe superare il tasso di crescita di riferimento del PIL potenziale a medio termine, a meno che l'eccesso di spesa non sia accompagnato da misure discrezionali di entrate tali da consentire allo Stato Membro di rimanere sul suo OMT. Nel caso di paesi che non hanno ancora raggiunto l’OMT, la crescita della spesa annuale non dovrebbe superare un livello specificatamente individuato e da collocarsi al di sotto del tasso di crescita di riferimento del PIL potenziale a medio termine a meno che l’eccesso non sia compensato da entrate appropriate. In aggiunta ogni riduzione fiscale discrezionale deve essere compensata con eguale riduzione delle spese o incremento di altre entrate.
Poiché l'Italia non ha ancora raggiunto il pareggio di bilancio strutturale (il proprio OMT) la spesa pubblica italiana[34] dovrebbe crescere a un tasso pari al massimo alla differenza tra il tasso di crescita di medio termine del PIL potenziale[35] e il cosiddetto margine di convergenza[36]
Indebitamento netto strutturale e obiettivo di medio termine
L'indebitamento netto strutturale è definito nel seguente modo: indebitamento netto (la differenza tra entrate e uscite, compresa la spesa per interessi, delle amministrazioni pubbliche), corretto per il ciclo economico (le oscillazioni del Pil attorno a un teorico andamento di lungo periodo) al netto delle misure una tantum e temporanee e al netto delle spese effettuate su programmi di spesa della UE finanziati con fondi della UE stessa. Si noti inoltre che le spese per investimento finanziate con fondi nazionali sono spalmate su 4 anni.
La correzione per il ciclo economico è coerente con la logica di garantire nel medio-lungo periodo la sostenibilità delle finanze pubbliche. Infatti, si ritiene che un paese che attraversa una fase negativa del ciclo economico potrebbe registrare un indebitamento netto più elevato di quanto desiderabile al fine di sostenere l'economia, viceversa in una fase positiva dovrebbe migliorare lo stato di salute delle proprie finanze più di quanto richiesto in una fase neutrale, per trovarsi così in condizioni più solide laddove il ciclo economico dovesse peggiorare.
L'esclusione delle misure una tantum e temporanee evita di tener conto di entrate e uscite che hanno effetti transitori sul bilancio pubblico (uno o pochi esercizi) e che, dunque, non producono cambiamenti duraturi sui saldi strutturali.
Nelle raccomandazioni specifiche rivolte all’Italia adottate dal Consiglio Europeo a luglio 2019, la programmazione di bilancio per il 2020 avrebbe dovuto assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 per cento nel 2020 e un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 per cento del Pil[37].
Rispetto alla valutazione di compliance con gli obiettivi di finanza pubblica, in virtù dell’emergenza sanitaria COVID-19, il DEF 2020 ritiene che sia formalmente corretto valutare il solo anno 2019 e trattare separatamente il biennio 2020-2021.
Nel luglio del 2018, la Commissione aveva suggerito all’Italia di convergere verso l’OMT (pareggio di bilancio) con un aggiustamento annuo dello 0,6% del saldo strutturale ed un tasso di crescita della spesa non superiore allo 0,1%. Nello stesso anno a causa degli eventi avversi (Ponte Morandi e calamità climatiche) su richiesta del Governo era stata accordata una flessibilità di 0,2 p.p. sull’aggiustamento ridimensionata poi allo 0,175 dalla Commissione. Considerato il percorso verso l’OMT (aggiustamento di 0.6%), la flessibilità (0,175) e dato il miglioramento dell’indebitamento netto di 0.6% l’Italia è risultata pienamente compliant rispetto all’OMT del 2019 (Tabella 25Tabella 25).
Per contro, si segnala una deviazione significativa rispetto al percorso indicato dalla regola della spesa. La regola, infatti, avrebbe richiesto un aumento nominale dell’aggregato di spesa “rilevante” non superiore a 0,5 per cento, mentre il tasso di crescita effettivo è stato di 1,5 per cento. La deviazione risulta significativa anche considerando il criterio biennale della regola.
Seguendo la normale procedura, la valutazione dovrebbe essere effettuata avvalendosi delle stime macroeconomiche e di finanza pubblica rilasciate dai servizi della Commissione e riguarderebbe il seguente arco temporale: i) ex post il 2019, sulla base dei dati consuntivi di finanza pubblica come si è fatto nelle righe precedenti; ii) ad interim il 2020, utilizzando le informazioni già disponibili e le previsioni sull’anno in corso e iii) ex ante, i prossimi tre anni di programmazione 2021 – 2023.
È necessario premettere che la pandemia da COVID-19 ha portato ad una caduta senza precedenti dell’attività economica in tutta l’Unione europea; ciò ha portato all’attivazione della General Escape Clause, mai prima utilizzata. In particolare, è stata concessa per il 2020 piena flessibilità rispetto a tutte le spese legate all’emergenza in corso[38]. Tale evento modifica l’approccio consueto alla valutazione del percorso dell’Italia verso l’OMT.
Nel 2020 le spese sostenute dal governo in ottemperanza ai decreti di marzo e dell’8 aprile per fronteggiare l’emergenza sanitaria saranno tutte soggette a flessibilità; in termini di percentuali di Pil si ha una spesa pari all’1,2 per cento. Aggiungendo un ammontare pari allo 0,2 per cento per le spese di messa in sicurezza del territorio si giunge a circa 1,4 punti percentuali di Pil. Si ricorda che anche le nuove politiche annunciate dal Governo saranno soggette a flessibilità (cfr. infra 2.4).
Si tenga anche presente che alcune poste di finanza pubblica sono escluse dal computo del saldo strutturale; per il 2020 queste misure una tantum ammontano a circa 3,2 miliardi di euro ossia 0,2 punti percentuali di Pil. In particolare, 1,6 miliardi di minori entrate legate agli introiti da imposte sostitutive varie, e 0,7 miliardi alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Le maggiori spese per 1,2 miliardi sono legate ad interventi specifici per calamità naturali.
Dalla Tabella 25 si evince che l’Italia violerà la regola del deficit (3%) ma tale violazione non produrrà alcuna sanzione a patto che la flessibilità sia appropriatamente utilizzata.
La variazione del saldo di bilancio strutturale peggiorerà di -1.7% nel 2020 (nel 2019 la variazione era stata +0.6) per poi migliorare nel 2021 di +0.6%. Tuttavia, a fronte della flessibilità per l’emergenza COVID-19, l’andamento di finanza pubblica risulta compatibile con l’OMT (Tabella 25). In particolare, con riferimento al percorso di aggiustamento strutturale verso l’OMT, nel 2020 l’Italia risulterebbe in deviazione non significativa sia sulla variazione annuale (-0,29 p.p.) che su quella biennale (-0,08) richieste; nel 2021, la variazione annuale è in piena compliance (+0,1 p.p), mentre quella biennale riporta una deviazione non significativa (-0.1 p.p.).
Per quanto riguarda la regola della spesa, per il 2020, nello scenario a legislazione vigente l’Italia risulterebbe pienamente compliant sul criterio annuale e in deviazione non significativa su quello biennale; infine, nel 2021 risulterebbe ampiamente in linea con l’attuale disciplina.
Tabella 25 – Deviazioni significative
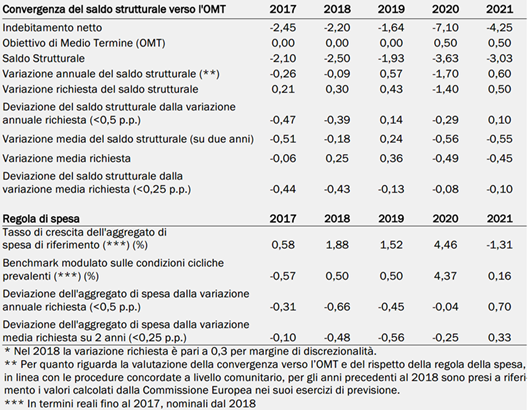 Fonte: DEF 2020, sezione I, tavola R 2.
Fonte: DEF 2020, sezione I, tavola R 2.
Con la Comunicazione sulla flessibilità del Patto di stabilità e crescita (PSC) del 13 gennaio 2015[39], la Commissione europea ha chiarito le modalità e le condizioni di utilizzo di margini di flessibilità, che consentono deviazioni temporanee dall’obiettivo a medio termine (OMT) o dal percorso di avvicinamento al medesimo, nell’ambito delle regole vigenti del PSC.
Tale flessibilità è, in particolare, riconosciuta per l’adozione di riforme strutturali e per gli investimenti pubblici (“clausole di flessibilità”). L’aggiustamento di bilancio richiesto è inoltre modulato in relazione all’andamento del ciclo economico, secondo i criteri fissati nella Comunicazione.
La posizione comune formalmente approvata dal Consiglio ECOFIN nel febbraio 2016[40] ha introdotto alcuni elementi di novità rispetto alla Comunicazione della Commissione in materia di flessibilità del gennaio 2015. In particolare:
· è stata precisata l’applicabilità della clausola per gli investimenti a progetti di investimento cofinanziati dai diversi Fondi strutturali e di investimenti europei;
· è stata indicata una misura massima dello 0,5 per cento del PIL alla deviazione dal percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine consentita per la clausola degli investimenti, in analogia a quanto previsto per la clausola delle riforme;
· è stato previsto un limite massimo dello 0,75 per cento alla deviazione complessiva che si ottiene cumulando le due clausole.
Il Patto di stabilità e crescita prevede inoltre un’ipotesi di allontanamento temporaneo nel percorso di avvicinamento all’OMT (soggetto ad autorizzazione) in caso di “eventi eccezionali”[41].
Il Vademecum della Commissione europea sul PSC[42] ricorda che questa ipotesi, definita di adeguamento del percorso di consolidamento di bilancio, è stata introdotta dal Six pack nel 2011 e chiarisce che l’attivazione di questa clausola non si traduce in una sospensione a tempo indefinito del consolidamento delle finanze pubbliche, bensì nella riprogettazione del percorso di avvicinamento, su basi specifiche per il singolo Paese, al fine di tener conto delle circostanze eccezionali di una grave crisi economica nell’area euro o nell’Unione, come pure di un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato. In tali circostanze, dunque, le descritte deviazioni temporanee possono essere consentite ex ante (ai sensi dell’articolo 5 citato) oppure possono non essere prese in considerazione ex post (ai sensi dell’articolo 6 citato).
Per consentire agli Stati di contrastare adeguatamente l’impatto economico e sociale prodotto dalla pandemia del Covid-19, già dalla sua prima comunicazione del 13 marzo 2020, la Commissione Europea ha affermato di voler fare pienamente uso di tutti gli strumenti messi a disposizione dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC). In particolare, la Commissione ha rassicurato gli Stati che le misure di sostegno, quali quelle necessarie a 1) contenere e trattare la pandemia, 2) garantire liquidità alle imprese e ai settori più colpiti, e 3) proteggere i posti di lavoro e i redditi dei lavoratori interessati, possono essere considerate spese una tantum e come tali possono essere escluse dal calcolo del saldo strutturale. L’Eurogruppo del 16 marzo 2020 ha poi ribadito la comune visione sull'applicazione del PSC e che verrà utilizzata tutta la flessibilità consentita per agevolare una risposta fiscale adeguata allo shock economico. Allo stesso modo, le misure
temporanee una tantum adottate in risposta al COVID-19 saranno escluse dal calcolo del saldo strutturale. Infine, il Consiglio conferma che la situazione è tale da giustificare la richiesta di flessibilità per far fronte ad eventi eccezionali.
Nella sua comunicazione al Consiglio Europeo del 20 marzo 2020 la Commissione ha chiarito che la clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure del PS e, fornendo una nuova e diversa indicazione rispetto alla comunicazione del 13 marzo, suggerisce agli Stati Membri di considerare le misure adottate per rispondere all’emergenza Covid-19 come misure strutturali rientranti nell’ambito di applicazione della clausola generale di salvaguardia[43]. Nella loro dichiarazione congiunta del 23 marzo i Ministri delle Finanze degli Stati Membri al Consiglio Europeo dichiarano di condividere l’analisi della Commissione e sostengono l’attivazione della clausola di salvaguardia generale. Per continuare ad agire all’interno del quadro di coordinamento previsto dal PSC, la Commissione ha concordato con gli Stati Membri delle linee guida per la predisposizione dei Programmi di Stabilità o di Convergenza il cui invio è previsto per il 30 aprile di ogni anno.
La Tabella 26 fornisce i dati relativi alla flessibilità accordata all'Italia con il dettaglio relativo alla flessibilità per eventi eccezionali.
A partire dal 2017 l’Italia ha goduto di flessibilità accordata per attivazione delle clausole di eventi non usuali ovvero per i rifugiati (0,16%) e la messa in sicurezza del territorio (0,19%) oltre ad un aggiustamento stimato modificato per le clausole di flessibilità e di eventi non usuali (0,21%). Nel 2019 è stata accordata la flessibilità per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio pari a 0,18%. Tale flessibilità è quantificata in circa 2,1 miliardi di euro (0,12 per cento del PIL) con riferimento al contrasto al dissesto idrogeologico e in 1,1 miliardi di euro (0,06 per cento del PIL) con riferimento alla rete stradale.
Nel 2020 le spese sostenute dal governo in ottemperanza ai decreti di marzo e dell’8 aprile saranno tutte soggette a flessibilità, con un incremento di spesa pari all’1,2 per cento del Pil per Covid-19. Aggiungendo un ammontare pari allo 0,2 per cento per le spese di messa in sicurezza del territorio, si giunge a circa 1,4 punti percentuali di Pil.
Tabella 26 – Flessibilità accordata all'Italia nel Patto di stabilità
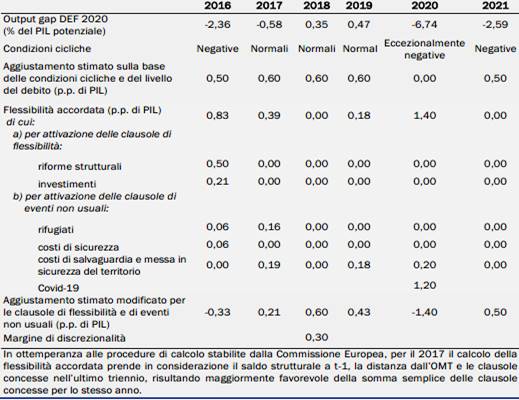
Fonte: DEF 2020, sezione I, tavola R 3.
Prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, il governo ha approvato il D.L. n. 32/2019 (cd. decreto Sblocca-cantieri) ove sono state introdotte modifiche al quadro normativo in materia di contratti e di progettazione. Sono state, inoltre, previste alcune misure temporanee, fino al 31 dicembre 2020, per consentire l’appalto integrato e procedure più snelle per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Governo, altresì, ha varato un piano straordinario di interventi tesi a contrastare il dissesto idrogeologico e ad adottare misure per la manutenzione straordinaria della rete viaria. Attraverso il Piano straordinario di interventi per mettere in sicurezza il territorio e la popolazione dai rischi collegati al dissesto idrogeologico (c.d. decreto ‘ProteggItalia’), varato il 20 febbraio 2019, è stato adottato il “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”. Per quanto attiene la spesa per il contrasto al rischio idrogeologico, si riscontra un incremento rispetto a quanto stanziato nel 2018 (698 milioni). Nel 2019, infatti, la spesa è stimata pari a circa 1,324 milioni di euro, relativi a oltre 10 mila interventi su tutto il territorio nazionale[44].
Il ProteggiItalia, inoltre, comprende modalità per l’avvio di interventi a immediata cantierabilità e una governance rafforzata del sistema. La spesa realizzata nel 2019 per nuovi progetti di manutenzione straordinaria della rete viaria ammonta a circa 1.884 milioni di euro, relativa a oltre 13 mila interventi su strade, ferrovie e connessioni intermodali tracciati nel Monitoraggio delle Opere Pubbliche. In conclusione, la spesa rendicontata è complessivamente in linea con le misure programmate per gli eventi eccezionali (3,2 miliardi di euro).
Per contrastare l’emergenza sanitaria e le ricadute economiche e sociali connesse all’evento epidemiologico, il Governo, tenuto anche conto dell’autorizzazione dello scorso mese di marzo del Parlamento ad aumentare per il 2020, rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF 2019, l’obiettivo di indebitamento netto fino a 20 miliardi corrispondenti a 25 miliardi di stanziamenti di bilancio, ha adottato diversi provvedimenti di urgenza (in particolare si tratta del D.L. 18/2020 e del D.L. 23/2020). I provvedimenti in questione intervengono su diverse direttrici. In primo luogo si prevede un potenziamento dell’intero sistema sanitario (circa 2,8 miliardi nel 2020).
A tutela dei lavoratori si prevedono risorse per circa 8,1 miliardi nel 2020. Nello specifico per i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza sanitaria si introducono disposizioni speciali per consentire la fruizione di trattamenti di integrazione salariale, attraverso l’istituto della cassa integrazione ordinaria e dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi. Il trattamento ordinario di integrazione salariale viene accordato anche alle aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria. A sostegno dei lavoratori dipendenti che non sono assicurati dalla cassa integrazione ordinaria e che non godono di tutele dei fondi di solidarietà si prevede, invece, un trattamento integrativo salariale (complessivamente circa 3,4 miliardi nel 2020). A beneficio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale Ago, dei lavoratori dipendenti del settore del turismo, degli operai agricoli che presentano particolari requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo è attribuita un’indennità una tantum per complessivi 2,9 miliardi nel 2020. Viene istituito il fondo per il reddito di ultima istanza per garantire misure di sostegno al reddito di lavoratori autonomi e dipendenti che in conseguenza dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro (0,3 miliardi nel 2020).
Apposite misure vengono introdotte per consentire l’assistenza dei figli in conseguenza dei provvedimenti di chiusura dei servizi dell’infanzia e delle scuole e per tutelare i lavoratori durante i periodi trascorsi in quarantena (circa 1,4 miliardi nel 2020).
Per sostenere la liquidità di imprese e famiglie si prevedono risorse per circa 5,1 miliardi nel 2020 così ripartite: 3,4 miliardi rifinanziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese; 0,4 miliardi per incrementare il fondo di solidarietà per i mutui prima casa; 1,3 miliardi circa per altri provvedimenti minori.
Altri interventi settoriali sono diretti ad assicurare la continuità delle imprese (circa 2 miliardi nel 2020). In ambito fiscale si assegnano risorse per circa 1,3 miliardi nel 2020. Nello specifico, per gli esercenti attività d’impresa arte o professioni si introduce un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per i canoni di affitto di negozi e botteghe, nell’ipotesi che in tale periodo risulti sospesa l’attività e un ulteriore credito d’imposta nella misura complessiva del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Altri interventi fiscali per 1,2 miliardi. A beneficio degli Enti territoriali si prevedono risorse per circa 0,35 miliardi nel 2020. Infine, per il rafforzamento dei servizi della pubblica amministrazione, si prevedono in particolare risorse: per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, la realizzazione di piattaforme digitali per la didattica a distanza, per gli interventi di pulizia straordinaria degli istituti scolastici e per il potenziamento delle attività delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati nelle azioni di contrasto della diffusione del Covid-19 per circa 0,3 miliardi[45].
Le misure adottate dall'Unione europea per fronteggiare
la crisi da COVID-19
In risposta alla pandemia le istituzioni europee stanno introducendo un quadro normativo di emergenza, che in parte è già in vigore e che in parte sta concludendo il proprio iter formale di approvazione[46]. Segue un elenco delle principali misure:
1) attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita (PSC), sospendendo l'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio;
2) sospensione temporanea delle norme UE che obbligano le compagnie aeree a gestire la maggior parte degli slot per evitare di perderli l'anno successivo;
3) iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, che introduce misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie;
4) estensione del campo di azione del Fondo di solidarietà dell'UE, includendovi anche le crisi di sanità pubblica;
5) garanzia di una flessibilità eccezionale nell'uso dei fondi strutturali e di investimento europei (iniziativa di investimento in risposta al coronavirus +);
6) sostegno di 3 miliardi di euro destinati ai settori sanitari negli Stati membri più colpiti dalla crisi e rafforzamento del Meccanismo unionale di protezione civile/RescuUE;
7) misure specifiche volte a mitigare l'impatto della pandemia da COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
8) modifica al vigente regolamento sui dispositivi medici finalizzata a garantire maggiori disponibilità dei dispositivi medesimi nel presente stato di emergenza[47];
9) mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio;
10) mobilitazione del margine per gli imprevisti per il 2020, che prevede assistenza di emergenza agli Stati membri e l'ulteriore rafforzamento del Meccanismo unionale di protezione civile (RescEU);
11) misure specifiche a favore dei più indigenti, mediante alcune modifiche al Fondo aiuti europei agli indigenti (FEAD);
12) possibilità di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per sostenere i lavori licenziati e gli autonomi nell’attuale contesto pandemico.
Maggiore flessibilità è stata introdotta anche nel settore degli aiuti di Stato. Il 19 marzo scorso la Commissione europea ha pubblicato il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (modificato il 3 aprile) con il quale autorizza fino al 31 dicembre 2020 dieci tipologie di aiuti di stato.
La Banca europea per gli investimenti:
1) ha annunciato il 16 marzo l'adozione di alcuni interventi miranti a fornire, mediante meccanismi di garanzia e di sostegno del sistema bancario, le risorse finanziarie necessarie a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le società a media e piccola capitalizzazione (c.d. mid cap) per un ammontare complessivo pari a circa 40 miliardi di euro;
2) farà ricorso agli strumenti finanziari a sua disposizione, condivisi con la Commissione europea - in primis al prodotto “InnovFin a sostegno della lotta alle malattie infettive” - per finanziare progetti destinati a fermare la diffusione, a trovare una cura e a sviluppare un vaccino contro il coronavirus;
3) sosterrà misure di emergenza dirette a finanziare il potenziamento urgente delle infrastrutture e il fabbisogno di dispositivi e attrezzature in campo sanitario.
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea:
1) nel corso di due riunioni, il 12 e il 18 marzo 2020 ha adottato una serie di misure straordinarie per fornire liquidità al sistema imprenditoriale europeo. Si segnala in particolare la decisione adottata il 18 marzo sull'avvio di un nuovo programma temporaneo di acquisto di titoli del settore privato e pubblico (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), con una dotazione finanziaria complessiva di 750 miliardi di euro. Insieme all'incremento di 120 miliardi del PAA annunciato il 12 marzo, l'intervento della BCE ammonta a una quantità di risorse pari al 7,3% del PIL dell'area euro;
2) con decisione del 7 aprile ha adottato un pacchetto di misure per allentare i requisiti in materia di garanzie per favorire la partecipazione delle banche alle operazioni di provvista di liquidità e, di conseguenza, l'offerta di prestiti bancari alle imprese.
Il Consiglio europeo del 23 aprile ha approvato:
1) il mandato alla Commissione europea per la presentazione urgente della proposta per l'istituzione di un Recovery fund per l'emissione di obbligazioni a lungo termine, con l'obiettivo di mobilitare risorse per circa il 10 per cento del PIL europeo (1.500-1.600 miliardi di euro);
2) l'accordo, già raggiunto in Eurogruppo il 9 aprile scorso, sull'istituzione di tre reti di sicurezza:
· per emittenti sovrani, tramite uno strumento di sostegno basato sull'esistente linea di credito a condizioni rafforzate attivabile dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), sul quale vedi infra;
· per imprese private, con l'attivazione del Fondo di garanzia pan-europea della BEI;
· per la tutela dell'occupazione. La proposta SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) della Commissione europea è volta a tutelare i lavoratori e i posti di lavoro messi a rischio dall'epidemia erogando prestiti, garantiti da tutti gli Stati membri, in relazione alla spesa pubblica volta a sostenere i regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe. La Commissione europea verrebbe autorizzata a prendere a prestito fino ad un massimo di 100 miliardi di euro per conto dell'Unione, mediante l'emissione di titoli sui mercati dei capitali o direttamente da istituzioni finanziarie. Gli Stati membri possono contribuire allo strumento fornendo una garanzia; l'operatività della proposta è subordinata alla prestazione di garanzia da parte di tutti gli Stati membri, per una cifra complessiva pari ad almeno 25 miliardi di euro ed alla condizione che la quota percentuale di importo garantito da ognuno corrisponda alla quota percentuale del reddito nazionale lordo del medesimo Stato rispetto al totale dell'RNL dell'Unione.
Il pacchetto - che il Consiglio europeo ha chiesto di rendere operativo entro il 1° giugno - avrebbe un valore globale di 540 miliardi di euro.
Si segnalano infine:
1) l'avvenuto finanziamento di progetti di ricerca, diagnosi, trattamenti focalizzati sul coronavirus che coinvolgono diversi gruppi di ricerca in Europa;
2) l'imminente presentazione, da parte della Commissione europea, di proposte di revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027[48] per tenere conto delle conseguenze del Coronavirus;
Il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato in media di quasi 5 punti percentuali (p.p.) all'anno nel periodo 2008-2014, per poi stabilizzarsi intorno al 135% (135,3% nel 2015, 134,8% nel 2016, 134,1% nel 2017 e di nuovo 134,8 nel 2018)[49]. La lieve diminuzione del rapporto negli anni 2015-2017 è dovuta in parte alla crescita del PIL nominale, che, combinato con gli avanzi del saldo di bilancio primario, ha più che compensato la spinta all'aumento prodotta dalla spesa per interessi. L'aumento del rapporto nel 2018 è dovuto alla minore crescita del PIL nominale e all'apporto in aumento dell'aggiustamento stock-flussi[50].
La stima preliminare per il 2019 indica un livello invariato al 134,8% (cfr. la Figura 16 e la Tabella 27). Non appare pertanto essersi materializzata la previsione in aumento di 0,9 punti percentuali (p.p.) prevista dalla NADEF 2019 e dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2020.
Figura 16 - Andamento del debito pubblico e della sua variazione annua
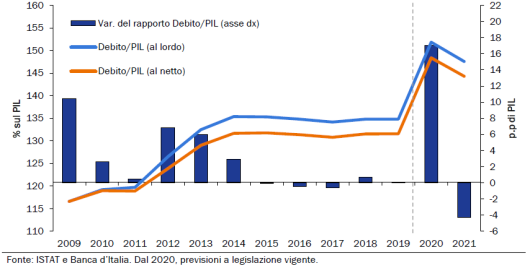
Il risultato migliore rispetto alle stime viene spiegato dal DEF con un tasso di crescita del PIL nominale maggiore di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni e un'accumulazione di debito minore di 0,6 p.p..
Per quanto riguarda le determinanti della variazione del rapporto debito/PIL, il DEF cita l'avanzo primario, salito all'1,7% del PIL, in aumento rispetto all'1,5% del 2018, che compensa quasi completamente il c.d. "effetto valanga"(snow-ball)[51], cresciuto all'attuale 1,8% rispetto all'1,4% del 2018. L'effetto valanga è stimato in aumento per il secondo anno consecutivo a causa dell'indebolimento della crescita del PIL nominale, solo in parte compensato dalla riduzione della spesa per interessi passivi, scesa dal 3,7 al 3,4% del PIL. La componente stock-flussi ha agito in modo favorevole alla diminuzione del rapporto debito/PIL del 2019 per 0,04 p.p. grazie al miglioramento della stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico, agli scarti di emissione e al cosiddetto up-lift - cioè l'effetto di rivalutazione - dei titoli pubblici, che hanno complessivamente controbilanciato le mancate privatizzazioni del 2019 (a fronte di una previsione pari all'1% del PIL nel DEF 2019 e a previsioni nulle nella NADEF 2019). Quale ulteriore determinante della stabilizzazione del rapporto debito/PIL nel 2019, il DEF cita il calo delle disponibilità liquide del Tesoro, in riduzione dello 0,1% del PIL rispetto al 2018.
Quanto alle previsioni, per effetto delle ripercussioni economiche della crisi da COVID-19, il rapporto debito/PIL è stimato in aumento di 17 p.p. fino al 151,8% nel 2020 nello scenario a legislazione vigente. A ciò contribuiscono innanzitutto gli effetti finanziari delle misure di risposta alla crisi approvate finora, pari a circa 20 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e di 25 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare[52]. Ciò implica, per il 2020, un disavanzo primario del 3,5% del PIL e una maggiore componente stock-flussi dovuta alla diversa contabilizzazione degli effetti finanziari delle misure con il criterio della competenza e quello della cassa. Contribuirà all'aumento del debito anche il forte peggioramento previsto per l'effetto valanga a causa della caduta del PIL nominale e reale, a fronte di un livello di spesa per interessi pari a circa il 3,6% del PIL.
Si rammenta che nella NADEF 2019 e nel DPB 2020, il Governo prevedeva per il 2020 una riduzione del rapporto debito/PIL pari a 0,5 p.p. al livello del 135,2%.
Il DEF attribuisce un carattere temporaneo al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica conseguente alla crisi da COVID-19, da cui deriverebbe nell'anno 2021 una previsione, a legislazione vigente, di riduzione del rapporto debito/PIL al 147,5%.
Tabella 27 - Debito delle amministrazioni pubbliche al lordo dei sostegni finanziari ai paesi dell'area euro(1)(2)(3)
(in milioni e in percentuale del PIL)
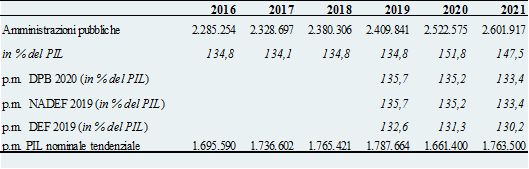
Fonte: DEF 2020, Tavola III.6 (Debito delle amministrazioni pubbliche per sottosettore), AMECO
1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
2) Al lordo delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d’Italia, ‘Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito’ del 15 aprile 2020). Le stime considerano una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,8 per cento del PIL nel 2020 e un aumento dello 0,4 per cento di PIL nel 2021. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.
3) Al lordo delle passività nei confronti degli altri sotto-settori.
Il DEF 2020 segnala inoltre che al netto dei contributi italiani all'ESM e dei prestiti ad altri Stati membri dell'UEM, il rapporto debito/PIL è stato pari al 131,6% nel 2019 e salirà al 148,4% nel 2020, per poi scendere al 144,3% nel 2021.
Si segnala che le tabelle del DEF relative all'evoluzione del rapporto debito/PIL, oltre a limitare lo scenario di previsione al 2021, non riportano la scomposizione del debito pubblico per sotto-settore delle Amministrazioni pubbliche.
Tabella 28 - Debito delle amministrazioni pubbliche al netto dei sostegni finanziari ai paesi dell'area euro(1)(2)(3)
(in milioni e in percentuale del PIL)
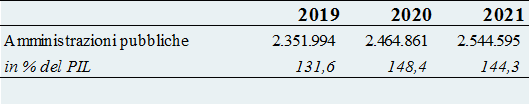
Fonte: DEF 2020, Tavola III.6 (Debito delle amministrazioni pubbliche per sottosettore), AMECO
1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
2) Al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d’Italia, ‘Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito’ del 15 aprile 2020). Le stime considerano una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,8 per cento del PIL nel 2020 e un aumento dello 0,4 per cento di PIL nel 2021. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.
3) Al lordo delle passività nei confronti degli altri sotto-settori.
Il DEF 2020 conferma la difficoltà per l'Italia a soddisfare la regola del debito nelle sue varie configurazioni (si veda il box di seguito per una sintesi dei requisiti previsti dalla regola).
Per il 2019, la versione retrospettiva (backward-looking) della regola prevede la realizzazione di un rapporto debito/PIL pari al 127,4%, cioè 7,4 p.p. in meno rispetto al valore conseguito (134,8%). Ancora maggiore sarebbe la distanza qualora si applicasse la correzione per depurare il rapporto debito/PIL dell'effetto del ciclo economico. In questo caso lo scostamento sarebbe pari a 11,5 p.p. in meno rispetto al valore ottenuto dalla correzione per il ciclo, pari al 138,8%. Nella configurazione prospettica (forward-looking) della regola, infine, il debito dovrebbe raggiungere il 133% del PIL, inferiore di 14,6 p.p. rispetto alle previsioni a legislazione vigente. La Tabella 29 mostra gli scostamenti dei valori del debito previsti nei vari anni rispetto ai valori soglia delle varie configurazioni della regola.
Tabella 29 - Rispetto della regola del debito
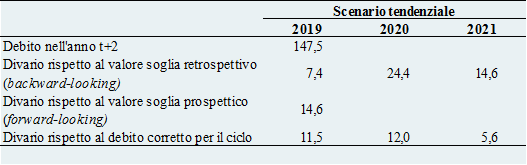
Fonte: DEF 2020, Tavola R 1 (Rispetto della regola del debito: criterio forward-looking e debito corretto per il ciclo). I calcoli per la configurazione forward-looking sono disponibili soltanto fino al 2019 in quanto l'orizzonte di previsione del Programma di stabilità si ferma al 2021.
La riforma della governance economica dell'UE, adottata nel novembre 2011 (six pack) e richiamata nel Fiscal compact, ha introdotto una regola numerica che specifica il ritmo di avvicinamento del rapporto debito/PIL al valore soglia del 60%. La regola è stata recepita nell'ordinamento italiano con la legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio.
In particolare, la regola si considera rispettata se la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60%
a) si è ridotta in media di 1/20 all'anno nei tre anni precedenti quello di riferimento (criterio retrospettivo o backward looking), ovvero
b) è prevista ridursi, in base alle stime elaborate dalla Commissione europea, in media di 1/20 all'anno nei due anni successivi all'ultimo per il quale si disponga di dati (criterio prospettico o forward-looking).
Nel valutare il rispetto dei due criteri precedenti, la regola prevede che si tenga conto dell'influenza del ciclo economico, depurando il rapporto debito/PIL dell'effetto prodotto dal ciclo sia sul numeratore sia sul denominatore.
Se anche in questo caso la regola non risulta rispettata, possono essere valutati i c.d. fattori rilevanti. In particolare, la Commissione sarà chiamata in questo caso a redigere un rapporto ex articolo 126, comma 3, del TFUE, nel quale esprimere valutazioni “qualitative” in merito agli sviluppi delle condizioni economiche e della finanza pubblica nel medio periodo, oltre che su ogni altro fattore che, nell'opinione dello Stato membro, sia rilevante nel valutare complessivamente il rispetto delle regole di bilancio europee.
In considerazione del mancato rispetto della regola in tutte le sue configurazioni, il DEF riconosce che la Commissione dovrebbe essere portata a redigere un nuovo rapporto ai sensi dell'articolo 126(3) del TFUE per valutarne l'effettiva violazione. Nel valutare se raccomandare al Consiglio l'apertura di una procedura per disavanzi eccessivi, la Commissione europea è tenuta tuttavia a valutare l'eventuale sussistenza di fattori rilevanti, quali le condizioni economiche di medio-termine, l'aderenza alle regole del Patto di stabilità e crescita (PSC), la dinamica e la sostenibilità del debito pubblico nel medio periodo. Secondo il DEF, il rispetto del braccio preventivo del PSC, cioè del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, nel 2019 rappresenterebbe un aspetto particolarmente rilevante e generalmente tenuto in considerazione dalla Commissione. L'impatto economico dello shock connesso all'emergenza da COVID-19, che ha completamente stravolto il profilo di evoluzione del rapporto debito/PIL dall'anno 2020, rappresenta, secondo il DEF, un altro fattore che influirà sulla valutazione del rispetto ex ante della regola del debito.
Dalla sua entrata a regime nel 2015, la regola del debito non è mai stata rispettata dall'Italia in nessuna delle sue configurazioni.
Il DEF spiega che i ridotti tassi di crescita del PIL nominale hanno reso molto difficile ridurre il rapporto debito/PIL se non mediante manovre di consolidamento radicali che, tuttavia, avrebbero, sempre secondo il DEF, rischiato di essere controproducenti a causa degli eventuali effetti negativi sulla crescita economica, sia nel breve sia nel medio periodo.
Grazie alla considerazione dei fattori rilevanti, la Commissione e il Consiglio hanno nel corso degli anni considerato valide le ragioni addotte dal Governo italiano per posticipare la riduzione del debito pubblico, e non si è mai arrivati quindi all'avvio della procedura di infrazione per disavanzi eccessivi basata sul criterio del debito.
Le prospettive di riforma del MES
Il 9 aprile 2020, nell'ambito delle iniziative per affrontare gli effetti della pandemia da COVID-19, l'Eurogruppo ha proposto di istituire uno strumento di sostegno agli Stati membri basato sull'esistente linea di credito soggetta a condizioni rafforzate attivabile dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), disponibile con condizioni standardizzate, concordate in anticipo con gli organi direttivi del MES. L'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati richiedenti si impegnino a utilizzarla per sostenere il finanziamento diretto e indiretto delle spese di prevenzione e assistenza sanitaria legate all'emergenza. L'ammontare delle risorse a disposizione sarà pari al 2% del PIL dello Stato richiedente alla fine del 2019.
Il MES è una organizzazione istituita nel 2012, sulla base di un Trattato intergovernativo, sottoscritto da tutti i 19 Paesi dell'Eurozona, e si configura come uno strumento di difesa dalle crisi finanziarie in grado di compromettere la stabilità della zona euro, residuale rispetto ai presidi stabiliti dal quadro integrato di sorveglianza fiscale e macroeconomica. Il capitale sottoscritto totale è di circa 704 miliardi di euro, di cui circa 80 sono stati effettivamente versati dagli Stati membri aderenti. La ripartizione delle quote è basata sulla partecipazione al capitale versato della Banca centrale europea (BCE). Con 125,3 miliardi di euro sottoscritti (di cui 14,3 effettivamente versati), l'Italia è il terzo Paese per numero di quote del capitale del MES (17,7%), dopo la Germania, che ha sottoscritto quote per 190 miliardi di euro, di cui 21,7 effettivamente versati (26,9% del totale), e la Francia, che ha sottoscritto quote per 142 miliardi di euro, di cui 16,3 effettivamente versati (20,2% del totale). L'organo al quale spettano le decisioni principali del MES è il Consiglio dei governatori (Board of Governors) composto dai Ministri responsabili delle finanze degli Stati membri della zona euro. Il Trattato individua un ulteriore organo al quale, direttamente o su delega del Consiglio dei governatori, vengono attribuiti poteri decisionali: il Consiglio di amministrazione (Board of Directors), composto da 19 funzionari esperti (senior civil service officials) nominati dai governatori. Il vertice amministrativo dell'organismo, infine, è affidato a un Direttore generale. Le decisioni relative alla concessione di assistenza finanziaria agli Stati aderenti, sono adottate dal Consiglio dei governatori secondo la regola del comune accordo e, dunque, con l'unanimità dei membri partecipanti alla votazione, senza contare le eventuali astensioni. Al fine di rendere più flessibile il sistema decisionale in circostanze straordinarie in cui appare minacciata la stabilità finanziaria ed economica della zona euro, è previsto il voto a maggioranza qualificata dell'85% del capitale, qualora la Commissione e la BCE evidenzino la necessità di decisioni urgenti. In tali casi, in cui viene meno la regola del comune accordo, ai fini della decisione diviene rilevante il numero di diritti di voto di ciascuno Stato aderente. L'obiettivo del MES è quello di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. A tal fine, il meccanismo può intervenire per fornire un sostegno ai Paesi aderenti che si trovino in gravi difficoltà finanziarie o ne siano minacciati, sulla base di condizioni rigorose, commisurate allo specifico strumento di sostegno utilizzato (principio della "rigorosa condizionalità"). Tali condizioni possono fare riferimento ad azioni e programmi da attuare per ottenere un miglioramento del bilancio dello Stato, o a parametri per i quali viene fissato un obiettivo quantitativo da rispettare, lasciando allo Stato la definizione degli strumenti da utilizzare a tal fine.
In particolare, il MES può:
· fornire assistenza finanziaria precauzionale a uno Stato membro sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate. Le linea di credito precauzionale, in base alle linee guida del MES è accessibile a condizioni prestabilite e per i Paesi aderenti caratterizzati da una situazione economica e finanziaria ancora fondamentalmente solida. I criteri di ammissibilità fanno riferimento al rispetto degli impegni derivanti dal Patto di stabilità e crescita e dalla Procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi, alla generale sostenibilità del debito e della posizione verso l'estero, alla capacità di accesso ai mercati finanziari e all'assenza di problemi di solvibilità bancaria con potenziali ricadute sistemiche. Per i membri che non dovessero rispettare alcuni di questi criteri, ma che fossero comunque caratterizzati da una situazione economica e finanziaria generalmente solida, è prevista la possibilità di accesso alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate;
· concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di sottoscrivere titoli rappresentativi del capitale di istituzioni finanziarie dello stesso Paese membro;
· concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti non connessi a uno specifico obiettivo;
· acquistare titoli di debito degli Stati membri in sede di emissione e sul mercato secondario.
In base al Report annuale del MES per il 2018, risultano attivi prestiti non connessi a uno specifico obiettivo verso Irlanda, Portogallo, Grecia e Cipro e prestiti finalizzati alla ricapitalizzazione di istituti bancari verso la Spagna.
Con riferimento alla procedura per l'attivazione degli strumenti di intervento, a seguito della presentazione di una domanda di sostegno alla stabilità da parte di uno Stato aderente, le disposizioni in vigore prevedono che ciascuna delle azioni suddette sia associata alla definizione di condizioni proporzionate all'impegno richiesto, elaborate attraverso un percorso negoziale che coinvolge lo Stato interessato e la Commissione europea nella stipula di un protocollo d'intesa (memorandum of understanding, MoU). Prima di definire il protocollo, la Commissione europea, di concerto con la BCE, valuta anche la sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato. La capacità di prestito del MES può essere integrata attraverso la partecipazione del Fondo monetario internazionale (FMI) alle operazioni di assistenza finanziaria. Al termine del programma di assistenza finanziaria, la Commissione europea e la BCE eseguono missioni di controllo ex-post, alle quali partecipa anche il FMI se ha contribuito finanziariamente al programma medesimo, per valutare se lo Stato che ha beneficiato dell'assistenza finanziaria continui ad attuare politiche di bilancio sostenibili e se sussista il rischio che non sia in grado di rimborsare i prestiti ricevuti. Gli strumenti di sostegno vengono utilizzati dal MES "nella prospettiva del creditore", valutando quindi la capacità di rimborso del debitore e gli altri rischi connessi all'operazione di finanziamento. I prestiti vengono caratterizzati da un'adeguata remunerazione che, seppur inferiore rispetto a quella che il Paese in difficoltà potrebbe dover offrire ad altri prestatori, deve garantire la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e includere un margine adeguato. Gli eventuali profitti realizzati dalla gestione finanziaria possono essere distribuiti in forma di dividendi, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale. Sul piano delle risorse a disposizione, oltre al capitale sottoscritto dagli Stati aderenti (704 miliardi di euro, di cui circa 80 effettivamente versati), il MES ha la possibilità di raccogliere fondi emettendo strumenti del mercato monetario, nonché strumenti finanziari di debito a medio e lungo termine, con scadenze fino a un massimo di 30 anni. La capacità di prestito del MES è pari a 410,1 miliardi di euro (dato aggiornato ad agosto 2019), pari alla differenza fra la capacità massima di prestito (500 miliardi) e gli impegni di credito (89,9 miliardi).
Rispetto a tale quadro, l'Eurogruppo del 13 giugno 2019 ha raggiunto un accordo su una proposta di riforma del MES, nell'ambito di un più ampio pacchetto di interventi secondo cui la revisione del meccanismo viene collegata alla definizione di uno strumento europeo di bilancio per la convergenza e la competitività e al completamento dell'Unione bancaria. La proposta di riforma, la cui adozione è legata alla conclusione del negoziato sul pacchetto di proposte cui è collegata e alla successiva ratifica degli Stati membri, prevede una procedura semplificata per l'attivazione della linea di credito condizionale precauzionale, il sostegno del MES al Fondo di risoluzione unico, alcune innovazioni nel riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l'attuazione del Trattato, anche con riferimento alla valutazione della situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri, nonché l'introduzione delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno. Per ulteriori approfondimenti sugli interventi sinora effettuati e sulle proposte di riforma del Trattato si rinvia al relativo dossier del Servizio studi del Senato.
La legge costituzionale n.1 del 2012 ha riformulato l'articolo 81 della Costituzione, prevedendo l'obbligo per lo Stato di assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Alla luce di tale principio, il ricorso all'indebitamento è pertanto di norma consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico. Tuttavia, previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi qualificabili come "eccezionali" può essere concesso un ulteriore indebitamento.
La nozione tecnico finanziaria di equilibrio di bilancio è stata specificata dalla legge n. 243 del 2012 (articoli 2, 3, 6, 8), corrispondendo all'obiettivo di medio termine (OMT), a sua volta definito come il valore del saldo "strutturale" individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea. Con riferimento allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea, cui come visto la legge italiana rinvia, l'articolo 10 del regolamento 1466/97 prevede espressamente il concetto di deviazione "significativa".
La nuova disciplina del quadro programmatico della finanza pubblica stabilisce che all'occorrenza possano essere ammessi anche scostamenti "temporanei" del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico (OMT), ma solo in presenza di eventi "eccezionali", così come questi sono tassativamente individuati dall'articolo 6 della legge 243/2012, ovvero nei casi di:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi "straordinari", al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali che presentino rilevanti ripercussioni sulla situazione economica finanziaria generale del Paese.
In presenza di tale tipologia eventi, lo stesso articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 prevede una specifica procedura, per cui è previsto che l'esecutivo qualora, al fine di fronteggiare tali eventi, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, è tenuto a presentare un'apposita relazione al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni, con cui si provvede all'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Corredando l'esposizione con una specifica richiesta di autorizzazione allo scostamento al Parlamento, di cui è tenuto a specificarne misura.
La norma prevede che la richiesta alle Camere deve altresì completarsi con l'indicazione delle finalità alle quali sono destinate le risorse disponibili in conseguenza dello sconfinamento, nonché l'esposizione di un dettagliato piano di rientro verso l'obiettivo "programmatico", commisurandone la durata all'entità economica e, soprattutto, alla "gravità" degli eventi.
La Relazione in esame riferisce che il 20 marzo la Commissione Europea ha disposto l’applicazione della c.d. general escape clause per l’anno in corso, al fine di definire il necessario spazio di manovra fiscale nell’ambito del bilancio dei paesi membri, indispensabili al sostenimento delle spese sanitarie da sostenersi per l’emergenza epidemiologica e per il contrasto degli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19, per cui ciò dovrebbe determinare una temporanea deviazione dal percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
In precedenza, segnala che la Commissione ed il Consiglio Europeo avevano già garantito a tutti i Paesi interessati, e in particolare all’Italia, la piena applicazione della flessibilità prevista nel Patto di Stabilità e Crescita in relazione alle misure collegate all’epidemia di Covid-19.
Pertanto, in considerazione degli effetti economici correlati alle misure sanitarie e di ordine pubblico introdotte già a partire dagli inizi di marzo, il Governo ha già provveduto a trasmettere al Parlamento una relazione sullo scostamento, che è stata approvata il 5 marzo scorso.
Conseguentemente, sono state adottate prime misure e interventi volti a fronteggiare i disagi sociali ed economici derivanti dal rallentamento e, in alcuni casi, dalla sospensione delle attività produttive. Tali interventi hanno già comportato un aumento dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2020, in ottemperanza alla legge attuativa del principio dell’equilibrio di bilancio, per cui con due Relazioni[53] al Parlamento ha richiesto l’autorizzazione ad una deviazione temporanea dal percorso di finanza pubblica programmato nella NADEF 2019, pari a circa 20,1 miliardi in termini di impatto sull’indebitamento netto (pari a circa 1,2 punti percentuali di PIL).
Con la presentazione della nuova Relazione al Parlamento, si valuta che gli interventi fin qui attivati hanno rappresentato solo una prima risposta per proteggere la salute dei cittadini e la salvaguardia del buon funzionamento del sistema sanitario e ospedaliero, nonché, per fronteggiare le più immediate esigenze di natura economica legate all’emergenza sanitaria.
In tale contesto, si rende pertanto necessaria l'adozione di altre misure volte garantire e incentivare la ripresa di tutte le attività economiche, nonché ad assicurare l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tal senso, si avverte l'urgenza di un adeguato sostegno alle imprese attraverso i necessari interventi di politica economica e fiscale, che potrebbero non esaurirsi nell’anno in corso, congiuntamente agli altri interventi che occorrerà adottare nella fase di convivenza con l’infezione, in attesa del completamento del processo di vaccinazione della popolazione.
Se la ripresa si realizzerà solo con una certa gradualità, ciò determinerà un lasso di tempo più ampio durante il quale risulterà fondamentale sostenere le attività produttive e la domanda interna, operando la rimozione dei fattori economici che possano minare i margini di recupero dell’economia, in primis evitando politiche "restrittive".
Il documento assicura che con il prossimo decreto si garantirà in un contesto di miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, la completa eliminazione dell’incremento delle aliquote IVA e delle accise previsto dal 2021.
Le cosiddette clausole di salvaguardia sulle imposte indirette hanno costituito in questi anni un elemento di scarsa credibilità della previsione di finanza pubblica che la Commissione europea non ha mai considerato nelle proprie previsioni “a politiche invariate” e, quindi, nei parametri utilizzati per la valutazione del Programma di stabilità.
Nel complesso, tenuto conto di quanto già autorizzato con la precedente Relazione al Parlamento e nella relativa Integrazione, nonché degli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica per via del deterioramento dello scenario macroeconomico, con la nuova Relazione in parola si richiede l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.
In considerazione della natura degli interventi programmati, l’effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche previsto è di 65 miliardi di euro nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e pari all’indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi.
Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi.
Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è quindi fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.
Quanto al livello del debito pubblico, lo stesso è previsto attestarsi al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.
Circa il Piano di rientro dello scostamento previsto, la Relazione evidenzia che l’elevato rapporto debito/PIL, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco che si registra quest’anno, consente di delineare un sentiero di rientro solo a partire dagli anni successivi.
A tale proposito, certifica comunque la sostenibilità del debito pubblico dell’Italia, il cui rapporto debito/PIL verrà ricondotto verso la media dell’area euro nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro che, oltre al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario, si baserà sul rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative.
Ciò dovrà essere pienamente compatibile con gli obiettivi di innovazione e sostenibilità ambientale e sociale che l’Europa e l’Italia si sono dati, in particolare, con il contrasto all’evasione fiscale e le imposte ambientali, unitamente a una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all’equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica, che saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio.
Come riferito nell'introduzione al presente dossier, a causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al diffondersi dell’epidemia da Covid-19, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020 del 6 aprile 2020. In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) vengono rinviati a un momento successivo.
Di seguito, per completezza, è offerta una analisi delle raccomandazioni specifiche che, su proposta delle Commissione, sono state adottate, nel luglio 2019, dal Consiglio per essere rivolte all'Italia così come agli altri Paesi dell’UE, nonché ai risultati delle analisi condotte all'interno della procedura sugli squilibri macroeconomici e alle relative raccomandazioni formulate dalla Commissione all'Italia.
Il Box seguente fornisce una sintesi del Semestre europeo al cui interno si inseriscono i documenti oggetto di esame della presente nota.
Il Semestre europeo
Il Semestre europeo consiste in un insieme di documenti, adempimenti e procedure volti ad assicurare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio dei paesi membri della zona euro e dell'Unione europea. Tali attività ? ritenute necessarie a mantenere le condizioni di stabilità economica e finanziaria da cui dipende il funzionamento dell'area valutaria ? sono poste in essere dal Consiglio dell'Unione europea su impulso della Commissione.
Il Semestre si sviluppa nella prima metà di ciascun anno di riferimento, quando la politica economica e di bilancio degli Stati membri si trova ancora in una fase di programmazione ed è quindi possibile indirizzarne i contenuti e gli strumenti al fine di garantire la coerenza delle decisioni assunte a livello nazionale con gli obiettivi fissati dall'Unione.
Negli ultimi sei mesi dell'anno, tra luglio e dicembre, si sviluppa invece il cd. "semestre nazionale", in cui ciascun paese attua le politiche programmate all'esito del dialogo con le istituzioni europee. I bilanci sono quindi sottoposti ad approvazione, secondo le procedure nazionali, entro fine anno.
Più in dettaglio, il calendario puntuale delle attività è articolato nei seguenti termini:
- nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento la Commissione europea pubblica il "pacchetto d'autunno", che contiene:
§ l'analisi annuale della crescita che propone le priorità politiche (economiche ma anche sociali) dell'UE per l'anno di riferimento. Gli Stati membri sono invitati a tenerne conto nell'elaborazione delle rispettive politiche economiche;
§ la relazione sul meccanismo di allerta, che passa in rassegna gli sviluppi macroeconomici nei singoli Stati membri dell'UE. Sulla base di essa può essere condotto un esame approfondito della situazione di quei paesi in cui si ritiene elevato il rischio di squilibri macro-economici;
§ il progetto di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro, in base alla quale tali Stati sono invitati ad attuare politiche ad essi specifiche;
- tra gennaio e febbraio:
§ il Consiglio dell'Ue discute l'analisi annuale della crescita; discute, eventualmente modifica ed approva il progetto di raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
§ il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a discutere questioni relative al Semestre. Può altresì promuovere uno scambio di opinioni con singoli Stati membri (cd. "dialogo economico");
§ il Parlamento europeo organizza la settimana parlamentare europea. Si tratta di una riunione interparlamentare che riunisce la Conferenza sul Semestre europeo (un'opportunità di scambiare informazioni sulle migliori prassi relative all'attuazione del Semestre) ed una delle due sessioni annuali della Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'UE;
- a fine febbraio la Commissione europea pubblica, nel "pacchetto d'inverno", una valutazione annuale della situazione economica e sociale negli Stati membri. Vengono pubblicate delle relazioni per paese che includono, qualora sia ravvisato un rischio, esami approfonditi degli squilibri macroeconomici. Può formulare progetti di raccomandazioni;
- a marzo:
§ il Consiglio europeo fornisce orientamenti politici sulla base dell'analisi annuale della crescita;
§ il Consiglio dell'UE fornisce analisi e conclusioni;
- entro aprile gli Stati membri presentano i propri programmi nazionali di riforma (PNR) e i programmi nazionali di stabilità (per i Paesi della zona euro, PS) o di convergenza (per gli altri Stati UE).
- a maggio, con il "pacchetto di primavera", la Commissione europea valuta i programmi nazionali e presenta dei progetti di raccomandazioni specifiche per paese;
- a giugno:
§ il Consiglio dell'UE discute le proposte di raccomandazioni specifiche per paese;
§ il Consiglio europeo ne approva la versione definitiva;
- a luglio il Consiglio dell'UE adotta le raccomandazioni specifiche e gli Stati membri sono invitati ad attuarle;
- tra settembre e novembre la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE organizza la Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea;
- entro il 15 ottobre gli Stati membri della zona euro presentano alla Commissione e all'Eurogruppo i documenti programmatici di bilancio dell'anno successivo;
- tra ottobre e novembre: la Commissione fornisce pareri sui documenti programmatici di bilancio e l'Eurogruppo esamina tali pareri e formula una dichiarazione;
- a fine autunno il Parlamento europeo esprime il proprio parere sul ciclo del Semestre europeo in corso.
Il 9 luglio 2019 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese e i pareri sulle politiche economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri (di seguito: raccomandazioni)[54], chiudendo così il ciclo annuale del Semestre europeo, avviato nell'autunno 2018.
La procedura si articola a livello europeo nelle seguenti fasi temporali:
· gennaio: presentazione da parte della Commissione dell'indagine annuale sulla crescita, poi negli ultimi anni anticipata al mese di novembre;
· febbraio/marzo: il Consiglio europeo elabora le linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;
· metà aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell'ambito della nuova Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;
· inizio giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;
· giugno: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;
· seconda metà dell'anno (c.d. semestre nazionale): gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni stesse.
Per quanto concerne l’Italia, il Consiglio dell’Unione europea ha formulato cinque raccomandazioni, riguardanti:
1. Aggiustamenti di bilancio, fiscalità ed economia sommersa. La Commissione UE raccomanda di assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta[55] dello 0,1 % nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL; utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL; spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati; contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti; attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita.
2. Intensificazione degli sforzi volti a combattere il lavoro sommerso. Si raccomanda di intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali.
3. Focalizzazione degli interventi di politica economica connessi agli investimenti in materia di ricerca, innovazione e qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali. Occorre porre l'accento sulla politica economica connessa agli investimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali. Migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.
4. Durata dei processi e misure anticorruzione. Occorre ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore; migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali.
5. Crediti deteriorati, settore bancario e accesso delle imprese alle fonti di finanziamento. La Commissione raccomanda di favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese innovative.
La Commissione europea ha pubblicato il 26 febbraio 2020, nell'ambito del Semestre europeo, il pacchetto d'inverno (winter package) contenente l'analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri. Qui di seguito si espongono, in sintesi, alcuni elementi riguardanti la Relazione per l'Italia[56].
Secondo quanto esposto nella Relazione, l'Italia rientra tra i paesi che presentano "squilibri eccessivi" (insieme a Cipro e alla Grecia)[57].
In un quadro macroeconomico globalmente debole - come emerge dalle Previsioni economiche d'inverno[58] - l'economia italiana, nonostante alcuni elementi di miglioramento nel mercato del lavoro, mostra scarsi segnali di ripresa rispetto al rallentamento del 2018.
Dall'esame approfondito condotto dalla Commissione si rileva che permane la vulnerabilità dell'economia italiana in relazione al debito troppo elevato (riguardo a tale tema si rinvia a più specifiche trattazioni del presente dossier). A breve termine i rischi di sostenibilità sembrano contenuti, risultando alti nel medio e lungo periodo. Alcune recenti riforme pensionistiche, osserva la Commissione, potrebbero erodere ulteriormente la crescita potenziale e la sostenibilità del debito, se prolungate oltre la fase iniziale di sperimentazione.
Quanto alle componenti del PIL, la Commissione evidenzia che al calo della spesa per i consumi, registrato nel 2018, non sia seguita alcuna apprezzabile ripresa nel 2019. In particolare nella prima metà del 2019 la spesa per alcuni beni di consumo, in particolare alimenti, abbigliamento e trasporti, è stata inferiore rispetto allo stesso periodo del 2018. Alcuni elementi di sostegno alla spesa per le famiglie potrebbero comunque derivare dalle forme di sostegno ai redditi più bassi (ad esempio con l'introduzione del reddito di cittadinanza) e dalla flessione dei tassi di interesse, che potrebbe liberare risorse per i consumi delle famiglie.
Si assottigliano, osserva la Commissione, i margini di profitto delle imprese. La formazione lorda di capitale fisso, al 18,1 % del PIL nel terzo trimestre del 2019, è ancora nettamente inferiore sia all'ultimo picco del 2007 (22 %) che alla media dell'UE (20,6 %). Tuttavia, le condizioni di finanziamento favorevoli sostengono gli investimenti.
Continua l'andamento negativo della produttività del lavoro, sempre inferiore rispetto alla media UE: l'efficacia delle misure adottate in materia, quali incentivi agli investimenti e all'innovazione, è stata limitata da "ritardi nell'attuazione, dall'incertezza delle politiche e dalla mancanza di una strategia organica". La diminuzione (-0,3 % a fronte di un aumento dello 0,5 % nella zona euro) è ricondotta al calo della produttività del lavoro nelle regioni meridionali e nel settore dei servizi, e al rallentamento della crescita della produttività nel settore manifatturiero rispetto alla media della zona euro.
Nel 2019 sono stati registrati miglioramenti nel mercato del lavoro. Tuttavia i tassi di disoccupazione rimangono superiori alla media UE, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile, che sta calando a ritmo troppo lento. Rimane tra i più alti in ambito UE il numero di giovani non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (19,2 % nel 2018). Inoltre, la crescita dell'occupazione si osserva soprattutto nei settori ad alta intensità di manodopera e basso valore aggiunto. Nonostante alcuni risultati positivi, quindi, la Commissione sottolinea che il ristagno del mercato del lavoro resta considerevole e che la scarsa produttività mette comunque a rischio la possibilità di compiere progressi ulteriori. Peraltro le politiche sociali rimangono scarsamente integrate con altre politiche, comprese le politiche attive del mercato del lavoro.
Riguardo al settore bancario, la Commissione registra alcuni miglioramenti in termini di maggiore resilienza, sebbene si registrino alcuni elementi di permanente vulnerabilità: rimane alta la quota dei crediti deteriorati, comunque in apprezzabile calo rispetto agli anni precedenti. Non è stata pienamente attuata la riforma delle grandi banche popolari mentre è giunta a compimento la riforma del credito cooperativo e quella della disciplina fallimentare. Permangono difficoltà, a giudizio della Commissione, per l'accesso al credito bancario ed è ancora scarsamente sviluppato l'accesso al credito non bancario.
In materia fiscale, la Commissione giudica troppo elevata la tassazione del lavoro. Ancora basso il livello di adempimento degli obblighi fiscali: nonostante l'introduzione di alcune misure per favorire l'adempimento degli obblighi tributari, l'evasione fiscale resta elevata. La Commissione, inoltre, giudica eccessivo il ricorso alle aliquote IVA ridotte. La legge di bilancio 2020 ha comunque compiuto alcuni progressi nella riduzione delle agevolazioni fiscali e del cuneo fiscale sul lavoro. Non vi è stato alcun spostamento, continua la Commissione, della pressione fiscale sui beni immobili, e non è stata avviata l'auspicata riforma del catasto.
Ulteriori elementi di criticità sono individuati nel settore dell'istruzione: rispetto alla media UE, l'Italia ha un tasso molto più elevato di giovani che abbandonano la scuola precocemente e hanno risultati insufficienti, in particolare nel Sud.
Nel complesso, secondo la Commissione, l'Italia ha compiuto "alcuni progressi" nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche del 2019.
Progressi significativi si sono osservati nella lotta contro l'evasione fiscale, anche grazie al rafforzamento degli obblighi dell'uso dei pagamenti elettronici.
Alcuni progressi sono registrati nei seguenti ambiti: i) l'effettiva integrazione tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali, coinvolgendo soprattutto i gruppi vulnerabili; ii) politiche economiche relative agli investimenti incentrate sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture; iii) una maggiore efficacia della pubblica amministrazione; iv) la promozione della ristrutturazione dei bilanci delle banche; v) il potenziamento dell'accesso al credito non bancario per le imprese più piccole e innovative.
Progressi limitati sono registrati nei seguenti ambiti: i) lo spostamento della pressione fiscale dal lavoro, nonché la riduzione delle agevolazioni fiscali e la riforma del sistema catastale; ii) la lotta al lavoro sommerso; iii) il sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale; iv) il miglioramento dei risultati scolastici, anche mediante investimenti adeguati e mirati, e la promozione del miglioramento delle competenze; v) la riduzione della durata dei processi civili, con particolare riferimento al miglioramento della disciplina procedurale; vi) la lotta contro la corruzione, mediante la riforma delle norme procedurali, al fine di ridurre la durata dei processi penali.
Nessun progresso è stato registrato nei seguenti ambiti: i) la riduzione del peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e la creazione di margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita; ii) la rimozione delle restrizioni alla concorrenza, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.
Il Governo stima che nel 2019 le entrate tributarie erariali del bilancio dello Stato accertate secondo il criterio di competenza sono pari a 471.622 milioni (+1,7 per cento rispetto al 2018), di cui 252.284 milioni derivanti da imposte dirette (+1,8 per cento) e 219.338 milioni derivanti da imposte indirette (+1,5 per cento). L’aumento delle imposte indirette è stato trainato dal gettito IVA (+2,5 per cento) e in particolare dalla componente relativa agli scambi interni (+3,0 per cento). Rispetto al 2018, il gettito di quest’ultima componente ha segnato un aumento di 3,6 miliardi, pari allo 0,2 per cento del PIL.
Nel documento si evidenzia che il tasso di crescita dell’IVA da scambi interni è stato notevolmente maggiore del tasso di crescita delle risorse interne (PIL + importazioni – esportazioni) in due tratti, nel periodo 2T 2015 - 3T 2016 e nell’intero 2019. In particolare dall’analisi dell’andamento del gettito emerge che il picco registrato nel 2016 è dovuto in gran parte all’introduzione dello split payment, mentre il picco del 2019 rimane pressoché invariato, suggerendo che il maggior gettito IVA possa dipendere da fattori diversi (obbligo di fatturazione elettronica, di trasmissione elettronica dei corrispettivi e nuovi Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale - ISA in sostituzione degli studi di settore).
IVA sugli scambi interni, al netto della quota versata con lo split payment e risorse interne
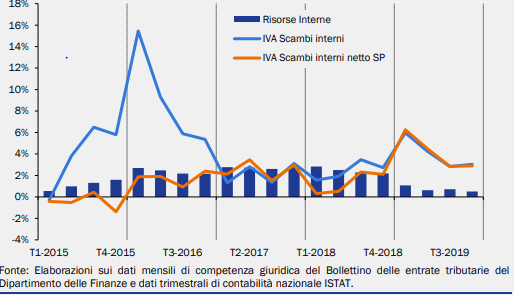
Nel corso di tutto il 2019, infatti, il gettito IVA da scambi interni ha avuto un andamento particolarmente favorevole rispetto agli anni scorsi, assicurando maggiori entrate erariali pur in presenza di un rallentamento della crescita economica. Tali risultati indicano che le misure adottate per incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti hanno esercitato un impatto positivo sul gettito IVA contribuendo a realizzare una crescita rilevante delle entrate IVA nonostante il rallentamento nella dinamica della base imponibile.
Nel documento, a tal proposito, si evidenzia che la crescita tendenziale annua delle risorse interne mostra un forte rallentamento nel 2019, scendendo dal +2,3 per cento del 2018 al +0,3 per cento, mentre il gettito dell’IVA sugli scambi interni al netto dello SP cresce del 2,9 per cento, comportando un aumento di gettito di 3,1 miliardi (pari allo 0,17 per cento del PIL). Ne deriva che il tasso di crescita delle entrate teorico stimato è pari solamente a +0,2 per cento, e il maggior gettito teorico ammonta a 179 milioni, da cui segue che meno del 10 per cento del maggiore gettito sarebbe spiegato dal ciclo economico, ossia dalla variazione della base imponibile. Conseguentemente, ben 2,9 dei 3,1 miliardi di maggior gettito IVA sugli scambi interni al netto dello SP rispetto al 2018 (pari allo 0,16 per cento del PIL) non sarebbero spiegabili dalla variazione della base imponibile.
I risultati possono ritenersi coerenti con la valutazione riportata nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva allegata alla NADEF 2019 ed aggiornata dall’Agenzia delle Entrate, che mostra un miglioramento della compliance tra 0,9 e 1,4 miliardi per il 2019. Tale dato risulta evidente dall’analisi del gap IVA, cosiddetta VAT-TAX, ossia della differenza tra l’IVA teorica, il gettito che si riscuoterebbe nel caso di perfetto adempimento alla disciplina tributaria, e l’IVA effettiva.
IVA teorica, IVA effettiva di competenza e gap IVA – anni 2016-2019
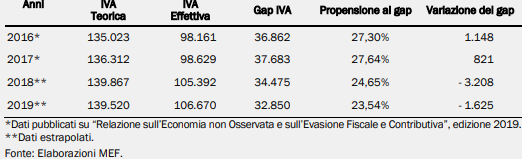
Il Governo sottolinea che la dinamica della compliance IVA è stata influenzata dall’adozione di alcune misure volte specificamente a contrastare fenomeni di evasione negli anni 2017-2019, tra le quali:
§ dal 1° luglio 2017 - estensione del meccanismo di split payment alle aziende partecipate dallo Stato e alle maggiori società quotate in borsa (FTSE-MIB);
§ da metà del 2017 - estensione dell’apposizione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo dei canali telematici per effettuare le compensazioni IVA;
§ da giugno 2018 - introduzione dell’obbligo di trasmissione elettronica delle fatture per le operazioni sui carburanti;
§ da gennaio 2019 - introduzione dell’obbligo generalizzato di trasmissione elettronica delle fatture;
§ da giugno 2019 - introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le partite IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
In materia di attività di contrasto all’evasione fiscale il Governo rappresenta che nel corso del 2019 sono stati riscossi dall’Agenzia delle Entrate quasi 17 miliardi dalle ordinarie attività di controllo, circa il 4 per cento in più rispetto al 2018 (16,2 miliardi). Di questi, 11,7 miliardi derivano dai versamenti diretti su atti emessi dall’Agenzia (+4 per cento), circa 2,1 miliardi sono il frutto dell’attività di promozione della compliance (+18 per cento), 3 miliardi il recupero derivante dalla riscossione coattiva (-4 per cento) di competenza.
Si registra invece un risultato sostanzialmente uguale a quello del 2018 con riferimento al recupero derivante da misure straordinarie pari a 3 miliardi di euro. Di questi, 2,1 miliardi (-19 per cento rispetto al 2018) derivano dalla rottamazione delle cartelle e 900 milioni dalla definizione agevolata (articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119 /2018).
Complessivamente nel corso del 2019 l’attività di recupero dell’evasione ha fatto registrare incassi per un ammontare pari a 19,9 miliardi, con un incremento del 3,4 per cento circa rispetto al 2018.
Risultati della lotta all’evasione: entrate tributarie erariali e non erariali (in milioni)
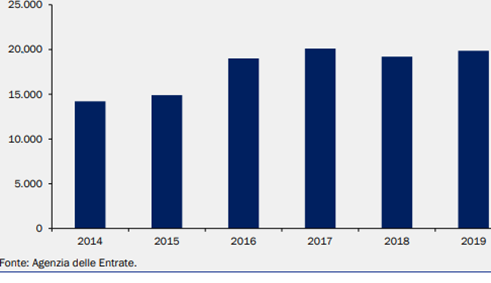
Nel Documento si ricorda che, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al 2017, l’evasione tributaria e contributiva (sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al 2017) è stimata in 109.684 milioni di cui la sola evasione tributaria rappresenta 97.912 milioni di euro; in media, nel periodo 2015-2017, l’evasione tributaria e contributiva è pari a 108.297 milioni, di cui la componente tributaria risulta pari a 96.871 milioni e la componente dei contributi evasi dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti è pari a 11.772 milioni di euro.
I valori di tax gap ovvero del divario (gap) tra i contributi e le imposte effettivamente versati e quelli che i contribuenti avrebbero dovuto versare in un regime di perfetto adempimento agli obblighi tributari e contributivi previsti a legislazione vigente, pur presentando una dinamica in netto miglioramento, rimangono ancora molto significativi.
Il Governo ricorda che dalla Relazione sull'Economia Non Osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – Aggiornamenti per gli anni 2012-2017 risulta una significativa diminuzione:
§ del gap delle entrate tributarie (pari a 1,4 miliardi di euro) che passano da circa 99,3 miliardi nel 2014 a circa 97,9 miliardi nel 2017;
§ della propensione al gap che diminuisce di un punto percentuale, dal 22,4% del 2014 al 21,4% del 2017.
L’incremento, tuttavia, del tax gap nel 2017 rispetto al 2016 è pari complessivamente a 486 milioni con un aumento di 0,1 punti percentuali della propensione al gap. In particolare, la composizione del tax gap segnala un incremento di 820 milioni dell’IVA e di 237 milioni di quello dell’IRAP. Aumenta anche il tax gap dell’IRES (di circa 1,1 miliardi) e quello dell’IRPEF per i lavoratori dipendenti (di circa 235 milioni). Si registra invece una riduzione dell’IRPEF dei lavoratori autonomi e delle imprese (di circa 2,2 miliardi). Rispetto al 2016, si riduce la propensione all’evasione dell’IRPEF dei lavoratori autonomi e imprese per -1,6 punti percentuali, e aumentano rispettivamente la propensione all’evasione IRPEF dei lavoratori dipendenti irregolari di 0,1 punti percentuali, la propensione all’evasione dell’IRAP di 0,8 punti percentuali e la propensione all’evasione dell’IRES di 3,8 punti percentuali.
Il Governo nel documento elenca inoltre alcune misure, adottate con la recente manovra di bilancio 2020 nonché con il decreto fiscale (D.L. 124 del 2019), che dovrebbero contribuire all’azione di contrasto dell’evasione fiscale:
§ disposizioni di contrasto alle frodi e agli illeciti fiscali in materia di IVA e accisa nel settore dei carburanti, di altri idrocarburi e dell’acquisto intracomunitario di veicoli;
§ norme volte a contrastare le indebite compensazioni di imposta;
§ norme volte a contrastare l’illecita somministrazione di manodopera; in particolare, con riferimento agli appalti e ai subappalti per opere ad alto contenuto di manodopera in cui è stato introdotto il meccanismo del reverse charge;
§ l’ampliamento del patrimonio informativo attraverso nuove acquisizioni di microdati, nonché attraverso l’utilizzo integrato delle banche dati a disposizione dell’Amministrazione fiscale;
§ l’incentivo all’uso di strumenti di pagamento elettronici in settori in cui il contante è ancora troppo diffuso (cd piano Italia Cashless). In particolare attraverso:
· la riduzione del limite massimo di utilizzo del contante (da 3.000 a 2.000 euro da luglio 2020 e a 1.000 euro da gennaio 2022);
· il potenziamento della lotteria dei corrispettivi se le transazioni sono effettuate con mezzi di pagamento tracciabili;
· lo stanziamento in un apposito Fondo di 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, destinato a finanziare il meccanismo del cd. Superbonus e a incentivare l’utilizzo del sistema dei pagamenti digitali;
· la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali dall’Irpef nella misura del 19 per cento solo se la spesa viene effettuata mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Il Governo, tuttavia, ritiene più rilevante, ai fini di un efficace contrasto all’evasione, l’accelerazione impressa alle misure di miglioramento della tax compliance, quali split payment e reverse charge, che trasferiscono l’onere del versamento dell’imposta dal venditore all’acquirente, più affidabile sul piano fiscale, l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica dalle sole transazioni B2G a tutte le transazioni tra soggetti IVA (B2B) e l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
La sezione VII del DEF presenta i dati relativi alle risorse destinate dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale, ponendo a raffronto i dati del 2019 con le previsioni per il periodo 2020-2023 (nel caso del Fondo sviluppo e coesione – FSC, comprendono anche le risorse relative al 2024 e 2025).
Ai complessivi 44,2 miliardi di euro autorizzati quale finanziamento del FSC si affiancano le risorse dei fondi della programmazione comunitaria, pari a 23,5 miliardi di euro quale finanziamento UE e a 16,1 miliardi di euro del cofinanziamento nazionale pubblico (Stato e Regioni).
| (milioni di euro) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 e ss |
| Programmazione nazionale |
|
|
|
|
|
| Fondo sviluppo e coesione |
6.351 |
6.857 |
7.286 |
7.854 |
22.242 |
|
|
|
|
|
|
|
| Programmazione comunitaria |
|
|
|
|
|
| FESR – Risorse UE |
1.713 |
2.300 |
2.500 |
2.700 |
3.000 |
| FSE – Risorse UE |
976 |
1.400 |
1.400 |
1.700 |
2.000 |
| FEASR – Risorse UE |
1.419 |
1.400 |
1.400 |
1.500 |
1.900 |
| FEAMP – Risorse UE |
54 |
60 |
70 |
70 |
100 |
| Risorse UE |
4.163 |
5.160 |
5.370 |
5.970 |
7.000 |
| FESR – Cofinanziamento nazionale |
953 |
1.300 |
1.350 |
1.400 |
1.700 |
| FSE – Cofinanziamento nazionale |
771 |
850 |
850 |
1.050 |
1.200 |
| FEASR – Cofinanziamento nazionale |
1.445 |
1.400 |
1.400 |
1.500 |
1.900 |
| FEAMP – Cofinanziamento nazionale |
44 |
50 |
55 |
55 |
80 |
| Cofinanziamento nazionale |
3.213 |
3.600 |
3.655 |
4.005 |
4.880 |
Al riguardo, il DEF sottolinea che “tenuto conto che l’attuale fase emergenziale richiede un’azione coordinata e incisiva di contrasto e di mitigazione degli effetti immediati e del futuro prossimo attraverso la mobilitazione delle risorse disponibili è attualmente in corso un’azione coordinata tra Governo, Regioni e Province Autonome al fine di utilizzare i fondi strutturali europei come una delle fonti finanziarie da attivare nell’immediato in funzione anticrisi. Sono, pertanto, attivate le procedure di riprogrammazione degli interventi previsti al fine di disporre con maggiore flessibilità delle risorse europee in funzione di contrasto all’emergenza. In esito a tali operazioni, gli importi dell’annualità 2020, riferiti alla quota comunitaria e a quella nazionale, saranno modificati in aumento”.
Nella successiva tabella sono riportate le dotazioni di competenza del Fondo sviluppo e coesione e del c.d. Fondo IGRUE (sul quale sono allocate le risorse del cofinanziamento statale dei fondi strutturali UE), come esposti nella legge di bilancio per il 2020.
| (milioni di euro) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 e ss |
| Fondo sviluppo e coesione (cap. 8000/MEF) |
6.856,8 |
7.286,0 |
7.854,2 |
22.242,4 |
| Fondo IGRUE – Cofinanziamento statale (cap. 7493/MEF) |
2.125,0 |
4.125,0 |
5.375,0 |
26.000,0 |
Per quanto riguarda le risorse aggiuntive del FSC è bene ricordare che, a fronte di stanziamenti in competenza pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2020 (che potranno essere contabilmente impegnati), le autorizzazioni di cassa ammontano a poco meno di 1,7 miliardi di euro. Si segnala, inoltre, che i residui passivi al 1° gennaio 2020 sono stimati in circa 26 miliardi di euro.
Analizzando i risultati della programmazione nazionale il DEF (VII.1), dopo aver ricordato che l’ammontare dei finanziamenti al FSC per il ciclo 2014-2020 è complessivamente pari a 68,8 miliardi di euro (ai 54,8 miliardi dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014, si sono aggiunti rifinanziamenti di 5 miliardi con la legge di bilancio 2018, di 4 miliardi con la legge di bilancio 2019 e 5 miliardi con la legge di bilancio 2020), ne illustra la destinazione effettuata dal CIPE, ai sensi dell’articolo 1, comma 703, della legge di stabilità 2015, attraverso l’assegnazione ai Piani stralcio, ai Piani operativi e ai relativi Addendum; una prima ricognizione riguarda il periodo dicembre 2016 - febbraio 2018, come certificata dalla delibera n. 26 del 2018; vengono poi segnalate le principali delibere intervenute nel 2019.
Analizzando l’utilizzo della disponibilità complessiva del FSC, pari a 68.810 milioni, 11.579 milioni sono stati utilizzati dal legislatore a copertura di oneri recati da specifiche norme di legge di finanziamento di interventi nel Mezzogiorno (comprensivi degli effetti della legge di bilancio 2020).
Della restante quota ben 50.844 milioni sono stati assegnati dal CIPE, fino al febbraio 2018 (delibera n. 26/2018), ai Piani stralcio, Piani operativi e Patti di sviluppo. Per il periodo successivo e fino alla fine del 2019, sono state effettuate assegnazioni per ulteriori 1.360 milioni. Conseguentemente la quota disponibile da assegnare risulterebbe pari a 5.027 milioni.
Riepilogando, le principali assegnazioni di risorse FSC effettuate dal CIPE per il ciclo 2014-2020 del FSC possono essere così sintetizzate:
§ per i Piani stralcio, sono stati assegnati 6,3 miliardi: al lordo del Piano Turismo e Cultura del valore di 1 miliardo di cui alla delibera n. 3/2016 (che viene qui conteggiato tra i Piani operativi), sono stati destinati in particolare 3,5 miliardi al piano “Banda ultra larga”, 500 milioni al finanziamento parziale degli investimenti del Programma Nazionale per la Ricerca, 450 milioni per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, 250 milioni per i contratti di sviluppo e 140 milioni per il completamento della metanizzazione del Mezzogiorno;
§ i Piani Operativi hanno avuto assegnazioni per 26,6 miliardi (comprensivi di 1 miliardo del Piano stralcio Turismo e Cultura), cosi riferite:
| Piano operativo |
Delibera |
Addendum o integrazione |
II Addendum e nuovi P.O. |
Altre |
TOTALE |
| Infrastrutture |
11.500,0 |
5.431,0 |
934,4 |
133,6 |
17.999,0 |
| Ambiente |
1.900,0 |
116,4 |
782,0 |
450,0 |
3.248,4 |
| Sviluppo economico e produttivo |
1.400,0 |
18,0 |
1.080,0 |
|
2.498,0 |
| Agricoltura |
400,0 |
12,6 |
|
130,0 |
542,6 |
| Cultura e turismo (con Piano Stralcio Del. n. 3/2016) |
|
|
740,0 |
1.030,4 |
1.770,4 |
| Salute |
|
|
270,0 |
|
270,0 |
| Sport e periferie |
|
|
250,0 |
|
250,0 |
| Conti pubblici territoriali |
|
|
16,8 |
|
16,8 |
| Totale |
15.200,0 |
5.578,0 |
4.073,2 |
1.744,0 |
26.595,2 |
§ Per quanto riguarda i Patti di sviluppo il CIPE ha assegnato con la delibera n. 26 del 2016 13.412 milioni ai 15 Patti per il Sud, mentre a quelli per il Centro-Nord sono stati destinati complessivamente 905 milioni.
§ Tra le altre assegnazioni di risorse FSC si segnalano i 280 milioni recentemente destinati al Contratto istituzionale di sviluppo dell’area di Foggia (CIS Capitanata) e i 220 milioni per il CIS Molise.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse del FSC, il DEF ricorda come il legislatore sia intervenuto sulla materia con l’art. 44 del decreto legge n. 34 del 2019 (peraltro recentemente modificato dalla legge di bilancio 2020), al fine di semplificare e rendere più efficienti i processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020. In particolare si prevede che, per ciascuna Amministrazione titolare di risorse a valere sul FSC, l'Agenzia per la coesione territoriale proceda ad una riclassificazione degli interventi contenuti nei diversi documenti programmatori attualmente in essere, al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE un unico Piano operativo per ogni amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
Il DEF focalizza la propria analisi sul Performance Framework (PF): si tratta del processo di monitoraggio costante circa il raggiungimento degli obiettivi intermedi (target) previsti nel quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione dei Programmi operativi (PO). Il PF verifica, pertanto, il legame tra gli obiettivi fissati attraverso i PO (Nazionali e Regionali) e i risultati effettivamente conseguiti, al fine di migliorarne l’efficacia.[59]
A tal fine la Ragioneria generale dello Stato, per mezzo della base-dati di monitoraggio unitario (BDU), verifica l’andamento dei valori degli indicatori[60] inclusi nel PF, considerando i dati inseriti e validati dalle singole amministrazioni.
Al riguardo il DEF afferma che “la riserva di Perfomance risulta interamente assegnata a n. 22 programmi (8 POR FESR, 13 POR FSE e 1 PON), parzialmente assegnata a 27 programmi (10 POR FESR, 4 POR FSE, 3 POR plurifondo, 10 PON) e non assegnata per un programma FSE. Le risorse non assegnate di tale programma, pari a circa 4 milioni di euro sono state proposte in riallocazione ad un programma FESR dello stesso territorio. I 27 programmi che hanno conseguito parzialmente i target stanno provvedendo alla riprogrammazione delle risorse su altri assi maggiormente performanti. Per i POR si tratta di riprogrammazioni interne. Alcuni PON, invece, hanno provveduto ad effettuare proposte di riprogrammazione con riallocazioni di risorse in altri PON non potendole riprogrammare in altri assi. Coinvolti in questa operazione sono stati i seguenti PON: PON Legalità, PON Inclusione, PON SPAO, PON Scuola, PON Governance, PON Metro.
In sintesi, su una riserva complessiva di 1.897,99 milioni di Euro (FESR e FSE al netto del cofinanziamento nazionale), vanno riassegnati ad altri assi dei propri o di altri programmi 543,24 milioni di euro di riserva FESR e FSE.”
Per quanto riguarda gli obiettivi di spesa 2019, il DEF sottolinea che i risultati raggiunti hanno consentito di superare le soglie di spesa previste al 31 dicembre 2019 per tutti i PO.
In particolare, al 31 dicembre 2019 la spesa complessivamente certificata alla Commissione europea dai Programmi FESR e FSE 2014-2020 è risultata pari a 15,2 miliardi di euro di cui 9,6 miliardi di euro a valere sulla quota UE, pari al 113% del target fissato a 8,4 miliardi di euro.
La spesa complessivamente certificata (15,2 miliardi) fa registrare un incremento di 5,4 miliardi di euro rispetto all’importo di 9,7 miliardi di euro conseguito al 31 dicembre 2018 e raggiunge il 28,5% del totale delle risorse programmate per i 51 Programmi Operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo 2014-2020 (pari a 53,2 miliardi di euro).
Al 31 dicembre 2019 lo stato di attuazione dei Fondi strutturali si attesta, per ciò che attiene agli impegni complessivamente assunti, ad un valore pari a oltre il 58,2% del contributo totale. Il livello dei pagamenti complessivi, rendicontati al 31 dicembre 2019, ha raggiunto oltre 16,7 miliardi, corrispondenti al 30,7% delle risorse programmate.
Il DEF, infine, sottolinea che “anche i programmi FEASR (Fondo Europeo Sviluppo Agricolo e Rurale) e il PO FEAMP (Fondo Europeo Attività Marittime e Pesca) sono stati soggetti alla verifica dei target per l’attribuzione della riserva di performance.
Il valore della riserva di perfomance dei programmi FEASR ammonta a 625,78 milioni di euro (al netto del cofinanziamento nazionale) e sono da riassegnare ad altre priorità 39,67 milioni di euro. Tale valore si riferisce solo a 6 programmi su 22.
Il PO FEAMP, su 24,94 milioni di euro (quota UE e Nazionale) afferenti due priorità, dovrà riassegnare ad altre priorità del programma 16,95 milioni di euro. Per quanto attiene gli obiettivi di spesa 2019, i risultati raggiunti hanno consentito di superare le soglie di spesa previste al 31 dicembre 2019 per tutti i PO del FEASR e del FEAMP”.
| Fondo |
Risorse programmate |
(di cui UE) |
Impegni |
Pagamenti |
% Impegni |
% Pagamenti |
| FESR |
34.509,3 |
22.499,7 |
19.659,0 |
9.992,2 |
56,97 |
28,96 |
| FSE |
19.719,5 |
11.987,7 |
11.917,2 |
6.666,3 |
60,43 |
33,81 |
| TOTALE |
54.228,8 |
34.487,4 |
31.576,2 |
16.658,5 |
58,23 |
30,72 |
Fonte: RGS, Monitoraggio Politiche di Coesione - Programmazione 2014-2020. Situazione al 31 dicembre 2019
Per una analisi dettagliata, si rinvia al Bollettino della Ragioneria generale dello Stato sul “Monitoraggio Politiche di Coesione - Programmazione 2014-2020. Situazione al 31 dicembre 2019”.
[1] Ad iniziare dall’Analisi annuale sulla crescita e dalla Relazione sul meccanismo di allerta dell’anno successivo, la Commissione dà anche conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell’attuazione delle raccomandazioni. Ciò avviene, in particolare, nell’ambito delle Relazioni per Paese, integrate dagli esami approfonditi per gli Stati (caratterizzati da più gravi squilibri macroeconomici) che vengono a tal fine indicati nella relazione sul meccanismo di allerta. Per quanto riguarda l’Italia, il relativo esame approfondito è contenuto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione “Relazione per Paese relativa all’Italia 2020” (per la quale si rinvia all’apposita sezione del presente dossier).
[2] La presentazione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile, è disciplinata dal Regolamento UE n. 473/2013, recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, che fissa, all’articolo 4, un calendario comune di bilancio.
[3] European Commission, Guidelines for a streamlined format of the Stability and Convergence Programmes in light of the Covid-19 outbreak, Brussels, 6 April 2020.
[4] Per un approfondimento sulla metodologia di calcolo dell'OMT si veda il dossier XVIII legislatura "Finanza Pubblica e Regole Europee: guida alla lettura e sintesi dei dati principali", seconda edizione, aprile 2018.
[5] Si specifica che per il triennio 2017-2019 l’OMT per l’Italia sarebbe stato un disavanzo strutturale di –0,5%. Il governo in carica all’epoca scelse un più ambizioso percorso di perseguimento del pareggio strutturale di bilancio.
[6] Per maggiori dettagli, si veda la pubblicazione annuale della Commissione Europea, Vademecum on the Stability and Growth Pact, 2019.
[7] Si ricorda che con la legge rinforzata n.243/2012 è stata data attuazione al nuovo articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio.
[8] In particolare, il DEF evidenzia come la persistente incertezza sul percorso della pandemia, l'intensità e l'efficacia degli sforzi di contenimento, la mancanza di miglioramento della fiducia, cambiamenti strutturali nel comportamento delle imprese e delle famiglie, prezzi delle materie prime volatili, potrebbero determinare una ripresa dell'economia globale – secondo l’FMI - più debole del previsto.
[9] Dopo una fase travagliata di negoziati, il Regno Unito ha lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020. Il periodo di transizione, durante il quale il Regno Unito e l'UE negozieranno le loro relazioni future, si concluderà il 31 dicembre 2020. La possibilità che un accordo formale non venga raggiunto costituisce ancora un rischio al ribasso e una fonte di incertezza che pesa sulle prospettive di crescita.
[10] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf?user=1653
[11] European Commission, Guidelines for a streamlined format of the Stability and Convergence in light of the COVID-19 outbreak, Brussels, 6 April 2020.
[12] Comunicato ISTAT, “Conti economici trimestrali” (4 marzo 2020).
[13] Comunicato ISTAT, “PIL e indebitamento delle AP – Anni 2016-2019” (2 marzo 2020).
[14] Si veda: ISTAT, "Prezzi delle abitazioni", marzo 2020.
[15] European Commission, Guidelines for a streamlined format of the Stability and Convergence Programmes in light of the COVID-19 outbreak, Brussels (6 Aprile 2020).
[16] Si veda, in particolare, il Reg. (EU) 473/2013, facente parte del c.d. Two-Pack.
[17] Confindustria, Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell’economia (marzo 2020)
[18] Le clausole di salvaguardia, si ricorda, prevedono un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2020 e a gennaio 2021, nonché un lieve rialzo delle accise sui carburanti a gennaio 2020. Secondo stime ottenute con il modello econometrico del Tesoro (ITEM), l’aumento delle imposte indirette provocherebbe una minore crescita del PIL in termini reali e un rialzo dell’inflazione - sia in termini di deflatore del PIL, sia di prezzi al consumo – rispetto ad uno scenario di invarianza fiscale. Questi impatti sarebbero concentrati negli anni 2020 e 2021, ma persisterebbero in minor misura anche nel 2022 tramite la struttura di ritardi di ITEM.
[19] DEF 2020, Sezione I, Tavola I.1 e Tavola II.2.c e
[20] Ai fini delle analisi contenute nel presente dossier si utilizza la NTI aggiornata in base al testo approvato della legge di bilancio per il 2020, resa disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.
[21] Comunicati “Pil e indebitamento AP”, del 2 marzo 2020; “IV trimestre 2019 - Conto trimestrale delle AP”, del 3 aprile 2020; “Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche”, del 22 aprile 2020.
[22] Il Documento afferma che la fatturazione elettronica obbligatoria attraverso il Sistema di Interscambio consente all’Amministrazione finanziaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute fra operatori e di effettuare controlli tempestivi e automatici, imprimendo anche un impulso significativo alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa. L’obbligo della fatturazione elettronica si è perciò rivelato uno strumento efficace nel contrasto alle pratiche evasive da omessa dichiarazione grazie alla tempestività, tracciabilità e capillarità delle informazioni che vengono acquisite dall’Amministrazione fiscale.
[23] Cfr. Focus “Contrasto all’evasione fiscale”, Sezione I.
[24] Relazione sull’Economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, Aggiornamenti per gli anni 2012-2017.
[25] Per i comparti ove tale emolumento è previsto.
[26] Con le Linee Guida del 6 aprile 2020 la Commissione europea, in considerazione dell’elevata incertezza economica causata dalla diffusione del Covid-19 e delle urgenti incombenze che gli Stati membri stanno affrontando, ha ridotto i contenuti obbligatori richiesti per i Programmi di Stabilità. L’Italia ha deciso di avvalersi di questa possibilità.
[27] Decreto legge n. 3 del 2020 che, con decorrenza 1 luglio 2020 dispone l’incremento da 80 a 100 euro al mese della misura del bonus e estende il beneficio ai soggetti non incapienti con reddito complessivo fino a 28.000 euro (in luogo di 26.600). Gli effetti finanziari lordi (stimati, ai fini del saldo netto da finanziare, in 6,6 miliardi nel 2020 e 13,2 miliardi dal 2021) costituiscono una “spesa corrente” nell’ambito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non sono considerati ai fini del calcolo della pressione fiscale.
[28] Disposta nella legge di bilancio 2020 e ivi qualificata come maggiore spesa corrente. In particolare, si tratta di 3 miliardi per l’anno 2020 e di 5 miliardi annui a decorrere dal 2021.
[29] Per l’andamento della spesa per interessi si rinvia all’apposito approfondimento.
[30] Per maggiori dettagli, cfr. Servizio del bilancio e Servizio studi del Senato della Repubblica e Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Finanza pubblica e regole europee: guida alla lettura e sintesi dei dati principali - Documentazione di inizio legislatura, Documentazione di finanza pubblica n. 1, aprile 2018.
[31] Commissione Europea, Communication from the Commission to the Council on the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact, 20.3.2020 COM(2020) 123 final. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf.
[32] Questa valutazione è in linea con quella riportata in: Ufficio Parlamentare di Bilancio, Memoria del Presidente dell’UPB sul DDL AS 1766 di conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18; 26 marzo 2020.
[33] Il rischio di sostenibilità di medio periodo è valutato attraverso l'indicatore S1 e le condizioni congiunturali (cicliche) dell’economia sono sintetizzate dall’output gap. l’indicatore di medio periodo S1 misura l’aggiustamento del saldo primario strutturale da realizzare in termini cumulati nei cinque anni successivi all’ultimo anno di previsione, in modo da garantire, se mantenuto costante negli anni successivi, il raggiungimento di un livello di debito/PIL pari al 60 per cento entro quindici anni sostenendo anche i maggiori costi legati all’invecchiamento. A motivo della sua costruzione, l’indicatore S1 è parametrizzato rispetto all’obbiettivo di debito pubblico sancito nel Patto di Stabilità e Crescita. Si veda a tal proposito Commissione europea, Vade Mecum on the Stability and Growth Pact, 2019 edition, Institutional Paper 101, aprile 2019, p. 15.
[34] Più precisamente l’aggregato di spesa riferimento è calcolato sottraendo, in ciascun anno, dalla spesa pubblica totale la spesa per interessi, la spesa per investimenti dell’anno in corso corretta per la dinamica dei precedenti quattro anni; la spesa per programmi europei finanziata dal bilancio comunitario; la componente ciclica dei sussidi di disoccupazione e la variazione delle misure discrezionali di entrata.
[35] Il tasso di crescita medio del potenziale è calcolato applicando una metodologia della funzione di produzione concordata a livello europeo che considera la media decennale delle previsioni della Commissione Europea centrata sull’anno in cui si esercita la valutazione. I dieci anni su cui viene calcolata la media sono quindi i quattro anni precedenti a quello della valutazione e i cinque anni successivi.
[36] La differenza tra il tasso di crescita appropriato per la spesa netta e il tasso di riferimento a medio termine della crescita potenziale del PIL viene indicato come margine di convergenza ed è impostato al fine di garantire un appropriato aggiustamento verso l'obiettivo a medio termine. Il margine di convergenza è calcolato per essere coerente con le richieste restrizioni del bilancio strutturale. Si veda Commissione europea, Vade Mecum on the Stability and Growth Pact, 2019 edition, Institutional Paper 101, aprile 2019, p. 28.
[37] Raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2019 sul programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Italia (2019/C 301/12).
[38] Commissione Europea, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact, 20.3.2020 COM(2020) 123 final
[39] La Comunicazione riguarda l’utilizzo di margini di flessibilità nel perseguimento dell’OMT per “tenere conto in modo ottimale di tre dimensioni politiche specifiche, concernenti rispettivamente: i) gli investimenti, in particolare riguardo all’istituzione del nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici nel quadro del piano di investimenti per l’Europa; ii) le riforme strutturali e iii) la situazione congiunturale”. Cfr. Commissione europea, Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e crescita, COM(2015) 12 final, 13.1.2015.
[40] Cfr. Economic and Financial Committee, A Commonly Agreed Position of Flexibility within the Stability and Growth Pact, 27 novembre 2015.
[41] L’articolo 5, par. 1, del Reg. (CE) n. 1466/97 dispone che: “Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo di bilancio a medio termine […], a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.” Corrispondentemente, l’art. 6, par. 3, del medesimo Regolamento, nel disciplinare la valutazione delle deviazioni dall'MTO o dal relativo percorso di avvicinamento, e le circostanze in presenza delle quali tali deviazioni risultino “significative” dispone che: “… la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.”
[42] Commissione europea, Vade Mecum on the Stability and Growth Pact, 2019 edition, Institutional Paper 101, aprile 2019, capitolo 2.
[43] Sebbene tali misure siano classificabili come una tantum secondo la definizione ufficiale del Report on Public Finances in EMU 2015, si riconosce che i provvedimenti adottati saranno: 1) difficilmente soggetti ad una rendicontazione dettagliata come avviene normalmente per le misure una tantum, 2) di importo anche inferiore a 0,1 per cento del Pil (soglia convenzionalmente adottata per le one-offs); 3) probabilmente articolati su un orizzonte temporale non solo annuale; 4) difficilmente quantificabili ex ante. Cfr. DEF Sezione I, p.85.
[44] Tali stime rappresentano i pagamenti relativi a progetti infrastrutturali per sottosettori di intervento considerati utili: al contrasto, alla mitigazione e alla prevenzione del dissesto tracciati dal Monitoraggio delle Opere Pubbliche ed altre spese erogate dal bilancio dello Stato e da apposite contabilità speciali. Queste comprendono le erogazioni dirette dei Commissari straordinari regionali per i “Piani strategici nazionali rischio idrogeologico” e, per il 2019, anche quelle relative alle misure attivate con la legge di bilancio per il 2019-2021 e affidate alla Protezione civile.
[45] Cfr. DEF 2020, Sezione I, p.119.
[46] Per ulteriori dettagli sulla risposta delle istituzioni europee alla pandemia e la sua evoluzione, si rinvia alla Nota "L'epidemia Covid-19 e l'Unione europea", pubblicata per la prima volta il 24 marzo 2020 (Nota UE n. 44) e successivamente aggiornata, con cadenza settimanale, con l'evoluzione della situazione al 27 marzo 2020 (Nota UE n. 44\1), al 3 aprile 2020 (Nota UE n. 44/2), al 10 aprile 2020 (Nota UE n. 44/3) e al 17 aprile 2020 (Nota UE n. 44/4).
[47] Si veda al riguardo la Nota Ue n 46 a cura del Servizio Studi del Senato.
[48] Per dettagli sulle proposte relative al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'evoluzione del negoziato per l loro approvazione si rinvia ai Dossier del Servizio studi del Senato: "Il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Le proposte originarie della Commissione europea" (78/DE) e "Il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I negoziati dopo la riunione del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020" (79\1 DE).
[49] Si rammenta che a settembre 2019 l'ISTAT ha apportato alcune modifiche alla stima del PIL mentre la Banca d'Italia ha apportato delle revisioni alle statistiche sul debito pubblico degli anni 2015-2018. Queste ultime, in particolare, derivano da una revisione della metodologia di valutazione di alcune categorie di depositi concordata a livello europeo. Per effetto di tale revisione, il debito pubblico del 2018 risulta maggiore di circa 58,3 miliardi rispetto alla precedente stima. Le revisioni relative agli anni precedenti sono ancora maggiori (65,9 miliardi di euro per il 2015, 64,9 miliardi per il 2016 e 59,7 miliardi per il 2017) in quanto riflettono anche gli effetti dell'ampliamento del perimetro delle Amministrazioni pubbliche definito dall'ISTAT. Per ulteriori dettagli su tali revisioni, cfr. Servizi del bilancio e Servizi studi della Camera e del Senato, Documentazione di finanza pubblica n. 8, Nota di aggiornamento del DEF 2019, 4 ottobre 2019.
[50] L'aggiustamento stock-flussi riflette operazioni finanziarie e di privatizzazione, nonché le poste di raccordo contabile tra dati di cassa e di competenza economica. A parità di altre condizioni, un suo aumento rispetto all'anno precedente aumenta il rapporto debito/PIL.
[51] A parità di ogni altra condizione, un avanzo primario (pari al saldo di bilancio al netto della spesa per interessi) in crescita rispetto all'anno precedente riduce il rapporto debito/PIL. Il c.d. "effetto valanga" (snow-ball) consiste nella differenza tra il tasso di interesse (costo medio) sul debito pubblico e il tasso di crescita del PIL nominale. A parità di altre condizioni, un effetto valanga in diminuzione rispetto all'anno precedente riduce il rapporto debito/PIL.
[52] Per ulteriori dettagli, cfr. i dossier sulle misure adottate pubblicati dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato e pubblicati nella pagina web dedicata alla documentazione sulla COVID-19. Per quanto riguarda l'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico, si veda, in particolare, Servizi del bilancio e Servizi studi della Camera e del Senato, "Interventi in materia di emergenza COVID-19: profili finanziari", Documentazione di finanza pubblica n. 12, marzo 2020.
[53] Rispettivamente con relazione del 5 marzo 2020 è stata richiesta autorizzazione per 6,35 miliardi di euro e con integrazione dell'11 marzo 2020 per ulteriori 13,75 miliardi.
[54] Per approfondimenti sul Semestre europeo, cfr. il dossier n. 37 del Servizio studi del Senato "Il Semestre europeo in Senato: procedure e prassi", marzo 2019. Sulle raccomandazioni specifiche per paese, cfr. la Nota breve n. 8 del Servizio del bilancio del Senato, "Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2019 dell'Italia", giugno 2019.
[55] La spesa pubblica primaria netta si compone della spesa pubblica totale al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell’Unione interamente coperta da entrate provenienti da fondi dell’Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. La formazione lorda di capitale fisso finanziata a livello nazionale è spalmata su un periodo di quattro anni. Rientrano nel calcolo le misure discrezionali in materia di entrate o gli aumenti delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda la spesa.
[56] SWD(2020) 511 final. Per approfondimenti, v. la Nota breve n. 14 (marzo 2020) del Servizio del bilancio e del Servizio studi del Senato.
[57] Presentano invece squilibri economici: Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. Per squilibrio macroeconomico si intende "ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione," mentre gli squilibri eccessivi sono "squilibri gravi, compresi quelli che mettono o potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria".
[58] European Economic Forecast, Winter 2020, Institutional Paper 121, febbraio 2020.
[59] Il Performance framework trova la base giuridica negli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303 del 2013. Si tratta di un set di indicatori fisici e finanziari previsti dai PO, stabiliti a livello di Asse, per i quali sono fissati dei valori intermedi e dei target finali da raggiungere, rispettivamente, nel 2018 e nel 2023, per il conseguimento di una dotazione di risorse pari al 6 per cento del valore del PO, chiamato “Riserva di performance”. La Commissione europea effettua la verifica dei target 2018 sulla base delle relazioni che le Autorità di gestione dei PO inviano ad essa nel 2019 e stabilisce l’eventuale raggiungimento dei target secondo specifici parametri di valutazione. Qualora si raggiungano i target intermedi 2018 la Commissione adotta una decisione con cui attribuisce la riserva di efficacia, attribuendo la quota sospesa del 6 per cento. Diversamente, lo Stato membro, dopo una concertazione con la Commissione, può ricollocare tali risorse premiali ad un’altra priorità più virtuosa.
[60] Le modalità di scelta degli indicatori è indicata all’Allegato 2 del Regolamento (UE) 1303 del 2013. Disposizioni sulla determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e valutazione del loro conseguimento sono contenute agli articoli da 4 a 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014.