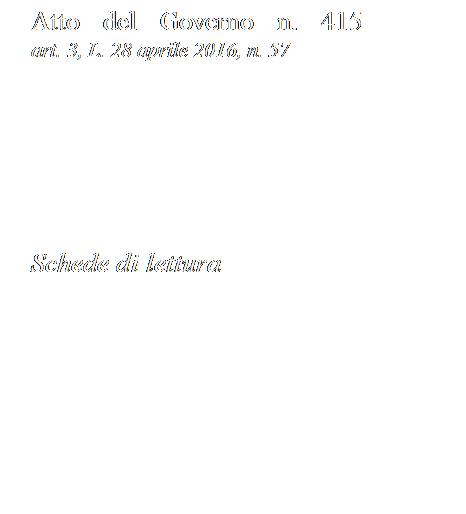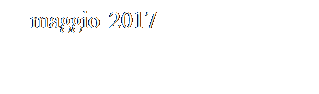Premessa
Lo schema di decreto
legislativo in esame (AG 415) - che consta di 36 articoli - completa l’attuazione della delega affidata al
Governo con la legge n. 57 del 2016. Quest’ultima, oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive (in materia
di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace nonchè di formazione di
tutti i magistrati onorari) - ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
In particolare, fermi restando gli specifici criteri
direttivi dettati (per la cui enunciazione si fa rinvio al contenuto delle
schede sulle singole disposizioni del provvedimento in esame), la legge delega ha previsto (art. 1) che
la normativa attuativa debba:
a)
prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio
giudiziario;
b)
prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio
della procura della Repubblica;
c)
disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria,
il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d)
operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle
incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e)
disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del
tribunale e della procura della Repubblica;
f)
disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata
massima dell'incarico;
g)
regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h)
individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i)
regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal
servizio;
l)
regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie
di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro
applicazione;
m)
prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare
i giudici onorari;
n)
prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;
o)
operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione
professionale;
p)
ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace,
nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia
e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i
casi di decisione secondo equità;
q)
prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione
di magistrati onorari elettivi;
r)
prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
s)
prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le
altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute
incompatibili.
Si ricorda
che una prima, parziale attuazione della delega è avvenuta con
il D.lgs. 92 del 2016 che ha
provveduto, in particolare, a confermare nell’incarico per 4 anni i giudici di
pace, giudici onorari di tribunale - GOT e viceprocuratori onorari - VPO in
servizio (alla data di entrata in vigore del decreto delegato), in possesso di
requisiti di idoneità all’esito della procedura di conferma straordinaria
introdotta; il D.Lgs ha poi stabilito una nuova composizione della sezione dei
magistrati onorari presso il consiglio giudiziario, comprendente sia i GOT che
i VPO
La relazione illustrativa del decreto attuativo in esame
precisa, tuttavia, come – sulla base del rispetto del carattere di onorarietà
dell’incarico - il Governo non abbia
dato attuazione alla materia dei trasferimenti d’ufficio e a domanda dei
magistrati onorari nonché alla materia disciplinare (art. 1, comma 1,
lett. g) e art. 2, comma 8, della legge delega).
Lo svolgimento di funzioni
giudiziarie onorarie trova copertura costituzionale nell’art. 106, secondo comma, Cost., secondo cui l’ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Tale ordinamento (RD 12/1941)
– oltre ad altre figure di giudici non professionali - ha previsto sia
l’attribuzione di limitate competenze ai giudice di pace che il supporto
all’attività del tribunali ordinari di magistrati onorari giudicanti (GOT) e
requirenti (VPO).
In
particolare, va ricordato come fin dalla riforma del giudice unico di primo
grado (D.Lgs. n. 51 del 1998), si
era stabilita la temporaneità delle disposizioni sull’utilizzo dei giudici onorari
di tribunale e dei viceprocuratori onorari presso i tribunali, prevedendo che
tale disciplina dovesse trovare applicazione fino al complessivo
riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque
entro 5 anni dall’effettivo passaggio di competenze al nuovo giudice (art.
245). Tale termine è stato più volte prorogato e, da ultimo, la legge di
stabilità 2016, lo aveva fissato al 31 maggio 2016.
Analoga temporaneità ha
riguardato le funzioni il giudice di pace; l’art. 7 della legge 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la
permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario
“in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace”.
Anche in tal caso, in attesa della riforma, il Governo è intervenuto con il
regime delle proroghe per prolungare l’attività di tali uffici, il cui apporto
nello smaltimento del contenzioso (come del resto accaduto per GOT e VPO) si è,
nel tempo, dimostrata sempre maggiore.
Si segnala che nel giugno 2016, la Commissione Europea ha
chiuso negativamente per l’Italia la procedura
EU-Pilot 7779/15/EMPL in relazione alla compatibilità con il diritto
dell’Unione di specifici profili della disciplina nazionale relativa al
servizio prestato dai magistrati onorari. Le misure introdotte dal
provvedimento in esame sono ritenute dal Governo idonee a rispondere
positivamente ai rilievi sollevati dalla Commissione (v. ultra).
Il termine per l’espressione del parere sullo schema di
decreto legislativo in esame è fissato al 10
giugno 2017.
Articolo 1
(Magistratura onoraria)
Il Capo I
(articoli 1-3) reca disposizioni
generali.
L'articolo 1, rubricato "magistratura onoraria",
dà attuazione alla delega volta a prevedere un'unica figura di giudice onorario
inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato
onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica, di
cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge n. 57 del
2016, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2
dell'articolo 2.
Il comma 1 dell'articolo 2
della legge delega individua quali principi direttivi per la creazione di
un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario,
l'unificazione del giudice di pace e del giudice onorario di tribunale nel
"giudice onorario di pace"(GOP).
La dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei relativi uffici
è di competenza del Ministro della giustizia.
In relazione ai VPO, il comma
2 dell'articolo 2 della legge n. 57 prevede il loro inserimento in una
specifica articolazione presso le Procure della Repubblica (“ufficio dei vice
procuratori onorari”) presso i tribunali ordinari. Anche in tal caso si prevede
che sia il Ministro a stabilire la dotazione organica dei VPO, ripartendoli tra
le Procure, anche tenendo conto del numero dei magistrati professionali in
organico.
Più nel dettaglio, ai sensi dell'articolo in esame la magistratura onoraria è costituita da:
ü
giudici
onorari di pace: magistrati onorari addetti all’ufficio del giudice di
pace. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall’articolo
9 dello schema (vedi infra);
ü
vice
procuratori onorari: magistrati onorari addetti all’ufficio dei vice
procuratori onorari, istituito ai sensi del articolo 2 (vedi infra). I compiti e le funzioni ad essi
assegnati sono disciplinati dall’articolo 16 dello schema (vedi infra);
Le funzioni
giudiziarie devono essere esercitate dal
magistrato onorario secondo principi di auto-organizzazione dell’attività, nel
rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e delle esigenze di
efficienza e funzionalità dell’ufficio.
L’incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche:
§
ha natura inderogabilmente temporanea;
La lettera a) del comma 7
dell'articolo 2 prevede, fra le altre, che, nell'esercizio della delega
contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera f) ("disciplinare il
procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima
dell'incarico"), debba essere attribuito all'incarico di magistrato
onorario natura imprescindibilmente temporanea.
§
si svolge in modo da assicurare la compatibilità
con lo svolgimento di attività lavorative o professionali. Al fine di
assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere
richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana;
A differenza di quanto
previsto per i giudici di pace, al momento della loro istituzione dalla legge
374/1991, l'incarico dei "nuovi" magistrati onorari non è più
incompatibile con attività di lavoro dipendente. Tale possibilità peraltro era
già contemplata con riguardo ai GOT e ai VPO. A ben vedere il DM 7 luglio 1999
(articolo 5, comma 6) esplicitamente indicava che non era di ostacolo alle
funzioni l'esercizio di attività lavorativa dipendente pubblica o privata, pur
essendo comunque necessario il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza
o del datore di lavoro.
§
non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.
Più
in generale, con riguardo alle caratteristiche dell'incarico di magistrato
onorario, nella relazione illustrativa si sottolinea come esse si pongano in
linea con la giurisprudenza costituzionale (Sentenza n. 103 del 1998) e di legittimità relativa alla figura del
funzionario onorario.
Articolo 2
(Istituzione
dell’ufficio dei vice procuratori onorari)
L'articolo, riprendendo testualmente quanto previsto dal
comma 6 dell'articolo 2 della legge delega con riguardo alle modalità di
impiego dei magistrati onorari all'interno delle procure della Repubblica, prevede l'istituzione, nelle procure della
Repubblica presso i tribunali ordinari, di
strutture organizzative denominate “ufficio dei vice procuratori onorari"(comma 1).
La lettera e) del comma 1
dell'articolo 1 della legge delega assegna il compito di disciplinare le
modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della
procura della Repubblica. Nell'esercizio di tale delega l'articolo 2, comma 6,
lettera a) impone al legislatore delegato di costituire presso l'ufficio di
procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice
procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il
tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 73 del DL 69/2013 e dell'articolo 37,
commi 4 e 5 del DL 98/2011.
All'istituendo ufficio sono preposti - secondo le
determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica-:
§
i vice procuratori onorari,
§
il personale di segreteria,
§
coloro
che svolgono il tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98 o la formazione professionale dei laureati a norma dell’articolo
37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (comma
2).
L’articolo 73 del D.L.
69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), prevede che i laureati in
giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta,
a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli
uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di
appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo
grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i
minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
I commi 4 e 5 dell'articolo
37 del D.L. 98/2011 (convertito con legge 15 luglio 2011, n.111) prevedono che,
in relazione alle concrete esigenze organizzative dell’ufficio, i capi degli
uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico
della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le
scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli
ordini degli avvocati, per consentire ai più meritevoli, su richiesta
dell’interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario per la
magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi
uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso
di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per
l’ammissione all’esame di avvocato. Gli ammessi alla formazione professionale
negli uffici giudiziari potranno assistere e coadiuvare i magistrati che ne
faranno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti
di studio.
Articolo 3
(Dotazione
organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta
organica dell’ufficio del giudice di pace)
L’articolo, in attuazione delle lettere b) dei commi 1 e 2
dell'articolo 2 della legge delega, demanda
ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del CSM, la fissazione del ruolo organico dei
giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari.
Il ruolo deve essere definito tenendo conto delle esigenze
di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, in relazione a tutti
i compiti e le funzioni attribuiti ai giudici onorari di pace dal Capo III del
provvedimento in esame. Con separato decreto del Ministro della giustizia è
determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace e degli uffici
dei viceprocuratori onorari(commi 1 e 3).
I principi e criteri direttivi
indicati dall’art. 2 riguardano i contenuti della delega volti a prevedere un’unica figura di giudice onorario,
I commi 1 e 2 dell’articolo 2
della legge delega recano i contenuti della delega volti a prevedere un’unica
figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (art. 1,
lett. a)) nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito
nell'ufficio della procura della Repubblica (art. 1, comma 1, lett. b)). Con
riguardo alla determinazione della dotazione organica di entrambi la delega
prevede che vi provveda il Ministro della giustizia.
Al decreto ministeriale di determinazione della pianta
organica è altresì demandata l'individuazione, per ciascun ufficio del giudice
di pace, del numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione
civile e penale presso il medesimo ufficio nonché del numero dei giudici
onorari di pace addetti all’ufficio per il processo del tribunale nel cui
circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace (comma 7).
I commi 2 e 4
prevedono che in sede di prima applicazione la dotazione organica dei magistrati
onorari non possa, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati
professionali che svolgono funzioni giudicanti/requirenti di merito (non si considerano i
magistrati professionali con funzioni direttive di merito
giudicanti/requirenti).
La dotazione organica e le piante organiche, nonché le
relative modifiche sono quindi stabilite - precisano i commi 5 e 6 dell'articolo- in modo da assicurare il rispetto di
quanto disposto dal precedente comma 3.
Infine il comma 8
della disposizione in commento precisa che, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 57 del 2016, i criteri per la
determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice
procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il contenuto del
comma 8 trova fondamento in quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della legge
delega.
In proposito è opportuno rilevare come il
rinvio sembra doversi considerare al comma 2 dell'articolo 9 della legge
delega.
Occorrerà verificare, nell’attuazione a
regime del decreto legislativo, l’adeguatezza dei nuovi organici rispetto al
contenimento dell’impegno settimanale dei magistrati onorari, previsto
dall’articolo 1 dello schema di decreto, cui si aggiungerà l’incremento delle
loro competenze e la nuova disciplina relativa alle loro funzioni e compiti.
Articolo 4
(Requisiti
per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario)
Il Capo II (articoli 4-7) reca norme in materia di
conferimento dell'incarico di magistrato onorario, di tirocinio e di
incompatibilità
Per quanto concerne l'articolo 4, il comma
1, in attuazione del comma 3 dell’articolo 2 della legge delega, individua i requisiti essenziali per il
conferimento dell’incarico di magistrato onorario.
L'articolo 1, comma 1,
lettera c), della legge delega demanda al Governo il compito di disciplinare i
requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento
di nomina e il tirocinio. Il successivo articolo 2, al comma 3, indica che
nell'esercizio di tale delega il legislatore preveda alcuni requisiti
essenziali.
Più in particolare è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
§
cittadinanza italiana;
§
esercizio dei diritti civili e politici;
§
essere di condotta incensurabile;
Tale requisito sembra voler
dare attuazione al requisito dell' onorabilità previsto dalla delega al numero
4) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2.
§
idoneità fisica e psichica;
§
età non inferiore a ventisette anni e non
superiore a sessanta;
La disposizione
non sembra precisare se i limiti di età vadano considerati al momento della
domanda ovvero a quello della nomina (la quale peraltro segue al periodo di
tirocinio obbligatorio).
§
laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni;
La disposizione non sembra escludere quindi la
validità di lauree quadriennali in giurisprudenza conseguite in altri Stati
dell'Unione europea, alle quali può essere riconosciuto valore legale in
Italia.
§
residenza in un comune compreso nel distretto in
cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta
eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni
notarili;
§
in caso di partecipazione alla assegnazione di
incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente,
nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta, conoscenza,
rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la
valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti
disposizioni di legge.
Questi ultimi due requisiti non sembrano trovare
diretto riscontro nella delega. Tuttavia trattandosi di "requisiti
essenziali" la delega stessa sembra consentire integrazioni ulteriori da
parte del legislatore delegato.
Il comma 2
dell’articolo vieta il conferimento
dell’incarico a coloro che:
§
hanno riportato condanne per delitti non colposi
o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
§
sono stati sottoposti a misure di prevenzione o
di sicurezza personali;
Con riguardo a queste ultime
due preclusioni si veda la lettera a),
numero 3), del comma 3 dell'articolo 2 della legge delega, la quale impone al
legislatore delegato di prevedere tra i requisiti il non aver riportato
condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli
effetti della riabilitazione.
§
hanno subito sanzioni disciplinari superiori
alla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;
La lettera a), numero 4), del
comma 3 dell'articolo 2 della legge delega impone al legislatore delegato di
prevedere tra i requisiti richiesti l'onorabilità " anche con riferimento
alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate.
§
sono stati collocati in quiescenza;
Si veda in proposito la
lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge delega, la quale impone al
legislatore delegato di prevedere che la nomina a magistrato onorario sia
preclusa per i soggetti che pur essendo in possesso dei requisiti previsti,
risultano collocati in quiescenza.
§
hanno svolto per più di quattro anni, anche non
consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente
decreto;
§
non sono stati confermati nell’incarico di
magistrato onorario, a norma dell’articolo 18; o è stata disposta nei loro
confronti la revoca dell’incarico, a norma dell’articolo 21.
Il comma 3, recependo la lettera b) dell’articolo 2 della legge
delega, prevede i titoli preferenziali
per la nomina a magistrato onorario.
Più nel dettaglio costituiscono
titolo di preferenza, nell’ordine:
§
l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie,
comprese quelle onorarie;
Il numero 1) della lettera b)
dell'articolo 2 della legge delega prevede quale titolo preferenziale l'aver
esercitato "funzioni giudiziarie a titolo onorario".
§
l'esercizio, anche pregresso, per almeno un
biennio, della professione di avvocato;
La legge delega, all’articolo
2, comma 3, lettera b), n. 2), non richiede un periodo minimo di esercizio. E'
opportuno rilevare inoltre che, a differenza di quanto indicato dalla
precedente legislazione con riguardo ai giudici di pace, non è sufficiente il
superamento dell’esame di abilitazione forense, ma è necessario un concreto,
pieno esercizio della professione.
§
l'esercizio, anche pregresso, per almeno un
biennio, della professione di notaio;
Anche in questo caso il legislatore delegato ha integrato il
principio di delega stabilito dall’articolo 2, comma 3, lettera b), n.3),
richiedendo un periodo minimo di esercizio.
§
l'esercizio, anche pregresso, per almeno un
biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
Con insegnamento delle
materie giuridiche la disposizione di delega ( n.4) della lettera b) del comma
3 dell'articolo 2) sembra voler alludere all’insegnamento in senso stretto, e
quindi riguardare professori ordinari o associati o anche docenti a contratto,
restando esclusi i ricercatori. Il legislatore delegato, tuttavia, ha ritenuto
di attribuire rilevanza anche all’attività di ricerca (vedi infra).
Costituiscono altresì titoli
preferenziali (anche se essi non trovano diretto riscontro nella legge
delega):
§
lo svolgimento con esito positivo del tirocinio,
senza che sia intervenuto il conferimento dell’incarico di magistrato onorario;
§
l'esercizio pregresso, per almeno un biennio,
delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie
con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
§
lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a
norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;
§
il conseguimento del dottorato di ricerca in
materie giuridiche;
§
l'esercizio, anche pregresso, per almeno un
biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori
statali.
A parità di titolo preferenziale, la disposizione riconosce
precedenza a coloro che hanno la più elevata anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci
anni di anzianità; e in caso di ulteriore parità coloro che hanno la minore età
anagrafica o ancora in subordine coloro che hanno conseguito il più elevato
voto di laurea (comma 4).
La
lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge delega riconosce la
precedenza, in caso di parità, a coloro che hanno la più elevata anzianità professionale
e in caso di ulteriore parità. a coloro che hanno la minore età anagrafica.
Articolo 5
(Incompatibilità)
L’articolo 5 disciplina le
cause di incompatibilità dei magistrati onorari.
La lettera d) del comma 1
dell'articolo 1 della legge delega conferisce delega al Governo a "operare
la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità
all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario". I principi e criteri
direttivi ai quali deve attenersi il legislatore delegato sono puntualmente
indicati nel successivo comma 4 dell'articolo 2.
Più nel dettaglio, ai sensi del comma 1, non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
§
i membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle
giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali;
§
gli ecclesiastici e i ministri di qualunque
confessione religiosa;
§
coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei
tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e
movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
§
coloro che ricoprono la carica di difensore
civico;
§
coloro che svolgono abitualmente attività
professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per
istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la
parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli
affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel
circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
Per
quanto concerne l’incompatibilità legata ai conviventi e congiunti è opportuno
ricordare che il CSM, chiamato a interpretare analoga previsione, nella
circolare 21 gennaio 2000, n. P-1436, aveva circoscritto il generico concetto
di attività professionale per imprese assicurative o banche- recato
dall’articolo 8, lettera c-bis) della
legge 374/1991- al concreto esercizio negli uffici legali delle stesse,
ritenendo che solo tale situazione potesse porre il giudice in una situazione
di conflitto d’interessi.
Il comma 2 prevede – riprendendo quanto già
previsto con riguardo ai giudici di pace e ai GOT e VPO- particolari preclusioni con riguardo agli esercenti l’avvocatura.
In conformità alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 della legge delega,
si prevede che gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le
funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario
del tribunale:
§
nel quale esercitano la professione forense,
ovvero
§
nel quale esercitano la professione forense i
loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci
della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell’unione civile o i conviventi, i parenti fino al
secondo grado o gli affini entro il primo grado.
Gli avvocati che esercitano la propria attività
professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non
possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del
tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi.
La disposizione precisa che non costituisce causa di
incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i
minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili,
nonché davanti alle commissioni tributarie.
Quest’ultima precisazione,
già prevista dalla delega, sembra giustificarsi in ragione del differente
ambito delle rispettive attività.
Il comma 3 ,
riprendendo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della delega, aggiunge
che gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di
magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli
uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio
giudiziario al quale sono assegnati e
non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale
divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione
professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte
dell’unione civile, ai conviventi,
ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
Tale preclusione
sembra interessare la sola attività giudiziaria, non ricomprendendo anche
l’attività stragiudiziale o di consulenza svolta nel circondario.
Conformemente alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2
della legge delega, si prevede il divieto di assegnare allo stesso ufficio
giudiziario magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al
secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza ovvero
siano parti di un’unione civile (comma 4).
Infine ai sensi del comma 5 (riprendendo la lettera e) del
comma 4 dell'articolo 2 della legge delega) il magistrato onorario non può
ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito
dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel
circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Tale divieto rileva in particolare per i notai, ma anche per
gli avvocati, come nell’ipotesi di professionista delegato nelle divisioni ed
esecuzioni immobiliari.
Articolo 6
(Ammissione
al tirocinio)
L'articolo detta disposizioni in materia di ammissione al
tirocinio, demandando al CSM l'individuazione
con propria delibera, da adottarsi entro il 30 marzo di ogni anno, dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nell'anno
successivo, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei VPO;
nonché la determinazione delle modalità
di formulazione del relativo bando e del termine per la presentazione delle
domande (comma 1).
Il comma 3 dell'articolo 2
della legge delega (lettere e), f) e g)) prevede i criteri e i principi direttivi
ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c) relativa alla disciplina dei requisiti e
delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, del procedimento di
nomina e dei tirocini). In particolare si attribuisce la competenza in ordine
al bando di concorso per titoli per magistrato onorario alla sezione autonoma
della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario. Alla stessa sezione del
Consiglio giudiziario è attribuita la competenza ad istruire e valutare le
domande di partecipazione e, all’esito, trasmettere al CSM le proposte di
ammissione al tirocinio, sul quale poi delibera lo stesso CSM.
Per quanto concerne il
necessario periodo di formazione prima di essere immessi nelle funzioni
giudiziarie onorarie, il principio di delega non prevede la durata del
tirocinio del magistrato onorario presso il magistrato affidatario, rimettendo
alle disposizioni adottate nell’esercizio della delega la disciplina sulla
durata e le modalità di svolgimento del periodo formativo. Compete alla sezione
autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario formulare
un giudizio di idoneità e proporre (al CSM) una graduatoria degli idonei alla
nomina a magistrato onorario (non viene precisato, ma si presume, sulla base
delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione
ai corsi). La nomina a magistrato onorario avviene con decreto del Ministro
della giustizia, in conformità alla deliberazione di idoneità del CSM.
E’ esplicitamente escluso dal
principio di delega che al magistrato onorario sia dovuta - durante il
tirocinio - qualche forma di indennità.
All’adozione
e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli
incarichi nel rispettivo distretto provvede,
entro trenta giorni dalla delibera del CSM, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario,
dandone notizia mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia
nonché comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonché
alle università aventi sede nel distretto (comma
2).
La lettera q) dell' articolo
1 della legge n. 57/2016 (per i principi di delega si veda l'articolo 2, comma
16 della legge n. 57) ha demandato al Governo la disciplina, all'interno dei consigli
giudiziari, di una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari.
In attuazione della delega è stato adottato il decreto legislativo 92/2016(Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la
conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari in servizio).
Dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine, stabilito nel bando, per la presentazione al
presidente della corte di appello delle domande, nelle quali sono indicati i
requisiti e i titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato
dal CSM. Alla domanda è allegata la dichiarazione attestante l'insussistenza
delle cause di incompatibilità (si veda
l'articolo 5 dello schema) (comma 3).
La disposizione prevede poi, al comma 4, che gli interessati possono presentare, in relazione ai posti
individuati, domanda di ammissione al
tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto.
La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio
giudiziario, acquisito il parere dell’ordine professionale al quale il
richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli
aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 4 commi 3 e 4
(relativi ai titoli di preferenza) e formula le motivate proposte di ammissione
al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti (comma 5).
Le domande degli interessati e le proposte della sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono trasmesse al CSM
(comma 6).
Quest'ultimo, ai sensi del comma 7, delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio
di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti
individuati, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all’unità
superiore
Articolo 7
(Tirocinio
e conferimento dell’incarico)
L'articolo 7, dando
attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c) della
legge n. 57, disciplina il tirocinio e
il conferimento dell'incarico.
Con riguardo alla delega, l' articolo
1, comma 1, lett. c) attribuisce al Governo il compito di disciplinare i
requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento
di nomina ed il tirocinio secondo i principi e criteri direttivi enunciati dal
comma 3 dell’articolo 2.
Il principio di delega non
contempla un termine di durata del tirocinio del magistrato onorario presso il
magistrato affidatario, rimettendo alle disposizioni adottate nell’esercizio
della delega la disciplina sulla durata e le modalità di svolgimento del
periodo formativo. La delega attribuisce alla sezione autonoma della
magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario il compito di formulare
un giudizio di idoneità e a proporre (al CSM) una graduatoria degli idonei alla
nomina a magistrato onorario (non viene precisato, ma si presume, sulla base
delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione
ai corsi.
La nomina a magistrato
onorario avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla
deliberazione di idoneità del CSM. E’ esplicitamente escluso dal principio di
delega che al magistrato onorario sia dovuta - durante il tirocinio - qualche
forma di indennità.
Più dettagliatamente, la disposizione (comma 3) prevede che il tirocinio - in relazione al quale non
spetta al magistrato alcuna indennità (comma
11)- per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, la cui durata è fissata in sei mesi, debba essere
svolto per i giudici onorari di pace nel tribunale ordinario nel cui
circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata
disposta l’ammissione al tirocinio; per i vice procuratori onorari, nella
procura della Repubblica presso la quale è istituito l’ufficio dei
viceprocuratori onorari in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al
tirocinio, sotto la direzione di un
magistrato collaboratore. Questi si avvale di magistrati professionali
affidatari, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in
materia civile e penale (comma 5).
Né ai magistrati collaboratori né a quelli affidataria spetta un compenso
aggiuntivo o un rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa in
questione (comma 12).
Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici
giudiziari, consiste altresì nella
frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non
inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. Tali
corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla
struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di corte d’appello,
e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori
assicurano l’assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano
lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e
altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della
magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata,
sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell’allegata documentazione
comprovante l’esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività
pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati un
rapporto per ciascun magistrato onorario (comma
6).
L'organizzazione dei tirocini è posta a carico del CSM e
della Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e
attribuzioni (comma 1). Il CSM, in
particolare, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce, con
delibera, la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari (comma 2).
Spetta alla sezione autonoma del
consiglio giudiziario organizzare e coordinare il tirocinio svolto presso gli
uffici giudiziari secondo le direttive generali del CSM, procedendo peraltro
alla nomina dei magistrati collaboratori (vedi supra) tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e
di elevato prestigio professionale (comma
4).
Per quanto concerne il conferimento
dell'incarico, la disposizione prevede che la sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del
magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai
magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto della
struttura formativa decentrata, formula un parere sull’idoneità del magistrato
onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al CSM la graduatoria
degli idonei per il conferimento dell’incarico, formata sulla base della
graduatoria di ammissione al tirocinio (comma
7).
Acquisita la graduatoria e la documentazione allegata, spetta
al CSM designare i magistrati onorari idonei al conferimento dell’incarico in
numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio (comma 8). L'incarico è
formalmente conferito con decreto del Ministro della giustizia (comma 9).
Infine la disposizione prevede che gli ammessi al tirocinio
che hanno conseguito l’idoneità e ai quali non sia stato conferito l’incarico
nell’ufficio in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio,
possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi risultate vacanti (comma 10).
Articolo 8
(Coordinamento
ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace)
Il Capo III (articoli 8-14) reca norme in materia di organizzazione
dell'ufficio del giudice di pace, delle funzioni e dei compiti dei giudici
onorari di pace.
Più nel dettaglio, l'articolo 8 attribuisce al presidente
del tribunale il coordinamento e la vigilanza dell'ufficio del giudice di pace
che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro,
mediante il ricorso a
procedure automatiche, tra i giudici. Questi è altresì chiamato a vigilare
sulla loro attività e a sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed
ausiliari, esercitando ogni altra funzione di direzione che la legge
attribuisce al dirigente dell’ufficio giudiziario (comma 1). Nello svolgimento di tali compiti, il presidente del
tribunale può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali (comma 3).
La previsione e
regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i
giudici onorari di pace (articolo 1, comma 1, lettera m) costituisce uno dei
profili di maggior rilievo della legge delega.
Infatti, la disciplina anteriore
alla legge n. 57 individuava l’ufficio del giudice di pace come autonoma
struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal
giudice di pace coordinatore (il più anziano per le funzioni giudiziarie
esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di
assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età) (art. 15,
L. 374/1991). I
principi e criteri direttivi inerenti a tale contenuto della delega prevedono
anzitutto l’attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento
dell’ufficio del giudice di pace, di provvedere alla gestione complessiva del
personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) che
amministrativo. In tale ambito, il presidente provvede alla predisposizione
delle tabelle di organizzazione dell’ufficio onorario, da sottoporre al
presidente della Corte d’appello. L’assegnazione degli affari ai giudici
onorari di pace deve avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente
del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche.
In considerazione della
gravosità dei nuovi compiti, la delega prevede che il presidente del tribunale
possa avvalersi dell'ausilio di giudici professionali.
Ai sensi del comma 2,
la proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all’articolo
7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, relativo alle tabelle degli uffici giudiziari. Il Presidente della Corte di appello
formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale,
sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari.
Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici
professionali il compito di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace
in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione
di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di stabilire le
direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle
riunioni trimestrali di cui all'articolo 22 dello schema (comma 4).
Infine con riguardo ai procedimenti di espropriazione
forzata si prevede che dodici mesi prima della scadenza del termine di cui
all’articolo 33, comma 3 (30 ottobre 2021), il Ministero della giustizia metta
a disposizione dell’ufficio del giudice di pace i programmi informatici
necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione
mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono
in possesso di terzi e per l’assegnazione con modalità automatiche dei medesimi
procedimenti. Tali programmi assicurano che l’assegnazione degli affari abbia
luogo secondo criteri di trasparenza (comma
5).
Articolo 9
(Funzioni
e compiti dei giudici onorari di pace)
L’articolo 9 disciplina
le funzioni e i compiti dei giudici
onorari di pace.
Il comma 5 dell'articolo 2
della legge n. 57 detta i principi e criteri direttivi per l’esercizio della
delega (di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1) relativa
all’impiego nei tribunali dei giudici onorari.
Nell'esercizio della delega il Governo
deve rispettare tre principi e criteri direttivi:
§
attribuire al Presidente del tribunale il
compito di inserire i giudici onorari nell’ufficio per il processo. All’interno
dell’ufficio del processo – nel quale dovranno restare tutti i giudici onorari
di pace per i primi 2 anni di incarico (comma 7, lettera e) dell'articolo 2) -
i magistrati onorari di pace potranno coadiuvare il giudice togato, compiendo
tutti gli atti preparatori all’esercizio della funzione giurisdizionale;
compiere tutte le attività e adottare tutti i provvedimenti che gli vengono
delegati dal giudice togato.
§
disciplinare la possibile applicazione dei
giudici onorari nel collegio. Pur escludendo l’applicazione del magistrato
onorario quale componente delle sezioni specializzate, la legge consente
infatti ai presidenti di tribunale di applicare i giudici onorari di pace, che
abbiano già svolto 2 anni di incarico, quali componenti dei collegi giudicanti
civili e penali. Tale applicazione, dovrà essere prevista in casi «tassativi,
eccezionali e contingenti» e in presenza di determinati presupposti.
§
disciplinare la possibile applicazione dei
giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di
competenza del tribunale ordinario. Anche in questo caso dovrà trattarsi di
magistrati onorari che abbiano già svolto 2 anni di incarico (presso l’ufficio
del processo) e il legislatore delegato è chiamato a individuare ipotesi
tassative che giustifichino questa applicazione, escludendo l’applicazione di
magistrati onorari nella trattazione di determinati procedimenti
Più nel dettaglio, la disposizione (comma 1) prevede che i giudici onorari di pace esercitano, presso
l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la
funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di rito
e delle leggi speciali.
Ai sensi del comma 2,
i giudici onorari di pace possono essere
assegnati all’“ufficio per il processo”, costituito presso il tribunale del
circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale
sono addetti.
L’articolo 50 del
decreto-legge n. 90 del 2014 ha introdotto l’ufficio per il processo,
prevedendo espressamente che di esso debbano fare parte anche i giudici
onorari. Nella relazione illustrativa oltre ad essere forniti cenni anche di
diritto comparato sulle strutture di assistenza ai magistrati si ricorda come
la scelta legislativa sottesa alla creazione dell’ufficio per il processo si
innesti in una prassi sperimentale da anni condotta – con successo- in alcuni
uffici giudiziari (Tribunali di Firenze, Milano, Prato, Modena e Bologna).
In “chiave formativa” la disposizione prevede l’obbligatorio
ed esclusivo inserimento dei giudici onorari di pace nelle strutture
dell’Ufficio per il processo per i primi
due anni del mandato (comma 4).
I giudici onorari di pace assegnati a tale struttura non
possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del
giudice di pace (comma 3).
Ai giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il
processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo
11 (vedi infra), la trattazione di
procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario (comma 5).
Come si precisa nella
relazione illustrativa, la natura assolutamente residuale di tale modalità di
impiego del giudice onorario (conforme peraltro alla delega, vedi supra) si fonda sul recupero di
efficienza che deriva dall'istituzione dell'ufficio per il processo e dalla
riforma della magistratura onoraria e in particolare delle disposizioni che
ampliano soprattutto nel settore civile ma anche in quello penale la competenza
dell'ufficio onorario del giudice di pace, con un significativo effetto
deflattivo sui tribunali ordinari. Per tale ragione il legislatore ha deciso di
riservare al giudice professionale in via tendenzialmente esclusiva la
decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del
tribunale, anche mediante l'impiego del modello organizzativo della delega dei
provvedimenti anche definitori.
Articolo 10
(Destinazione
dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo)
L'articolo 10 reca
norme concernenti l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il
processo. Esso attribuisce compiti specifici al presidente di tribunale e
definisce le modalità del procedimento di assegnazione. Sono quindi
disciplinate le funzioni che possono essere delegate al giudice onorario di
pace presso l'ufficio.
L'articolo 2, comma 5, della legge n. 57 del 2016, reca i criteri di
delega con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari di pace
all'interno del tribunale. In particolare la lett. a), alinea, di tale comma stabilisce che, nell'esercizio della
delega, si attribuisca al presidente del tribunale il compito di inserire
i giudici onorari nell’ufficio per il processo.
I commi da 1 a 9 disciplinano le modalità dell'inserimento, a
domanda o d'ufficio, e i casi di revoca.
Il comma 1 dell'articolo in
epigrafe prevede che la
proposta di assegnazione all'ufficio per il processo, formulata dal
presidente di tribunale, dovrà tenere conto di quanto previsto dal decreto
del Ministro della giustizia che fissa la pianta organica degli uffici
del giudice di pace, previsto dall'art. 3, comma 1, dello schema di decreto in
esame. La proposta di assegnazione dovrà quindi tenere conto del limite dei
giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo, ivi determinato, e
conformarsi ai criteri indicati, in via generale, dal CSM con propria delibera.
Si
ricorda qui solamente che l’articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, introducendo
l’ufficio per il processo, ha previsto espressamente che di esso debbano fare
parte anche i giudici onorari. Inoltre si rammenta che l'art. 9, comma 2, del
presente provvedimento prescrive che i giudici onorari di pace possono essere
inseriti nell'ufficio del processo del tribunale del circondario presso cui
ha sede l'ufficio di giudice di pace al quale sono addetti.
Il comma 2
pone in capo al presidente di tribunale l'individuazione delle posizioni da
coprire nell'ufficio per il processo, almeno due volte l'anno, tenendo
conto anche delle assegnazioni in scadenza nei sei mesi successivi. Il presidente
propone quindi l'assegnazione d'ufficio dei giudici onorari di pace ai
quali sia stato conferito l'incarico da meno di due anni: i soggetti che si
trovino in tale condizione, infatti, devono essere assegnati all'ufficio per il
processo ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente provvedimento (cfr. la relativa scheda). Peraltro il comma
7 stabilisce che tale assegnazione d'ufficio cessa di produrre effetti alla
scadenza dei due anni.
Sempre ai fini delle
successive assegnazioni, ai sensi del comma 3 il presidente determina le
posizioni residue che dovranno essere comunicate a tutti i giudici
onorari di pace del circondario.
Il comma 4
elenca i criteri di valutazione che il presidente - ferme le esigenze
di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato
- dovrà seguire per individuare i magistrati da assegnare in caso di più
aspiranti.
In particolare il
presidente dovrà valutare:
a)
l'attitudine
del candidato ai compiti e alle attività da svolgere, sulla base della sua
complessiva esperienza professionale pregressa (con riferimento alle attività
svolte, alle materie e alla tipologia di affari trattati, alle esperienze
professionali non giurisdizionali); si prevede espressamente che si debba
accordare la preferenza a magistrati con "esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee";
b)
il tempo
dedicato dall'aspirante nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti
all'ufficio;
c)
la posizione in graduatoria di ammissione al tirocinio.
Il comma 5
prevede che, in mancanza di aspiranti, si debbano scegliere coloro ai
quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo.
Il criterio si deve applica anche quando l'aspirante abbia operato in settori
diversi da quello di destinazione. Le eventuali ragioni che siano in conflitto
con tale criterio devono essere espressamente indicate nella proposta di
assegnazione.
Sembrerebbe opportuno chiarire il criterio
previsto dal comma 4, lett. b), relativo al "tempo trascorso nello
svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all’ufficio", anche alla
luce di quanto disposto "in chiave formativa" dall'art. 9, comma 4,
dello schema di decreto (assegnazione in esclusiva all’ufficio del processo nei
primi due anni dell’incarico, cfr. sopra).
La disposizione del
comma 4 relativa ai criteri di valutazione ai fini dell'assegnazione
all'ufficio per il processo, come sopra accennato, mantiene ferme le esigenze
dell'ufficio del giudice di pace cui gli aspiranti sono assegnati. Tali
esigenze sono considerate prioritarie - come rilevato dalla relazione
illustrativa - nella procedura per la revoca dell'assegnazione di cui al
successivo comma 9. Tale comma, infatti, prevede la possibilità di
revocare l'assegnazione all'ufficio del processo per sopravvenute esigenze
di funzionalità dell'ufficio del giudice di pace di provenienza del giudice
onorario. In caso siano stati assegnati all'ufficio per il processo più giudici
addetti a un ufficio del giudice di pace in relazione al quale siano
soppravvenute le nuove esigenze, ai fini della revoca si adottano gli stessi
criteri previsti per l'assegnazione dai commi 4 e 5 (quest'ultimo in mancanza
di domande).
Gli aspetti
procedurali dell'assegnazione all'ufficio del processo sono definiti dal comma
6. Peraltro il citato comma 9 stabilisce che la medesima modalità si
applichi per la revoca.
Si stabilisce che
l'assegnazione è disposta con il procedimento previsto dall'articolo
7-bis dell'Ordinamento giudiziario (di cui al R.D.
n. 12 del 1941). La proposta è trasmessa al consiglio giudiziario che la
inoltra al CSM, corredata del proprio parere, per l'approvazione definitiva.
I
Consigli giudiziari sono organi territoriali dell’autogoverno della
magistratura, che svolgono una attività consultiva nei confronti del C.S.M.,
redigendo pareri relativi alla progressione in carriera dei magistrati, al
cambio di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale dei
magistrati. Oltre a ciò, i Consigli Giudiziari svolgono attività istruttoria
nell’ambito dei procedimenti relativi alla magistratura onoraria. Sono
regolamentati dal decreto legislativo n. 25 del 2006.
Il comma 8
prevede che un giudice onorario di pace già assegnato ad un ufficio del
processo non può essere inserito, a domanda, in altro ufficio del processo del
medesimo tribunale prima di due anni. In caso di inserimento d'ufficio
ex comma 5, il termine è ridotto a un anno.
I commi 10-15
disciplinano i compiti che i magistrati onorari inseriti all'interno
dell'ufficio per il processo possono svolgere, attuando la delega prevista
dall'articolo 2, comma 5, lett. a),
nn. 1)-3).
Il comma 10
stabilisce che il magistrato onorario coadiuva il giudice togato compiendo
tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione
giurisdizionale, sotto la "direzione e il coordinamento" del giudice
professionale.
Tale
disposizione attua quanto previsto al n. 1) del comma 5, art. 2, della
legge di delega, ove si prevede il seguente compito: coadiuvare il giudice
togato, compiendo tutti gli atti preparatori ("necessari o
utili") all’esercizio della funzione giurisdizionale.
Il comma in esame
stabilisce, inoltre, che tale attività di ausilio possa essere compiuta anche
in riferimento ai procedimenti nei quali il tribunale decide in composizione
collegiale. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.
Riguardo ai contenuti dell'attività, si prevede che in essa possano rientrare
lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la
redazione di bozze dei provvedimenti.
Il comma 11
prevede la possibilità, da parte del giudice professionale, di delegare talune
funzioni nell'ambito dei procedimenti civili, anche relativi a
procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non
particolarmente complesse.
Viene
in tal modo ripreso quanto previsto nella prima parte del n. 2) della
delega ove si prevede l'individuazione delle categorie di atti delegabili al
giudice onorario "in considerazione della natura degli interessi coinvolti
e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte".
Quanto alle attività
che possono essere delegate, la disposizione in commento reca alcune tipologie
esemplificative quali: l'assunzione dei testimoni, i tentativi di
conciliazione, i procedimenti speciali concernenti il pagamento di somme non
contestate (di cui all'art. 186-bis e
all'art. 423, comma primo, del codice di procedura civile), i provvedimenti di
liquidazione dei compensi degli ausiliari e la risoluzione di questioni
"semplici e ripetitive".
Il comma 12
stabilisce, in via generale, che al giudice onorario di pace non può essere
delegata la pronuncia di provvedimenti definitori. Sono previste, però, alcune
eccezioni (lettere a) - g)).
La
delega chiarisce che non possono essere delegati al giudice onorario i
provvedimenti che definiscono i procedimenti, "salvo quelli
specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità" (n.
3).
Le eccezioni – per
le quali è delegata al giudice onorario di pace la pronuncia di provvedimenti
definitori - sono:
a) provvedimenti
che definiscono procedimenti di volontaria
giurisdizione, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
Si
tratta di procedimenti caratterizzati dal fatto di non prevedere, di regola,
due o più parti contrapposte.
b) provvedimenti
possessori;
c) provvedimenti
che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria;
d) provvedimenti
che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso
provvedimenti amministrativi;
e) provvedimenti
che definiscono cause relative a beni
mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché
quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non
eccedenti il medesimo valore;
f)
provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore
della controversia non superi euro 100.000;
g) provvedimenti
di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti
di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non
superi euro 50.000.
Si
ricorda che, per quanto riguarda la competenza del giudice di pace in
materia civile, l’art. 7 c.p.c. gli assegna la competenza per valore:
§
per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla
legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
§
per le cause di risarcimento del danno prodotto
dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia
non superi 20.000 euro.
Per materia, il giudice onorario è
competente, qualunque ne sia il valore:
§
per le cause relative ad apposizione di termini
ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi
riguardo al piantamento degli alberi e
delle siepi;
§
per le cause relative alla misura ed alle
modalità d'uso dei servizi di condominio
di case;
§
per le cause relative a rapporti tra proprietari
o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilità;
§
per le cause relative agli interessi o accessori
da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Il comma 13
stabilisce che le attività delegate debbano essere svolte attenendosi alle
direttive concordate con il giudice professionale, anche secondo le direttive
di carattere generale che possono emergere dalle riunioni cui i giudici onorari
presso gli uffici del processo partecipano ai sensi dell'articolo 22 del
presente provvedimento (si veda la relativa scheda). La modalità di diffusione
e trasmissione al capo dell'ufficio delle direttive concordate sono individuate
dal CSM.
Il comma 14
disciplina i casi in cui il giudice onorario, apprezzato il caso concreto, non
possa provvedere secondo le direttive impartitegli, riferisce al giudice togato
che compie le attività oggetto di delega.
Si osserva che il comma in esame fa
riferimento alle direttive e ai criteri "di cui a comma 12" che sono
previsti invece al comma 13.
Il comma 15
attribuisce al giudice professionale la vigilanza sulle attività svolte dal
giudice onorario e può revocare la delega in presenza di giustificati motivi,
informandone il presidente del tribunale.
Tali
disposizioni attuano quanto previsto al n. 2) dell'art. 2, comma 5,
della legge n. 57 del 2016, il quale stabilisce che il giudice togato dovrà
impartire direttive sulle modalità di espletamento dei compiti delegati e si
dovrà consentire al giudice onorario che non intenda rispettare tali
indicazioni di rimettere l’atto da compiere al giudice delegante.
Articolo 11
(Assegnazione ai giudici onorari di pace
dei procedimenti civili e penali)
L'articolo 11 consente - al ricorrere di situazioni di
carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato
tassativamente indicate - di assegnare procedimenti civili e penali ai giudici
onorari di pace con più di due anni di esperienza nell'incarico.
Per quanto concerne i
principi criteri direttivi per l’esercizio della delega (di cui alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 1) relativa all’impiego nei tribunali dei giudici
onorari, dettati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 57 si rinvia alla
scheda di lettura relativa all'articolo 9. La lettera c) del citato comma 5,
nel disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nella
trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale
ordinario, precisa che tale applicazione, (consentita per i soli giudici
onorari che hanno già svolto due anni di incarico) dovrà essere prevista in
casi «tassativi». La norma di delega prevede inoltre esplicitamente alcune
esclusioni.
Il comma 1 elenca
le condizioni necessarie ai fini
dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai giudici onorari che si
trovino nella situazione prevista dall'articolo 9, comma 4 (si tratta di coloro
che abbiano già svolto due anni nell'incarico). L'assegnazione è giustificata
al verificarsi di almeno una delle
condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure
organizzative diverse.
Le condizioni sono:
a) riduzione di oltre
il 30% dell'attività dei giudici
professionali in un tribunale (o in una sua sezione) a causa di vacanze
nell'organico, di assenze non temporanee o di esoneri dal servizio totali o
parziali;
b) numero dei procedimenti rispetto ai quali sia stato superato il termine di ragionevole durata
(legge n. 89 del 2001) superiore: di
almeno il 50% rispetto al numero
complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al tribunale; di almeno il 40% rispetto al numero
complessivo dei procedimenti penali
pendenti dinanzi al medesimo ufficio;
c) il numero medio
dei procedimenti civili o penali
pendenti per ciascun giudice
professionale in servizio presso il tribunale supera di almeno il 70% il numero medio nazionale dei
procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale nello
stesso periodo; il dato è rilevato alla data del 30 giugno dell’anno precedente
dal Ministero della giustizia attraverso apposite rilevazioni statistiche
operate sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il CSM,
distinguendo, ove possibile, per settori civile e penale, per materie, per rito
e per dimensioni degli uffici;
d) il numero medio
dei procedimenti civili o penali sopravvenuti per ciascun giudice professionale
in servizio presso il tribunale supera
di almeno il 70% il numero medio nazionale dei procedimenti sopravvenuti
per ciascun giudice professionale di tribunale nello stesso periodo; anche in
questo caso il dato è rilevato al 30 giugno dell'anno precedente e sono dettate
disposizioni inerenti la rilevazione analoghe a quelle previste dalla lett. c).
Ai sensi del comma 2,
quando la condizione prevista dalla suddetta lettera a) ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici
onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente
i procedimenti devoluti alla medesima sezione.
Per l'individuazione dei giudici onorari cui assegnare i
procedimenti si applicano i criteri previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5
(alla cui scheda si rinvia). I criteri di assegnazione degli affari ai giudici
onorari sono determinati ex art. 7-bis dell'Ordinamento giudiziario, relativo
alla proposta tabellare (commi 3 e 4).
Il comma 5 pone
un limite alle assegnazioni per
ciascun giudice onorario di pace: esse non possono essere superiori ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun
giudice professionale del tribunale, distinto per il settore civile e per
quello penale.
Il comma 6
enumera le esclusioni.
Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace, per
il settore civile:
§
i procedimenti
cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso
della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di
competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma
dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti della fase
cautelare; si segnala che nel testo
trasmesso non compare la fonte dei due articoli;
L'art. 615, secondo comma, c.p.c, concerne la forma
dell'opposizione del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione con
ricorso al giudice dell'esecuzione stessa, quando questa è stata avviata. Il
successivo art. 617, secondo comma, c.p.c. stabilisce che le opposizioni
relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che sia
stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative
alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di
esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nei termini ivi
fissati.
§
i procedimenti di impugnazione avverso i
provvedimenti del giudice di pace;
nonché i procedimenti in materia:
§
di rapporti di lavoro e di previdenza ed
assistenza obbligatorie;
§
societaria e fallimentare;
§
di famiglia;
Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace, per
il settore penale:
§
i procedimenti diversi da quelli previsti
dall’articolo 550 del codice di procedura penale, riguardanti i casi di citazione diretta a giudizio;
Ai sensi dell'art. 550, primo comma, c.p.p. l'azione
penale è esercitata dal PM con la citazione diretta a giudizio nei casi di
contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non
superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla
predetta pena detentiva. Lo stesso vale (secondo comma) per i seguenti reati:
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a un pubblico
ufficiale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato; violazione di
sigilli aggravata; rissa aggravata (con esclusione delle ipotesi in cui nella
rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime); lesioni
personali stradali; furto aggravato; ricettazione.
§
le funzioni di giudice per le indagini
preliminari;
§
i giudizi di appello avverso i provvedimenti
emessi dal giudice di pace;
§
i procedimenti di cui all’articolo 558 del
codice di procedura penale e il conseguente giudizio. Tale articolo riguarda la
convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo.
Tali
disposizioni attuano quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lett. c). Essa prevede l'esclusione delle funzioni
previste dall'articolo 43-bis, terzo
comma, dell'Ordinamento giudiziario e di quelle inerenti la trattazione dei
procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatoria. Al citato art. 43-bis, terzo comma, si prevedono le seguenti
esclusioni: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e
possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di
merito o del giudizio petitorio; b) nella materia penale, le funzioni di
giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare,
nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo
550 del codice di procedura penale. Si tratta dunque di esclusioni previste
dalle disposizioni in esame dello schema di decreto.
Il comma 7
attribuisce al presidente del tribunale l’assegnazione degli affari, secondo i
criteri stabiliti ai sensi del comma 4. L'assegnazione deve essere effettuata
necessariamente entro sei mesi dal verificarsi della carenza di
organico nei termini definiti dalla lett. a) oppure entro sei mesi dalla pubblicazione dei dati
attestanti la situazione dell'arretrato come previsto dalle lett. b),
c) e d). A tale proposito, ai sensi del comma 8 il Ministero
della giustizia rende noti i dati necessari ai fini del comma 1 entro il 31
dicembre e ci si dovrà riferire a tale data in relazione al numero dei
procedimenti pendenti. Il provvedimento di assegnazione degli affari è
trasmesso al CSM per l’approvazione, previo parere del Consiglio giudiziario
nella composizione integrata dai componenti designati dal consiglio regionale
ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano (articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2006). Il provvedimento di
assegnazione del presidente del tribunale è corredato delle relative
statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la sussistenza delle
condizioni previste, ivi compresa la non adottabilità di misure organizzative
diverse.
Infine sono dettati
limiti di durata dell'assegnazione. Essa può essere mantenuta per un periodo non
superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 (si
tratterebbe del termine perentorio dei sei mesi dal verificarsi delle
condizioni), anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1.
Nel testo trasmesso, la disposizione in
oggetto è compresa nel medesimo comma 7: appare quindi opportuno meglio
specificare tale riferimento interno.
L’assegnazione non
può essere nuovamente disposta, anche relativamente a giudici onorari di pace
diversi, alla scadenza del suddetto triennio, salvo che nell’ipotesi della
carenza nell'organico, di cui al comma 1 lettera a).
Articolo 12
(Destinazione
dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali)
L'articolo 12 disciplina la destinazione del giudice onorario di pace, quando sussistono
determinate condizioni e con specifiche modalità, a comporre i collegi civili e penali del tribunale.
Per quanto concerne i
principi criteri direttivi per l’esercizio della delega (di cui alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 1) relativa all’impiego nei tribunali dei giudici
onorari, dettati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 57 si rinvia alla
scheda di lettura relativa all'articolo 9. In questa
sede si ritiene opportuno ricordare soltanto che la lettera b) del citato comma
5, nel disciplinare la possibile
applicazione dei giudici onorari nel collegio, precisa che tale applicazione,
(consentita per i soli giudici onorari che hanno già svolto due anni di
incarico) dovrà essere prevista in casi «tassativi, eccezionali e contingenti»
e in presenza dei seguenti presupposti:significativa scopertura dei posti di
magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale; numero dei
procedimenti assegnati ai magistrati ordinari; numero di procedimenti rispetto
ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata del processo.
Più nel dettaglio, l'unico comma della disposizione prevede
che i giudici onorari di pace con oltre due anni di mandato, che sono inseriti
nell’ufficio per il processo possono essere destinati a comporre i collegi
civili e penali del tribunale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di
cui all’articolo 11 (vedi supra). Del collegio non può comunque far
parte più di un giudice onorario di pace.
I provvedimenti di
destinazione devono essere adottati, perentoriamente, entro dodici mesi:
§
dal verificarsi della vacanza di posti in
organico
§
ovvero dalla pubblicazione dei dati relativi ai
procedimenti (ex art. 11, comma 8 dello schema).
Ai giudici onorari di pace destinati
a comporre i collegi possono essere
assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La
destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.
La disposizione preclude
la possibilità che il giudice
onorario di pace possa essere destinato:
§
per il
settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia
fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate;
§
per il settore penale, a comporre i
collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati di
particolare gravità indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice
di procedura penale.
Per quanto concerne la
preclusione relativa al tribunale del riesame nella relazione illustrativa si
precisa come tale scelta sia giustificata in ragione dell'oggetto della
decisione che coinvolge il bene primario della libertà personale e impone che
il tribunale sia composto esclusivamente da magistrati professionali. Analoghe
ragioni sottendono la decisione di escludere i
giudici onorari dalla possibilità di far parte di collegi del tribunale
quando questo giudichi sui reati contemplati dall'articolo 407, comma 2,
lettera a) c.p.p.. Si tratta a ben
vedere di una vasta area di reati per i quali sono stabilite pene severe e il
cui accertamento presuppone competenze professionali come tali non delegabili
al magistrato onorario.
Articolo 13
(Destinazione
in supplenza dei giudici onorari di pace)
L'articolo 13 prevede la
destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o
impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del
collegio.
Più nel dettaglio, l'unico comma della disposizione prevede
che, nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale,
il giudice onorario di pace può essere destinato a compiti di supplenza, anche
nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, anche
qualora non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1 (significativa
scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del
tribunale; numero elevato di procedimenti assegnati ai magistrati ordinari e di
procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole
durata del processo).
Nella relazione illustrativa
si precisa che con assenza temporanea si intende, anche alla luce della
terminologia impiegata nelle circolari del CSM, la mancata presenza in ufficio
del magistrato professionale per impedimenti contingenti destinati a risolversi
nel breve periodo, come , ad esempio per ragioni di malattia.
Il giudice onorario da destinare in supplenza deve essere
individuato secondo i criteri di cui all’articolo 10, comma 5 (la scelta deve
cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario
da minor tempo).
In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere
destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro
ovvero alle vacanze nell’organico dei giudici professionali.
Per quanto concerne la
delega, l’articolo 1, comma 1, lett. d), pone al Governo l’obiettivo di
disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del
tribunale e della procura della Repubblica. I principi e criteri direttivi per l’esercizio della
delega sono dettati dall’art. 2, comma 5, per quanto riguarda i giudici onorari
di pace. Nella relazione illustrativa la scelta del legislatore delegato di
prevedere tali ipotesi è giustificata in base ad una generale conformità con lo
spirito complessivo della legge n. 57, in quanto la destinazione in supplenza
rappresenta, storicamente, la prassi di ordinario utilizzo della magistratura
onoraria, che trova conforto, sul piano normativo nell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario.
Si valuti la conformità a delega delle disposizioni
sulla destinazione a supplenza dei magistrati onorari, dal momento che esse non
trovano espressa corrispondenza nella delega medesima. Infatti, l’unica applicazione temporanea è
prevista e disciplinata dalla delega in modo dettagliato dalla lettera b) del
comma 5 del citato articolo 2 (per la cui attuazione si rinvia all'articolo 12
dello schema).
In proposito è altresì
opportuno ricordare che la disciplina legislativa (si veda l'articolo 245 del
decreto legislativo n. 51 del 1998) precedente alla legge del 2016 consentiva
ai giudici onorari di tribunale (GOT) ed ai vice procuratori onorari (VPO), di
svolgere funzioni temporanee e di mera "supplenza" della magistratura
ordinaria, sostituendo i giudici e i pubblici ministeri “ordinari” in sempre
più numerose udienze con funzioni, competenze e responsabilità identiche a
quelle della magistratura togata.
La disciplina relativa ai
giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari è contenuta
nell’ordinamento giudiziario; più numerose e dettagliate disposizioni
integrative sono poi dettate dalle specifiche circolari del C.S.M.
Articolo 14
(Supplenze
e applicazioni negli uffici del giudice di pace)
L'articolo 14 prevede che, nell'ipotesi di vacanza
dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di
uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare
in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario
per un periodo non superiore ad un anno.
Più in particolare la disposizione individua, al comma 1, i seguenti presupposti per
l'applicazione:
§
vacanze
di organico dell'ufficio del giudice di pace;
§
assenze o
impedimenti temporanei dei giudici addetti all'ufficio onorario che si
trova in crisi funzionale;
§
speciali esigenze
di servizio relative all'ufficio.
Alle disposizioni in commento non corrispondono puntuali
principi e criteri direttivi nella legge delega.
Secondo quanto si precisa
nella relazione illustrativa, tale previsione - volta ad assicurare una
migliore funzionalità degli uffici giudiziari-, sebbene non contemplata da un
puntuale criterio di delega, si pone in linea con lo spirito complessivo della
legge delega e nel solco di quanto previsto dall'articolo 6 della stessa.
L'articolo da ultimo citato, è opportuno ricordare, permette - per un periodo
di due anni dall'entrata in vigore della riforma- di applicare giudici di pace
in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di
pace del medesimo distretto di corte d’appello, anche se privi di scoperture di
organico.
Il comma 2 disciplina la
procedura per l'applicazione prevedendo in primo luogo che la scelta dei
magistrati onorari da applicare venga operata sulla base dei criteri di cui
all’articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti
dal comma 5 del medesimo articolo. L’applicazione deve essere disposta con
decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario che deve esprimersi su richiesta dell'interessato, nel
termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. Copia del decreto è
trasmessa al CSM e al Ministro della giustizia.
L'applicazione non può in ogni caso superare la durata di un
anno, rinnovabile per al massimo un altro anno, nei casi di necessità
dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato. In ogni caso,
un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere
disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente (comma 3).
Articolo 15
(Organizzazione
dell’ufficio dei viceprocuratori onorari)
Il Capo IV
(articoli 15-17) reca norme in materia di funzioni e compiti dei VPO.
L'articolo 15 demanda al procuratore della Repubblica il compito di coordinare l'ufficio dei VPO
(distribuendo il lavoro attraverso il ricorso a procedure automatiche) e di
vigilare sulle attività svolte da questi, anche sorvegliando l'andamento dei
servizi di segreteria ed ausiliari (comma
1).
Ai sensi dell'articolo 2,
lettera b), della legge delega la funzione di gestione che è riconosciuta al
presidente del tribunale con riguardo ai giudici onorari di pace è svolta per
quanto concerne i VPO dal procuratore della Repubblica, che li inserisce con
proprio provvedimento nell'ufficio e può assegnare loro compiti ausiliari e
delegati (si vedano gli articoli 16 e 17 dello schema).
Nell'assolvimento dei compiti di coordinamento e di
vigilanza il procuratore della Repubblica può avvalersi dell’ausilio di uno o
più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare
sull’attività dei VPO nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i
criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di
coordinamento periodicamente indette (comma
2).
Si tratta di una previsione,
come si rileva nella relazione illustrativa, volta ad assicurare una maggiore
semplificazione e funzionalità dell'ufficio.
La disposizione demanda infine (comma 3) ad un successivo decreto
ministeriale, da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del
decreto, la messa a disposizione di programmi informatici che assicurino che
l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza ed
automaticità.
Articolo 16
(Funzioni
e compiti dei vice procuratori onorari)
L'articolo stabilisce le
funzioni e i compiti dei VPO.
Nel dettaglio la disposizione stabilisce che l’assegnazione
dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con
provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma
per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (comma 2).
Come già ricordato, i consigli giudiziari sono organi
territoriali dell'autogoverno della magistratura, che svolgono una attività
consultiva nei confronti del C.S.M., redigendo pareri relativi alla
progressione in carriera dei magistrati, al cambio di funzioni e ad altre
evenienze della vita professionale dei magistrati. Oltre a ciò, i Consigli
Giudiziari svolgono attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti relativi
alla magistratura onoraria. I Consigli giudiziari sono istituiti in ogni distretto di corte d'appello e sono
attualmente regolamentati dal decreto legislativo n. 25 del 2006. La lettera q)
dell' articolo 1 della legge n. 57/2016 (per i principi di delega si veda
l'articolo 2, comma 16 della legge n. 57) ha demandato al Governo la
disciplina, all'interno dei consigli giudiziari, di una sezione autonoma alla
quale partecipano magistrati onorari. In attuazione della delega è stato
adottato il decreto legislativo 92/2016(Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la
conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari in servizio).
Per quanto concerne le funzioni, in linea con quanto
previsto dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 2 della legge delega, ai
VPO sono attribuiti:
§
compiti
ausiliari. Il VPO è chiamato a collaborare con il magistrato professionale
per l'espletamento degli ordinari compiti serventi rispetto all'esercizio della
funzione giudiziaria (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale e predisposizione delle minute dei provvedimenti);
§
compiti e
attività delegate (si rinvia all' articolo 17 dello schema). Tali compiti
sono preclusi ai VPO nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico.
Sull'attività svolta dal VPO è chiamato a vigilare il
magistrato professionale, il quale, laddove ricorrano giustificati motivi, può
disporre la revoca della delega (nel caso in sui siano stati delegati compiti),
dandone comunicazione al procuratore della Repubblica.
Articolo 17
(Attività delegabili ai vice procuratori
onorari)
L'articolo disciplina
espressamente le attività delegabili, da parte del procuratore della
Repubblica, al vice procuratore onorario.
Nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) relativa alle modalità di impiego
dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il
legislatore delegato deve prevedere, ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'articolo
2 della legge n. 57 , che ai VPO possano essere assegnati compiti da svolgere
"in proprio" su delega del procuratore della Repubblica. Con riguardo
a tali attività la delega delle funzioni può essere operata soltanto in
considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima
prevista per il reato per cui si procede. La disposizione precisa inoltre che non possono essere
delegati- salvo tipologie di reati da individuarsi specificamente anche in
considerazione della modesta offensività degli stessi- la richiesta di
archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su
richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale. Nell'espletamento
dei compiti delegati la legge prevede inoltre che il magistrato professionale
stabilisca le direttive generali cui il VPO deve attenersi nell'espletamento
dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene nel caso concreto
le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa
chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato
professionale titolare del procedimento.
Più nel dettaglio, ai sensi dei commi 1 e 2 con riguardo ai procedimenti penali di competenza del
giudice di pace, possono essere svolte - per delega (che deve essere conferita in
relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento) del
procuratore della Repubblica - dal VPO le funzioni
del PM:
§
nell'udienza dibattimentale;
§
per gli atti previsti dagli articoli 15
(chiusura delle indagini preliminari), 17 (archiviazione) e 25 (richieste del
pubblico ministero) del D.Lgs. n.274/2000;
L'articolo 15
del D.Lgs. 274/2000 disciplina la chiusura delle indagini preliminari
prevedendo che il PM, ricevuta la relazione
della polizia giudiziaria, se non richiede l'archiviazione, esercita
l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione
dell'imputato. La disposizione aggiunge che nel caso in cui ritenga necessarie
ulteriori indagini il PM vi provvede personalmente ovvero attraverso la polizia
giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
L'articolo 17 del medesimo decreto legislativo prevede
e disciplina i casi nei quali il PM deve presentare al giudice di pace
richiesta di archiviazione. L'articolo 25 del d.lgs. del
2000, da ultimo, disciplina le richieste del pubblico ministero, prevedendo che
entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il PM presenta le sue
richieste nella cancelleria del giudice di pace. Nel caso in cui ritenga il
ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad
un giudice di pace incompetente per territorio, il PM esprime parere contrario
alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando
l'addebito contenuto nel ricorso.
§
nei procedimenti in camera di consiglio, nei
procedimenti di esecuzione e nei procedimenti di opposizione al decreto del PM
di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori.
Con riguardo ai procedimenti nei quali il tribunale giudica
in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui
agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p.
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, il VPO può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e
secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che
ne coordina le attività, le funzioni di
PM:
§
nell'udienza dibattimentale;
§
nell'udienza di convalida dell'arresto;
§
per la richiesta di emissione del decreto penale
di condanna;
§
nei procedimenti in camera di consiglio (comma 3).
Nella relazione illustrativa
si precisa che la scelta di escludere che l'ufficio possa essere rappresentato
dal VPO nei procedimenti riguardanti i delitti di lesioni e omicidio colposo
conseguenti a violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro è riconducibile al fatto che si tratta di aree nelle quali in
considerazione dei beni giuridici coinvolti e della professionalità richiesta
in ragione dell'accertamento dei fatti,
risulta necessaria in sede dibattimentale la presenza del magistrato
professionale.
Ai sensi del comma 4,
Il VPO delegato può assumere le
determinazioni relative all’applicazione della pena su richiesta nei
procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata con
decreto di citazione diretta, pur quando si proceda con giudizio direttissimo,
e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad
opposizione a decreto penale.
Con
riguardo alla applicazione della pena su richiesta, come si rileva nella
relazione, al VPO è solo consentito assumere determinazioni, trattandosi di
attività non delegabile di regola se non per reati la cui offensività va
ritenuta modesta.
Il VPO, nei procedimenti riguardanti reati di minore gravità,
può redigere e avanzare richiesta di
archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi
compresa l’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e
l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata (comma 5).
I reati di minore gravità
sono individuati dalla disposizione attraverso il rinvio al comma 1 dell'articolo
550, c.p.p., il quale prevede che il PM esercita l'azione penale con la
citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di
delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro
anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva .
Il VPO si attiene nello svolgimento delle attività a lui
direttamente delegate alle direttive
periodiche di cui all'articolo 15, comma 2, dello schema (vedi supra) e può chiedere che l’attività e
il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare
del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per
provvedere in loro conformità (comma 6).
Capo V
Della conferma nell’incarico
Articolo 18
(Durata dell’ufficio e conferma)
Il Capo V,
rubricato “Della conferma nell’incarico”, è composto dal solo articolo 18 che
disciplina la durata dell’incarico di magistrato onorario e il procedimento per
la conferma in ruolo per un secondo mandato, in attuazione dei principi e
criteri direttivi dell’art. 2, comma 7,
della legge delega.
La legge delega, ribadita la natura temporanea dell’incarico, prevede
che il magistrato onorario possa svolgere, in ogni caso, le funzioni per un
periodo massimo di 8 anni. Dopo un primo quadriennio questi potrà, infatti,
essere confermato, all’esito di un giudizio di idoneità, per altri quattro
anni. Viene precisato che nel calcolo degli 8 anni vanno compresi gli anni
precedentemente svolti come magistrato onorario durante l’intera attività
professionale.
Il limite di età per lo svolgimento
delle funzioni di magistrato onorario è, in ogni caso, fissato in 65 anni.
Motivi ostativi della
conferma sono individuati nell’aver riportato la sanzione disciplinare della
sospensione dall’incarico o nell’essere stato condannato a più di una sanzione
(ovviamente diversa dalla citata sospensione).
Sono, poi, indicati come
elementi necessari del giudizio di idoneità per la conferma la capacità, la
produttività, la diligenza e l’impegno del magistrato onorario. Tali elementi
sono valutati sulla base dei dati statistici sul lavoro svolto, dell’esame a
campione dei provvedimenti nonché del parere del capo dell’ufficio giudiziario
e della sua relazione.
La conferma è disposta con
decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM sulla base
del giudizio di idoneità espresso dalla sezione autonoma per la magistratura
onoraria del Consiglio giudiziario; la sezione acquisisce, a tal fine, i pareri
dei capi degli uffici giudiziari dove il magistrato onorario ha esercitato le
funzioni (presidente del tribunale o Procuratore della repubblica) nonché degli
ordini degli avvocati del circondario.
Sono disciplinate le
conseguenze della mancata conferma, che comporterà l’impossibilità di proporre
nuove domande per magistrato onorario (attualmente non prevista).
Novità di rilievo è
costituita dalla previsione secondo cui nei primi due anni dell’incarico, i
giudici onorari di pace (cioè gli attuali GOT e giudici di pace) devono essere
impiegati presso l’ufficio del processo. Tale novità si inserisce in un quadro
normativo di riferimento che già prevede l’utilizzo dei giudici onorari (ma non
dei giudici di pace) presso l’ufficio del processo.
Lo svolgimento per due
quadrienni delle funzioni di magistrato onorario viene riconosciuto come titolo
preferenziale nei concorsi nelle amministrazioni dello Stato.
In particolare, quanto alla durata dell’incarico, la riforma prevede che:
·
l’incarico di magistrato onorario dura 4 anni e alla scadenza può essere confermato – a domanda - per ulteriori 4 anni (comma 1);
·
l’incarico di magistrato onorario non può essere
svolto per più di 8 anni (oggi sono
12), anche non consecutivi, «includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato
onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra
quelli disciplinati dal presente decreto» (comma 2). Sul punto lo schema di
decreto reca una formulazione diversa rispetto alla legge delega, in base alla
quale nel computo degli 8 anni devono essere «inclusi gli anni comunque svolti
quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale». La
diversa terminologia potrebbe avere una ripercussione sulla durata massima
dell’incarico per coloro che già attualmente svolgono le funzioni di giudice di
pace e di GOT e VPO. Per costoro, tuttavia, si applicheranno i principi e
criteri direttivi specificamente dedicati ai magistrati onorari già in
servizio, che potranno essere confermati per quattro mandati quadriennali (art.
2, comma 17, lettera r), della legge delega e art. 30, dello schema di decreto
legislativo, per cui v. ultra);
·
l’incarico di magistrato onorario cessa comunque
al compimento dei 65 anni di età
(comma 3). Attualmente, il limite di età per la magistratura onoraria è fissato
a 75 anni. Sul punto interviene anche la disciplina relativa ai magistrati
onorari in servizio, fissando un limite massimo di 68 anni (v. art. 30, comma
2, dello schema di decreto).
Per quanto riguarda la conferma
nell’incarico per altri 4 anni, lo schema di decreto delinea il seguente procedimento:
► la domanda di conferma deve essere presentata dal magistrato
onorario in servizio almeno 6 mesi prima
della scadenza del quadriennio al capo dell'ufficio giudiziario presso il
quale esercita la funzione (per il giudice di pace la domanda va presentata al
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio);
► ricevuta la
domanda, il capo dell’ufficio giudiziario dovrà integrarla con i seguenti allegati (comma 5):
a)
rapporto del
capo dell'ufficio sull'attività svolta e su capacità, laboriosità,
diligenza, impegno, indipendenza, imparzialità, equilibrio e partecipazione
alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale. Per
redigere il rapporto il dirigente dovrà esaminare a campione almeno 20 verbali
di udienza e 20 provvedimenti (comma 6);
b)
copia degli atti
e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del suddetto
rapporto;
c)
relazioni dei
magistrati togati che hanno lavorato con il magistrato onorario;
d)
autorelazione del magistrato onorario;
e)
statistiche
comparate sull'attività svolta ed ogni altro documento utile alla valutazione.
► la domanda viene trasmessa dal capo dell’ufficio giudiziario alla sezione autonoma per i magistrati onorari
del consiglio giudiziario (comma 4). Si
osserva che la disposizione non individua un termine entro il quale il capo
dell’ufficio deve integrare e trasmettere la domanda alla sezione autonoma.
Spetta alla sezione stabilire i criteri per la selezione dei verbali di udienza
e dei provvedimenti da parte del capo dell’ufficio giudiziario che redige il
rapporto. Oltre alla domanda corredata degli allegati, la sezione autonoma
dovrà acquisire anche:
·
il parere
del consiglio dell'ordine territoriale forense. Il Consiglio dell’ordine
dovrà indicare «fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le
funzioni», concentrandosi in particolare sulle «situazioni concrete e oggettive
di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino
mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica» (comma 8, lett. c);
·
l’attestazione
della Scuola superiore della magistratura circa la partecipazione del
magistrato onorario alle attività di formazione (art. 22, comma 3);
Si osserva che l’art. 18 non menziona tra i parametri da
valutare ai fini della conferma la condotta disciplinare del magistrato. L’art.
2, comma 7, lett. b), della legge delega stabilisce infatti che il magistrato
può essere confermato nell’incarico «sempre che non abbia riportato più
sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione».
► la sezione
autonoma del consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità (o inidoneità) del magistrato onorario
all’ulteriore svolgimento delle funzioni, eventualmente previa audizione
dell’interessato.
La sezione autonoma del consiglio giudiziario dovrà valutare negativamente il magistrato onorario che abbia
privilegiato nella sua attività la definizione di procedimenti di natura seriale, a meno che ciò non risponda a
specifiche esigenze dell'ufficio (comma 11).
Il giudizio deve essere formulato almeno
2 mesi prima della scadenza del quadriennio e deve essere inviato al Consiglio superiore della
magistratura (comma 7). Il comma 8 aggiunge che il giudizio è formulato
sulla base degli allegati alla domanda, nonché dell’effettiva partecipazione
alle attività di formazione (salvo che l’assenza sia giustificata) e alle
riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale.
Si osserva che l’art. 18 non prevede un procedimento
particolare per la conferma dei magistrati onorari che facciano parte della
sezione autonoma del consiglio giudiziario. La relazione illustrativa dello
schema, invece, precisa che «Per evitare possibili situazioni di conflitto di
interessi, si stabilisce che per i magistrati onorari che compongono la sezione
autonoma del consiglio giudiziario la valutazione di idoneità è assunta
direttamente dal Consiglio superiore della magistratura in sede di
deliberazione sulla domanda di conferma».
► delibera del CSM sulla domanda di
conferma (comma 9) e decreto del
Ministro della giustizia (comma 10). In base alla formulazione del comma
13, il decreto del Ministro interverrà solo in caso di conferma nell’incarico;
la mancata conferma non assumerà tale veste bensì quella di provvedimento del
CSM.
Lo schema di decreto prevede che, nelle more della conclusione del procedimento di conferma, il magistrato onorario continui a svolgere le funzioni anche alla scadenza
del quadriennio, per un massimo di
12 mesi di proroga (comma 12).
In merito, si consideri che la sezione autonoma del
consiglio giudiziario deve concludere il procedimento elaborando un proprio
giudizio due mesi prima della scadenza del quadriennio. La formulazione della
disposizione riserva dunque un termine non breve (fino a 14 mesi) a CSM e
Ministro per gli ultimi adempimenti del procedimento.
Inoltre, la legge delega non prevede la possibilità della
proroga annuale nelle more della conferma. Si consideri che, nel caso di
mancata conferma, il termine massimo quadriennale per ciascun incarico,
previsto dalla legge delega, risulterebbe in realtà pari a cinque anni.
Se, alla scadenza dei 12 mesi di proroga, il procedimento
non si è concluso, il magistrato onorario non può più esercitare le funzioni,
con sospensione dall'indennità, sino alla adozione del decreto di conferma.
Il decreto del
Ministro della giustizia di conferma
nell’incarico produce effetti dal primo giorno successivo alla scadenza del
quadriennio, senza soluzione di continuità nell’esercizio delle funzioni del
magistrato onorario (comma 13). La mancata
conferma, invece, discende dal provvedimento del CSM e comporta la
cessazione dalle funzioni del magistrato onorario a partire dalla comunicazione
del provvedimento.
Si osserva che non
risulta esercitata la delega con riguardo al principio e criterio direttivo che
richiede al Governo di «disciplinare le conseguenze della mancata conferma,
prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre
successive domande di nomina quale magistrato onorario» (art. 2, comma 7, lett.
f), della elgge 57/2016).
In attuazione della delega, il comma 14 riconosce ai
magistrati onorari che hanno esercitato per 8 anni le funzioni preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni
dello Stato (ex art. 5, DPR n. 487 del 1994).
Si valuti la formulazione di questa disposizione, che
riconosce ai magistrati onorari “preferenza” nei concorsi pubblici e non un
“titolo di preferenza”, come previsto invece dalla disposizione di delega (art.
2, comma 7, lettera g)).
Capo VI
Dell’astensione e della ricusazione
Articolo 19
(Astensione e ricusazione)
Il capo VI,
composto dal solo articolo 19,
disciplina le ipotesi di astensione e ricusazione del magistrato onorario,
dando così attuazione all’art. 2, comma
9, della legge n. 57 del 2016.
Si ricorda che questa disciplina riveste una particolare
rilevanza in ragione del fatto che il magistrato onorario può, durante lo
svolgimento delle funzioni, esercitare anche altre attività professionali (in
genere, esercitare la professione forense).
La legge delega richiede che tutti i magistrati onorari siano soggetti
alla disciplina relativa all’osservanza dei doveri prevista per la magistratura
ordinaria, confermando quanto già stabilito per giudici di pace, GOT e VPO
dalla legge 374/1991 e dal RD 12/1941.
E’, inoltre, stabilito che
ai magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto per i giudici ausiliari presso le corti d’appello
dall’art. 70 del decreto-legge n. 69/2013 (l. conv. 98/2013).
Il magistrato onorario
avrà, quindi, un obbligo di astensione:
- quando è stato associato
o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con
lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti;
- quando ha in precedenza
assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei
difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per
una delle parti in causa o uno dei difensori.
Analogo obbligo avrà nei
casi previsti dall’art. 51, primo comma
c.p.c.:
- se ha interesse nella
causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- se egli stesso o la
moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- se egli stesso o la
moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con
una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- se ha dato consiglio o
prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne
ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi
ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- se è tutore, curatore ,
amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti;
- se, inoltre, è amministratore
o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
L’articolo 19 attua la delega distinguendo gli obblighi di
astensione in ragione delle funzioni svolte dal magistrato onorario. In
particolare,
·
nei procedimenti
civili, si applica al giudice onorario di pace l’art. 51, primo comma
c.p.c. (v. sopra) e,
conseguentemente, anche l’art. 52 c.p.c. che disciplina la ricusazione del giudice che non rispetti l’obbligo di astensione.
Il giudice di pace dovrà astenersi anche quando è stato associato o comunque
collegato, anche mediante il coniuge, la parte dell’unione civile, il
convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado,
con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una
delle parti (comma 1). Questa parte della disposizione non richiama le ipotesi
di astensione previste dall’art. 70, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013:
questo aspetto è colmato dal comma 3, che si riferisce in generale a tutti i
giudici onorari di pace (v. infra);
·
nei procedimenti
penali il giudice onorario di pace deve astenersi nei casi previsti dall’art. 36 c.p.p., pena l’applicazione
delle ipotesi di ricusazione di cui
all’art. 37 c.p.p. (come richiesto dalla delega che impone ai giudici onorari
l’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari). Il giudice di pace
dovrà astenersi anche quando è stato associato o comunque collegato, anche
mediante il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente, i parenti fino
al secondo grado o gli affini entro il primo grado, con lo studio professionale
di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti (comma 2).
Il codice di procedura penale prevede per il giudice l'obbligo
di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti
private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di
una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una
di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere
sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo
congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è
offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha
svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità
stabilite dagli articoli 34 e 35 c.p.p. e dalle leggi di ordinamento
giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
Quanto alla ricusazione, l’art. 37 c.p.p. prevede che il giudice
possa essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b),
c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia
pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio
convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
I commi 3 e 4 individuano ulteriori obblighi di astensione per il giudice onorario di pace.
Si tratta dei casi in cui il giudice onorario o il coniuge o la parte
dell'unione civile o il convivente:
·
ha in precedenza assistito, nella qualità di
avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori;
·
ha svolto attività professionale nella qualità
di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. La disposizione si
applica anche quando l'attività professionale è stata svolta da un avvocato o
da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della società tra
professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario;
·
ha avuto o ha ancora rapporti di lavoro autonomo
o di collaborazione con una delle parti. In questo caso l’astensione è
obbligatoria anche quando i rapporti sono intercorsi con un parente fino al
secondo grado del giudice onorario nonché quando il rapporto di lavoro autonomo
o di collaborazione è intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte
dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello
studio associato a cui partecipa il giudice onorario.
Tutti gli obblighi di astensione previsti per i giudici
onorari di pace si applicano anche ai vice
procuratori onorari (comma 5).
Capo VII
Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della
revoca
Il Capo VII, composto dagli articoli 20 e 21, disciplina i doveri del
magistrato onorario e le ipotesi di decadenza, dispensa e revoca dall’incarico,
in attuazione dell’art. 2, comma 9, lett. a), e comma 10, della legge delega.
Articolo 20
(Doveri del magistrato onorario)
L’articolo 20 dà attuazione all’art. 2, comma 9, lett. a),
della legge n. 57 del 2016, in base al quale il Governo deve «prevedere che il
magistrato onorario sia tenuto all’osservanza
dei doveri previsti per i magistrati ordinari». Si tratta peraltro di
previsione analoga a quella già prevista attualmente per giudici di pace, GOT e
VPO dalla legge 374/1991 e dal RD 12/1941.
Lo schema di decreto legislativo riprende la formulazione
della legge delega, specificando che l’osservanza di tali doveri è dovuta in
quanto gli stessi siano compatibili.
La clausola di compatibilità non è espressamente prevista
dalla legge delega e potrebbe introdurre elementi di aleatorietà nella
individuazione dei doveri del magistrato onorario.
In particolare, prosegue l’art. 20 ricalcando la
formulazione dell’art. 1 (Doveri del
magistrato) del D.Lgs. 109/1996, il magistrato onorario deve esercitare le
funzioni e i compiti con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità,
riserbo, equilibrio e nel rispetto della dignità della persona.
Articolo 21
(Decadenza, dispensa e revoca)
L’articolo 21 dà attuazione all’articolo 2, comma 10, della
legge delega, che individua principi e criteri direttivi per regolamentare i
casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio.
La legge delega richiede che:
- nella disciplina della
decadenza e della dispensa si applichi all’intera magistratura onoraria la
disciplina oggi prevista per i giudici di pace. Si tratta dell’art. 9 della
legge n. 374/1991 che collega la decadenza al venir meno di taluno dei
requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni, alle dimissioni
volontarie ovvero al sopravvenire di una causa di incompatibilità. La dispensa
avviene, su domanda del giudice onorario o d'ufficio, per infermità che
impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti
di durata superiore a 6 mesi;
- la revoca debba essere
prevista quando il magistrato onorario non è in grado di provvedere
diligentemente e in maniera proficua allo svolgimento dell’incarico; in
particolare, quando non raggiunge gli obiettivi di performance prestabiliti dal
presidente del tribunale (per i magistrati onorari di pace) o dal procuratore
della Repubblica (per i VPO). Tale previsione riprende in parte quanto previsto
per i giudici di pace dall’art. 9 della legge 374 del 1991.
Con esclusione delle
ipotesi di dimissioni volontarie del magistrato onorario, la legge delega
prevede che la dichiarazione di decadenza, dispensa e revoca dal servizio sia
di competenza della sezione autonoma del Consiglio giudiziario che, previa
istruttoria, la deve trasmettere al CSM affinché provveda sulla dichiarazione.
Anche in tal caso, il procedimento è modellato su quello attualmente previsto
per i giudici di pace; non è, tuttavia, prevista la formalizzazione della
decisione con DM giustizia.
L’articolo 21 dello schema di decreto legislativo,
riprendendo il contenuto dell’art. 9 della legge n. 374, prevede la decadenza dall’incarico di magistrato
onorario nelle seguenti ipotesi (comma 1):
·
venire meno di uno dei requisiti necessari per
essere ammesso alle funzioni;
·
dimissioni volontarie;
·
sopravvenienza di una causa di incompatibilità.
La dispensa
dall’incarico, che può essere rilevata anche d’ufficio, è conseguenza di
impedimenti di durata superiore a 6 mesi. Se l’impedimento ha durata inferiore,
in base al comma 2 il magistrato onorario è comunque sospeso dall’incarico e
perde il diritto all’indennità (v. infra).
Si avverte sin d’ora che tale disposizione si applica anche
quando l’impedimento del magistrato onorario sia conseguenza di una malattia: se la malattia si protrae
oltre i 6 mesi, il magistrato è dispensato dall’incarico; quando la malattia
determina un impedimento di durata inferiore a 6 mesi comunque il magistrato
onorario è privato dell’indennità (sul punto, si veda più in dettaglio il
commento all’art. 25 dello schema).
Si osserva che la disposizione non prevede la dispensa in
caso di «infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni»,
come invece previsto oggi dall’art. 9, comma 2, della legge n. 374 del 1991.
Quanto alla revoca
dall’incarico, questa discende dall’inidoneità
del magistrato onorario ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti
dell'ufficio del processo.
La relazione di accompagnamento dello schema motiva l’ampio
ambito applicativo dell’istituto della revoca dall’incarico con il mancato
esercizio della delega relativa al regime disciplinare.
Si può formulare, “in particolare” un giudizio di inidoneità
quando (comma 3):
·
senza giustificato motivo, il magistrato
onorario ha «conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi
prestabiliti» (v. infra, art. 23);
·
il magistrato onorario non ha definito, entro 3
anni, un numero significativo di procedimenti civili o penali che gli siano
stati assegnati (secondo le determinazioni del CSM).
Inoltre, la revoca è disposta quando il magistrato onorario
tiene in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle
funzioni (comma 5).
Il comma 4 individua una serie di ulteriori circostanze di
fatto che possono essere valutate ai fini del giudizio di inidoneità del
magistrato onorario. Si tratta:
·
dell’adozione di provvedimenti non previsti
dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del
fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
·
dell’adozione di provvedimenti affetti da palese
e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali
da manifestare una e inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo;
·
della scarsa laboriosità;
·
del grave e reiterato ritardo nel compimento
delle attività richieste;
·
dell’assenza reiterata, senza giustificato
motivo, alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o
alle iniziative di formazione.
Si osserva che la formulazione delle
disposizioni in commento non pare delineare un elenco tassativo delle cause di
revoca. Si valuti quindi se il carattere esemplificativo di alcune cause di
revoca, contenuto nella delega e mutuato dall’art. 21 (si veda l’utilizzo della
locuzione “in particolare”), rimetta al legislatore delegato la puntuale
individuazione tassativa di tali cause.
I commi da 6 a 10 delineano il procedimento da seguire per l’adozione del provvedimento di
decadenza, dispensa o revoca dall’incarico:
1)
spetta al magistrato
togato che dirige e coordina (in base all’art. 10, comma 10 e all’art. 16,
comma 1) il magistrato onorario comunicare
al capo dell'ufficio giudiziario
ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o
della revoca del magistrato onorario;
2)
ricevuta tale comunicazione, il capo dell’ufficio – o il presidente del tribunale in caso di
magistrato onorario assegnato all’ufficio del giudice di pace – comunica a sua volta tali circostanze
al presidente della corte di appello
o al procuratore generale presso la corte d’appello;
3)
a meno che non si tratti di dimissioni volontarie, il
presidente della corte d’appello (o il procuratore generale presso la corte
d’appello) propone alla sezione autonoma
per i magistrati onorari del consiglio giudiziario la decadenza, la
dispensa o la revoca;
4)
la sezione autonoma verifica la fondatezza della proposta, procedendo anche ad audire
l’interessato;
5)
se la sezione autonoma ritiene fondata la proposta di
decadenza, dispensa o revoca dall’incarico,
trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura;
6)
il CSM delibera sulla proposta e il Ministro della giustizia dispone la
decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.
Capo VIII
Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Articolo 22
(Formazione dei magistrati onorari)
Il Capo VIII, composto dal solo articolo 22, disciplina le
attività di formazione dei magistrati onorari, tra le quali ricomprende anche
riunioni periodiche organizzate dal presidente del tribunale. La disposizione
attua l’art. 2, comma 14, della legge delega.
La legge n. 57 del 2016
delega il Governo a prevedere una formazione
permanente decentrata, valida per l’intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei
magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati
sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La
formazione acquisita sarà valutata anche ai fini dell’adempimento degli
obblighi formativi e di aggiornamento previsti dalla disciplina di settore
dell’attività lavorativa eventualmente svolta dal magistrato onorario (si pensi
agli obblighi di formazione previsti per la professione forense).
Inoltre, la delega prevede
specifiche attività formative per i giudici onorari di pace e per i vice
procuratori onorari: stante la collaborazione a regime in tribunali e procure
dei giudici onorari di pace e dei VPO, si prevede la loro partecipazione alle
riunioni trimestrali organizzate, ai sensi dell’art. 47 dell’ordinamento
giudiziario, dal capo dell’ufficio (presidente del tribunale per i GOP;
Procuratore della Repubblica per i VPO) o dal magistrato delegato, per l’esame
delle questioni giuridiche di maggior rilievo di cui abbiano curato la
trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate nonché per favorire lo
scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.
La partecipazione ai corsi di formazione a alle indicate riunioni
trimestrali è obbligatoria e - fatti
salvo giustificati motivi di assenza – dovrà essere valutata ai fini della
conferma quadriennale nell’incarico.
Si ricorda che, contestualmente alla previsione di criteri
di delega (art. 2, comma 14), la legge n. 57 ha anche introdotto una disciplina immediatamente precettiva sulla
formazione di giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di
tribunale (art. 7).
Lo schema di decreto legislativo riprende quella disciplina,
integrandola.
Si osserva che lo
schema di decreto legislativo non prevede alcun raccordo con tale disciplina né
una clausola abrogativa espressa.
In generale, tutti i
magistrati onorari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati specificamente per loro, con
cadenza semestrale, dalla Scuola superiore della magistratura
(comma 3).
Come richiesto dalla norma di delega, gli ordini
professionali ai quali i magistrati onorari siano eventualmente iscritti
dovranno riconoscere la partecipazione a tali corsi come attività formativa
anche ai fini della professione.
Dell’effettiva partecipazione ai corsi le strutture
decentrate della formazione dovranno fornire riscontro, soprattutto in
occasione dell’eventuale richiesta da parte del magistrato di conferma
nell’incarico allo scadere del quadriennio (v. sopra, art. 18).
In particolare, i
giudici onorari di pace sono tenuti, inoltre:
·
a partecipare
alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale (o da un
suo delegato) con la presenza obbligatoria anche dei giudici togati che si
occupano delle materie oggetto della discussione (comma 1). Nel corso delle
riunioni dovranno essere esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui
il magistrato onorario abbiano curato la trattazione. L’obiettivo è chiaramente,
oltre a un arricchimento professionale dei magistrati onorari, anche la
promozione di una uniformità delle prassi e della giurisprudenza degli uffici.
A tal fine saranno discusse le soluzioni adottate «per favorire lo scambio di
esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative»;
·
se inseriti nell'ufficio per il processo,
destinati nei collegi o assegnatari di procedimenti di competenza del
tribunale, a partecipare alle riunioni
convocate ai sensi dell'articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, per la
trattazione delle materie di loro interesse.
Si ricorda che l’art. 47-quater del R.D. n. 12 del 1941
prevede che il presidente di sezione,
oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirigere la sezione cui è assegnato e,
in particolare, sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed
ausiliari, distribuire il lavoro tra i giudici e vigilare sulla loro attività,
deve anche curare anche lo scambio di
informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione.
Analogamente ai giudici onorari di pace, anche i vice procuratori onorari dovranno
partecipare alle riunioni trimestrali
organizzate dal procuratore della Repubblica (o da un suo delegato).
Come previsto dalla norma di delega, il comma 5 dell’art. 22
qualifica la partecipazione alle iniziative di formazione e alle riunioni
periodiche come attività obbligatorie.
Si ricorda che entrambe, infatti, sono valutate al fine della conferma
nell’incarico per il secondo quadriennio (v. sopra, art. 18).
Capo IX
Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Il Capo IX dello schema di
decreto legislativo, composto dagli articoli da 23 a 26, disciplina le
indennità spettanti ai magistrati onorari e il relativo regime fiscale, lo
svolgimento delle attività nel periodo feriale e il regime giuridico della
maternità e della malattia.
Articolo 23
(Indennità spettanti ai magistrati
onorari)
L’articolo 23 dà attuazione all’art. 2, comma 13, della
legge delega, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati
onorari
L’art. 1, comma 1, lett. n), della legge n. 57 del 2016 individua come
specifico obiettivo della delega quello di prevedere i criteri di liquidazione
dell’indennità. Si prevede, anzitutto, una doppia
componente dell’indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una
parte fissa e una parte variabile. Oltre al carattere
duale dell’indennità, i principi e criteri direttivi del comma 13 prevedono
che:
- ai magistrati onorari giudicanti (giudici onorari di pace) la parte fissa dell’indennità per le attività svolte nell’ufficio del
processo è attribuita in misura inferiore
a quella prevista per l’esercizio di funzioni
giurisdizionali;
- analogamente, ai magistrati onorari requirenti (i VPO) la parte fissa dell’indennità dovuta per le attività svolte come ausiliare del magistrato togato nelle
attività preparatorie delle funzioni di quest’ultimo è attribuita in misura inferiore a quella prevista per
l’esercizio delle attività svolte e per i provvedimenti adottati dal VPO su delega
del magistrato togato;
- sia ai giudici onorari di pace che ai VPO, in caso di svolgimento
di più funzioni tra quelle sopraindicate, sia corrisposta la parte fissa
dell’indennità riconosciuta per le funzioni
svolte in modo prevalente;
- i capi degli uffici (presidente del tribunale e procuratore della
Repubblica) determinano con un apposito provvedimento, in base a criteri
generali predeterminati dal CSM, gli obiettivi
da raggiungere nell’anno solare (individuati tenendo conto della media
della produttività dei magistrati dell’ufficio); il provvedimento va comunicato
alla sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio
giudiziario;
- in caso di raggiungimento degli obiettivi di performance
prefissati, ai magistrati onorari è corrisposta la parte variabile dell’indennità in misura determinata tra il 15% e il 50% della parte fissa;
ciò anche in relazione al raggiungimento totale o parziale degli obiettivi
stessi. Il presidente del tribunale (per i giudici onorari di pace) e il
procuratore della Repubblica (per i VPO), in relazione agli obiettivi
raggiunti, liquidano con uno specifico
provvedimento detta parte variabile dell’indennità, comunicandolo alla
citata sezione autonoma del Consiglio giudiziario;
- lo svolgimento dell’ufficio onorario sia compatibile con altra
attività lavorativa e, di conseguenza, la dotazione organica dei magistrati
onorari nonché le funzioni loro demandate, gli obiettivi stabiliti e i criteri
di liquidazione delle indennità siano stabiliti prevedendo tale compatibilità.
Alla luce dei principi di delega, l’articolo 23 dello schema
di decreto legislativo delinea la misura
dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per
l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali
compensi sono onnicomprensivi (comma 11).
In particolare, la riforma:
·
conferma che l’indennità spettante ai magistrati
onorari si compone di una parte fissa
e di una parte variabile di risultato
(comma 1);
·
individua in 16.140 euro la misura annuale lorda (comprensiva di oneri
previdenziali e assistenziali) dell’indennità
fissa da corrispondere ai magistrati
onorari che esercitano funzioni giudiziarie (comma 2). Si tratta dei
giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso
l'ufficio del giudice di pace, ovvero che risultano assegnatari della
trattazione di specifici procedimenti in tribunale ovvero destinati nei collegi
giudicanti del tribunale, nonché dei vice procuratori onorari che sono stati
delegati all’esercizio delle funzioni giudiziarie;
·
prevede che ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie sia
corrisposta una indennità fissa pari all’80%
dell’indennità prevista per i magistrati onorari che esercitano le funzioni
giudiziarie, ovvero 12.912 euro (comma
3). Si tratta dei giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo
(v. sopra art. 10) e dei vice
procuratori onorari inseriti nell’apposito ufficio (v. sopra art. 2) che coadiuvano il magistrato professionale e, sotto
la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori
utili per l’esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest’ultimo (v. sopra art. 16, comma 1, lett. a);
·
esclude
che l’indennità per l’esercizio delle funzioni giudiziarie possa essere cumulata con l’indennità per
l’esercizio delle funzioni non giurisdizionali (comma 4), prevedendo che quando
un magistrato onorario svolge entrambe le attività, la misura dell’indennità
fissa è quella prevista per i compiti e le attività svolti in via prevalente (comma 5).
Conseguentemente, al magistrato onorario che, oltre a
svolgere attività preparatoria e di supporto alla funzione giudiziaria, si
trovi anche ad esercitare direttamente le funzioni giudiziarie, potrà essere
corrisposta una indennità fissa identica a quella del collega magistrato
onorario che si limiti a far parte dell’ufficio del processo.
·
demanda al presidente
del tribunale la determinazione
degli obiettivi che i giudici onorari di pace dovranno raggiungere
nell’anno solare, sia che esercitino la giurisdizione presso l’ufficio del
giudice di pace o presso il tribunale, sia che svolgano attività non
giurisdizionali nell’ufficio del processo. Il provvedimento del presidente
dovrà essere adottato entro il 30 gennaio di ogni anno e dovrà essere elaborato
tenendo conto:
- dei criteri oggettivi fissati dal Consiglio superiore della magistratura;
- della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
- dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione
dell'ufficio e, per il tribunale, dei programmi per la gestione dei
procedimenti civili pendenti previsti dall’art. 37 del d.l. n. 98 del 2011;
·
demanda al procuratore
della Repubblica l’adozione di analogo provvedimento, nei medesimi termini,
per la determinazione degli obiettivi
che dovranno raggiungere i vice
procuratori onorari, tanto che esercitino le funzioni giudiziarie, quanto
che coadiuvino un magistrato professionale. Tanto il provvedimento del
presidente del tribunale, quanto quello del procuratore della Repubblica
dovranno essere comunicati alla sezione autonoma per i magistrati onorari del
consiglio giudiziario (commi 6 e 7);
·
assegna al CSM
il compito di adottare una delibera per definire i criteri in base ai quali
fissare gli obiettivi nonché le procedure per la valutazione della
realizzazione degli stessi (comma 8);
·
individua in una percentuale tra il 15% e il 30% dell’indennità fissa, la misura dell’indennità di risultato,
connessa al raggiungimento degli
obiettivi (e dunque, in caso di esercizio prevalente delle funzioni
giudiziarie, l’indennità di risultato potrà andare dai 2.421 ai 4.842 euro
lordi; in caso di esercizio prevalente di funzioni non giudiziaria da 1.937 a
3.873 euro lordi). Si ricorda che la norma di delega consente al legislatore
delegato di fissare l’indennità di risultato fino al 50% dell’indennità fissa;
La relazione
illustrativa evidenzia che il Governo ha scelto «di non fissare la
percentuale più elevata del 50% consentita dalla legge delega, al fine di poter
disporre di maggiori risorse da destinare alla parte fissa dell’indennità».
·
prevede che nella quantificazione dell’indennità
di risultato da corrispondere al singolo magistrato onorario si tenga conto,
all’interno della forbice 15-30%, del livello
di conseguimento degli obiettivi assegnati.
L’articolo 23 delinea quindi il procedimento per la liquidazione dell’indennità (comma 10),
prevedendo che ogni anno il presidente del tribunale e il procuratore della
repubblica:
■ attestino, in relazione a ciascun
magistrato onorario assegnato all’ufficio giudiziario, se il magistrato eserciti o meno le funzioni giudiziarie o se queste
sono o meno prevalenti, ai fini della determinazione della misura
dell’indennità fissa annua da corrispondere (se 16.140 o 12.912 euro);
■ verifichino il livello di raggiungimento degli obiettivi
assegnati a ciascun magistrato onorario;
■ conseguentemente propongano la liquidazione dell’indennità di
risultato, indicandone la misura.
I provvedimenti con i quali i capi degli uffici giudiziari
assumono tali determinazioni sono immediatamente
esecutivi, dovendo essere semplicemente comunicati alla sezione autonoma
del Consiglio giudiziario.
Il provvedimento è altresì comunicato al presidente della
Corte d’appello o al procuratore generale presso la Corte d’appello, che
provvedono materialmente al pagamento dei compensi.
Si osserva che sarebbe opportuno precisare l’organo
destinatario dell’eventuale gravame sul provvedimento che certifica le funzioni
svolte e il livello di raggiungimento degli obiettivi, in quanto le valutazioni
del capo dell’ufficio incidono direttamente sul diritto alla retribuzione.
Infine, il Governo
non ha esercitato la delega prevista dall’art. 2, comma 18, della legge n. 57 del 2016, relativamente alla
definizione delle modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla
individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e
procura per la liquidazione delle indennità dell’intero personale di
magistratura onoraria.
La relazione
illustrativa motiva questa scelta con «l’impossibilità di predeterminare ad
inizio d’anno l’importo di cui ogni Tribunale o Procura della Repubblica presso
il Tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle
indennità, tenuto conto del regime previsto per la parte variabile della
predetta indennità, legata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, in misura non
inferiore al 15% e non superiore al 30% della parte fissa, determinabile
soltanto alla chiusura dell'esercizio, con imputazione della relativa spesa
all'esercizio successivo».
In base alla riforma, questo è il quadro dei compensi annui lordi che possono essere corrisposti ai
magistrati onorari.

Rispetto alla normativa vigente, soprattutto quella sui
giudici di pace, è evidente come la riforma realizzi una drastica riduzione delle indennità.
Infatti, in base alla relazione tecnica del Governo, allegata
al disegno di legge delega presentato al Senato (AS 1738), l’attuale
retribuzione annuale media (per 11 mesi) della magistratura onoraria è la
seguente:
- giudici di pace,
47.896 euro;
- giudici onorari di
tribunale, 7.546 euro;
- vice procuratori
onorari, 14.000 euro.
Peraltro si anticipa che, in base all’art. 32 dello schema
di decreto (v. infra), per la
liquidazione delle indennità dovute ai magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma continueranno ad applicarsi, per 4 anni da
tale data, le disposizioni oggi vigenti.
Normativa vigente
L’art. 11 della legge
374/1991 prevede che ai giudici di
pace sia corrisposta un'indennità di euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di
rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento
dei servizi generali di istituto (parte
fissa). Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per
le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno (in tale ultimo numero
non si computano le udienze per i provvedimenti indicati al comma 3-quater del
TU immigrazione (sentenze di non luogo a procedere che il giudice di pace
pronuncia quando ha acquisito la prova dell'avvenuta espulsione prefettizia e
non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio) per
ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.
Al giudice di pace è, poi,
corrisposta un'indennità (parte
variabile):
- di euro 36,15 per ogni udienza civile o penale, anche se non
dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli;
- di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o
cancellato dal ruolo.
Una indennità di euro 10,33 è dovuta, in materia civile,
per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva (per il pagamento di somme
non contestate) emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile;
l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con
provvedimento motivato.
In materia penale, al
giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di una lunga e specifica serie di
provvedimenti individuati dall’art. 11, comma 3-ter.
Per le udienze di
convalida dell’espulsione e trattenimento dello straniero e le controversie
relative al decreto di espulsione è corrisposta una indennità di euro 10.. Le indicate indennità
previste dall’art. 11 della legge 374/1991 non
possono superare, in ogni caso,
l'importo di euro 72.000 lordi annui, comunque cumulabili con i trattamenti
pensionistici e di quiescenza comunque denominati
Al coordinatore dell’ufficio del giudice di pace spetta
un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di euro 129,11 per gli uffici aventi un
organico fino a cinque giudici, di euro
206,58 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di euro 309,87 per gli uffici aventi un
organico da undici a venti giudici e di euro
387,34 per tutti gli altri uffici.
L'ammontare delle indennità è
rideterminato ogni tre anni, con DM giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla
variazione ISTAT.
La disciplina delle
indennità di GOT e VPO è contenuta nell’art. 4 del del D.Lgs 273/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del DPR 449/1988, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati
minorenni). Tale ultima norma non
stabilisce, come per i giudici di pace, una quota di retribuzione fissa, bensì in forma di gettone di
presenza, indipendentemente dal numero dei provvedimenti emessi. Si prevede:
- per i GOT, un'indennità di euro
98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, più un’ulteriore
indennità di euro 98 ove il
complessivo impegno lavorativo per le attività di udienza superi le 5 ore; nessuna indennità è invece prevista per la
redazione di sentenze (attività obbligatoria per i GOT, ex delibera CSM 18
gennaio 2012) e attività di studio degli atti.
Per i VPO, un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte
cumulativamente:
a) partecipazione ad una o
più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
b) ogni altra attività
delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Poiché in particolare gli
artt. 72 del RD 12/1941 e 25 del D.Lgs. 274/2000 prevedono una serie di
attività che il PM può delegare nel settore civile e penale al VPO, ne deriva la
possibilità per quest’ultimo, rispetto al GOT (sostanzialmente retribuito solo
per l’attività d’udienza) di godere di una maggiore indennità.
Anche ai VPO spetta
un'ulteriore indennità di euro 98
ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o
più delle citate attività superi le 5 ore giornaliere. Ai fini della
determinazione delle indennità, la durata delle udienze è rilevata dai
rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento
delle indicate attività delegabile per legge, è rilevata dal procuratore della
Repubblica.
Come per i giudici di
pace, sia per i GOT che per i VPO è previsto un adeguamento triennale dell'ammontare delle indennità con DM
giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
verificatasi nel triennio precedente.
L’ammontare totale della spesa dello Stato per le indennità per la magistratura
onoraria, riferiva la relazione tecnica
del Governo allegata al disegno di legge delega presentato al Senato (AS
1738), risulta, negli ultimi anni, in diminuzione: si è passati dai circa 150
mln di euro del 2010, ai 142 mln del 2011, ai 135,5 mln del 2013. Sulla base
della normativa vigente, le maggiori
indennità sono godute dai giudici di pace; di molto inferiori le indennità
liquidate ai magistrati onorari in servizio presso tribunali e procure.
Articolo 24
(Attività dei magistrati onorari durante
il periodo feriale)
L’articolo 24
esclude che i magistrati onorari possano svolgere attività durante il periodo
di sospensione feriale dei termini, ovvero dal
1° al 31 agosto di ciascun anno (v. art. 1, legge n. 742 del 1969), pur
riconoscendo loro, anche in relazione a quel mese, l’indennità fissa annua.
La preclusione non è assoluta, perché potrebbe essere
superata dalla sussistenza di «specifiche esigenze d’ufficio». In tal caso, il
magistrato onorario chiamato a svolgere il proprio incarico in agosto, avrà
diritto di non prestare attività nel periodo ordinario, per un corrispondente
numero di giorni.
La disposizione non
trova corrispondenza espressa in alcuna disposizione della legge delega.
Articolo 25
(Tutela della gravidanza, malattia e
infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS)
I commi 1 e 2
prevedono una tutela sociale minima
dell’attività dei magistrati onorari in relazione ad alcuni eventi della vita,
precisando che la malattia, l’infortunio o la gravidanza non comportano, entro determinati termini, la dispensa dall'incarico.
In particolare:
§
il comma
1 prevede che, in caso di malattia e
infortunio dei magistrati onorari, non vi è dispensa dall'incarico (la cui
esecuzione rimane sospesa), per un periodo non
superiore a 6 mesi; in tale periodo, in ogni caso, non si ha diritto
all’indennità fissa (v. sopra, art. 23);
§
il comma
2 prevede che - durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e
nel corso dei 3 mesi dopo il parto (o, alternativamente, a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto) - la gravidanza non comporta la dispensa
dall'incarico (la cui esecuzione rimane sospesa) ma non dà diritto
all'indennità prevista dal citato art. 23.
Il successivo comma 3
prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Per il
versamento del contributo dovuto (pari al 25%) trovano applicazione le modalità
e i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma l,
del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).
Istituita dall’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, la
gestione separata I.N.P.S. è un fondo pensionistico destinato ad erogare, in
generale, le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori cd. atipici,
autonomi con partita I.V.A. o parasubordinati. Ai sensi dell’articolo 1, comma 165,
della L. 232/2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi
(titolari di posizione fiscale ai fini dell'I.V.A.), non iscritti ad altre gestioni
di previdenza obbligatoria né pensionati, iscritti alla richiamata Gestione
separata è stata ridotta a regime in misura pari al 25%.
Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica allegata al
provvedimento afferma che a carico dei soggetti interessati è dovuto anche un
contributo dello 0,72% per la tutela della maternità, per gli assegni per il
nucleo familiari, per degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.
La stessa relazione tecnica evidenzia altresì che, in
ottemperanza alla legge delega 57/2016, i contributi da versare alla Gestione
separata sono “stati considerati a valere sull’importo complessivo
dell’indennità annua prevista,·in tal senso si è proceduto alla determinazione
dell'importo dell’indennità in misura tale da poter consentire il versamento
dei contributi previdenziali, secondo le aliquote previste a legislazione
vigente”, ponendole totalmente a carico del magistrato ordinario.
Infine, ai sensi del comma
4 le disposizioni previdenziali individuate in precedenza non trovano
applicazione per gli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di
giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali opera l’obbligo di iscrizione alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (ai sensi dell'articolo 21,
commi 8 e 9, della L. 247/2012).
L’articolo 21, comma 8, della L. 247/2012 ha stabilito
l’obbligo, per i soggetti iscritti agli Albi forensi, della contestuale
iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la quale
(ai sensi del successivo comma 9), con proprio regolamento, determina, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge, i minimi contributivi dovuti
nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei
contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione
del regime contributivo.
In estrema sintesi, si ricorda che la previdenza forense è sorta
con la l. 406/1933, istitutiva dell'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati
e Procuratori. Successivamente, la l. 6/1952 ha soppresso tale Ente,
costituendo la Cassa forense, alla quale fu attribuito il patrimonio del
soppresso Ente. Con la L. 289/1963 si dispone l’obbligatorietà dell'iscrizione
alla Cassa forense di tutti gli avvocati che esercitino la professione con
continuità, indipendentemente dal livello di reddito dichiarato. La Cassa venne
poi privatizzata a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi del D.Lgs. 509/1994,
assumendo la natura di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato
(ai sensi degli articoli 12 e s.s. c.c.). La Fondazione ha autonomia
gestionale, organizzativa e contabile, ma data la rilevanza pubblica
dell'attività svolta, è vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della
giustizia. Spetta inoltre alla cassa assicurare, nella gestione
economico-finanziaria, l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da
redigersi con periodicità almeno triennale.
Infine, si ricorda che, con nota del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali del 18 dicembre 2009, è stata definita la riforma del
sistema previdenziale degli iscritti alla Cassa forense; tra le novità
principali apportate si segnala, in particolare:
- il
progressivo aumento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia (da 65 a
70 anni di età e da 30 a 35 anni di contribuzione), prevedendo altresì la
possibilità si accedere anticipatamente con specifiche penalizzazioni
economiche e l'aumento dei requisiti per la maturazione del diritto alla
pensione di anzianità (da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di
contribuzione);
- l'introduzione
di una quota di pensione c.d. "modulare" determinata su base
contributiva e finanziata da specifici contributi facoltativi che si aggiungono
a quelli obbligatori, con contestuale introduzione di un’ulteriore quota di
contributo soggettivo, in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa
(dall'1% al 9%) per finanziare la pensione "modulare";
- la
riduzione del requisito di accesso alle pensioni di inabilità e invalidità da
10 a 5 anni di anzianità contributiva;
- l'aumento
temporaneo sperimentale dal 2 al 4% del contributo integrativo sul volume
d'affari;
- l'aumento
dal 12 al 13% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto sul reddito
professionale e dal 4 al 5% su quello dovuto dai pensionati che abbiano già
maturato i supplementi;
- l'abolizione
del contributo minimo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all'albo
professionale.
Articolo 26
(Modifiche al testo unico delle imposte
sui redditi)
L’articolo 26 apporta modifiche al TUIR al fine di
qualificare le indennità corrisposte ai
magistrati onorari come reddito assimilato
a quello da lavoro autonomo.
In particolare, la norma espunge le indennità corrisposte ai
giudici di pace tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.
50, comma 1, lett. f)) e le
qualifica, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari, come reddito di lavoro autonomo.
La lettera a) in
esame sopprime il riferimento ai giudici
di pace presente nell’articolo 50 del TUIR, comma 1, lett. f), (D.P.R. n. 917 del 1986), relativo
ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La norma citata prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri, le
indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato,
dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche
funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano
un'arte o professione autonoma, e non siano state effettuate nell'esercizio di
impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti
del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono
essere riversati allo Stato.
La lettera b)
aggiunge una lettera f-bis) al comma
2 dell’articolo 53 del TUIR, laddove si prevede che sono inoltre redditi di lavoro autonomo le indennità corrisposte ai giudici onorari di
pace e ai vice procuratori onorari.
Il comma 2 dell’articolo 53 contiene un elenco di redditi
considerati di lavoro autonomo, oltre a quelli che derivano dall’esercizio di
arti e professioni, indicati dal comma 1. Si tratta:
·
dei redditi derivanti dall'utilizzazione
economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali,
ecc., se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
·
degli utili derivanti da contratti di
associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si segnala, tuttavia, che
l’articolo 2549, comma 2, c.c., come modificato dall’art. 53, del D.Lgs. n. 81
del 2015, prevede che nel caso in cui l’associato sia una persona fisica
l’apporto al contratto di associazione in partecipazione non può consistere,
nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro);
·
degli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata;
·
delle indennità per cessazione di rapporti di
agenzia;
·
delle attività di levata dei protesti esercitata
dai segretari comunali.
La lettera c)
aggiunge un periodo al comma 8 dell’articolo 54 del TUIR, relativo alla
determinazione del reddito di lavoro autonomo, al fine di precisare che i
redditi indicati alla lettera f-bis)
del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti dall’ammontare delle indennità in
denaro o in natura percepite nel periodo di imposta. A differenza di quanto
stabilito per alcuni degli altri redditi assimilati a quelli di lavoro
autonomo, non sono pertanto previste
delle riduzioni a titolo di deduzione forfettaria delle spese.
L’articolo 54, comma 8, prevede infatti che i redditi
derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali sono costituiti dall'ammontare dei
proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono
percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. I redditi derivanti
dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali sono
costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese
Le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di
associazione in partecipazione, quelle spettanti ai promotori e soci di società
di capitali e le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia costituiscono
invece reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
Articolo 27
(Ampliamento della competenza del giudice
di pace in materia civile)
L’articolo 27 - in
attuazione dei criteri di delega
indicati dall’art. 2, comma 15, della legge 57/2016 - estende la competenza del giudice onorario di pace a procedimenti
attualmente di competenza del tribunale.
L’articolo 1 della legge delega n. 57 del 2016 ha indicato tra i contenuti l’ampliamento della competenza del giudice onorario
di pace sia nel settore penale che in quello civile.
Si ricorda che la
legge delega del 2016 ha fatto cadere la distinzione tra giudici di pace e
giudici onorari di tribunale (i cd. GOT), prevedendo una figura unitaria di
magistrato onorario denominato “giudice onorario di pace” inserito in un unico
ufficio giudiziario (l’ufficio del giudice di pace). Al contrario, i giudici
onorari requirenti ovvero i viceprocuratori unitari (cd. VPO) confluiranno in
un apposito ufficio costituito presso la procura della Repubblica presso il
tribunale. Il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace è affidato al Presidente
del Tribunale (attualmente tale compito è affidato a giudici di pace
coordinatori); il coordinamento dei VPO spetta, invece, al Procuratore della
repubblica.
In particolare, nel settore civile, deve essere aumentata la competenza per materia e per
valore, ed estesi i casi di decisione secondo equità nelle cause il cui
valore non ecceda 2.500 euro, (art. 2, comma 1, lett. p), della legge delega).
I criteri di delega attribuiscono
alla competenza dell'ufficio del giudice di pace civile il seguente catalogo di
procedimenti (art. 2, comma 15, della legge delega):
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di
condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e
di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e
decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da
minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro
30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore
complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di
espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; spetta al
presidente del tribunale attribuire ad uno o più giudici professionali il
compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi
applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace.
Si tratta di
principi e criteri direttivi che prevedono sia una mera attuazione da parte del legislatore delegato in caso di attribuzione
di blocchi di materie o di aumento dei limiti di valore [lettere a), d),
e) e g)], sia una valutazione in sede di attribuzione delle competenze
sulla base di parametri di complessità
dell’attività attribuita al giudice onorario di pace [lettere b), c)
ed f)].
Per quanto concerne l’ampliamento della competenza per materia in capo al giudice onorario di pace (si
prescinde, quindi da limiti di valore) la delega è attuata dal Governo – così
precisa la relazione al provvedimento - sulla base dei “parametri della minore complessità nonché della natura degli
interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono
essere risolte”. Ulteriore valutazione, agli stessi fini, ha riguardato “il
tasso di normale conflittualità delle singole fattispecie di procedimento,
preferendo mantenere nell’ambito di competenza del giudice professionale le
procedure che presentano un tasso abitualmente elevato”.
Le modifiche al codice di procedura civile e le disposizioni di
coordinamento
Una prima serie di novelle è introdotta dall’articolo 27 al codice di procedura
civile per ampliare la competenza del
giudice onorario di pace.
Il comma 1, lett. a),
n. 1, modifica, anzitutto, l’articolo 7 c.p.c., che attualmente delinea il quadro della competenza per materia e per valore del
giudice di pace. I
L’aumento della competenza per
valore
In relazione al valore
della causa (da cui è evidentemente desunta la sua minore complessità), vengono attribuite al giudice onorario di pace
le controversie:
§
relative a beni mobili di valore non superiore a
30.000 euro; l’attuale limite è
5.000 (art. 7, primo comma);
§
di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non
supera i 50.000 euro; l’attuale
limite è 20.000 euro (art. 7, secondo comma).
Tale intervento risponde alle
previsioni di delega (art. 15, comma 2, lett. d) ed e).
In materia di diritti reali e comunione, la delega ha previsto per l’attribuzione
al giudice onorario la verifica del parametro della minore complessità. La
relazione al provvedimento chiarisce che, per alcune tipologie di cause, tale
minore complessità è rivelata dalla predeterminazione di una certa soglia di
valore.
Sono, infatti, attratte alla competenza del giudice onorario
di pace, purchè nel limite di valore di
30.000 euro, i procedimenti nelle
seguenti materie (art. 7, nuovo quarto comma c.p.c.):
§
usucapione di beni immobili e di diritti reali
immobiliari;
§
riordino della proprietà rurale (v. Libro terzo,
titolo II, capo II, sez. II del codice civile);
§
accessioni;
§
azioni di rivendica e negatorie;
§
regolamento di confini;
§
superficie;
§
costituzione, acquisto, estinzione ed
accertamento della servitù;
§
impugnazione della divisione di beni immobili
§
scioglimento della comunione su beni immobili.
L’intervento riguarda l’attuazione dell’art. 15, comma 2,
lett. d) ed e), della legge delega.
Sempre in relazione al limite di valore, in attuazione
dell’art. 1, comma 1, lett. p), della legge delega, il comma 1, lett. a), n. 3, dell’art. 27 novella l’articolo 113, comma 2, c.p.c., per consentire al giudice onorario di pace di
decidere secondo equità nelle cause
il cui valore non sia superiore a 2.500
euro (il limite di valore attuale è di 1.100 euro)
L’aumento della competenza per materia
Dopo avere preliminarmente confermato la competenza del
giudice onorario per le cause in materia di apposizione di termini (risulta
espunta, per coordinamento con il contenuto del nuovo comma 3-ter dell’art. 7
c.p.c., la competenza per le cause sull’osservanza delle distanze stabilite da
leggi, regolamenti ed usi per il piantamento di alberi e di siepi) e le cause
condominiali (come definite dall’art. 71-quater, disp. att. c.c.), l’art. 27, comma 1, lett. a), n. 1, aggiunge 10 nuovi numeri al terzo comma dell’art. 7, c.p.c.
(nn. da 3-ter a 3-duodecies) che estendono la competenza del giudice
onorario di pace in materia di diritti
reali e comunione in relazione alle seguenti controversie, ora attribuite
al tribunale.
Si tratta di una categoria di cause attribuite al giudice
onorario in virtù della ridotta complessità dell’attività
istruttoria e decisoria e degli interessi in gioco, ovvero:
§
distanze nelle piantagioni e scavi e dei muri,
fossi e siepi interposti tra i fondi,
§
luci e vedute, eccetto le cause relative a
distanze per l’apertura di luci dirette a balconi, per l’apertura di luci
laterali e oblique sul fondo del vicino e di
distanze delle costruzioni dalle vedute (conservate alla competenza del
tribunale);
§
stillicidio ed acque;
§
occupazione e invenzione di cose mobili;
§
specificazione, unione e commistione;
§
enfiteusi;
§
usufrutto, uso e abitazione;
§
esercizio delle servitù (come detto, la
competenza del giudice onorario su costituzione, acquisto, estinzione ed
accertamento della servitù è, invece, limitata alle cause di valore fino a
30.000 euro);
§
impugnazione del regolamento e delle delibere
dell’assemblea condominiale;
§
diritti e obblighi del possessore nella
restituzione della cosa.
Anche tale intervento è ricondotto all’art. 15, comma 2, lett.
c), della legge delega.
Il comma 1, lett. a),
n. 1, dell’art. 27 aggiunge, poi, un
ulteriore comma all’art. 7 c.p.c. che prevede, infine, indipendentemente da ragioni
di connessione, l’attrazione alla
competenza del tribunale di due azioni contro la stessa parte quando una
delle domande riguardi specifiche controversie di competenza del giudice
onorario di pace (ai sensi dell’art. 7, terzo comma, nn. da 3-ter a 3-duodecies
e quarto comma, c.p.c.)
Il comma 1, lett. a),
n. 2, dell’art. 27 introduce nel codice di procedura civile un nuovo art. 16-bis che estende la competenza del giudice onorario di
pace all’esecuzione forzata mobiliare, in attuazione dell’art. art. 15, comma
2, lett. g), della legge 57/2016.
Si tratta, sostanzialmente,
di un ritorno alla disciplina dell’art. 16 c.p.c. abrogato con la riforma del giudice unico (D.Lgs.
51/1998), che prevedeva su tale materia la competenza del pretore (le cui
funzioni dal 2 giugno 1999 sono state rilevate dal giudice di pace).
Tale regola generale trova, tuttavia, eccezione quando il
bene mobile è oggetto della misura esecutiva insieme all’immobile in cui si
trova; in tal caso la competenza è attratta dal tribunale. Rimane infatti di competenza
del tribunale l’esecuzione forzata di immobili. Analoga competenza del
tribunale riguarda l’esecuzione di crediti, di obblighi di fare e di non fare
nonché per la consegna e il rilascio di cose.
Le successive, numerose modifiche apportate, dalle rimanenti
disposizioni del comma 1 nonchè dai commi 2 e 3 dell’art. 27, alla
disciplina del codice di rito civile, al codice civile e alle sue disposizioni
di attuazione hanno natura di coordinamento con l’indicato,
complessivo trasferimento di competenze dal tribunale al giudice onorario di
pace.
Una prima serie di interventi riguarda la disciplina del codice processuale civile sull’esecuzione
forzata mobiliare cioè quelle
inerenti alla disciplina del pignoramento
mobiliare presso il debitore (artt. 513, 518, 519, 520 e 521-bis, c.p.c.) e presso terzi (art. 543 c.p.c.)
Non sono dettate disposizioni attuative dell’art. 2,
comma 15, lett. g), nella parte in
cui, in relazione a tali procedimenti esecutivi, spetta al presidente del
tribunale attribuire ad uno o più giudici professionali il compito di impartire
specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative nonchè di vigilare
sull'attività dei giudici onorari di pace.
Altre novelle sono introdotte in attuazione dei contenuti
della legge delega relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione in
materia successoria (art. 2, comma 15, lett. b), della legge 57). Si
segnala il passaggio al giudice onorario di pace dei procedimenti sul ricorso
per l’autorizzazione alla vendita di beni mobili ereditari (art. 747, c.p.c.),
del procedimento per la fissazione di termini (art. 749 c.p.c.), in materia di
rimozione dei sigilli (artt. 763, 764, 765 c.p.c.) e di richiesta
dell’inventario dell’eredità (art. 769 c.p.c.). Nello stesso settore vengono
modificate disposizioni del codice
civile in relazione al passaggio, dal tribunale al giudice onorario, della
competenza sulla richiesta di proroga dell’inventario (art. 485), di nomina del
curatore dell’eredità (art. 528), di designazione della banca presso cui il
curatore deve depositare il denaro dell’eredità (art. 529), di autorizzazione
al curatore a pagare i debiti ereditari (art. 530), di provvedimenti in materia
di testamento olografo (art. 620), di apertura e pubblicazione del testamento
segreto (art. 621), di scelta della persona cui consegnare i documenti relativi
ai beni e diritti assegnati ad ognuno nella divisione (art. 736).
Ulteriori modifiche
riguardano, nella disciplina del codice
civile (libro IV), l’acquisita competenza del giudice onorario di pace: per
l’autorizzazione a vendere le cose deteriorabili o di dispendiosa custodia
(art. 1211); per l’indicazione del luogo di deposito della cosa venduta (art.
1514); per la nomina del commissario per la vendita senza incanto in caso di
inadempimento del compratore (art. 1515); per l’autorizzazione all’apertura
forzata delle cassette bancarie in caso di contratto bancario scaduto (art.
1841).
Alle disposizioni di
attuazione del codice civile, ancora in relazione alla disciplina delle successioni:
§
è modificato l’art. 51-bis per sottrarre alla competenza del tribunale in
composizione monocratica, in virtù delle novelle precedenti, le attribuzioni di
cui ai citati artt. 528, 529, 530, 620, 621 e 736 del codice civile (v. ante);
§
è aggiunto un art. 51-ter per attribuire al giudice onorario di pace (anziché
dell’indicato tribunale) la competenza: sull’imposizione di una garanzia se la
disposizione testamentaria sia sottoposta a condizione risolutiva (art. 639
c.c.) o se il legato è sottoposto a condizione sospensiva o a termine (art. 640
c.c.); sulla nomina di un amministratore in caso di condizione sospensiva o di
mancata presentazione di garanzia.
Altre modifiche alle disposizioni di attuazione riguardano:
§
l’art. 57
che, in materia di riordino della proprietà fondiaria, attribuisce alla
competenza del tribunale le azioni con cui il proprietario chiede il
trasferimento in suo favore della proprietà di altri appezzamenti di estensione
inferiore alla minima unità culturale che si trovino sul suo terreno; la competenza
è, però, del giudice onorario di pace per azioni di valore fino a 30.000 euro,
ai sensi del nuovo quarto comma dell’art. 7 c.p.c.
§
l’art.
57-bis, ovvero la competenza del magistrato onorario, anziché del tribunale
monocratico, per l’autorizzazione (a chi ne abbia interesse) alla riparazione
di sponde o argini di acque ove il proprietario non provveda (art. 915 c.c.);
§
l’art. 59,
ovvero la competenza del magistrato onorario, anziché del presidente del
tribunale, sul ricorso per la designazione dell’istituto di credito presso cui
depositare i titoli al portatore in caso di mancanza o insufficienza della
garanzia da parte dell’usufruttuario; di conseguenza, il provvedimento va
reclamato davanti al tribunale anziché davanti al presidente della corte d’appello;
In relazione alla delega per i procedimenti in materia di comunione sono aggiunte alle norme
di attuazione del codice civile nuove disposizioni che attribuiscono al giudice
onorario di pace, anziché al tribunale, la competenza, rispettivamente (art. 2,
comma 15, lett. c), legge delega):
§
sul ricorso per la validità delle deliberazioni
della maggioranza per difetto di informazione preventiva sull’oggetto della
decisione (art. 60-bis)
§
per l’impugnazione del regolamento della
comunione e delle deliberazioni relative alle innovazioni della cosa comune o
ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 60-ter).
Altre modifiche delle stesse norme
di attuazione, nella stessa materia, riguardano la competenza del giudice
onorario di pace, anziché del tribunale:
§
per la revoca dell’amministratore che non rende
il conto della gestione o compia gravi irregolarità o che non dia notizia
all’assemblea condominiale di atti che esorbitino le sue attribuzioni; di
conseguenza, l’impugnazione del provvedimento di revoca assunto dal giudice
onorario va proposta davanti al tribunale anziché alla corte d’appello (art. 64).
Sempre nelle disposizioni di attuazione al codice civile, in relazione alle
citate novelle apportate nel codice civile (libro IV) alla disciplina delle obbligazioni
(v. ante) si prevede:
§
l’abrogazione dell’art. 73-bis – che prevede la competenza del tribunale monocratico
sui procedimenti di cui agli artt. 1211, 1541, 1515 e 1841 del codice civile, per
coordinamento con le novelle introdotte (v.
ante);
§
in specifici casi, la competenza del giudice
onorario per l’autorizzazione al debitore a depositare presso un locale idoneo
(anziché in un pubblico deposito) cose mobili diverse da denaro e titoli di
credito (art. 77).
Le modifiche all’art. 79 attribuiscono, inoltre, al
giudice onorario la competenza all’adozione del decreto di nomina del
sequestratario dell’immobile su richiesta del debitore (art. 1216 c.c.) e,
quindi, l’eventuale impugnazione del provvedimento davanti al tribunale,
anziché alla corte d’appello.
Gli ultimi due commi
dell’art. 27 prevedono, infine:
§
la modifica dell’art. 17 della L. 108 del 1996,
per stabilire la competenza del giudice onorario di pace per l’adozione del decreto
di riabilitazione del debitore protestato (o per il relativo diniego);
attualmente la competenza appartiene al presidente del tribunale (comma 4);
§
la conseguente novella dell’art. 13 del D. Lgs 150
del 2011, per affermare la competenza
del tribunale (anziché, come ora, della corte d’appello) sull’impugnazione
dei provvedimenti sia di concessione che di diniego della citata riabilitazione
(comma 5).
Per quanto riguarda la competenza del giudice di pace in materia
civile, il vigente art. 7 c.p.c. gli
assegna la competenza per valore:
- per le cause relative a beni
mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono
attribuite alla competenza di altro giudice;
- per le cause di risarcimento
del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore
della controversia non superi 20.000 euro.
Per materia, il giudice onorario è competente, qualunque ne sia
il valore:
- per le cause relative ad
apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla
misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- per le cause relative a
rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e
simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- per le cause relative agli
interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali.
Per cause civili di valore fino
1.100 euro, il giudice di pace si può pronunciare secondo equità e non secondo stretto diritto, eccezione fatta per
tutti i cosiddetti "contratti di massa" (ossia i contratti conclusi
mediante sottoscrizione di moduli o formulari già predisposti), quali ad
esempio i contratti di assicurazione, di conto corrente, di fornitura di acqua
e gas, etc., dove il giudizio segue le normali regole di procedura, art. 113
c.p.c.).
Il giudice di pace ha anche una funzione
conciliativa in sede non contenziosa (art. 322 c.p.c.) E’, infatti,
competente su tutte le istanze di conciliazione senza limiti di valore su
richiesta delle parti interessate e per tutte le materie che non siano di
competenza esclusiva di altri giudici (come nelle cause di lavoro e in quelle
matrimoniali).
Competenza in favore del giudice di pace è prevista dalla legge per i ricorsi contro le sanzioni amministrative
pecuniarie, comprese quelle concernenti le violazioni al Codice della
strada (L. 689/1981 e D.Lgs 285/1992).
Articolo 28
(Ampliamento della competenza del giudice
di pace in materia tavolare)
L’articolo 8 della legge delega n. 57 del
2016 detta specifiche disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol
e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, nell’attribuzione delle
competenze civili al giudice onorario di pace (art. 1, comma 1, lett. p) l’art.
8 ha previsto che debba tenersi conto della particolarità dell’istituto tavolare, attribuendo al giudice di
pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità.
Come
noto, il sistema tavolare – in uso
nei territori italiani già assoggettati alla dominazione austriaca – è un
sistema di pubblicità immobiliare di derivazione germanica. Dopo la fine della
prima guerra mondiale il Governo italiano si trovò di fronte alla scelta se
introdurre ex novo in tali territori
il sistema italiano di trascrizione immobiliare, di derivazione latina, oppure
mantenere il sistema di pubblicità immobiliare tavolare, ereditato dall’ordinamento
austriaco.
La
scelta del legislatore fascista fu per il mantenimento nei territori annessi
del sistema tavolare; in particolare i libri fondiari vennero conservati in
forza del regio decreto n. 2325 del 1928 e risultano attualmente disciplinati, con
il sistema di iscrizione immobiliare, dal Regio
Decreto n. 499 del 1929, Disposizioni
relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province.
Tra le principali differenze tra il regime tavolare e quello
italiano va segnalata la deroga al cd.
principio consensualistico nell’acquisto dei diritti reali immobiliari per
atti tra vivi. Infatti, il codice civile prevede (art. 1376) che, nei contratti
di trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il
trasferimento di un diritto reale (ovvero il trasferimento di un altro diritto),
la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestato con il contratto. Al contrario,
in base al sistema tavolare, il
trasferimento del diritto reale si avrà solo al momento dell’ iscrizione
tavolare, che avviene in base al procedimento dettato dal citato regio
decreto n. 499 del 1929; il perfezionamento del contratto ad effetti reali
viene ad attribuire all’avente causa solamente un diritto obbligatorio alla
prestazione.
Tale previsione è integrata da quella dell’art. 2, comma 15, lett. b), della
stessa legge delega, che ha previsto l’attribuzione della competenza del
giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in
materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto
all'attività istruttoria e decisoria.
In attuazione della citata delega, l’articolo 28 introduce
anzitutto una serie di modifiche al titolo
II del R.D. n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di eredità e di legato.
Dopo l’abrogazione dell’istituto di diritto austriaco della ventilazione
ereditaria, è stato mantenuto il sistema di devoluzione ereditaria proprio del
diritto italiano, adeguandolo però al regime tavolare, con la istituzione del certificato di eredità e di legato;
l’acquisto viene a operare a favore dell’erede o del legatario
indipendentemente dalla iscrizione tavolare, che in questo caso viene ad avere
un effetto solo dichiarativo e non costitutivo; tuttavia, per potere
successivamente alienare il bene ereditato, nel rispetto della continuità delle
iscrizioni, occorrerà che l’erede o il legatario chieda ed ottenga il
certificato di eredità e di legato, e provveda quindi alla intavolazione del
suo diritto contro il de cuius.
In particolare,
§
all’art. 13 - che viene modificato ed
integrato da 5 nuovi commi - si stabilisce che il ricorso autenticato per
chiedere il certificato di eredità o di legato (si precisa ex novo “anche con modalità telematiche”) può essere chiesto, anziché al tribunale monocratico, all’ufficio
tavolare del luogo di apertura della successione (ufficio cui è dovuto il
contributo unificato da parte del ricorrente, comma 5). Lo scopo, si legge
nella relazione illustrativa, è quello di permettere al conservatore un
controllo preliminare tra quanto richiesto e le risultanze dei libri fondiari.
Se la concordanza tavolare sussiste e il ricorso si basa su un titolo di
successione legittima, si rientra nel criterio della minore complessità e
quindi il conservatore dovrà depositare
(possibilmente in via telematica) il
ricorso presso l’ufficio del giudice
di pace (comma 6); in caso contrario nonchè quando è richiesto un
certificato di legato, sarà necessaria un’attività istruttoria maggiore e sul
ricorso sarà, quindi, competente il
tribunale, che deciderà in composizione monocratica (comma 7). Con il
deposito, il conservatore trasmette (all’ufficio onorario o al tribunale) le
somme dovute a titolo di contributo
unificato; se il ricorrente non ha provveduto al pagamento, sarà il
conservatore a versare comunque il contributo, fatta salva la rivalsa sul
ricorrente (commi 8 e 9);
§
le
successive modifiche agli artt. 16, 17 e
20 rispondono a necessità di coordinamento
con la disciplina introdotta all’art. 13 e riguardano il procedimento davanti
al giudice di pace (anziché davanti al tribunale monocratico) per il rilascio
del certificato di eredità;
§
all’art. 22, per analoghe esigenze di
coordinamento con l’art. 13, si prevede che il legatario debba chiedere all’ufficio
tavolare del giudice il rilascio di certificato sull'acquisto del legato.
Si valuti se occorra coordinare l’art. 22
con il contenuto del nuovo comma 7 dell’art. 13 del R.D. 499/1929, in base a
cui il ricorso per il rilascio del certificato di legato deve essere depositato
dal conservatore presso il tribunale.
§
all’art. 23, è stabilito che il
procedimento dinanzi al giudice di pace (anziché davanti al tribunale
monocratico) sia disciplinato dalle disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di
procedura civile.
Le successive disposizioni individuano una serie di affari tavolari per i quali,
sussistendo la minore complessità, sono affidati alla competenza del giudice onorario di pace.
E’, a tal fine, aggiunto un nuovo art. 95-ter all’allegato al R.D. 499 del 1929, denominato “Nuovo testo della legge generale sui libri
fondiari” che – in presenza di valutazione del conservatore di piena
concordanza tavolare - affida al giudice di pace l’adozione dei decreti
tavolari nelle seguenti materie:
§
contratti
ricevuti da notaio che consentano un trasferimento di proprietà di un immobile
(o altro diritto reale immobiliare) per il quale una banca (o altro soggetto
autorizzato) abbia concesso un finanziamento (prestito, mutuo) garantito da
ipoteca sull’immobile stesso;
§
ipoteche
volontarie, costituite per via notarile, a garanzia di finanziamenti concessi
da banche o altri soggetti autorizzati.
La modifica dell’art. 130-ter dell’allegato 1 riguarda il reclamo davanti al tribunale in
composizione collegiale avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri
fondiari, emesso per delega del giudice tavolare. Le medesime modalità dovranno
essere seguite nel caso del reclamo avverso il decreto tavolare emesso dal
giudice di pace.
Articolo 29
(Ampliamento delle competenze del giudice
di pace in materia penale)
L’articolo 29 costituisce integrale attuazione della delega prevista dall’art. 1, comma 1, lett. p), della legge
57/2016, con riguardo all’ampliamento della competenza in materia penale dell'ufficio del giudice di
pace.
Rispetto a quelle
civili è più
limitata l’estensione delle competenze penali dell’ufficio del
giudice di pace.
I principi di delega (art.
2, comma 15, lett h) hanno stabilito l’attrazione alla competenza del
giudice di pace dei procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti
dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre
circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le
contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per
quelle previste dall'articolo 6 della legge 283 del 1962.
L’art. 29 modifica l’art. 4 del D.Lgs 274 del 2000 che delimita la competenza
per materia del giudice di pace nel settore penale.
Rispetto a quanto già previsto, il giudice onorario di pace vede estesa la propria
competenza ai procedimenti relativi ai seguenti reati:
§ minaccia grave (art.
612, secondo comma, c.p); la minaccia
grave è quella commessa con armi o da persona travisata, o da più persone
riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza
intimidatrice derivante dal segrete associazioni, esistenti o supposte; se
sussistono circostanze aggravanti, la competenza è, invece, del tribunale;
occorrerebbe chiarire se il riferimento
alla sussistenza di circostanze aggravanti quale fondamento della competenza
del tribunale riguardi – come parrebbe – la sola minaccia grave oppure investa
anche la minaccia semplice.
Le nuove contravvenzioni di competenza del
giudice onorario di pace sono:
§ rifiuto d'indicazioni sulla propria identità
personale (art. 651 c.p.);
§ abbandono di animali (art. 727, c.p.);
§ uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);
§ violazioni della disciplina autorizzatoria sul
controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di sostanze alimentari messe
in produzione,
commercio e vendita e che contengano residui di prodotti - usati in agricoltura
per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari
immagazzinate - tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate
alimentari immagazzinate (art. 6, L. 283/1962).
Si
ricorda che l’attribuzione al giudice onorario di pace della competenza sui
procedimenti per il reato previsto dall’articolo 626 c.p.(Furti punibili a
querela dell’offeso) non è disciplinata dallo schema di decreto. Infatti,
nonostante l’espressa previsione da parte della legge delega, si tratta di
reato per il quale il giudice di pace è già competente.
In materia penale,
l’art. 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 prevede che il giudice di pace
sia attualmente competente per una serie
di illeciti minori (cd. bagatellari), ritenuti di limitato allarme sociale.
In relazione ai delitti, la
competenza comprende quelli consumati o tentati previsti dai seguenti articoli
del codice penale: 581 (percosse);
582 (lesione personale) limitatamente ai casi di minore gravità, anche in
relazione alla persona offesa; 590 (lesioni personali colpose), anche qui
limitatamente ai casi meno gravi e con esplicita esclusione delle fattispecie
di cui all'articolo 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con
violazione del codice della strada), quando si tratta di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, 594 (ingiuria), 595 (diffamazione), primo e secondo comma, 612
(minaccia semplice), primo comma, 626
(furto punibile a querela), 627 (sottrazione di cose comuni); i delitti di cui
agli artt. 631 (usurpazione) 632 (deviazione di acque e modificazioni dello
stato dei luoghi 633 (invasione di terreni o edifici), 636 (Introduzione o
abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), se non ricorre
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis (si tratti, cioè, di acque, terreni,
fondi o edifici destinati ad uso pubblico); per i delitti di cui agli artt. 635
primo comma (danneggiamento semplice), 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui),
638, primo comma (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), 639, primo
comma, (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (Appropriazione di
cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito).
Il giudice di pace è, poi, competente per le contravvenzioni previste dagli articoli 689 (Somministrazione di
bevande alcooliche a minori o a infermi di mente), 690 (Determinazione in altri
dello stato di ubriachezza), 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a
persona in stato di manifesta ubriachezza), 726 (Atti contrari alla pubblica
decenza) e 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei
minori) del codice penale.
Lo stesso art. 4 della D. Lgs 274/2000 attribuisce al giudice di pace la
competenza per una ulteriore, numerosa
serie di delitti (consumati o tentati) e
contravvenzioni previste da leggi speciali.
La competenza per gli illeciti indicati è tuttavia del tribunale se in
caso di concorso di circostanze, le attenuanti (diverse da quella della minore
età), concorrenti con le aggravanti, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa.
In base al Testo Unico sull’immigrazione
(art. 13, D.Lgs 286/1998), il giudice di pace è, inoltre, competente per la convalida del decreto di espulsione
amministrativa dello straniero emesso dal prefetto L'esecuzione da parte
del questore del provvedimento di espulsione amministrativa dello (con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza
Articolo 30
(Durata dell’incarico dei magistrati
onorari in servizio)
Il capo XI riguarda i magistrati onorari in servizio ed è
composto da tre articoli, concernenti rispettivamente la durata dell’incarico,
le funzioni e i compiti, la indennità spettante.
L’articolo 30 disciplina la durata dell’incarico dei
magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto
legislativo: tali magistrati possono essere confermati, alla scadenza del primo
quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni.
Si tratta più specificamente:
-
dei magistrati onorari in servizio alla data del 31
maggio 2016, confermati in base alla disciplina introdotta dal primo decreto
legislativo n. 92 del 2016; entrato in vigore in tale data;
-
dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata
in vigore del nuovo decreto legislativo, nominati successivamente alla entrata
in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del 2016. Anche per questi
ultimi, infatti, la durata dell’incarico è quadriennale secondo quanto previsto
dall’articolo 33, comma 9, dello schema di decreto in commento (v. ultra).
La conferma ha luogo a domanda e secondo il procedimento e
le modalità previste a regime dall’articolo 18, commi da 4 a 14, dello schema
di decreto (v. sopra).
Più in particolare, la legge delega n. 57 del 2016 ha espressamente previsto (art. 1, lettera r)
la necessità di prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero
dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.
Con specifico riguardo alla durata dell’incarico dei
magistrati onorari in servizio, la
legge delega, all’articolo 2, comma 17, fa esplicito riferimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della delega e prevede:
·
la
possibilità di essere confermati per quattro ulteriori mandati di quattro anni;
la riforma, a regime, uniforma la durata riducendo da tre a due quadrienni la
permanenza massima nell’incarico dei giudici di pace e aumentando da sei a otto
anni la permanenza massima nell’incarico di GOT e VPO;
·
 che la conferma sia disposta dal Ministro
della giustizia, previa deliberazione del CSM e valutazione positiva di
idoneità da parte del Consiglio giudiziario (sezione della magistratura
onoraria); sulla conferma esprimono parere anche i capi degli uffici giudiziari
interessati (Presidente del tribunale e Procuratore della Repubblica) nonché i
consigli forensi del circondario competente;
che la conferma sia disposta dal Ministro
della giustizia, previa deliberazione del CSM e valutazione positiva di
idoneità da parte del Consiglio giudiziario (sezione della magistratura
onoraria); sulla conferma esprimono parere anche i capi degli uffici giudiziari
interessati (Presidente del tribunale e Procuratore della Repubblica) nonché i
consigli forensi del circondario competente;
·
che
la disciplina indicata sia applicabile anche ai magistrati onorari che abbiano
compiuto 65 anni alla scadenza di tre quadrienni, che potranno essere
confermati fino al raggiungimento del limite di età;
·
che
detto limite di età per l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario sia
in ogni caso fissato a 68 anni (al compimento dei quali il magistrato onorario cessa
quindi dall’attività).
Successivamente, il decreto legislativo n. 92 del 2016, oltre a disciplinare la sezione autonoma dei Consigli
giudiziari per i magistrati onorari, ha introdotto disposizioni per la
conferma per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice
procuratori onorari in servizio al 31 maggio 2016, data di entrata in vigore
del medesimo decreto.
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 92 ha
stabilito il procedimento di conferma
di quei magistrati onorari, concernente: la presentazione della domanda; la
predisposizione di un rapporto del presidente del tribunale o del procuratore
della Repubblica sull'attività svolta dal magistrato onorario; la valutazione
di idoneità da parte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio
giudiziario; il divieto di conferma dei magistrati onorari che hanno riportato,
in forza di provvedimento definitivo, due o più sanzioni disciplinari diverse
dall'ammonimento; la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e
il successivo decreto del ministro della giustizia. Inoltre, la procedura di
conferma deve concludersi entro 24 mesi dalla costituzione della sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.
Sempre l’articolo 2 del decreto legislativo n. 92
ha previsto che i magistrati onorari rimangano in servizio fino alla
definizione della procedura di conferma e che quest’ultima produce effetti a
far data dal 31 maggio 2016.
Con il nuovo decreto legislativo sono dunque due le
categorie di magistrati onorari in servizio di cui – in base alla delega - il
legislatore delegato deve occuparsi:
·
i magistrati onorari in servizio al 31 maggio
2016, confermati o in corso di conferma in base alla disciplina contenuta nel
decreto legislativo n. 92;
·
i magistrati onorari in servizio nominati dopo
il 31 maggio 2016 e prima della entrata in vigore del nuovo decreto
legislativo.
Per i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, la
prima delle quattro conferme nell’incarico consentite dalla delega produce
effetti a decorrere da tale data, coincidente con l’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 92.
Per i secondi, il primo quadriennio decorre comunque dalla
nomina (v. art. 33, comma 9, dello schema di decreto).
Per entrambe le categorie saranno possibili tre successive
conferme quadriennali.
Si osserva che, alla
lettera, per ambedue le categorie di magistrati onorari in servizio la delega
(articolo 2, comma 17, lettera a), numero 2, della legge 57/2016) prevede che
possano essere “confermati” nell’incarico per quattro mandati quadriennali. Lo
schema di decreto, invece, opera una distinzione per i magistrati onorari
nominati successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 e
prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, consentendo solamente
tre conferme dopo la prima nomina.
In base al comma 2
dell’articolo 30, in ogni caso, l’incarico cessa al compimento del 68° anno di
età.
La disposizione riprende pressochè alla lettera quanto
previsto dalla legge delega all’art. 2, comma 17 lettera a), n. 4).
Non viene esplicitata
la disposizione, contenuta nella legge delega all’art. 2, comma 17, lettera a),
n. 3), relativa alla possibilità di conferma, fino al raggiungimento del limite
massimo di età, per i magistrati onorari che abbiano compiuto il 65° anno di
età alla scadenza di tre quadrienni.
Articolo 31
(Funzioni e compiti dei magistrati
onorari del servizio)
L’articolo 31 stabilisce funzioni e compiti dei magistrati
onorari in servizio.
Sul punto, la legge delega indica principi e criteri
direttivi all’art. 2, comma 17, lettera a), numeri 2) 3) e 4), e lettera b),
numeri 1), 2), 3) e 4).
In particolare, la delega sul punto prevede che:
·
nell’ultimo
quadriennio di mandato i GOT possano lavorare nell’ufficio del processo e i VPO
debbano soltanto coadiuvare il sostituto procuratore nell’attività preparatoria
relativa alle sue funzioni;
·
tuttavia,
il CSM - valutate le esigenze di servizio - possa confermare il magistrato
onorario per l’ultimo quadriennio destinandolo all’esercizio di funzioni
giudiziarie;
·
la
disciplina indicata sia applicabile anche ai magistrati onorari che abbiano
compiuto 65 anni alla scadenza di tre quadrienni, che potranno essere
confermati fino al raggiungimento del limite di età, in ogni caso fissato a 68
anni;
·
dal quinto anno successivo alla data di entrata
in vigore dell’ultimo decreto legislativo, i GOT confluiscano nell’ufficio del
giudice di pace;
·

 fino alla scadenza del
quarto anno successivo alla medesima data di entrata in vigore, sia i GOT che i
giudici di pace (questi ultimi, a domanda) possono essere destinati - dal
presidente del tribunale - all’ufficio del processo;
fino alla scadenza del
quarto anno successivo alla medesima data di entrata in vigore, sia i GOT che i
giudici di pace (questi ultimi, a domanda) possono essere destinati - dal
presidente del tribunale - all’ufficio del processo;
·
fino alla stessa scadenza quadriennale, potranno
essere assegnati dal presidente del tribunale, nel rispetto delle deliberazioni
del CSM – anche al di fuori dei casi tassativi previsti dal comma 5, lettera b)
- nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente
ai GOT;
·
fino alla stessa scadenza quadriennale, il
presidente del tribunale assegni nuovi procedimenti civili e penali di
competenza del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio,
ivi compresi quelli che abbiano fatto domanda per essere assegnati all’ufficio
del processo.
L’articolo 31 dello schema prevede, in particolare, che per quattro anni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo il presidente del tribunale:
·
può assegnare all’ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici
onorari di tribunale; inoltre, a domanda, può assegnare i magistrati onorari
già in servizio come giudici di pace; per l’assegnazione all’ufficio del
processo il presidente del tribunale dovrà seguire le modalità e i criteri
individuati, a regime, dall’articolo 10 dello schema di decreto (v. sopra); i
giudici onorari di pace così assegnati all’ufficio per il processo possono
svolgere i compiti e le attività previste, a regime, dall’articolo 10 dello
schema di decreto legislativo (vedi sopra); si tratta in particolare:
o
delle
funzioni di aiuto e supporto al giudice professionale da parte del giudice
onorario di pace;
o
delle funzioni delegabili dal giudice
professionale al giudice onorario di pace;
o
degli ambiti per i quali al giudice onorario di
pace può essere delegata la pronuncia;
o
delle modalità di svolgimento delle attività
delegate in conformità alle direttive concordate con il giudice professionale;
·
può assegnare la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di
competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di
tribunale; a tal fine potrà derogare alla disciplina a regime che individua le condizioni per l’assegnazione ai
giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali; tali condizioni (per
le quali si rinvia in dettaglio all’art. 11, comma 1) sono connesse ai seguenti
aspetti: dotazioni effettive di personale di magistratura; numero dei
procedimenti pendenti, per i quali è stato superato il termine di ragionevole
durata; numero dei procedimenti pendenti per giudice professionale; numero dei
procedimenti sopravvenuti. Peraltro, il presidente del tribunale dovrà
procedere nel rispetto delle deliberazioni del CSM e del comma 7 dell’articolo
11; quest’ultimo, a sua volta, delinea il procedimento di assegnazione e
stabilisce i termini entro cui il presidente del tribunale deve procedere alla
assegnazione, in presenza delle condizioni indicate dal comma 1;
Si chiarisca se
l’assegnazione da parte del Presidente del tribunale possa realizzare la deroga
alle condizioni previste dall’articolo 11, comma 1; infatti, la previsione del
necessario rispetto del comma 7 del medesimo articolo sembra presupporre la
sussistenza di tali condizioni.
·
deve assegnare la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e
di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici di pace, compresi
coloro che risultano assegnati all’ufficio per il processo.
Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, i giudici onorari di pace in
servizio come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del
tribunale secondo quanto previsto, a regime, dall’articolo 12 dello schema
di decreto legislativo (v. sopra). L’assegnazione ai collegi può avere luogo
anche qualora non sussistano le condizioni indicate dall’articolo 11, comma 1.
La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione è
prevista “nonostante l’assenza di uno specifico criterio di delega al riguardo
(presente invece ai fini dell’assegnazione della trattazione dei procedimenti
da decidere in composizione monocratica) perché strettamente attinente allo
spirito della legge delega, conformata, in punto di regime transitorio, al
principio della ultra attività dei preveggenti criteri di liquidazione
dell’indennità con conseguente permanenza, nel periodo de quo, del
corrispondente regime di utilizzo della magistratura onoraria”.
Occorre valutare –
ancor più in assenza di un esplicito principio di delega - l’inserimento del
giudice onorario nel collegio, per quanto avente carattere eccezionale, alla
luce dell’art. 106 della Costituzione. Quest’ultimo, al secondo comma, stabilisce
infatti che la legge sull'ordinamento giudiziario possa prevedere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli».
In merito, con la
sentenza n. 99 del 1964, la Corte costituzionale ha affermato che «i
provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea
destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da
quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo "stato" dei
magistrati (sentenza n. 156 del 1963)» e che non si ha violazione dell’art. 106
della Costituzione quando per «esigenze eccezionali dell'amministrazione della
giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è
possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice»,
il giudice onorario (nella specie il vice pretore onorario) viene chiamato a
far parte del collegio. Tale principio, ovvero della possibile deroga in casi
eccezionali, è stato ribadito anche dalla più recente sentenza n. 103 del 1998.
Sul possibile
utilizzo dei GOT nei collegi si è pronunciata più recentemente la Corte di
cassazione (sent. n. 9323 del 2005) escludendo l’incapacità del giudice
onorario che abbia partecipato ad una deliberazione collegiale del tribunale.
L’utilizzo dei GOT nei collegi è ammesso
anche dalle tabelle di organizzazione approvate dal CSM; dopo alcune
oscillazioni (la circolare delle tabelle per il triennio 2009-2011 ne vietava
l’utilizzo), le ultime circolari del Consiglio ammettono esplicitamente che,
fatti salvi specifici limiti di materia, i giudici onorari possano essere
destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi. La
circolare delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019,
prendendo atto delle novità introdotte sul punto dalla legge 57/2016, ha inteso
valorizzare ulteriormente anche il modello organizzativo del ruolo autonomo dei
giudici onorati di tribunale, estendendone la possibilità di impiego.
Spetta al CSM stabilire il numero minimo dei procedimenti da trattare nell’udienza tenuta dal
giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati (comma 4).
Il comma 5 stabilisce poi le funzioni e i compiti dei magistrati onorari già in servizio con
riguardo al loro quarto mandato.
Andrebbe specificato
se, come sembra, si faccia riferimento al quarto mandato successivo alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo numero 92.
I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata
in vigore del nuovo decreto legislativo sono inseriti nell’ufficio per il
processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività relative ad
esso, secondo quanto previsto, a regime, dall’articolo 10 dello schema di
decreto.
Si rammenta che, per i
giudici onorari, la disposizione di delega (art. 2, comma 17, lettera a) numero
2)), non esplicita il carattere esclusivo dei compiti e delle funzioni presso
l’ufficio del processo.
I viceprocuratori onorari in servizio alla medesima data
possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di aiuto al magistrato
professionale e, sotto la sua direzione e coordinamento, di svolgimento di
tutti gli atti preparatori; si tratta delle funzioni e dei compiti che, a
regime, sono individuati dall’articolo 16, comma 1, lettera a), dello schema di
decreto.
Come già rilevato
sopra, non è prevista una disposizione che, in attuazione della delega (art. 2,
comma 17, lettera a) n. 3), precisi l’applicabilità – fino al compimento del
68° anno - delle disposizioni inerenti al quarto mandato anche ai magistrati
onorari che abbiano compiuto il 65° anno di età alla scadenza di tre
quadrienni.
Peraltro, la delimitazione
di compiti e funzioni stabilita dal comma 5 non opera nel caso in cui il
CSM, con la conferma dell’incarico, riconosca la sussistenza di specifiche
esigenze relativamente alla procura della Repubblica presso cui svolge i
compiti spettanti a regime il viceprocuratore onorario oppure all’ufficio del
giudice di pace cui è addetto il giudice onorario di pace oppure ancora al
tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede.
E’ lo stesso schema di decreto legislativo che precisa
(comma 7) quali siano le esigenze di funzionalità appena richiamate: esse
sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle quattro condizioni,
stabilite dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto per l’assegnazione
ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali.
Si osserva che le
condizioni individuate dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto non
riguardano espressamente anche i viceprocuratori onorari.
Articolo 32
(Indennità spettante ai magistrati
onorari in servizio)
Articolo 32 riguarda l’indennità dei magistrati onorari in servizio.
Sul tema, la legge delega stabilisce specifici principi e
criteri direttivi all’articolo 2, comma 17, lettera b), numero5), e lettera c).
In particolare, la delega prevede che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore
del decreto o dell’ultimo dei decreti legislativi per la liquidazione delle
indennità spettanti ai giudici di pace e ai GOT dovranno essere ancora
applicati fino alla scadenza del quadriennio.
Un autonomo
criterio di delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall’entrata in
vigore del decreto legislativo o dell’ultimo dei decreti legislativi di
attuazione, per la liquidazione delle indennità spettanti ai VPO, continuino ad
applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di
entrata in vigore.
In base all’articolo 32, per la liquidazione delle indennità
dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e viceprocuratori
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo a tale
data, i criteri previsti:
-
dall’articolo 11 della legge n. 374 del 1991, per i
giudici di pace;
-
dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del
1989, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari.
Per la descrizione
della normativa vigente in tema di indennità, si rinvia alla scheda nel
commento all’art. 23.
Dalla scadenza indicata, per la liquidazione dell’indennità
ai magistrati onorari si applicano le nuove disposizioni a regime, che sono
contenute nel capo IX dello schema di decreto legislativo (articoli da 23 a 26,
v. sopra).
Il comma 3 dell’articolo 32, in conseguenza delle
disposizioni appena indicate, precisa che il divieto di richiedere a ciascun
magistrato onorario un impegno superiore a due giorni a settimana (articolo 1,
comma 3, secondo periodo, dello schema di decreto) si applica ai magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo solo
a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo a tale data.
La relazione illustrativa, dopo avere richiamato l’esigenza di
assicurare il rispetto del principio sovranazionale del pro rata temporis, evidenzia che a decorrere dalla scadenza del
quadriennio si produce il definitivo superamento del sistema a cottimo.
Articolo 33
(Disposizioni transitorie e abrogazioni)
Il capo XII contiene disposizioni transitorie e finali ed è
composto da due articoli.
L’articolo 33 contiene una serie di disposizioni transitorie
che regolano l’efficacia nel tempo delle diverse disposizioni dello schema di
decreto.
Si osserva che la
rubrica dell’articolo 33 fa riferimento anche ad “abrogazioni” che, tuttavia,
sono l’oggetto proprio dell’articolo 34.
Il comma 1 regola l’applicabilità ai diversi magistrati onorari.
Prevede che i primi nove capi dello schema di decreto legislativo siano
applicati ai magistrati onorari immessi nel servizio dopo l’entrata in vigore
del decreto.
Per quanto riguarda i magistrati onorari in servizio a tale
data, per quattro anni dovranno essere applicate le disposizione dei primi nove
capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda. Decorsi quattro
anni, anche ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del decreto dovranno essere applicate tutte le disposizioni da esso previste,
venendo pertanto meno l’efficacia delle disposizioni del capo XI.
In base al comma 2, entreranno a fare parte dell’organico dei giudici onorari di pace e dei
viceprocuratori onorari i magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto del ministro della giustizia con cui dovrà essere
determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
Come precisato nella relazione illustrativa, non dovranno
così risultare diverse dotazioni organiche: una relativa a chi è stato immesso
in servizio prima e l’altra relativa a chi è stato immesso in servizio dopo
l’entrata in vigore del decreto legislativo.
Come regola generale, tali magistrati dovranno essere
assegnati, con decreto del ministro della giustizia, all’ufficio presso il
quale prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale che determina la pianta organica. Tuttavia, ciò si potrà
realizzare solamente nel caso in cui il decreto sulla pianta organica preveda
un corrispondente posto nella medesima, anche con riferimento all’esercizio da
parte dei giudici onorari di pace della giurisdizione civile e penale presso
tale ufficio oltre che ai giudici onorari di pace addetti all’ufficio per il processo
del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace.
Qualora il decreto ministeriale relativo alla pianta
organica disponga la riduzione
dell’organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio cui è stato
conferito l’incarico da minor tempo, che risultino in soprannumero, sono
riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto.
Viene poi individuata dai commi 3, 5 e 6 la data del 30 ottobre 2021 quale termine di decorrenza:
- per l’applicazione delle più ampie competenze del giudice
di pace in materia civile, previste dall’articolo 27 dello
schema di decreto, che riguarderanno i procedimenti civili contenziosi, di
volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti a decorrere da
tale data; dalla stessa data, a tali procedimenti dovranno essere applicate le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla stessa data.
- per l’applicazione delle nuove disposizioni relative all’ampliamento
della competenza penale del giudice
di pace (il riferimento è ai procedimenti penali concernenti notizie di reato
acquisite o ricevute a decorrere dal 30 ottobre 2021);
Il 30 ottobre 2021 corrisponde alla conclusione della fase
formativa dei nuovi giudici onorari immessi secondo il nuovo decreto
legislativo.
Il comma 4 prevede che le disposizioni relative
all’ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare (articolo 28) debbano essere
applicate ai procedimenti in materia introdotti a decorrere dal sesto mese successivo alla entrata in
vigore del decreto legislativo.
La relazione illustrativa precisa che per tali procedimenti,
sulla base delle attuali evidenze statistiche, si possono stimare contenuti
flussi di sopravvenienze che consentono l’applicazione pressoché immediata
delle nuove disposizioni.
In base al comma 7, lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo rileva in due ipotesi:
-
ai fini del computo relativo al superamento del periodo
di quattro anni, anche non consecutivi, nelle funzioni giudiziarie onorarie,
che impedisce il conferimento di un nuovo incarico di magistrato onorario
(articolo 4, comma 2, lettera e), dello schema di decreto legislativo);
-
ai fini del raggiungimento del limite massimo di otto
anni complessivi nello svolgimento dell’incarico di magistrato onorario
(articolo 18, comma 2, dello schema di decreto).
Il comma 8 stabilisce un termine di sei mesi per l’adozione da parte del CSM della delibera relativa alla
individuazione dei posti da pubblicare nelle piante organiche degli uffici del
giudice di pace e di viceprocuratori onorari. In base all’articolo 6, comma 1,
tale delibera dovrà essere adottata dal CSM entro il 30 marzo di ogni anno. Il
comma 8 evidentemente disciplina la prima applicazione e, a tal fine, specifica
che la delibera del CSM debba essere adottata nel termine di sei mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro della giustizia
che determina la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
Il comma 9 riguarda i magistrati onorari nominati dopo il 31
maggio 2016, data di entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del
medesimo anno, e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.
Per tali magistrati onorari l’incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla
nomina e sia la nomina sia il tirocinio debbono essere regolati dalle disposizioni
vigenti prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.
Si valuti se la
disposizione relativa alla nomina e al tirocinio di magistrati onorari in
questione sia necessaria dal momento che, inevitabilmente, prima della entrata
in vigore del nuovo decreto legislativo non potranno che essere applicate le
disposizioni previgenti. Si tratta di magistrati che, già in base all’articolo
33, comma 2, entrano a fare parte dell’organico dei giudici onorari di pace e
dei viceprocuratori onorari.
Il comma 10 riguarda la possibilità di destinare in supplenza o in applicazione, anche
parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano
servizio, i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo. La applicazione o la
supplenza potranno essere realizzate in presenza dei presupposti previsti a
regime dall’articolo 14 dello schema di decreto e con le modalità ivi indicate
(v. sopra).
La relazione illustrativa collega la previsione alle gravi
scoperture dell’organico dei giudici di pace che sarebbe tale da comportare la
sostanziale non funzionalità di alcuni uffici sul territorio.
Il comma 10 fa inoltre salve le previsioni sulla
applicazione all’interno del distretto dei giudici di pace, contenute
nell’articolo 6 della legge 57/2016. Si tratta, in quest’ultimo caso, di
disposizioni che perderanno efficacia decorsi due anni dall’entrata in vigore
della legge 57 (dunque il 13 maggio 2018).
In particolare, l’articolo 6 della legge 57 prevede che, fermi
i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del
giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo
organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti,
uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto
(comma 1). La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri
obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura. L'applicazione è disposta con decreto
motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato, dal presidente della
corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della
magistratura e al Ministro della giustizia (comma 2). Il parere del consiglio
giudiziario è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla richiesta (comma 3). L'applicazione non può
superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il
giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore
ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione non può essere disposta se
non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente (comma 4).
Si valuti se occorra
prevedere forme di coordinamento tra la disciplina delle applicazioni e delle
supplenze in ambito circondariale e quella delle applicazioni in ambito
distrettuale.
Si valuti inoltre se,
in base alla formulazione del comma 10, anche per i giudici di pace e i giudici
onorari di tribunale in servizio valgano i divieti in materia di
incompatibilità cui, a regime, l’articolo 14 dello schema di decreto
legislativo rinvia.
In base al comma 11, nelle more dell’adozione del decreto
ministeriale sulla pianta organica, il CSM
dovrà adottare per il 2017, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto
legislativo, la prima delibera con
cui sono individuati i posti da
pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei 12 mesi successivi,
nelle piante organiche. In tale prima applicazione il CSM dovrà individuare,
nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare sulla base delle
piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni
numeriche per l’ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori
onorari.
Il comma 12 stabilisce che i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
continueranno a essere regolati dalle disposizione previgenti.
Peraltro, il comma 13 precisa che non possono essere
promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in
servizio per fatti commessi prima della entrata in vigore del decreto
legislativo. Per tali fatti dovranno essere applicate le disposizioni in
materia disciplinare cui all’articolo 21, commi da 3 a 10, dello schema di
decreto (vedi sopra). Si tratta, in particolare, delle disposizioni in materia
di revoca dall’incarico e di alcune disposizioni sul procedimento relativo a
decadenza, dispensa e revoca.
La relazione non
chiarisce le ragioni per le quali venga introdotto un divieto di promuovere
nuove azioni disciplinari per fatti antecedenti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, che eventualmente possono essere conosciuti
successivamente alla medesima data.
Si chiarisca inoltre
se, per i fatti pregressi, si debbano applicare, in base al comma 12, le
disposizioni previgenti oppure, in base al comma 13, le nuove disposizioni
previste dall’articolo 21, commi da 3 a 10. Si valuti inoltre se si tratti
esclusivamente dei fatti pregressi per i quali sia già stata avviata un’azione
disciplinare.
Articolo 34
(Abrogazioni)
L’articolo 34 prevede l’abrogazione di alcune disposizioni:
-
articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998
E’ la disposizione in base alla quale le norme
dell’ordinamento giudiziario, in forza delle quali possono essere addetti al
tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a
norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non
oltre il 31 maggio 2016;
-
i seguenti articoli dell’ordinamento giudiziario:
o
42 ter (Nomina dei giudici onorari di tribunale),
o
42 quater (Incompatibilità),
o
42-quinquies (Durata dell'ufficio),
o
42-sexies (Cessazione, decadenza e revoca
dall'ufficio),
o
42-septies (Doveri e diritti del giudice
onorario di tribunale),
o
43-bis (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari
addetti al tribunale ordinario),
o
71 (Nomina e funzioni dei magistrati onorari
della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario),
o
71-bis (Esercizio delle funzioni di vice
procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata) e
o
72 (Delegati del procuratore della Repubblica
presso il tribunale ordinario);
-
I seguenti articoli della legge 374/1991 (istituzione
del giudice di pace):
o
3 (Ruolo organico e pianta organica degli uffici
del giudice di pace),
o
4 (Ammissione al tirocinio),
o
4-bis (Tirocinio e nomina),
o
5 (Requisiti per la nomina),
o
6 (Corsi per i giudici di pace),
o
7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
pace),
o
8 (Incompatibilità),
o
9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari),
o
10 (Doveri del giudice di pace),
o
10-bis (Divieto di applicazione o supplenza),
o
10-ter (Richiesta di trasferimento e concorso di
domande)
o
15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di
pace).
Per l’abrogazione dell’articolo 245 del decreto legislativo
n. 51 non è indicata alcuna decorrenza. L’effetto abrogativo dovrebbe
coincidere quindi con l’entrata in vigore del decreto legislativo.
Per le altre disposizioni dell’ordinamento giudiziario e
della legge istitutiva del giudice di pace è precisata la decorrenza, che
tuttavia coincide con la data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decorre invece dalla scadenza del quarto anno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo l’abrogazione delle
seguenti disposizioni:
-
articolo 11 della legge n. 374 del 1991 (indennità
spettanti al giudice di pace);
-
articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989
(sempre sulle indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale)
-
articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 (indennità dei magistrati onorari).
Articolo 35
(Monitoraggio)
L’articolo 35 prevede che il ministro della giustizia ogni
anno proceda al monitoraggio sullo stato
di attuazione del decreto legislativo con particolare riferimento agli
effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati
rilevanti saranno stabiliti dal ministro della giustizia, previo parere del
CSM.
L’articolo 35 individua tutta una serie di dati che, in particolare, il ministro
della giustizia dovrà sottoporre a monitoraggio: il numero dei procedimenti
presso gli uffici del giudice di pace e presso i tribunali ordinari, la loro
durata, il numero dei tribunali cui è stata disposta l’assegnazione della
trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace, lo stato delle spese di
giustizia relative alla magistratura onoraria, il numero dei magistrati onorari
confermati nell’incarico e di quelli revocati.
Il monitoraggio dovrà inoltre sottoporre a verifica
l’efficienza nell’erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi
nazionali con riguardo a ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto e non
soppresso dalla riforma della geografia giudiziaria. Qualora il livello di
efficienza risulti insufficiente, il relativo ufficio dovrà essere soppresso.
In tal caso i giudici onorari in servizio presso tale ufficio dovranno essere
riassegnati ad altro ufficio dello stesso circondario.
L’attività di monitoraggio dovrà prestare particolare
riguardo alla piena compatibilità tra lo stato di attuazione delle disposizioni
del decreto legislativo e i livelli minimi di regolazione previsti dalla
normativa europea.
Entro il 30 giugno di ogni anno il ministro della giustizia
deve trasmettere alle Camere e al CSM una relazione relativa all’attività di
monitoraggio svolta.
Articolo 36
(Disposizioni finanziarie e finali)
L’articolo 36 prevede al comma uno la clausola di invarianza
finanziaria e precisa, al comma due, che al giudice onorario di pace assegnato
nell’ufficio per il processo ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di
pace non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi
intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.
La Commissione europea, nell’ambito della procedura EU-Pilot 7779/15/EMPL, pone
la questione della compatibilità con il diritto dell’UE della disciplina
nazionale relativa al servizio prestato dai magistrati onorari.
In particolare, la Commissione avrebbe rilevato:
·
il
mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in
violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in base al quale gli Stati
membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di
almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite (che non possono essere
sostituite da un’indennità finanziaria, salvo i casi di fine rapporto);
·
il
mancato riconoscimento del congedo di maternità, in violazione della
direttiva 92/85/CEE sulla maternità o – a seconda della natura del servizio
prestato – della direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e
donne che esercitano un’attività di lavoro autonomo;
·
l’assenza
di misure atte a prevenire eventuali abusi di successioni nei contratti di
lavoro a tempo determinato, in violazione della clausola 5 dell’accordo
quadro sui contratti a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, in
base alla quale gli Stati membri devono introdurre una o più misure relative a:
-
ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo
dei suddetti contratti;
-
la durata massima totale dei contratti a tempo
determinato successivi;
-
il numero dei rinnovi dei suddetti contratti;
·
disparità di trattamento rispetto ai magistrati
professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di
regimi di sicurezza sociale, in violazione della clausola 4 del citato accordo
quadro sui contratti a tempo determinato: tale norma, infatti, impone l’obbligo
di osservare il principio del pro rata
temporis, in forza del quale il lavoratore a tempo determinato deve godere,
proporzionalmente, delle medesime tutele riconosciute al lavoratore a tempo
indeterminato (nel caso specifico, al magistrato professionale), ivi compresa
la tutela previdenziale.
La Commissione europea sottolinea
che le citate norme del diritto dell’UE sono applicabili a condizione che il servizio
prestato dai magistrati onorari sia, di fatto, da considerarsi prestazione di
lavoro di tipo subordinato. A tale riguardo, la Commissione rileva che, secondo
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, la caratteristica
essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca,
per un certo periodo di tempo a favore di un’altra e sotto la direzione di
quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione.
Nella prospettiva della Commissione sarebbe dunque irrilevante la
qualificazione dell’ordinamento nazionale in termini di onorarietà del
servizio.
Riguardo alle
osservazioni della Commissione europea, lo schema di decreto legislativo
interviene con le seguenti disposizioni:
·
prevenzione dell’abuso di successioni di
contratti a tempo determinato; l’art. 18 stabilisce che l’incarico di
magistrato ordinario ha la durata di quattro anni prorogabili, al massimo, per
un secondo quadriennio. E’ espressamente escluso che il mandato possa durare
oltre il citato periodo;
·
riconoscimento dell’indennità di riposo: l’art.
24 prevede che i magistrati onorari
continuino a ricevere l’indennità nel periodo feriale riconosciuto ai
magistrati professionali dall’art. 1 della legge 742/1969, salvo che ricorrano
specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non
prestare attività per un corrispondente numero di giorni;
·
rispetto del principio di non discriminazione
nella determinazione dell’indennità: la misura dell'indennità è prudenzialmente
fissata nel rispetto del principio del pro rata temporis rispetto alla
categoria comparabile, prevedendo, ai fini del computo proporzionale, specifici
criteri quali la regola per cui l'attività dell'onorario deve essere
organizzata dal capo dell'ufficio in modo da comportare un impegno non
superiore a due giorni a settimana, al fine di rendere possibile lo svolgimento
di attività diverse, lavorative o professionali (art. 1, comma 3);
·
congedo di maternità: l’art. 25 dello schema di
decreto stabilisce che la maternità non comporta la dispensa dall’incarico;
inoltre, in sostituzione dell'indennità percepita per il servizio onorario
prestato, sancisce il diritto all'indennità economica corrisposta dall’INPS,
ovvero dalla Cassa professionale forense;
• rispetto del principio di non
discriminazione nel trattamento previdenziale: il citato art. 25 stabilisce
che i magistrati onorari iscritti agli albi forensi e, come tali, soggetti
all'obbligo contributivo in favore della Cassa professionale, ricevano tutela
previdenziale e assistenziale dalla Cassa medesima, e gli altri magistrati
onorari siano iscritti, ex lege, alla gestione separata INPS. E' altresì
previsto che la malattia e l'infortunio non comportino la dispensa
dall'incarico e che la relativa tutela sia assicurata, a seconda dei casi,
dalla Cassa professionale ovvero dalla gestione separata INPS.

![]() @SR_Studi
@SR_Studi
![]() @CD_giustizia
@CD_giustizia