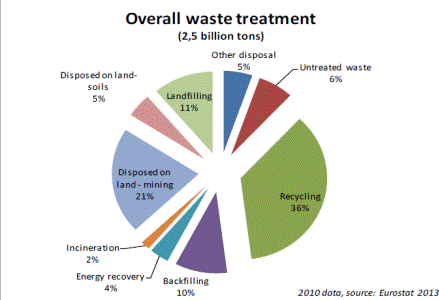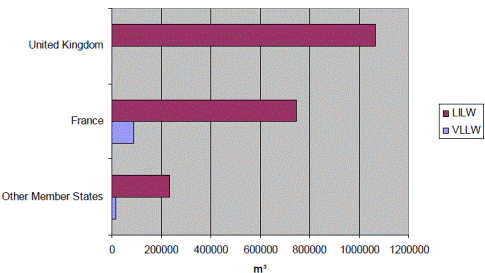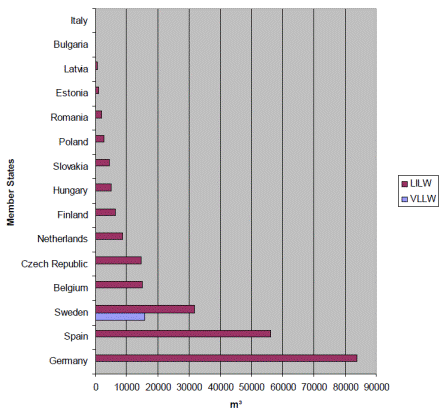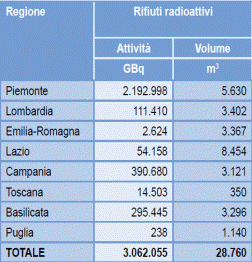Scheda di lettura
Per aumentare il ritmo di miglioramento dei risultati nella
gestione dei rifiuti, lo scorso luglio, la Commissione europea ha presentato la
proposta di direttiva (COM(2014)397)
che modifica sei direttive vigenti: le direttive sui rifiuti (2008/98//CE),
sugli imballaggi (94/62/CE),
sulle discariche (1999/31/CE),
sui veicoli fuori uso (2000/53/CE),
sulle batterie ed accumulatori (2006/66/CE)
e sui rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/CE).
La proposta fa parte di un pacchetto di misure
che interessano più aspetti. Il quadro entro il quale si inseriscono le misure
del pacchetto è costituito dalla comunicazione “Verso un’economia circolare:
un programma a zero rifiuti per l’Europa” (COM(2014)398),
che si basa sul presupposto che da un uso più efficiente delle risorse
deriveranno nuove opportunità di crescita e occupazione.
Una progettazione innovativa, prodotti migliori e più resistenti, processi
produttivi più efficienti e sostenibili, modelli imprenditoriali lungimiranti e
i progressi tecnici per trasformare i rifiuti in una risorsa concorreranno ad
accrescere l'efficienza. Il pacchetto che accompagna la comunicazione
intende creare il contesto che aiuterà a realizzare l'economia circolare,
con politiche meglio integrate, una regolamentazione più razionale e, infine,
con il sostegno delle attività di ricerca e innovazione. Ciò, ad avviso della
Commissione, permetterà di sbloccare gli investimenti e attrarre i
finanziamenti, incentivando, nel contempo, la partecipazione dei
consumatori e il coinvolgimento delle imprese. Il pacchetto suggerisce inoltre
di misurare la produttività delle risorse in base al rapporto tra PIL e
consumo di materie prime, proponendo di individuare nell'aumento del 30%
di tale produttività entro il 2030 un possibile obiettivo principale
da inserire nella prossima revisione della strategia Europa 2020.
In particolare, al fine di incrementare i benefici
economici, sociali ed ambientali derivanti dalla migliore gestione dei rifiuti
urbani, la Commissione propone di:
· incrementare
il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani ad un minimo del 70%
entro il 2030;
· aumentare
il tasso di riciclaggio di rifiuti di imballaggio all’80% entro il 2030,
con obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025, con
obiettivi specifici per i materiali;
· vietare
la messa in discarica del materiale riciclabile (plastica, metalli, vetro,
carta e cartone e rifiuti biodegradabili) entro il 2025 (mentre gli Stati
membri dovrebbero adoperarsi per eliminare virtualmente le discariche entro il
2030);
· promuovere
ulteriormente lo sviluppo dei mercati delle materie prime secondarie di
alta qualità;
· chiarire
il metodo di calcolo dei materiali riciclati al fine di garantire un
alto livello qualitativo di riciclaggio.
In ultima analisi, la proposta è tesa a fornire
indicazioni chiare sulla gestione dei rifiuti nell’Unione e garantire in
tal modo la sicurezza degli investimenti per gli Stati membri e il
settore. Gli Stati membri, all’atto di elaborare le strategie nazionali di
gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti, dovrebbero fare un
uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in
linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
Il 29 ottobre 2014 la Commissione europea ha definitivamente adottato l’accordo di partenariato con cui si definisce
la strategia, articolata in obiettivi tematici, per un uso ottimale dei Fondi
strutturali e di investimento europei in Italia. L'accordo consentirà l'investimento
di 32,2 miliardi di euro di finanziamenti totali a titolo della politica
di coesione nel periodo 2014-2020.
Nell’ambito dell’obiettivo
tematico OT6 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle
risorse linee di indirizzo strategico” rientrano gli interventi che, alla luce
degli obiettivi posti dalla normativa europea, perseguono il miglioramento
del servizio di gestione dei rifiuti, soprattutto nel Mezzogiorno dove,
“nel complesso e malgrado alcuni avanzamenti localizzati, si è ancora distanti
da standard minimi di servizio adeguati”.
Nel periodo di programmazione 2007-2013 il settore dei rifiuti è
stato oggetto di intervento della politica di coesione sia comunitaria che
nazionale, che - secondo quanto riporta l’Accordo – “ha dato risultati non
in linea con le attese, ma ha comunque contribuito a mobilitare
importanti risorse finanziarie a sostegno di interventi non ancora conclusi
e i cui effetti positivi potranno essere apprezzati nei prossimi anni”. Lo
stesso documento ricorda che nel ciclo di programmazione 2007-2013 gli
investimenti (a valere su tutte le fonti finanziarie nazionali ed europee) per
interventi già programmati, in corso di realizzazione e conclusi ammontano a
circa 1,5 miliardi di euro per la gestione dei rifiuti urbani.
Per il nuovo periodo 2014-2020
l’allocazione finanziaria programmatica riferita alla gestione dei
rifiuti, all’interno dell’OT6, è quella relativa al risultato atteso
RA.6.1, pari a 255 milioni di euro (247 dei quali destinati alle regioni
meno sviluppate).
L’Accordo sottolinea altresì
che l'impegno richiesto in tema di gestione dei rifiuti urbani “richiede un
parallelo sostegno mirato, da un lato, a favorire l'innovazione dei processi
produttivi al fine di generare meno rifiuti durante tutta la vita del prodotto
e, dall'altro, a promuovere modalità di consumo che minimizzino l'utilizzo
degli imballaggi. A questa esigenza, nell’ambito del sostegno alla
competitività delle piccole e medie imprese e per la riduzione degli impatti
ambientali dei sistemi produttivi, sono previsti, nell’Obiettivo
Tematico 3, incentivi per la riduzione dell’impatto ambientale delle
produzioni inclusi i c.d. rifiuti speciali, avendo come obiettivi
principali il recupero dei materiali e la diminuzione dell’estrazione e dello
sfruttamento di materie prime anche attraverso il sostegno alla creazione di
reti di riutilizzo e di riparazione e di impianti a servizio di sistemi di
imprese”.
La proposta della Commissione interviene in un quadro che
presenta complessivamente buoni risultati sul piano della gestione dei
rifiuti, sia pure in un panorama variegato per quanto riguarda i
singoli Stati membri.
La produzione dei rifiuti urbani (pari a circa il
7-10% del totale dei rifiuti prodotti) nell’UE-28 risulta nel 2012 in flessione del 2,4% rispetto all’anno precedente: si è passati da circa 253 milioni di
tonnellate nel 2011 a circa 246,8 milioni di tonnellate nel 2012.
Risulta pertanto consolidata la tendenza degli anni precedenti (tra il 2010 e
il 2011, il calo era stato dello 0,9%).
Nella zona EU 15 la produzione di rifiuti urbani è passata
da 214,6 milioni di tonnellate nel 2011 a 209 milioni di tonnellate nel 2012 (-2,6 %). Con riferimento ai Paesi più densamente popolati, le
riduzioni più significative si registrano in Italia e in Spagna (-4,4%),
nel Regno Unito e in Germania (rispettivamente, -3,3% e -2,2%).
Con riferimento ai dati di produzione pro capite, il
panorama risulta estremamente variabile: nel 2012 si passa dai 279 kg/abitante
della Estonia ai 668 kg/abitante della Danimarca. Si tratta, comunque, di dati in
riduzione rispetto al 2011. In linea generale, i nuovi Stati membri hanno un dato
di produzione di rifiuti pro capite mediamente inferiore a quello degli Stati
dell’area EU 15. Ciò probabilmente è riconducibile ai minori consumi derivanti
da condizioni economiche più modeste. Il dato medio di produzione pro capite
nell’area EU 15 è pari a 523 Kg/abitante nel 2012 (-2,6% rispetto al 2011),
mentre nell’area EU 28 è pari a 489 Kg/abitante nel 2012 (-2 % rispetto al 2011).
Anche in Italia, la produzione di rifiuti pro capite tende a
ridursi, essendo passata dai 528 Kg/abitante nel 2011 a 505 Kg/abitante nel 2012.
I rifiuti industriali, commerciali e minerari hanno composizione
e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della
struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore che li
produce e della densità di attività produttive di una determinata zona
geografica.
I rifiuti da costruzione e demolizione sono ammontati nel 2011 a 860 milioni
di tonnellate in totale, di
cui 350 milioni di tonnellate di rifiuti minerali (e di questi, il 19% o 64 milioni
di tonnellate non
è stato recuperato), il resto costituito da terreni scavati.
Gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio (che, in parte, sono riconducibili ai rifiuti urbani) e lo smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili sono stati
raggiunti da quasi tutti gli
Stati membri. Il tasso di recupero dei rifiuti da
imballaggio è aumentato dal 53,7%
nel 1998 (UE 15) al 77,3% nel 2011 (UE 27) e il tasso
di riciclo dei rifiuti biodegradabili è passato dal 47,3% al 63,6% nei medesimi anni.
L'incenerimento dei rifiuti
è passato da 95 kg pro capite nel 2005 a 111 kg nel 2011, di cui 89 kg/ab potrebbe
essere considerato come “recupero
di energia”. Allo stesso tempo, la messa in discarica
dei rifiuti urbani è diminuita
dal 65% nel 1995 al 49% nel 2005 e
al 36% nel 2011. Il riciclaggio dei rifiuti è passato dal 36,5% nel
2008 al 38,5% nel 2011.
Trattamento complessivo dei
rifiuti (dati 2010)
A giudizio della Commissione, i dati dimostrano che le
politiche europee in materia di rifiuti stanno dando buoni risultati e che sono
raggiungibili le tappe delineate dalla tabella
di marcia per l’impiego efficiente delle risorse
e quelli del settimo
programma d’azione per l’ambiente,
tra cui la piena attuazione della gerarchia dei rifiuti
in tutti gli Stati membri, una produzione minore di rifiuti in termini
assoluti e pro capite e l’elaborazione di una strategia globale per combattere
gli sprechi alimentari, in modo da assicurare un riciclaggio di alta
qualità e il ricorso ai rifiuti riciclati come fonte importante e
affidabile di materie prime per l’Unione, la limitazione del recupero
energetico ai materiali non riciclabili e il collocamento in
discarica unicamente dei rifiuti non recuperabili.
La materia del traffico transfrontaliero dei rifiuti è attualmente
disciplinata dal regolamento
n. 1013/2006 che fissa le norme per le spedizioni di rifiuti sia
all'interno dell'UE sia tra l'UE e paesi terzi, allo scopo di tutelare
l'ambiente.
Sulla base di tale regolamento, all’interno dell'UE,
tutte le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni di recupero beneficiano del
diritto di libera circolazione.
Per i rifiuti non pericolosi, tali spedizioni non
sono soggette ad obblighi di notifica preventiva e devono solo rispettare
obblighi generali di informazione. Sia le spedizioni di rifiuti pericolosi
destinati ad operazioni di recupero sia le spedizioni di rifiuti
destinati allo smaltimento sono soggette a obblighi di notifica e
autorizzazione preventive scritte.
Il regolamento n. 1013/2006 vieta inoltre tutte le
esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE e
tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi non
membri dell'UE/EFTA. I rifiuti non pericolosi destinati ad operazioni di
recupero al di fuori dell'OCSE possono essere esportati purché siano
gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, ossia in maniera
essenzialmente equivalente alle norme applicate nell'UE.
Per quanto riguarda l’Italia, dagli ultimi
dati disponibili risulta che, nel 2013, i rifiuti urbani esportati
ammontano a 395 mila tonnellate, di cui 392 mila tonnellate di rifiuti
non pericolosi (il 99,3%). I Paesi Bassi sono il Paese verso cui vengono
destinate le maggiori quantità di rifiuti urbani, 94 mila tonnellate (il
23,9% del totale esportato); seguono l’Austria con il 22,4% del totale, la
Slovacchia con il 10,7% e la Cina con il 10,1%. Del totale dei rifiuti
esportati, 213 mila tonnellate sono avviate a recupero di energia, 170 mila
tonnellate a recupero di materia e 13 mila tonnellate a operazioni di
smaltimento.
Le importazioni in Italia di rifiuti urbani
ammontano a oltre 218 mila tonnellate, di cui solo 22 tonnellate di rifiuti
pericolosi. Il Paese da cui proviene il maggior quantitativo di rifiuti
urbani è la Francia, con 160 mila tonnellate, corrispondente al 73,5% del
totale importato; seguono la Svizzera con il 9,9% e la Germania con il 9,6%.
Gli Stati membri, da un lato, sono tenuti a garantire
l’applicazione del regolamento attraverso ispezioni presso stabilimenti e
imprese a norma degli obblighi ispettivi di cui alla direttiva
2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti), dall’altro, hanno la facoltà
di controllare i rifiuti nel corso del trasporto su strada, nei porti ecc.,
oppure, successivamente, quando già si trovano negli impianti di recupero o
smaltimento. I controlli sono, per il resto, rimessi alla discrezionalità
degli Stati membri, poiché il regolamento vigente non detta le modalità
precise con cui eseguire le ispezioni.
Da tale discrezionalità e dalla mancanza di precise
indicazioni sui contenuti delle ispezioni è scaturito un panorama
estremamente variegato delle attività di controllo da parte degli Stati
membri, che vede, da un lato, sistemi d'ispezione estesi e ben funzionanti
e, dall’altro, sistemi inefficienti, che non garantiscono il rispetto
delle norme e sono privi di strutture e risorse adeguate per controllare i
flussi di rifiuti e per eseguire le ispezioni. Di ciò approfittano gli esportatori
illegali di rifiuti che, con la pratica nota come "port hopping",
fanno transitare i rifiuti illegali attraverso gli Stati membri con minori
controlli.
I maggiori problemi sono legati ai rifiuti pericolosi
e ai rifiuti spediti illegalmente, abbandonati in discariche abusive o
trattati in maniera inadeguata, in quanto possono porre gravi problemi
ambientali e sanitari agli abitanti delle zone intorno alle discariche.
La necessità di intervenire in questo settore è stata
evidenziata anche dalle risultanze dell’indagine condotta, con il sostegno
della Commissione, dal gruppo "Spedizioni transfrontaliere di
rifiuti" della Rete europea per l'attuazione e il controllo del
rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL – TSF), che ha denunciato un
altissimo numero di casi di mancata conformità al regolamento dovuta a
spedizioni illegali di rifiuti. All'origine delle spedizioni illegali di rifiuti
in uscita dal territorio UE vi sono di frequente impianti non
controllati di raccolta, deposito e cernita, gestiti da operatori abusivi
che entrano in possesso dei rifiuti e li spediscono illegalmente nei paesi
in via di sviluppo, spesso servendosi di siti intermedi di deposito per
coprire le vere destinazioni finali dei rifiuti e per impedire alle autorità di
contrasto di individuare le imprese da cui provengono i rifiuti.
Le principali lacune nei sistemi di controllo degli
Stati membri sono la mancanza di pianificazione delle ispezioni e di
valutazione dei rischi; disposizioni insufficienti in materia di onere della
prova; mancanza di controlli a monte per rilevare programmate esportazioni
illegali; mancanza di formazione per il personale ispettivo.
Le ispezioni condotte nei porti, sulle strade e presso gli
impianti hanno dimostrato che circa il 25% delle spedizioni contenenti
rifiuti nell'UE non sono conformi al regolamento sulle spedizioni di
rifiuti UE (n. 1013/2006). Tuttavia, non è possibile avere informazioni precise
sul numero di spedizioni illegali di rifiuti proprio per la loro natura.
Problemi significativi per la raccolta di dati affidabili sulle spedizioni di
rifiuti derivano anche dalla insufficiente segnalazione da parte delle autorità
nazionali e dalla mancanza di armonizzazione del sistema di controllo tra gli
Stati membri.
Quanto alle destinazioni, una gran parte delle
spedizioni illegali di rifiuti provenienti dall'UE appare destinata a paesi
africani e asiatici. Ghana, Nigeria e altri paesi dell'Africa occidentale
sembrano essere le destinazioni più comuni in Africa. In Asia, le spedizioni
illegali di rifiuti spesso sembrano passare attraverso il porto di Hong Kong,
verso la Cina o altri paesi asiatici. Sono state evidenziate spedizioni illegali
di rifiuti anche tra gli Stati membri. Uno studio del 2011 di Europol[9] ha concluso che i
rifiuti pericolosi sono spediti spesso da sud a sud-est Europa (ad esempio da
Italia a Romania e Ungheria).
Gli alti profitti e i rischi di condanne particolarmente
miti hanno indotto le organizzazioni criminali internazionali (in
particolare, quelle italiane) ad entrare nel business della
spedizione illegale di rifiuti (trasporto, deposito e vendita), come
trafficanti e intermediatori. Il traffico illegale riguarda i rifiuti
urbani, i rifiuti industriali e i rifiuti pericolosi (tra cui, anche
veicoli fuori uso, componenti elettriche ed elettroniche). Il volume del
traffico e degli affari illeciti è tuttavia difficile da stimare.
Dai dati risulta che gli Stati membri orientali, in particolare, sono sia
destinazione sia paesi di transito del traffico illegale di rifiuti. I rifiuti
elettronici e le componenti dei veicoli fuori uso sono esportati soprattutto
in Africa (soprattutto in Africa occidentale) e in Asia (in
particolare, in India, Vietnam e Cina). Il traffico illegale di rifiuti,
soprattutto urbani e industriali, avviene tuttavia anche tra i Paesi UE,
in particolare con destinazione la zona centro-orientale dell’UE.
Per colmare tali lacune, è stato approvato lo scorso 15
maggio il regolamento
n. 660/2014, che modifica il regolamento n. 1013/2006.
Il nuovo regolamento, che si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2016, interviene proprio sulle ispezioni a cui sono tenuti
gli Stati membri. L’approccio scelto è il sostegno agli Stati membri
nella loro attività ispettiva, da concentrarsi, però, sulla categoria dei
rifiuti pericolosi.
In particolare, la nuova normativa è volta a garantire un'applicazione
più uniforme del regolamento sulla spedizione dei rifiuti stabilendo obblighi
di ispezione minimi in tutta l'UE, con particolare attenzione ai rifiuti
pericolosi problematici.
Il regolamento è impostato sulla convinzione che l'ispezione
degli impianti di trattamento dei rifiuti compete alle autorità dello Stato
membro in cui sono dislocati. Tuttavia, è necessario che le autorità
competenti nello Stato membro di spedizione siano in grado di valutare il
modo in cui i rifiuti sono gestiti dall'impianto nello Stato membro di
destinazione. Per evitare spedizioni illegali, tale valutazione va
effettuata prima che il trasporto lasci il paese di spedizione. In
caso di spedizione illegale, il paese di spedizione potrebbe essere tenuto a
farsi carico, tra l'altro, delle spese per il rimpatrio dei rifiuti. La
valutazione degli impianti di gestione dei rifiuti non può pertanto essere
affidata alle sole autorità del paese di destinazione.
In materia di trattamento e riciclaggio dei rifiuti, sono
attualmente in corso diverse procedure di infrazione promosse dalla Commissione
europea nei confronti dell’Italia.
La procedura di infrazione n. 2011/4021 è stata
avviata nel maggio 2012 per la non conformità alla normativa europea sulle
discariche di rifiuti (direttiva
1999/31/CE in combinato disposto con la direttiva
quadro sui rifiuti 2008/98/CE) della discarica di Malagrotta e
di altre discariche laziali. In esito a tale procedura, lo scorso 15
ottobre, la Corte di giustizia europea, su ricorso della Commissione, ha
dichiarato l’Italia inadempiente rispetto agli obblighi ad essa incombenti in
forza della normativa europea sulle discariche (C-323/13).
La sentenza di condanna si riferisce alla situazione al primo agosto 2012.
In particolare, la Corte di
giustizia ha riconosciuto che l'Italia ha violato le norme in materia di
rifiuti relativamente al loro conferimento in sette discariche del Lazio:
cinque a Roma (Malagrotta, Colle Fagiolara, Cupinoro, Montecelio-Inviolata e
Fosso Crepacuore) e due di Latina situate a Borgo Montello.
L'Italia, ad avviso della Corte, non ha adottato tutte le
misure necessarie per evitare che i rifiuti urbani fossero conferiti
nelle discariche dei sei siti in questione senza subire un trattamento
adeguato, con la differenziazione delle diverse sezioni e la
stabilizzazione della frazione organica. Inoltre secondo la Corte, un'ulteriore
violazione da parte dell'Italia sta nella mancata creazione, nella
Regione Lazio, di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei
rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. Infine, la
Corte ribadisce che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie
affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati in discarica.
Sottolinea, inoltre, che la nozione di "trattamento" comprende
i processi fisici, termici, chimici o biologici (inclusa la cernita), che
modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o
la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero; la
direttiva Ue prevede, inoltre, che il trattamento sia costantemente adeguato al
progresso scientifico e tecnico.
Con sentenza del 4 marzo 2010, pronunciata nella causa
C
297/08 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195),
la Corte di Giustizia ha statuito che l’Italia ha violato gli obblighi
comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, in
particolare per la mancanza di una rete integrata di gestione dei
rifiuti nella regione.
Rilevando che il Programma attuativo per la
realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti
nella citata sentenza, predisposto e approvato dalla regione Campania, non è
stato rispettato, il 10 dicembre 2013, la Commissione europea
ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia
per mancata esecuzione della medesima sentenza.
Il programma attuativo reca misure destinate a
gestire i rifiuti nella regione fino al 2016, quando dovrebbero diventare operativi
nuovi impianti di trattamento. Tuttavia, la Commissione contesta che dall'estate
2011 le autorità locali hanno dirottato grandi quantità di rifiuti verso
impianti in altre regioni, soluzione questa di natura meramente temporanea. Pur
riconoscendo i progressi fatti, ad esempio sotto il profilo della
raccolta differenziata, la Commissione sottolinea i ritardi che hanno
portato all'arresto della costruzione della maggior parte degli impianti
previsti per il recupero dei rifiuti organici, degli inceneritori e delle
discariche, con il rischio che molte delle installazioni previste non siano
pronte per la fine del 2016. Altri fattori preoccupanti sono, ad avviso della
Commissione, i circa sei milioni di tonnellate di rifiuti imballati e
stoccati presso vari siti in Campania, in attesa di un inceneritore che
deve ancora essere costruito, e il basso tasso di raccolta differenziata
nella provincia di Napoli: pur essendo la città della Campania che produce
più rifiuti, Napoli ha un tasso di raccolta differenziata solo di circa il 20%.
La Commissione chiede alla Corte di giustizia di condannare l’Italia
al versamento di sanzioni pecuniarie consistenti in una somma forfettaria
di 28.089,6 euro al giorno (quantificabile su base annua in circa 10.252.704
euro) per il periodo intercorso tra la prima e la seconda sentenza e in una
penalità di mora di 256.819,20 euro al giorno (vale a dire 85.606,4 euro al
giorno per ogni categoria di installazione) dovuta dal giorno in cui verrà
pronunciata la seconda sentenza fino al completo adempimento (quantificabile su
base annua in circa 93.739.008 euro).
Lo scorso 6 novembre, la Corte di giustizia, con la sentenza
nella causa C-385/13 P, ha confermato le decisioni con cui la
Commissione ha rifiutato di pagare all’Italia i contributi finanziari per la
gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
Nel 2000, nell’ambito degli interventi strutturali
dell’Unione in Italia, la Commissione ha approvato il programma
operativo Campania (PO Campania) per spese effettuate fra il 1999 e il
2008. Una misura[11]
contenuta in tale programma concerneva svariate operazioni relative al
sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti. Gli interventi
della regione destinati a migliorare e a promuovere la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti hanno dato luogo a esborsi pari a 93.268.731,59 euro,
il cui 50% (vale a dire 46.634.365,80 euro) è stato cofinanziato dai Fondi
strutturali. Avendo avviato la procedura di infrazione n. 2007/2195,
a partire dal 2008, la Commissione ha informato le autorità italiane che si
proponeva di rifiutare il rimborso delle spese relative al sistema
regionale dei rifiuti, oggetto del procedimento d’infrazione. Essendosi
tale procedura di infrazione chiusa con la sentenza di condanna (causa C-297/08),
con la quale la Corte di giustizia ha dichiarato che l’Italia ha violato la
normativa europea sui rifiuti, la Commissione, ritenendo che non vi fossero garanzie
sufficienti quanto alla corretta realizzazione delle operazioni cofinanziate
dal FESR, ha rifiutato le richieste di rimborso avanzate dalle
autorità italiane e pari a 18.544.968,76 euro. Adito dall’Italia, il Tribunale,
con una sentenza del 2013 (cause riunite T‑99/09 e T‑308/09),
ha confermato il rifiuto della Commissione, dichiarando che, per poter
rifiutare pagamenti intermedi del FESR, è sufficiente che la Commissione
dimostri che l’oggetto di un procedimento d’infrazione in corso è direttamente
collegato alla «misura» cui si riferiscono le operazioni destinate a essere
finanziate dai Fondi strutturali. La Corte di giustizia, con la sentenza
nella causa 385/13 P, ha dichiarato che giustamente il Tribunale ha legato
l’oggetto del procedimento d’infrazione avviato dalla Commissione con
quello della misura FESR e che ha dunque avuto ragione nel confermare che
la Commissione aveva dimostrato un nesso sufficientemente diretto fra la
procedura d’infrazione e l’oggetto delle domande di pagamento FESR dichiarate
inammissibili. La Corte ha così confermato il rifiuto della Commissione
di pagare all’Italia i contributi finanziari per la gestione e lo smaltimento
dei rifiuti in Campania.
Il 23 novembre 2012, la Commissione, nell’ambito
della procedura di infrazione 2011/2215, ha emesso nei confronti
dell’Italia un parere motivato ex art. 258 TFUE per la violazione degli
obblighi imposti dall’art. 14 (obbligo di procedere all’esecuzione di piani di
riassetto) della direttiva
1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. In particolare, la Commissione
considera irregolari 102 discariche già esistenti o autorizzate al 16
luglio 2001 per le quali, entro il 16 luglio 2009, in base alla normativa europea si sarebbe dovuto prevedere e dare esecuzione ad un adeguato
piano di riassetto ovvero procedere alla chiusura, qualora detto piano fosse
risultato inadeguato.
Sulla base delle informazioni, risulta alla
Commissione che, nonostante i progressi compiuti, sul territorio italiano vi
sono ancora 46 discariche con riferimento alle quali non sono stati adempiuti
gli obblighi previsti dalla direttiva. Le regioni interessate sono l’Abruzzo
(15 discariche), la Basilicata (19 discariche), la Campania (2 discariche), il
Friuli Venezia Giulia (4 discariche), la Liguria (1 discarica per rifiuti
pericolosi) e la Puglia (5 discariche).
Si segnala che, in
risposta all’interrogazione P-000566-14 in cui si richiedevano maggiori particolari sul contenuto
dei rilievi della Commissione e sui siti oggetto dei rilievi, il Commissario
europeo per l'ambiente della Commissione Barroso, Janez
Potočnik, in data 28 febbraio 2014, ha precisato che, qualora i procedimenti di infrazione siano ancora in corso, la Commissione non è autorizzata a
fornire informazioni dettagliate, nella fattispecie l'ubicazione di
discariche specifiche. Inoltre, il procedimento 2011/2215 non è ancora
giunto alla Corte di giustizia. Spetta, infine, alle autorità italiane
competenti decidere quali tecniche debbano essere usate per bonificare
le discariche, tenendo conto delle specificità di ciascun sito.
Per la mancata adozione di misure di controllo delle discariche
abusive, in violazione delle direttive 75/442/CEE
(relativa ai rifiuti), 91/689/CEE
(relativa ai rifiuti pericolosi) e 1999/31/CE
(relativa alle discariche) è in corso la procedura di infrazione 2003/2077.
In relazione a tale procedura, la Corte di giustizia,
il 26 aprile 2007 (causa C-135/05),
ha dichiarato l’inadempienza dell’Italia per non avere adottato tutti i
provvedimenti necessari per assicurare lo smaltimento dei rifiuti senza
pericolo per la salute umana e per l’ambiente e per vietare l’abbandono, lo
scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; inoltre, secondo la
sentenza l’Italia non ha adempiuto agli obblighi relativi all’obbligo di
autorizzazione delle operazioni di smaltimento, alla catalogazione dei rifiuti
pericolosi, all’adozione di piani di riassetto delle discariche esistenti alla
data del 16 luglio 2001.
Lo scorso 2 dicembre 2014, la Corte di giustizia,
nell’ambito della causa
C-196/13, promossa dalla Commissione per l’inerzia dell’Italia
ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla richiamata sentenza
del 26 aprile 2007, ha condannato l’Italia al pagamento di sanzioni
pecuniare.
In particolare, secondo la Corte, la mera chiusura
di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non è
sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva rifiuti.
Pertanto, i provvedimenti di chiusura e di messa in sicurezza delle
discariche non sono sufficienti per conformarsi alla direttiva. Inoltre,
gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare
le vecchie discariche abusive e, all’occorrenza, sono tenuti a bonificarle.
Il sequestro della discarica e l’avvio di un procedimento penale
contro il gestore non costituiscono misure sufficienti. Per quanto
riguarda l’Italia, la Corte rileva che, alla scadenza del termine
impartito del 30 settembre 2009, lavori di bonifica erano ancora in corso
o non erano stati iniziati in certi siti; mentre per altri siti, non è stato
fornito alcun elemento utile a determinare la data in cui tali lavori
sarebbero stati eseguiti.
Tali fatti, ad avviso della Corte, dimostrano la persistente
violazione da parte dell’Italia dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza
del 2007.
In particolare, l’Italia non si è assicurata che il
regime di autorizzazione istituito fosse effettivamente applicato e rispettato;
non ha assicurato la cessazione effettiva delle operazioni realizzate in
assenza di autorizzazione; non ha neppure provveduto ad una catalogazione e
un’identificazione esaustive di ciascuno dei rifiuti pericolosi sversati
nelle discariche. Infine, essa continua a violare l’obbligo di garantire
che per determinate discariche sia adottato un piano di riassetto o un
provvedimento definitivo di chiusura.
Pertanto, la Corte condanna l’Italia al pagamento di una
somma forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità decrescente,
il cui importo iniziale (pari a 42.800.000 euro) sarà ridotto
progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma
conformemente alla sentenza, computando due volte le discariche contenenti
rifiuti pericolosi.
Si segnala che, in risposta all’interrogazione 5-03513, il Governo, lo scorso 11
settembre, ha fatto il quadro
della situazione relativa alla causa in atto. In particolare, come
emerso anche nel corso dell'udienza dello scorso 4 settembre dinanzi alla Corte
UE, dall'ultimo aggiornamento trasmesso dalle Regioni sullo stato degli
interventi di bonifica a maggio 2014 risulta che 47 delle 218
discariche segnalate nel ricorso del 2013 sono state bonificate, mentre per
i 171 siti ad oggi residui gli interventi sono progettati o in corso di
esecuzione. Inoltre, con la Legge di Stabilità 2014 è stato
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni
di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, destinato al finanziamento
di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate
in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Da una ricognizione
preliminare sugli interventi da finanziare sono state individuate 43
aree di discarica che necessitano di adeguata copertura finanziaria ed è stato
definito il piano straordinario degli interventi con il relativo fabbisogno
finanziario. Tale piano è in corso di approvazione.
I rifiuti radioattivi sono costituiti essenzialmente da
rifiuti derivanti dallo smantellamento di centrali nucleari; combustibile
nucleare esaurito (SNF – Spent Nuclear Fuel) usato per la
generazione di energia elettrica; rifiuti di altra provenienza
(essenzialmente derivanti da applicazioni mediche o da attività industriali o
di ricerca).
I rifiuti dalla radioattività
più significativa sono costituiti dal combustibile nucleare
usato per circa tre anni in un reattore nucleare
per la produzione di energia elettrica. Rifiuti a basso livello di
radioattività sono elementi leggermente
contaminati, come strumenti e indumenti da lavoro utilizzati nel funzionamento degli impianti e costituiscono
la maggior parte delle scorie radioattive. Articoli smaltiti come
rifiuti di livello intermedio possono includere filtri usati, componenti in acciaio dall'interno del reattore e alcuni effluenti
di ritrattamento.
I rifiuti radioattivi sono classificati sulla base della
loro radioattività:
· Very
Low Level Waste (VLLW): si tratta della categoria di rifiuti con il minor
tasso di radioattività e, quindi, di pericolosità per l’ambiente e la salute;
· LILW-SL: si tratta
di rifiuti di breve durata a
bassa e media radioattività. Lo smaltimento di questa categoria di rifiuti avviene spesso in depositi di superficie o in
prossimità della superficie;
· LILW-LL: si tratta di rifiuti a lunga
durata a bassa e media radioattività, l
cui smaltimento avviene in depositi
non di superficie;
· HLW: si tratta dei rifiuti ad alta
radioattività, la maggior parte dei quali risulta dal ritrattamento del combustibile esaurito (SNF) e il
cui smaltimento normalmente avviene in depositi geologici
profondi.
I rifiuti ad alto livello di radioattività sono solo il 3% del volume totale
di rifiuti derivanti da produzione
nucleare, ma contengono il 95% della radioattività derivante dal nucleare. I rifiuti a basso livello
di radioattività rappresentano il 90% del volume totale dei rifiuti radioattivi, ma contengono solo l'1% della radioattività,
come risulta dalla tabella che segue:
|
Tipologia di rifiuto
|
Volume
|
Radioattività
|
|
Alto livello
|
3%
|
95%
|
|
Medio livello
|
7%
|
4%
|
|
Basso livello
|
90%
|
1%
|
La maggior parte del combustibile
nucleare utilizzato è l'uranio mentre il plutonio è
utilizzato solo marginalmente. Sia uranio sia il plutonio possono essere riciclati in nuovo combustibile.
Una caratteristica dei rifiuti radioattivi è che, a differenza di altri rifiuti
pericolosi, la loro radioattività decade progressivamente e diminuisce.
Per esempio, dopo 40 anni, il combustibile utilizzato rimosso dal reattore ha
solo un millesimo di radioattività iniziale residua.
Ogni anno, impianti
di generazione di energia nucleare in tutto il mondo producono circa 200.000 m3 di rifiuti
radioattivi a bassa e media
intensità, e circa 10.000 m3 di rifiuti ad alto livello, tra cui combustibile esaurito.
Nei paesi dell'OCSE,
sono prodotti circa 81.000 m3 rifiuti radioattivi all'anno.
Nel Regno Unito, ad esempio, la quantità totale di rifiuti radioattivi (compresi quelli
radioattivi derivanti dagli impianti
nucleari esistenti) è di circa 4,7 milioni di m3, pari a
circa 5 milioni di tonnellate. Un ulteriore milione di
m3 è già stato smaltito.
Del totale dei rifiuti radioattivi
del Regno Unito, circa il 94% (cioè circa 4,4 milioni di m3) rientra nella categoria di
rifiuti a bassa radioattività (LLW). Circa il 6% (290.000 m3) rientra nella categoria dei rifiuti radioattivi
di livello intermedio (SDM), e meno dello 0,1% (1000 m3) è classificato come rifiuto di alto
livello (HLW). Sebbene il volume di HLW
è relativamente ridotto, esso
contiene circa il 95% del totale di
radioattività.
La classificazione
dei rifiuti radioattivi - alto,
medio, basso livello- consente di determinare
le modalità di trattamento e la destinazione finale. I rifiuti di alto livello richiedono la schermatura e il raffreddamento, mentre i rifiuti
di basso livello possono essere gestiti
senza schermatura.
I rifiuti ad alto
livello di radioattività sono smaltiti in depositi in profondità geologicamente
stabili. Anche se nessuna
di tali strutture per
i rifiuti di alto livello è attualmente
in essere, la loro fattibilità è stata dimostrata e ci sono diversi paesi ora in
fase di progettazione e costruzione.
I rifiuti a livello di radioattività
intermedio e basso
sono smaltiti in depositi più superficiali. I siti
di smaltimento dei rifiuti a
basso livello non sono molto diversi dai normali siti di
rifiuti urbani.
Ad oggi, non risulta ancora funzionante
un deposito unico finale per i rifiuti altamente radioattivi e per il
combustibile nucleare esaurito (i primi depositi di questo tipo si prevede saranno aperti
tra il 2020 e il 2025).
Attualmente, circa 270.000 tonnellate di combustibile
esaurito sono stoccate in deposito, per lo più nei siti dei reattori. I bacini
di deposito presso i reattori e quelli presso le strutture centralizzate,
come CLAB in Svezia, sono a 7-12 metri di profondità, per consentire di raccogliere diversi metri di acqua sopra il combustibile esaurito.
Nel mondo, sono state introdotte disposizioni
finanziarie specifiche per la gestione di tutti i tipi di rifiuti radioattivi civili. Ad esempio, il costo di gestione e smaltimento
dei rifiuti da centrali nucleari rappresenta circa il 5% del costo totale dell'energia elettrica
prodotta. La maggior parte delle centrali
nucleari è tenuta dai governi
di appartenenza ad accantonare annualmente una quota
(ad esempio, 0,1 centesimi
per chilowattora negli Stati Uniti, 0.14 ¢/kWh in Francia)
per assicurare la gestione e
lo smaltimento dei loro rifiuti. L'obiettivo principale è garantire che
siano disponibili fondi sufficienti in
caso di necessità.
Il Parlamento europeo e la Commissione Europea si
raccomandano affinché tutti gli Stati membri dispongano di un programma per
la gestione dei propri rifiuti; questo programma dovrà garantire che tutti
gli Stati abbiano accesso ad un impianto di smaltimento geologico, anche
in comune a livello regionale. Nel 2009 è stato istituito un gruppo
di lavoro multinazionale (WG), i cui membri sono nominati dalle competenti
organizzazioni di governo, per studiare la fattibilità della costituzione di
una Organizzazione Europea senza fini di lucro per lo sviluppo del
deposito (ERDO: European
Repository Development Organisation) che, dovrebbe portare alla realizzazione
di uno o più depositi geologici condivisi in Europa.
ERDO-WG è un progetto gestito dall’agenzia nazionale
per i rifiuti dei Paesi Bassi, COVRA (www.covra.nl) e dall’Associazione Arius
(www.arius-world.org) per conto dei suoi membri. Partecipano ad ERDO-WG I
seguenti paesi partecipano attualmente ad ERDO WG: Austria, Bulgaria, Paesi
Bassi, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia,
Slovenia. Inoltre, l’IAEA e la Comunità dell’energia (CE) hanno delegato degli
osservatori nell’ERDO-WG. Trattative continuano con altri paesi europei.
Il combustibile nucleare esaurito può essere
trattato (reprocessing) recuperando gli elementi
riutilizzabili (uranio e plutonio) per la fabbricazione di nuovo combustibile. La ridotta quantità
residua di rifiuti altamente radioattivi è immagazzinata prima di
essere definitivamente smaltita
in un deposito in strati
geologici profondi. Tuttavia, non tutti gli Stati adottano il processo
di ritrattamento del combustibile nucleare esaurito che, pertanto, viene direttamente inviato in un deposito
provvisorio in attesa dello smaltimento
finale in un deposito in strati
geologici profondi.
I principali impianti
commerciali di ritrattamento operano in Francia, Regno Unito, e in Russia, con una
capacità di circa 5.000 tonnellate
all'anno. Un nuovo impianto
di ritrattamento con una capacità
di 800 t/anno è
in fase di messa in servizio in Giappone. Francia e Regno Unito si
impegnano inoltre nei servizi di ritrattamento
per altri paesi, in particolare per
il Giappone, che ha fatto oltre
140 spedizioni in Europa di
combustibile esaurito dal 1979.
I dati ufficiali disponibili riguardanti la
UE sono riportati nel Settimo rapporto riguardante il trattamento dei
rifiuti radioattivi (SEC(2011)1007). Da tali dati risulta che la maggior
parte dei rifiuti è stata conferita alla fine del 2007 (soprattutto dal Regno Unito
e dalla Francia) ed è pari a 2.149.200 m3. Un certo numero di paesi (con o senza centrali nucleari) ha piccoli siti
di smaltimento per i rifiuti, ma molto limitati e alcuni
di questi siti hanno richiesto
notevoli lavori di ristrutturazione
negli ultimi anni per garantire il
rispetto accettabile standard di
sicurezza.
Quadro generale del
conferimento dei rifiuti nucleari al 2007
Fonte:
Commissione europea – SEC(2011)2007
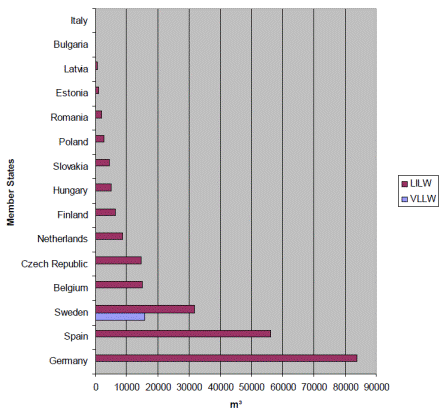 Quadro generale del conferimento dei rifiuti nucleari
al 2007 (esclusi Regno Unito e Francia
Quadro generale del conferimento dei rifiuti nucleari
al 2007 (esclusi Regno Unito e Francia
Fonte:
Commissione europea – SEC(2011)2007
In Italia le centrali nucleari e le altre
installazioni connesse al ciclo del combustibile non sono più in esercizio,
tuttavia sono da tempo in corso le attività per la messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso esercizio e quelle connesse alla
disattivazione delle installazioni stesse. Permangono, inoltre, in
esercizio alcuni piccoli reattori di ricerca presso Università e Centri di
ricerca. Continua, altresì, a essere diffuso l’impiego delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti nelle applicazioni mediche, nell’industria e nella ricerca
scientifica, con le necessarie attività di trasporto per la distribuzione delle
sorgenti stesse e dei rifiuti da esse derivanti.
Un’attenzione particolare meritano le attività di decommissioning
degli impianti nucleari attualmente esistenti in Italia. Le principali installazioni
del pregresso programma nucleare, oggi in fase di disattivazione a diversi
stati di avanzamento, sono le centrali nucleari del Garigliano, di Latina,
di Trino e di Caorso, gli impianti sperimentali di riprocessamento EUREX e
ITREC, l’impianto Plutonio e OPEC 1 del Centro ENEA della Casaccia, l’impianto
Fabbricazioni Nucleari, il Deposito Avogadro, le installazioni del Centro
Comune di Ricerche di Ispra (VA). In tali installazioni sono presenti i
rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso esercizio, gran parte dei quali
necessita di essere trattata e condizionata. Ulteriori quantitativi di rifiuti
deriveranno dalle operazioni di smantellamento delle strutture e dei componenti
costituenti le installazioni stesse.
Per quanto riguarda l’Italia, Il trend attuale
dell’indicatore è da considerarsi sostanzialmente stazionario, in quanto, in
termini quantitativi, non sussiste una produzione di rifiuti radioattivi, fatta
eccezione per i rifiuti ospedalieri. Si prevede, nei prossimi anni,
una consistente crescita della quantità dei rifiuti radioattivi con
l’avvio delle attività di smantellamento delle installazioni nucleari italiane.
Secondo i dati forniti dagli operatori all’ISPRA sono oggi presenti
in Italia circa 27.000 m3 di rifiuti radioattivi a bassa e medi a
attività (prima e seconda categoria), dei quali circa 5.000 m3 sono di origine non energetica (provenienti da ospedali, industrie ecc.), e circa
1.700 m3 a più alta attività (terza categoria), in larga parte
ancora da condizionare. Ai rifiuti suddetti si aggiungeranno i rifiuti
derivanti dallo smantellamento delle installazioni nucleari che sono
stimabili in circa 30.000 m3, prevalentemente di bassa e media
attività, nonché i rifiuti condizionati, derivanti dalle operazioni di
riprocessamento del combustibile irraggiato che rientreranno in Italia dalla
Gran Bretagna (circa 20 m3 di rifiuti vetrificati di terza categoria)
e dalla Francia (circa 50 m3 di terza categoria). Si deve
tenere conto infine dei rifiuti a bassa e media attività di origine non
energetica che vengono annualmente prodotti con un quantitativo stimabile
in circa 200-300 m3.
Inventario dei rifiuti
radioattivi (2012)
Fonte:
Data Base SIRR-ISPRA
Annuario
dei dati ambientali 2013 - ISPRA
Si segnala che la Commissione europea ha presentato nell’ottobre 2013 la comunicazione (COM(2013)734)
in materia di disattivazione degli impianti nucleari e gestione dei rifiuti
radioattivi. In tale documento la Commissione fornisce informazioni aggiornate sullo stato del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti
nucleari ("programma DWM") degli impianti nucleari gestiti
dal Centro comune di ricerca ("JRC") della Commissione
europea.
Si ricorda che le principali attività del
programma sono svolte presso la sede del JRC di Ispra (Italia), che
ospita gran parte degli impianti nucleari dismessi del JRC. Negli altri siti
nucleari del JRC, ubicati a Karlsruhe (Germania), Petten (Paesi Bassi) e
Geel (Belgio), le attività di disattivazione (decommissioning)
sono per il momento relativamente limitate, poiché gli impianti nucleari
di questi tre siti sono tuttora in esercizio. Con riferimento al sito di Ispra,
il JRC ha concentrato le sue attività sulla progettazione e costruzione,
nel sito stesso, di propri impianti di caratterizzazione, trattamento e
condizionamento dei rifiuti, in vista della disattivazione degli impianti.
Ultimata la disattivazione, tutti i rifiuti prodotti presso il sito JRC di
Ispra, dopo essere stati condizionati, dovranno essere immagazzinati in
loco fintanto che non saranno disponibili sul territorio italiano
depositi temporanei o definitivi per i rifiuti nucleari. Per tale motivo il
JRC sta costruendo un impianto di deposito temporaneo in loco. Nel frattempo,
la maggior parte delle materie nucleari obsolete è stata trasferita fuori dal
sito o sta per essere trasferita a terzi.
Con riferimento al programma di disattivazione dei
reattori italiani, si ricorda che il 27 novembre 2009 è stato firmato un accordo
transattivo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo italiano,
sui seguenti aspetti:
- il
trasferimento della responsabilità per la disattivazione del reattore Ispra-1
al governo italiano come compensazione per le responsabilità italiane connesse
ad attività di ricerca nucleare condotte anteriormente nel sito JRC-Ispra;
- le
condizioni per il trasferimento di tutti i rifiuti presenti nel sito JRC-Ispra
al futuro Deposito Nazionale italiano prima della conclusione del programma
DWM;
- la
limitazione del rischio di un successivo ricondizionamento dei rifiuti in caso
di modifiche dei criteri italiani di accettabilità dei rifiuti.
Il programma DWM del sito di Ispra, in corso di
esecuzione, si articola in cinque obiettivi principali:
- messa
in sicurezza degli impianti obsoleti;
- costruzione
o miglioramento di impianti di caratterizzazione, trattamento, condizionamento
e stoccaggio temporaneo;
- recupero,
trattamento e ricondizionamento dei rifiuti esistenti;
- condizionamento
delle materie nucleari ai fini del loro stoccaggio in loco o del loro
trasferimento a terzi;
- disattivazione
degli impianti obsoleti e gestione dei rifiuti che ne risultano.
Con riferimento, in particolare, alla
gestione dei rifiuti e delle materie nucleari, la comunicazione fornisce il
quadro dei principali progressi compiuti nel periodo 2008-2012:
· sito
JRC di Ispra (Italia): tutti i metalli alcalini fuori uso (15 tonnellate)
sono stati rimossi dal sito; circa 1.700 fonti radiologiche obsolete sono state
rimosse dalle sito; i rifiuti tecnologici storici presenti in vari edifici sono
stati separati per tipologia (le attività in corso, realizzate al 40% circa),
caratterizzati, adeguatamente reimballati e immagazzinati per categoria in
un'apposita «area di transito», in attesa di condizionamento; sono stati
effettuati studi volti a valutare le possibilità di ridurre il volume di
rifiuti specifici attraverso diversi processi esistenti di riduzione dei
rifiuti; circa il 90% delle materie nucleari non irraggiate è stato rimosso dal
sito e spedito negli USA e in Francia per il riciclaggio, dopo il trasferimento
del titolo di proprietà; un magazzino centralizzato è stato installato per lo
stoccaggio temporaneo delle materie nucleari irraggiate;
· sito
JRC di Karlsruhe (Germania): i rifiuti radioattivi sono trasferiti
all'impianto tedesco HDB ubicato nello stesso sito, che ne tratta il
condizionamento e lo stoccaggio temporaneo. È in corso una campagna
supplementare di caratterizzazione e ri-condizionamento dei fusti di rifiuti
smaltiti dall'impianto HDB prima del 1995; si è realizzato lo smantellamento di
un grande numero di attrezzature dismesse e la bonifica dei rifiuti storici;
· sito
JRC-Petten (Paesi Bassi): i rifiuti radioattivi sono trasferiti agli
impianti di condizionamento e di stoccaggio temporaneo dell'organizzazione
olandese COVRA a Vlissingen; per circa dieci anni il combustibile nucleare
esaurito obsoleto, che era una proprietà storica del JRC, è stato regolarmente
rimosso dal sito ed inviato in parte negli Stati Uniti e in parte al COVRA (l'ultima
spedizione è stata effettuata nel marzo 2011);
· sito
JRC-Geel (Belgio): i rifiuti radioattivi sono trasferiti agli impianti di
condizionamento e di stoccaggio temporaneo di Belgoprocess a Dessel e si sta
procedendo alla rimozione progressiva delle materie nucleari obsolete.
Quanto alle spese sostenute nel
periodo 2008-2012, rispetto alla previsione di bilancio per l'intero
programma DWM del JRC di 124 milioni di euro2003 (corrispondenti a
un importo attuale, corretto per l'inflazione, di 146 milioni di euro), risulta
che sono state utilizzate risorse per complessivi 133 milioni di euro,
cifra inferiore di circa il 9% rispetto alla stima iniziale. La minore spesa, sebbene
sia parzialmente imputabile a una riduzione dei costi, è principalmente dovuta
a spese non effettuate per il rinvio di alcuni progetti del programma del JRC
di Ispra.
Si segnala che al settore dello smaltimento dei rifiuti
nucleari sono destinate, nel periodo 2014-2020, le seguenti risorse
finanziarie:
· 969 milioni
di euro, per lo smantellamento delle centrali nucleari di Bulgaria (293
milioni di euro), Lituania (451 milioni di euro) e Sllovacchia (225 milioni di
euro);
· 225
milioni di euro per la cooperazione alla sicurezza nucleare.
Si ricorda infine che, è attualmente in corso una procedura
di infrazione a carico dell’Italia (arrivata allo stadio di messa in
mora comunicata con lettera del 21 novembre 2013), per il mancato
recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi (procedura di infrazione n. 2013/2229).
La direttiva, in particolare, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad
elaborare e comunicare alla Commissione i programmi nazionali per la gestione
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi di loro giurisdizione,
dalla produzione fino allo smaltimento definitivo.
Si ricorda che alla direttiva 2011/70/Euratom ha dato
attuazione il decreto legislativo n. 45/2014.