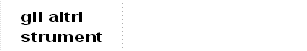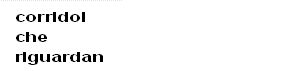Scheda di lettura
 Le reti
transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e
delle telecomunicazioni (TENs) esistono come politica europea dal 1993. Come
previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’azione dell’UE
mira a favorire l’interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali
e la loro interoperabilità, per contribuire al buon funzionamento del mercato
interno e consentire a cittadini ed operatori economici di beneficiare dei
vantaggi di uno spazio interno senza frontiere.
Le reti
transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e
delle telecomunicazioni (TENs) esistono come politica europea dal 1993. Come
previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’azione dell’UE
mira a favorire l’interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali
e la loro interoperabilità, per contribuire al buon funzionamento del mercato
interno e consentire a cittadini ed operatori economici di beneficiare dei
vantaggi di uno spazio interno senza frontiere.
I principali strumenti della politica in materia di reti TEN
sono:
- le linee guida dell’Unione che indicano gli obiettivi
e le priorità, individuano le misure per sviluppare le reti e
definiscono il quadro per l’identificazione dei progetti di comune
interesse;
- uno strumento finanziario dedicato per sostenere i
progetti, che sono preparati e attuati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e in conformità delle regole e delle procedure degli Stati
membri sui cui territori sono localizzati i progetti.
 Per
quanto riguarda in particolare i trasporti (TEN-T), l’obiettivo
generale è quello di stabilire un'unica rete transeuropea multimodale per
integrare trasporto terrestre, marittimo e aereo, consentendo a merci e
persone di circolare rapidamente e facilmente tra gli Stati membri. A tal fine occorre
affrontare a livello dell'UE cinque grandi problematiche:
Per
quanto riguarda in particolare i trasporti (TEN-T), l’obiettivo
generale è quello di stabilire un'unica rete transeuropea multimodale per
integrare trasporto terrestre, marittimo e aereo, consentendo a merci e
persone di circolare rapidamente e facilmente tra gli Stati membri. A tal fine occorre
affrontare a livello dell'UE cinque grandi problematiche:
· i collegamenti
mancanti, in particolare nelle tratte transfrontaliere;
· la notevole
disparità sotto il profilo della qualità e della disponibilità di
infrastrutture tra e all'interno degli Stati membri (strozzature).
In particolare, devono essere migliorati i collegamenti est-ovest,
attraverso la creazione di nuove infrastrutture di trasporto e/o la
manutenzione, il ripristino o l'aggiornamento delle infrastrutture esistenti;
·  la
frammentazione dell'infrastruttura dei trasporti tra i diversi modi di
trasporto. Per quanto riguarda i collegamenti multimodali, in Europa molti
terminali merci, stazioni passeggeri, porti interni, porti marittimi, aeroporti
e nodi urbani non sono all'altezza del compito;
la
frammentazione dell'infrastruttura dei trasporti tra i diversi modi di
trasporto. Per quanto riguarda i collegamenti multimodali, in Europa molti
terminali merci, stazioni passeggeri, porti interni, porti marittimi, aeroporti
e nodi urbani non sono all'altezza del compito;
· gli
Stati membri continuano ad avere norme e requisiti operativi diversi, in
particolare in materia di interoperabilità, il che non fa che aggiungere
ostacoli e strozzature alle infrastrutture di trasporto..
Nel 2013 il valore totale delle attività di trasporto
dei beni dell’UE a 28 è stato stimato in 3.481 bilioni di tonnellate per
chilometro. Il totale delle attività di trasporto passeggeri nell’UE a 28 per
tutti i mezzi di trasporto è stato stimato in 6.465 bilioni di persone per km.,
vale a dire che ogni cittadino dell’UE ha percorso in un anno una media di
12.900  km.
km.

Per il trasporto passeggeri l’automobile resta il
mezzo preferito — in parte perché è utilizzata per brevi spostamenti e in zone
rurali in cui non esistono altre opzioni — e rappresenta quasi il 74 % del
mercato. Seguono l’aviazione con l’8 %, gli autobus e i pullman con una
percentuale simile, le ferrovie con il 6 % e, infine, i veicoli a motore a due
ruote, i tram e le metropolitane. Chiudono la classifica i viaggi via mare, con
meno dell’1 %. Per il comparto merci il trasporto stradale con autocarri domina
ancora sulle brevi e medie distanze. Una ripartizione simile mostra che il
trasporto su gomma rappresentava quasi la metà delle tonnellate di merci
trasportate nel 2010, seguita dal trasporto marittimo, dalle ferrovie, dal
trasporto per vie navigabili interne e dagli oleodotti. All’ultimo posto, con
meno dell’1 %, si colloca il traffico cargo aereo, il cui rapporto costi-valore
è però spesso abbondantemente superiore, nonostante il suo volume contenuto


Le prime linee guida sono state adottate dal Parlamento
europeo e dal Consiglio nel 1996; il primo regolamento sul finanziamento delle
reti è stato adottato nel 1995.
La politica TEN-T ha oggi una crescente importanza, dopo
tre grandi allargamenti dell’UE e a fronte di un’evoluzione della situazione
politica ed economica durante i vent’anni della sua esistenza. Una
revisione sostanziale è stata avviata nel 2009 e ha condotto ad un nuovo quadro
legislativo entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, costituito da:
· regolamento
(UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti;
· regolamento
(UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa
(vedi infra).
Le nuove disposizioni definiscono il quadro di sviluppo
della politica dei trasporti fino al 2030/2050.
I nuovi orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti prospettano la creazione di una rete
TEN-T articolata in due livelli:
·
una rete globale (da realizzarsi entro il 2050) che mira a
garantire la piena copertura del territorio dell'UE e l'accessibilità a tutte
le regioni. La lunghezza totale della rete globale è:
- 138.072 km
di linee ferroviarie;
-
136.706 km di strade;
-
23.506 km di vie d’acqua interne.
·
una rete centrale a livello UE (da realizzarsi entro il
2030) basata su un “approccio per corridoi”;
La rete
centrale è parte della rete
globale ed è stata individuata sulla base della sua importanza strategica per i
principali flussi di trasporto europeo e globale. La metodologia di pianificazione utilizzata dalla Commissione è stata sottoposta ad
un’ampia consultazione degli Stati membri e dei soggetti interessati. La
lunghezza totale della rete centrale ammonta a:
- 50.762
km di linee ferroviarie;
- 34.401
km di strade;
- 12.880
km di vie d’acqua interne.
La rete collegherà:
- 94 grandi porti europei con linee
ferroviarie e stradali;
- 38 grandi aeroporti con linee
ferroviarie che portano alle città principali;
- 15 000 km di linee ferroviarie
convertite ad alta velocità;
- 35 progetti transfrontalieri
destinati a ridurre le strozzature.
La rete centrale è articolata
intorno a 9 corridoi principali: 2 corridoi nord-sud, 3 corridoi
est-ovest e 4 corridoi diagonali. Ogni corridoio deve includere tre modalità di
trasporto, tre Stati membri e due sezioni transfrontaliere:
- il
corridoio Baltico-Adriatico è uno dei più importanti assi stradali e
ferroviari transeuropei che collega il Mar Baltico al Mare Adriatico
attraversando zone industrializzate che vanno dalla Polonia meridionale (Slesia
superiore) a Vienna e Bratislava, alla Regione delle Alpi orientali e
all'Italia settentrionale. Il tratto italiano del corridoio inizia al valico
del Tarvisio e si conclude a Ravenna;
- il
corridoio Mare del Nord-Mar Baltico da Helsinki ad Amburgo;
- il
corridoio Mediterraneo che collega la Penisola iberica con il confine
ungro-ucraino costeggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della
Francia per poi attraversare le Alpi nell'Italia settentrionale in
direzione est, toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia, e proseguire
verso l'Ungheria. A parte il fiume Po e qualche altro canale nel Norditalia, il
corridoio è essenzialmente stradale e ferroviario. I principali progetti
ferroviari lungo questo corridoio sono i collegamenti Lione-Torino e la
sezione Venezia-Lubiana. Il tratto italiano inizia dal Piemonte,
attraversa la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e si conclude
dopo Trieste, al confine con la Slovenia;
- Il
corridoio orientale/mediterraneo orientale collega la Germania settentrionale
con la Grecia e Cipro;
-  il
corridoio scandinavo-mediterraneo è un asse nord-sud cruciale per
l'economia europea. Attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla Svezia
e passando attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, collega i principali
centri urbani e porti della Scandinavia e della Germania settentrionale ai
centri industrializzati di produzione della Germania meridionale, dell'Austria
e del Norditalia e quindi ai porti italiani e della Valletta. I progetti più
importanti di questo corridoio sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria
di base del Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il corridoio
raggiunge quindi via mare Malta passando dall'Italia meridionale e dalla Sicilia.
Il corridoio attraversa l’Italia per tutta la sua lunghezza, dal confine con
l’Austria fino a Palermo, e prevede anche il collegamento ferroviario Napoli-Bari;
il
corridoio scandinavo-mediterraneo è un asse nord-sud cruciale per
l'economia europea. Attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla Svezia
e passando attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, collega i principali
centri urbani e porti della Scandinavia e della Germania settentrionale ai
centri industrializzati di produzione della Germania meridionale, dell'Austria
e del Norditalia e quindi ai porti italiani e della Valletta. I progetti più
importanti di questo corridoio sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria
di base del Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il corridoio
raggiunge quindi via mare Malta passando dall'Italia meridionale e dalla Sicilia.
Il corridoio attraversa l’Italia per tutta la sua lunghezza, dal confine con
l’Austria fino a Palermo, e prevede anche il collegamento ferroviario Napoli-Bari;
-  il corridoio Reno-Alpi costituisce una delle
rotte merci più trafficate d'Europa: collega i porti del Mare del Nord di
Rotterdam e Anversa con il Mar Mediterraneo a Genova attraversando la
Svizzera e passando per alcuni dei principali centri economici della Ruhr
renana, le regioni del Reno-Meno-Neckar e l'agglomerazione di Milano. È un
corridoio multimodale che include il Reno come via navigabile interna. I
principali progetti sono le gallerie di base in Svizzera, in parte già
completate, e le loro vie di accesso in Germania e in Italia. Il tratto
italiano del corridoio inizia dal Gottardo e dal Sempione e attrverso Novara e
Milano raggiunge Genova;
il corridoio Reno-Alpi costituisce una delle
rotte merci più trafficate d'Europa: collega i porti del Mare del Nord di
Rotterdam e Anversa con il Mar Mediterraneo a Genova attraversando la
Svizzera e passando per alcuni dei principali centri economici della Ruhr
renana, le regioni del Reno-Meno-Neckar e l'agglomerazione di Milano. È un
corridoio multimodale che include il Reno come via navigabile interna. I
principali progetti sono le gallerie di base in Svizzera, in parte già
completate, e le loro vie di accesso in Germania e in Italia. Il tratto
italiano del corridoio inizia dal Gottardo e dal Sempione e attrverso Novara e
Milano raggiunge Genova;
- il
corridoio atlantico collega la parte occidentale della Penisola iberica
e i porti di Le Havre e Rouen a Parigi e quindi a Mannheim/Strasburgo;
- il
corridoio Mare del Nord-Mar Mediterraneo va dall'Irlanda e dal nord del
Regno Unito fino al Mare Mediterraneo nel sud della Francia attraverso i Paesi
Bassi, il Belgio e il Lussemburgo;
- il
corridoio Reno-Danubio, collega le regioni centrali intorno a Strasburgo
e Francoforte sul Meno attraverso la Germania meridionale a Vienna, Bratislava
e Budapest per arrivare infine al Mar Nero.

Fonte: Servizi
della Commissione
L’Italia risulta il Paese più “premiato” dalla nuova
geografia infrastrutturale europea con:
- corridoio mediterraneo:
completamento dell'alta velocità Lione-Torino-Milano-Venezia
- corridoio Reno-Alpi:
rafforzamento della Genova-Milano-Novara-Gottardo
- corridoio baltico-adriatico
potenziamento dei collegamenti Udine-Venezia-Ravenna-Bologna
- corridoio scandinavo-mediterraneo:
rafforzamento dei collegamenti Brennero-Bologna-Napoli-Palermo,
Palermo-Messina e Napoli-Bari
- Roma
- Bologna
- Genova
- Milano
- Napoli
- Torino
- Venezia
- Palermo
- Milano Linate
- Milano Malpensa
- Roma Fiumicino
- Ancona
- Bari
- Genova
- Gioia Tauro
- La Spezia
- Livorno
- Napoli
- Ravenna
- Taranto
- Trieste
- Venezia
Tra le priorità indicate dall’Italia è rimasto fuori
solamente il Ponte sullo Stretto. Si mantengono infatti:
·
l'asse ferroviario e autostradale Salerno-Reggio Calabria;
·
i collegamenti triangolari Messina-Catania-Palermo (finora
Catania non era contemplata);
·
la ferrovia Napoli-Bari, che all'inizio era stata tracciata sulla
carta come alternativa al corridoio multimodale Napoli-Palermo.
 I lavori per la
realizzazione dei nove corridoi fanno capo ad altrettanti coordinatori
europei, scelti tra persone che hanno maturato competenze nel settore ed
esperienza presso le istituzioni europee. Come regola generale, provengono da
un paese che non è interessato dal corridoio per il quale sono stati nominati
coordinatori. Come previsto dagli orientamenti, sono stati designati anche due
coordinatori orizzontali, che lavoreranno rispettivamente sull’attuazione
coordinata delle autostrade del mare e del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management
System).
I lavori per la
realizzazione dei nove corridoi fanno capo ad altrettanti coordinatori
europei, scelti tra persone che hanno maturato competenze nel settore ed
esperienza presso le istituzioni europee. Come regola generale, provengono da
un paese che non è interessato dal corridoio per il quale sono stati nominati
coordinatori. Come previsto dagli orientamenti, sono stati designati anche due
coordinatori orizzontali, che lavoreranno rispettivamente sull’attuazione
coordinata delle autostrade del mare e del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management
System).
Il mandato include:
-
redigere il piano di lavoro relativo al corridoio di concerto con
gli Stati membri e
-
sostenere e controllarne l’attuazione, segnalando le eventuali
difficoltà e individuando i rimedi necessari;
-
consultare regolarmente il Forum del corridoio, un organo
consultivo composto dagli Stati membri coinvolti e da varie soggetti
interessati;
-
predisporre ogni anno una relazione per il Parlamento europeo, il
Consiglio, la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ai progressi
ottenuti nella realizzazione del corridoio in questione.
 Come previsto dal mandato,
per ciascun corridoio è stato predisposto un piano di lavoro che
contiene: la descrizione dello status delle infrastrutture, un piano
per la rimozione degli ostacoli fisici, tecnici, operativi ed amministrativi e
il quadro generale delle risorse finanziarie (dell’UE, internazionali,
nazionali, regionali e locali). Il programma di lavoro è anche il risultato di
una serie di incontri – nell’ambito del Forum del corridoio - con gli Stati interessati,
così come con regioni, gestori di infrastrutture, rappresentanti dell’industria
dei trasporti. I piani di lavoro degli 11 coordinatori europei, che
stabiliscono le basi per l’azione fino al 2030, sono stati approvati a
giugno 2015.
Come previsto dal mandato,
per ciascun corridoio è stato predisposto un piano di lavoro che
contiene: la descrizione dello status delle infrastrutture, un piano
per la rimozione degli ostacoli fisici, tecnici, operativi ed amministrativi e
il quadro generale delle risorse finanziarie (dell’UE, internazionali,
nazionali, regionali e locali). Il programma di lavoro è anche il risultato di
una serie di incontri – nell’ambito del Forum del corridoio - con gli Stati interessati,
così come con regioni, gestori di infrastrutture, rappresentanti dell’industria
dei trasporti. I piani di lavoro degli 11 coordinatori europei, che
stabiliscono le basi per l’azione fino al 2030, sono stati approvati a
giugno 2015.
Il costo totale del potenziamento e sviluppo delle reti
infrastrutturali per venire incontro alla richiesta nel settore dei trasporti è
stato stimato in 1.500 miliardi di euro per il periodo 2010-2030 per l’intera
rete degli Stati membri. Il completamento delle reti TEN-T da solo richiede
500 miliardi di euro, di cui 250 miliardi per la rete centrale e i progetti
annessi. Le risorse disponibili risultano tuttavia di ammontare nettamente
inferiore. Sette anni dopo l’inizio della crisi, la ripresa economica dell’Europa
è ancora lenta e il livello degli investimenti nel settore dei trasporti rimane
basso.
D’altra parte, secondo uno studio,
realizzato per conto della Commissione e pubblicato a giugno 2015, il mancato
completamento delle reti TEN-T comporterebbe la perdita di 1,8 %
di PIL (che a prezzi costanti 2005 ammonta a 294 billion di euro) nel 2030
e di 10 milioni di anni-uomo di lavoro.
In conseguenza del fatto che le
risorse disponibili non sono sufficienti per realizzare integralmente i
progetti inclusi nelle reti TEN-T, il Meccanismo per collegare l'Europa -
istituito dal regolamento
(UE) n. 1316/2013 dell'11 dicembre 2013 - delinea un piano di
investimenti destinato a migliorare le reti europee di trasporto (oltre
alle reti di energia e telecomunicazioni), contribuendo a creare posti di
lavoro e a rafforzare la competitività dell'Europa, in linea con gli
obiettivi della strategia Europa 2020.
Lo scopo del meccanismo è razionalizzare
ed agevolare la concessione del sostegno dell’UE a favore delle infrastrutture,
ottimizzando gli strumenti disponibili, uniformando le norme operative per il
loro uso e mettendo a frutto le possibili sinergie tra i tre settori
considerati. Esso sarà coordinato con gli altri interventi finanziati dal
bilancio dell’Unione, come “Horizon 2020”, il fondo di coesione e i fondi strutturali. Per la realizzazione del progetto delle reti TEN-T, infatti l'Unione
europea fa riferimento a varie fonti di finanziamento, tra cui: il bilancio di
trasporto per le reti transeuropee; il Fondo di coesione (nei paesi ammissibili
per il suo intervento); il Fondo europeo di sviluppo regionale; la Banca europea degli investimenti (BEI).
 La dotazione
finanziaria per il Connecting Europe Facility per il periodo 2014-2020
è pari a 33,24 miliardi di euro, di cui 24,05 miliardi sono
destinati al settore dei trasporti; tra questi 11,3 miliardi di euro
sono riservati ai paesi dell’obiettivo di coesione (agli Stati con PIL pro capite
inferiore al 90% della media UE-27; l’Italia quindi non potrà beneficiarne).
La dotazione
finanziaria per il Connecting Europe Facility per il periodo 2014-2020
è pari a 33,24 miliardi di euro, di cui 24,05 miliardi sono
destinati al settore dei trasporti; tra questi 11,3 miliardi di euro
sono riservati ai paesi dell’obiettivo di coesione (agli Stati con PIL pro capite
inferiore al 90% della media UE-27; l’Italia quindi non potrà beneficiarne).
I 24,05 miliardi di euro
stanziati per i trasporti agiranno come "capitale di avviamento" per
stimolare ulteriori investimenti da parte degli Stati membri. Tali finanziamenti
infatti esercitano generalmente un forte “effetto leva”. L'esperienza degli
ultimi anni dimostra che ogni milione di euro speso a livello europeo
genererà 5 milioni dai governi degli Stati membri e 20 milioni dal
settore privato.
La Commissione ha calcolato che gli investimenti nelle
infrastrutture relative ai trasporti per 200 miliardi di euro possono
generare, di qui al 2020, almeno 650.000 nuovi posti di lavoro.
Più in generale, gli investimenti previsti nel CEF
avranno un significativo impatto economico dal momento che accresceranno
l’accessibilità al mercato e miglioreranno l’efficienza delle industrie di
rete. I costi relativi ai trasporti, ad esempio, oggi rappresentano dal 2
al 10 % dei costi totali dei servizi e le famiglie europee spendono circa il
13% del loro reddito per beni e servizi collegati ai trasporti. Migliori
collegamenti infrastrutturali contribuiranno a far scendere questi costi, oltre
ad avere un significativo effetto sulla competitività e sulla salute dei
cittadini.
Il sostegno finanziario assume
prevalentemente due forme:
· sovvenzioni,
vale a dire investimenti non rimborsabili dal bilancio dell’UE;
· contribuzioni
di strumenti finanziari innovativi, sviluppati insieme a istituzioni
finanziarie come la BEI (vedi infra).
Nell’elenco di interventi
individuati in via preliminare per la rete centrale, allegato al regolamento
che istituisce il CEF, si segnalano quelli riguardanti l’Italia:
|
Corridoio
Baltico-Adriatico
|
Trieste,
Venezia, Ravenna
|
Porti
|
Interconnessioni
con i porti, (ulteriore) sviluppo delle piattaforme multimodali
|
|
Corridoio
Mediterraneo
|
Lione
- Torino
|
Ferrovia
|
Sezione
transfrontaliera, lavori sulla galleria di base; studi e lavori sulle vie di
accesso
|
|
|
Milano
- Brescia
|
Ferrovia
|
Parziale
adeguamento della linea ad alta velocità e linea ad alta velocità
parzialmente nuova
|
|
|
Brescia
- Venezia - Trieste
|
Ferrovia
|
Lavori
da avviare entro il 2014 su diverse sezioni in sinergia con i lavori di
adeguamento intrapresi sulle tratte comuni come nel corridoio Baltico –
Adriatico
|
|
|
Milano
– Cremona- Mantova – Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste
|
Vie
navigabili interne
|
Studi
e lavori
|
|
|
Cremona,
Mantova, Venezia, Ravenna, Trieste
|
Porti
di navigazione interna
|
Interconnessioni
con i porti, (ulteriore) sviluppo delle piattaforme multimodali
|
|
Corridoio
Scandinavo-Mediterraneo
|
Galleria
di base del Brennero
|
Ferrovia
|
Studi
e lavori
|
|
|
Fortezza-Verona
|
Ferrovia
|
Studi
e lavori
|
|
|
Napoli-Bari
|
Ferrovia
|
Studi
e lavori
|
|
|
Napoli-Reggio
Calabria
|
Ferrovia
|
Adeguamento
|
|
|
Verona-Bologna
|
Ferrovia
|
Adeguamento
in corso
|
|
|
Ancona,
Napoli, Bari, La Spezia, Livorno
|
Porti
|
Interconnessioni
con i porti, (ulteriore) sviluppo delle piattaforme multimodali
|
|
|
Messina
- Catania – Augusta/Palermo
|
Ferrovia
|
Adeguamento
|
|
|
Palermo-Taranto
– Valletta/Marsa Scirocco
|
Porti,
autostrade del mare
|
Interconnessioni
con i porti
|
|
|
Bologna-Ancona
|
Ferrovia
|
Adeguamento
|
|
Corridoio
Reno-Alpi
|
Genova
|
Porto
|
Interconnessioni
con i porti
|
|
|
Genova
- Milano/Novara - frontiera CH
|
Ferrovia
|
Studi;
inizio dei lavori entro il 2020
|
Sulla base delle indicazioni contenute nel citato
regolamento nonché nei piani di lavoro elaborati per ciascun corridoio, il 10
luglio 2015 il comitato per il Meccanismo per collegare l'Europa (composto
da rappresentanti degli Stati membri) ha accolto le proposte della Commissione,
approvando i 276 progetti specifici da finanziare. Nel processo di
selezione i progetti sono stati valutati in base a una serie prestabilita di
criteri: pertinenza, durata, impatto e qualità. E’ stata data la priorità ai
progetti che presentavano il più alto valore aggiunto europeo, garantendo allo
stesso tempo una distribuzione equilibrata sia dal punto di vista geografico
sia tra le diverse modalità di trasporto.
 Il
contributo finanziario dell'UE è costituito da sovvenzioni intese a coprire dal
20% all'85% dei finanziamenti, a seconda del tipo di progetto.
Il
contributo finanziario dell'UE è costituito da sovvenzioni intese a coprire dal
20% all'85% dei finanziamenti, a seconda del tipo di progetto.
Per quanto riguarda l’Italia,
dei 71 presentati (si veda il capitolo “Reti TEN-T La situazione in
Italia) i progetti sotto coordinamento italiano giudicati meritevoli di
finanziamento sono stati 14 per un controvalore complessivo del co-finanziamento
comunitario pari a oltre 1,5 miliardi di euro. I più importanti sono la
galleria di base del Brennero e il potenziamento tecnologico e infrastrutturale
della Chiasso-Milano. Tra gli altri progetti italiani selezionati si segnala:
- il miglioramento
della navigabilità del Po: 9.282.800 euro,
- soluzioni
ambientali per il porto di Genova: 4.651.000 euro,
- il
rafforzamento del collegamento ferroviario da Malpensa: 2.066.000
euro,
- il
miglioramento del terminal per i container dell'interporto di Padova:
3.396.318 euro.
Approvato anche il progetto per
l’alta velocità Torino Lione, che è sotto il coordinamento della Francia (per
i progetti approvati si vedano in allegato le schede di dettaglio).
 Allo scopo
di facilitare l’accesso a finanziamenti privati mediante strumenti finanziari
innovativi, come i prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti (project
bond), la Commissione europea ha presentato, insieme al Meccanismo
per collegare l’Europa, l’iniziativa sui project bond, che intende
rilanciare il mercato delle obbligazioni e al contempo supportare i promotori
dei singoli progetti infrastrutturali ad attrarre finanziamenti obbligazionari
privati di lunga durata.
Allo scopo
di facilitare l’accesso a finanziamenti privati mediante strumenti finanziari
innovativi, come i prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti (project
bond), la Commissione europea ha presentato, insieme al Meccanismo
per collegare l’Europa, l’iniziativa sui project bond, che intende
rilanciare il mercato delle obbligazioni e al contempo supportare i promotori
dei singoli progetti infrastrutturali ad attrarre finanziamenti obbligazionari
privati di lunga durata.
L’iniziativa è stata definitivamente approvata con la firma
dell’Accordo di cooperazione tra la Commissione europea e la Banca europea degli investimenti (BEI), che definisce i criteri per la ripartizione dei
rischi.
La fase pilota, gestita dalla BEI, beneficia di un finanziamento
di 230 milioni di euro e incoraggerà interventi privati fino a 4
miliardi di euro per investimenti nelle infrastrutture nei settori dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. La fase pilota si pone due
obiettivi da realizzare:
· creare
un mercato di capitali di debito come fonte addizionale di
finanziamento di progetti infrastrutturali;
· stimolare
gli investimenti nelle infrastrutture nel settore dei transporti,
dell'energia e della tecnologia.
Nel dicembre 2013 la Commissione ha pubblicato la relazione
intermedia sulla fase pilota dell’iniziativa, in cui si evidenzia che dopo
solo 12 mesi, l’iniziativa sta rispondendo alle aspettative ed è un successo
per quanto riguarda l’erogazione di finanziamenti a favore dei progetti. La Commissione rileva come il mercato abbia mostrato interesse per l’iniziativa e abbia
trasmesso riscontri positivi, dando un contributo fondamentale alla promozione
dei prestiti obbligazionari fra gli investitori. Per intensificare il ricorso
ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, occorre tuttavia
sviluppare ulteriormente un mercato obbligazionario attivo. Inoltre, i governi
dovrebbero impegnarsi a effettuare una programmazione a lungo termine, in modo
da garantire una riserva di progetti infrastrutturali più stabile e
trasparente.
I progetti attualmente finanziati
nella fase pilota sono otto..
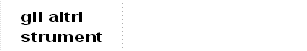 Oltre
ai project bond, gli altri strumenti finanziari innovativi sono:
Oltre
ai project bond, gli altri strumenti finanziari innovativi sono:
· il Loan
Guarantee for Transport Projects (LGTT), lo strumento di garanzia dei
prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti nato
per consentire una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento
delle infrastrutture di trasporto di importanza europea, in
particolare agli investimenti nei progetti relativi alle reti transeuropee, che
presentano un elevato rischio finanziario nella fase operativa iniziale. L'LGTT,
che fa parte del programma "Rete transeuropea dei trasporti" (TEN-T)
e dell'iniziativa a favore della crescita (Action for Growth Initiative – AGI)
della BEI, coprirà in parte questo rischio, migliorando in tal modo in misura
significativa la fattibilità finanziaria degli investimenti nelle reti
transeuropee;
· il 2020
European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure (“Marguerite”) istituito
con il sostegno delle sei maggiori istituzioni finanziarie europee per fare
investimenti capital-intensive in progetti infrastrutturali con
l’obiettivo di favorire ricavi di lungo termine adattati al livello di rischio.
Ognuna delle seti istituzioni ha impegnato nel fondo 100 milioni di euro; in
aggiunta tre ulteriori investitori, compresa la Commissione europea, hanno
impegnato ulteriori 110 milioni di euro, portando gli impegni attuali a 710 milioni
di euro;
· il CEF
strumento di debito, operativo da giugno 2015, con una dotazione di 1.5
miliardi di finanziamento con un potenziale di leva degli investimenti di 1:15.
Progetti infrastrutturali nei trasporti sono finanziati
anche attraverso il Fondo di coesione che assiste gli Stati membri con
un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media
dell'Unione europea e al quale l’Italia non può accedere.
Il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) mira a consolidare la coesione economica e sociale
dell'Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni.
Nel periodo 2014-2020 l’Italia
riceverà complessivamente circa 32,2 miliardi di euro (al valore attuale), di
cui 2,4 miliardi di euro per l’obiettivo 7 “Promuovere sistemi di trasporto
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”,
che l’Italia ha deciso destinare esclusivamente alle regioni meno sviluppate,
vale a dire Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basicilia.
Horizon 2020 – il programma dell’UE destinato a finanziare
le attività di ricerca – ha destinato oltre 6 miliardi di euro per il settore Smart,
Green and Integrated Transport con l’obiettivo di sviluppare dispositivi, reti
e servizi intelligenti e miliorare il trasporto e la mobilità delle aree
urbane.
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici la cui
disciplina è contenuta nel regolamento
UE n. 2015/1017, si configura come un
fondo fiduciario dedicato in seno alla Banca europea per gli
investimenti (BEI).
Il FEIS è fondato sui seguenti elementi:
- una garanzia di 16 miliardi di euro dal bilancio dell'UE. 8
miliardi di euro stanziati nel bilancio dell'UE a sostegno di una garanzia
di 16 miliardi di euro, nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa
(cd. Connecting Europe, nella misura di 2,8 miliardi),
del programma Horizon 2020 (2,2 miliardi) e della riserva
di bilancio (3,2 miliardi), derivante dall'utilizzo del margine
di flessibilità del bilancio dell'Unione, vale dire del margine
disponibile tra il massimale delle risorse proprie e quello delle spese;
- 5 miliardi di EUR dalla Banca europea per gli investimenti
Il FEIS - 21 miliardi di EUR in totale - dovrebbe
raggiungere un effetto moltiplicatore complessivo di 1:15, generando circa 315
miliardi di EUR in nuovi investimenti. Si concentrerà su progetti in un'ampia
gamma di settori, tra cui:
- sviluppo di infrastrutture;
- ricerca, sviluppo e innovazione;
- investimenti nei settori di istruzione e formazione, sanità,
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- sviluppo del settore energetico.
 Il
Consiglio informale trasporti del 16 e 17 settembre 2014 ha tenuto un dibattito
sul tema del finanziamento delle reti TEN-T, sottolineando la necessità di
acquisire fondi aggiuntivi, sia da fonti private che pubbliche, per
finanziare le necessità di investimento di 500 miliardi fino al
2020. Secondo i ministri, sono necessarie maggiori risorse –
europee e nazionali – per il rafforzamento del finanziamento, delle garanzie e
dei prestiti. In aggiunta agli strumenti esistenti, dovrebbero anche essere
valutati nuovi strumenti di debito, quali le obbligazioni di progetto per i
corridoi o i raggruppamenti di progetti, le garanzie sovrane sottoscritte
individualmente o collettivamente in caso di progetti transfrontalieri degli
Stati membri, o ancora la possibilità per l’Unione Europea di prevedere
direttamente fondi su mercati capitali per progetti specifici di interesse
europeo. Secondo i ministri, un uso maggiore di strumenti finanziari nuovi ed
esistenti potrebbe attrarre fino a 100 miliardi di investimenti aggiuntivi in
infrastrutture.
Il
Consiglio informale trasporti del 16 e 17 settembre 2014 ha tenuto un dibattito
sul tema del finanziamento delle reti TEN-T, sottolineando la necessità di
acquisire fondi aggiuntivi, sia da fonti private che pubbliche, per
finanziare le necessità di investimento di 500 miliardi fino al
2020. Secondo i ministri, sono necessarie maggiori risorse –
europee e nazionali – per il rafforzamento del finanziamento, delle garanzie e
dei prestiti. In aggiunta agli strumenti esistenti, dovrebbero anche essere
valutati nuovi strumenti di debito, quali le obbligazioni di progetto per i
corridoi o i raggruppamenti di progetti, le garanzie sovrane sottoscritte
individualmente o collettivamente in caso di progetti transfrontalieri degli
Stati membri, o ancora la possibilità per l’Unione Europea di prevedere
direttamente fondi su mercati capitali per progetti specifici di interesse
europeo. Secondo i ministri, un uso maggiore di strumenti finanziari nuovi ed
esistenti potrebbe attrarre fino a 100 miliardi di investimenti aggiuntivi in
infrastrutture.
Su tali basi, nel corso del Consiglio informale è
stato chiesto all’ex Vice Presidente della Commissione Europea Christophersen e
ai Coordinatori Bodewig e Secchi di presentare un rapporto, di concerto con la
BEI, che identificasse i progetti dei corridoi particolarmente idonei a
beneficiare dei predetti nuovi schemi finanziari nel contesto del “Pacchetto
Occupazione, Crescita e Investimenti” proposto dal Presidente Juncker. Nella
sua versione finale il rapporto
Making the best use of new financial schemes è stato
presentato a giugno 2015.
 Il rapporto definisce
un piano d’azione con 12 raccomandazioni per il finanziamento dei progetti:
Il rapporto definisce
un piano d’azione con 12 raccomandazioni per il finanziamento dei progetti:
- le
amministrazioni degli Stati membri dovrebbero avere un accesso agevole a
forme di assistenza tecnica dedicata;
- i
promotori dei progetti dovrebbero includere, nel processo di preparazione, considerazioni
sul ciclo di vita del progetto, dalla sua ideazione allo sviluppo e
attuazione, inclusi i costi e tutte le altre rilevanti questioni connesse alla
loro manutenzione;
- gli
Stati membri e i promotori dei progetti dovrebbero lavorare e ricevere sostegno
per migliorare la qualità dei progetti e per renderli appetibili agli
investitori;
- gli
Stati membri dovrebbero semplificare le procedure degli appalti al fine
di accelerare l’attuazione dei progetti;
- gli
Stati membri dovrebbero semplificare le procedure di autorizzazione per
facilitare l’attuazione dei progetti:
- la
Commissione dovrebbe assicurare un quadro adeguato per gli aiuti di stato;
- la
Commissione dovrebbe individuare soluzioni di cross-financing per
recuperare risorse aggiuntive;
- la
Commissione dovrebbe proporre un quadro per recuperare risorse aggiuntive
attraverso la monetizzazione dei costi esterni e dei benefici e applicando il
principio “l’utente-paga”;
- la
Commissione e la BEI dovrebbero facilitare il blending and pooling
combinando le sovvenzioni del CEF e del FEIS con gli strumenti finanziari e i
prodotti disponibili nell’ambito degli stessi fondi;
- la
Commissione dovrebbe assicurare che possibili impatti inattesi dei regolamenti
sui mercati finanziari, come Solvency 2 e Basilea III, siano mitigati grazie
alla ricalibrazione non discriminatoria delle previsioni di rischio per una
nuova infrastruttura;
- la
Commissione dovrebbe proporre un trattamento statistico chiaro dei partenariati
pubblico-privato per conoscere il loro contributo alla crescita e
all’occupazione e fornire certezze ai promotori e investitori dei progetti;
- la
Commissione e la BEI dovrebbero assicurare in uno sforzo congiunto un’ampia
consultazione delle parti interessate, sul finanziamento delle infrastrutture
per il trasporto..
Nel rapporto si
evidenziano alcuni nuovi schemi di finanziamento tra i quali:
-  gli
schemi di cross-financing (vale a dire di finanziamento di un
settore con gli introiti di un altro), quale ad esempio l’utilizzo dei pedaggi
autostradali per finanziare interventi sulle linee ferroviarie che è ancora
oggetto di critiche perché le ferrovie beneficiano di più alti livello di
sussidio rispetto alle strade o al trasporto aereo. Non di meno la maggior
parte degli esempi di successo nell’attuazione di grandi progetti
infrastrutturali ferroviari è stata possibile grazie al cross-financing.
Secondo gli autori del rapporto, la Commissione dovrebbe favorire l’uso del
cross financing per la rimozione dei colli di bottiglia nella rete TEN-T
centrale, privilegiando i progetti con netti benefici sociali ma che con
difficoltà verrebbero finanziati a causa degli elevati investimenti o per la
loro natura transfrontaliera. Un esempio di questo tipo è rappresentato dalla
galleria di base del Brennero;
gli
schemi di cross-financing (vale a dire di finanziamento di un
settore con gli introiti di un altro), quale ad esempio l’utilizzo dei pedaggi
autostradali per finanziare interventi sulle linee ferroviarie che è ancora
oggetto di critiche perché le ferrovie beneficiano di più alti livello di
sussidio rispetto alle strade o al trasporto aereo. Non di meno la maggior
parte degli esempi di successo nell’attuazione di grandi progetti
infrastrutturali ferroviari è stata possibile grazie al cross-financing.
Secondo gli autori del rapporto, la Commissione dovrebbe favorire l’uso del
cross financing per la rimozione dei colli di bottiglia nella rete TEN-T
centrale, privilegiando i progetti con netti benefici sociali ma che con
difficoltà verrebbero finanziati a causa degli elevati investimenti o per la
loro natura transfrontaliera. Un esempio di questo tipo è rappresentato dalla
galleria di base del Brennero;
- nel
corso della revisione del sistema di scambio delle quote di emissione
(ETS) attualmente, si potrebbe considerare di dirottare parte delle entrate derivanti
dalla vendita delle quote per progetti di mobilità sostenibile;
- un
uso incrementato del pooling and blending delle risorse potrebbe
determinare un effetto sinergico delle limitate risorse dell’UE e a livello
nazionale, creando una massa critica di investimenti intorno alle
infrastrutture strategiche dei trasporti per favorire la conclusione di tali
progetti nel breve e medio termine;
- un uso
migliore della liquidità disponibile sul mercato dei capitali e in
particolare dei patrimoni gestiti dagli investitori istituzionali. Gli
investitori istituzionali sono una delle maggiori fonti di capitale pubblico e
privato con circa 63 trilioni di euro contro un totale globale di capitali
finanziari di circa 190 trilioni. In Europa, i capitali gestiti da investitori
istituzionali ammontano a circa 13.5 trilioni di euro, equivalente a oltre il
90% del PIL dell’UE. Gli Investitori istituzionali sono una fonte affidabile di
capitale di lungo termine principalmente perché necessitano di far
corrispondere le loro passività con long-term maturity assets. Questo rende gli
investitori istituzionali eccezionalmente adatti ad intraprendere investimenti
ciclici nei settori dell’economia reale caratterizzati da alta produttività.
Nel rapporto inoltre, come
richiesto dai ministri dei trasporti, sono individuati – per ciascun corridoio
- i progetti idonei ad essere finanziati attraverso strumenti innovativi. Per
quanto riguarda l’Italia si tratta degli interventi sul porto di Trieste e
sull’A4, l’Autovia Veneta.
RETI TEN-T la situazione in Italia
(A cura del Servizio
Studi)
L’Italia è interessata da quattro
dei nove corridoi della rete centrale TEN-T:
· 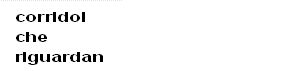 il
corridoio 1 Baltico-Adriatico, che collegherà Helsinki a Ravenna,
che comprende i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e
Trieste-Venezia-Ravenna;
il
corridoio 1 Baltico-Adriatico, che collegherà Helsinki a Ravenna,
che comprende i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e
Trieste-Venezia-Ravenna;
· il corridoio
3 Mediterraneo da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese,
con i collegamenti ferroviari Torino- Lione, Milano-Brescia,
Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divaccia;
· il corridoio
5 Scandinavo-Mediterraneo che comprende il tunnel di base del Brennero
nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio
Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta;
· il corridoio
6 Reno-Alpi che comprende i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara,
tra cui il “terzo valico alpino dei Giovi” della linea AV/AC Milano
Genova, nonché una serie di interventi collegati alla futura realizzazione del
nuovo tunnel di base del Gottardo, situato interamente in territorio svizzero,
ma di interesse anche l'Italia per i suoi riflessi sul traffico tra il nostro
territorio e il Nord Europa.
Per
consentire infatti alla rete ferroviaria italiana di assorbire il nuovo
traffico veloce che si verrà a creare in seguito al completamento del progetto
della società Alptransit San Gottardo SA cui è affidata le realizzazione del
tunnel ferroviario del Gottardo, si prevede di realizzare in Italia una serie
di interventi, tutti collocati all'interno del Corridoio 6, alcuni dei quali
rientranti anche nel Programma delle infrastrutture strategiche che comprendono
anche il potenziamento del Nodo di Genova.
Il Progetto definitivo realizzazione della linea
Alta Velocità Torino–Lione, collocata nel Corridoio 3
"Mediterraneo", è stato approvato dal CIPE con delibera del 20
febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo
soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas),
responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura.
ll 24 febbraio 2015 è stato quindi firmato a Parigi l'Accordo tra
Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della
linea ad alta velocità Torino-Lione. Tale Accordo, integrato dal protocollo
addizionale che recepisce la certificazione dei costi e il Regolamento dei
contratti, dovrà essere ratificato dai Parlamenti italiano e francese.
 Il
progetto definitivo approvato dal CIPE del nuovo collegamento internazionale Torino
Lione riguarda la Parte comune italo francese, in particolare la tratta
in territorio italiano della Sezione transfrontaliera.
Il
progetto definitivo approvato dal CIPE del nuovo collegamento internazionale Torino
Lione riguarda la Parte comune italo francese, in particolare la tratta
in territorio italiano della Sezione transfrontaliera.
Il Progetto definitivo prevede una parte comune italo
francese che comprende un tunnel di base di 57 km, da Saint Jean de Maurienne a
Susa/Bussoleno, con due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di
comunicazione, che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di
pianura ed una sezione all'aperto di circa 3 km nella piana di Susa.
La sezione transfrontaliera sarà collocata in territorio italiano
per circa 17 km, di cui 12,5 in galleria, dalla frontiera fino a Bussoleno
(Susa), e include il Tunnel di base, il Nodo di Susa, il tunnel
dell'interconnessione alla linea storica Torino Modane di 2,1 km e
l'interconnessione all'entrata della stazione di Bussoleno.
Il costo complessivo dell'intera sezione transfrontaliera è
di circa 8,6 miliardi di euro, a valori 2012, da ripartire tra Francia, Italia
e UE.
La tratta in territorio italiano ha un costo di circa 2,634
miliardi di euro, mentre quella in territorio francese di circa 5,968 miliardi
di euro. Ciascuno di questi costi viene finanziato per quote da tutti e tre i
soggetti interessati: UE, Francia e Italia. La ripartizione dei costi tra
Italia e Francia prevede un contributo dell'Italia del 35% circa e della
Francia del 25% circa. Il contributo UE è stato stimato in circa il 40%. La
copertura finanziaria dell'intervento per la parte a carico dell'Italia è a
valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 208 della legge di Stabilità 2015
(legge n. 190 del 2014) riportata in tabella E (cap. 7532).
 E' stata
quindi inviata il 26 febbraio 2015, alla Commissione UE, la domanda per il contributo
europeo, relativo all'Italia, nell'ambito della prima tranche dei bandi
infrastrutturali 2014 per le reti TEN-T. L'agenzia incaricata dalla Commissione
Europea di esaminare i progetti di trasporto, ha proposto il 29 giugno 2015 il finanziamento,
operativo dal 10 luglio, della Sezione Transfrontaliera della
Torino-Lione al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019. Si tratta di
un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della
"Connecting Europe Facility" per la prima fase dei lavori. Il
contributo europeo consente di ridurre il costo a carico dell'Italia, relativo
alle opere in territorio italiano, stimato originariamente in circa 1,6
miliardi, a meno di 900 milioni di euro. La delibera CIPE di approvazione del
progetto definitivo è stata trasmessa alla Camera il 22 luglio 2015.
E' stata
quindi inviata il 26 febbraio 2015, alla Commissione UE, la domanda per il contributo
europeo, relativo all'Italia, nell'ambito della prima tranche dei bandi
infrastrutturali 2014 per le reti TEN-T. L'agenzia incaricata dalla Commissione
Europea di esaminare i progetti di trasporto, ha proposto il 29 giugno 2015 il finanziamento,
operativo dal 10 luglio, della Sezione Transfrontaliera della
Torino-Lione al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019. Si tratta di
un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della
"Connecting Europe Facility" per la prima fase dei lavori. Il
contributo europeo consente di ridurre il costo a carico dell'Italia, relativo
alle opere in territorio italiano, stimato originariamente in circa 1,6
miliardi, a meno di 900 milioni di euro. La delibera CIPE di approvazione del
progetto definitivo è stata trasmessa alla Camera il 22 luglio 2015.
La Commissione europea ha approvato il 29 luglio 2015 il Programma
Operativo Infrastrutture e Reti dell'Italia (PON Reti 2014-2020), la cui
dotazione di bilancio ammonta a 1,843 miliardi di euro, di cui 1,382 miliardi
di euro provengono dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)
ed il 25% dal cofinanziamento nazionale, di 460 milioni circa, come stabilito
dall'Accordo di partenariato. Il PON Infrastrutture e Reti è gestito dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che lo ha pubblicato il 2
settembre 2015 e si colloca nell'Obiettivo tematico 7 "Mobilità
sostenibile di persone e merci" dell'Accordo di partenariato 2014-2020.
La finalità principale del Programma è la promozione di
sistemi di trasporto sostenibili e l'eliminazione delle strozzature nelle
principali infrastrutture di rete, attraverso il finanziamento progetti
collocati in 5 regioni del Sud Italia: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e
Basilicata, ovvero nelle Regioni "Obiettivo Convergenza", quelle per
le quali la politica di Coesione comunitaria punta ad investire al fine di
portarle a convergere verso i parametri socio-economici della media del resto
dell'Unione. ll programma prevede investimenti in tre settori: le
infrastrutture ferroviarie, le infrastrutture portuali e i sistemi di trasporto
intelligenti ed in particolare si concentrerà sulla priorità degli investimenti
nella RETE TENT con un finanziamento totale di 1.095 milioni di euro pari
al 62% del bilancio del programma.
Per ulteriori informazioni:
PON Infrastrutture e
Reti 2014-2020;
La politica di coesione e l'Italia;
La sintesi dell'Accordo di partenariato per l'Italia 2014-2020;
La sintesi dei
singoli programmi nazionali e regionali.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
presentato il 26 febbraio 2015 alla Commissione europea un piano organico di
interventi infrastrutturali, con richiesta di finanziamento nell’ambito del
CEF, in base ai bandi TEN-T 2014 nell'ambito dei quali sono stati stanziati
circa 13 miliardi di euro (prima tranche dei 24 miliardi previsti). Il MIT
indica che sono state inviate a Bruxelles 71 proposte progettuali italiane per
un costo totale di 6 miliardi e 822 milioni di euro che verranno spesi entro il
2020 in base a un cronoprogramma. La richiesta di contributo comunitario è di 2
miliardi e 471 milioni di euro.
Tra i 71 progetti presentati 32 riguardano il settore
ferroviario, con una richiesta di contributo di 2 miliardi e 236,9 milioni di
euro che costituiscono il 90,5 per cento della richiesta totale: tra queste 14
proposte di RFI sulle tratte nazionali dei corridoi multimodali TEN-T, 3
progetti RFI per il collegamento ferroviario degli aeroporti di Venezia, Roma
Fiumicino e Milano Malpensa, 3 proposte relative a studi e lavori sulle sezioni
transfrontaliere del Tunnel di Base del Brennero e della linea ferroviaria
Torino-Lione.
L'elenco dei progetti nel settore
ferroviario è il seguente:
- 3
proposte relative a studi e lavori sulle sezioni trasfrontaliere del Tunnel di
Base del Brennero e della linea ferroviaria Torino-Lione, con la richiesta di
contributo europeo per l'Italia da parte di BBT SE e LTF SAS
rispettivamente pari a circa 630 mln di euro e 720 mln di euro;
- 14
proposte di RFI sulle tratte nazionali dei corridoi multimodali TEN-T:
realizzazione AV/AC Terzo Valico dei Giovi (110,4 milioni) e potenziamento di
linee ed impianti (nodo di Genova) sul Corridoio "Reno-Alpino",
potenziamento tecnologico ed infrastrutturale sul Corridoio
"Mediterraneo" (rispettivamente sulle linee
"Milano-Venezia", "Treviglio-Brescia" e "Torino-Milano-Venezia"),
potenziamento tecnologico, infrastrutturale ed intermodale (nodo di Roma e
Napoli) ed adeguamenti prestazionali sulle linee di collegamento con i porti
(Livorno, La Spezia) sul Corridoio "Scandinavo-Mediterraneo";
realizzazione di impianti di collegamento con i nodi e ripristino di linee sul
Corridoio "Baltico-Adriatico" (Nodo di Bologna, la linea per Venezia
e linea dei bivi sul nodo di Venezia);
- 3
progettazioni, sempre in capo ad RFI, per il collegamento ferroviario degli
aeroporti di Venezia, Roma Fiumicino e Milano Malpensa, quest'ultima correlata
a una proposta di collegamento a Nord dell'aeroporto di Milano Malpensa (SEA e
FERROVIE NORD);
- 1
studio di articolazione tecnico-finanziaria per il collegamento dell'aeroporto
di Genova;
- 6
progetti riguardano l'implementazione del sistema di segnalamento e controllo
ERTMS sui corridoi A e D, sulla linea "Roma-Firenze", di cui 2
progetti per la formazione del personale e l'attrezzaggio a bordo treno
promosso da NTV e una proposta internazionale di semplificazione, facilitazione
e armonizzazione dei processi autorizzativi per la messa in esercizio e
certificazione ERTMS, con la partecipazione di RINA;
- 1
progetto di potenziamento tecnologico mediante SCMT sulla rete sarda (RFI);
- 2
proposte di rafforzamento delle performance dei Corridoi Ferroviari Merci n.5 e
6;
- 2
studi rispettivamente per la circolazione di treni con lunghezza di 750 mt
lungo alcune sezioni dei corridoi e la riqualificazione e ristrutturazione di 4
nodi di interscambio nella Regione Lazio.
Al settore marittimo sono destinate 15 proposte per
130,2 milioni €, tra cui la progettazione e costruzione di piattaforme
logistiche e terminal container a Trieste e Venezia per 22,3 milioni e lo
sviluppo di nuovi collegamenti di Autostrade del Mare (Civitavecchia per 6,9
milioni €) e altri progetti riguardano le idrovie
. Tra i progetti nel settore marittimo vi sono:
- realizzazione
di banchine, allungamento moli, piazzali, attività di dragaggio, stazioni
marittime, piattaforme offshore/onshore, (Ravenna 29 milioni; Trieste 19,7
milioni);
- progettazione/costruzione
di piattaforme logistiche e terminal container (Trieste e Venezia, 22,3
milioni; Vado ligure 5 milioni;
- opere
di accesso ai porti e collegamenti a interporti, in particolare ferroviari
(Livorno 11,5 milioni; Venezia 11,4 milioni);
- sviluppo
di nuovi collegamenti di Autostrade del Mare (Civitavecchia 6,9 milioni);
- lavori
per viabilità interna al porto (Cagliari 2,1 milioni);
- realizzazione
di una infrastruttura per rete in fibra ottica promossa dal Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto per lo scambio delle informazioni
nave-porto (Capitanerie/RAM 6,6 milioni).
Venti progetti riguardano il settore stradale e
intermodale (per complessivi 37,8 milioni €). Tra i progetti nel settore
stradale si segnalano:
- 2
progettazioni preliminari (ANAS) per l'ammodernamento degli svincoli del GRA
del nodo di Roma e per il by-pass urbano per il nodo di Palermo;
- 4
proposte per lo sviluppo di azioni pilota per servizi di ITS sui corridoi
nazionali stradali (Consorzio European ITS European Platform);
- 1
proposta per l'implementazione del servizio delle chiamate di emergenza E-Call;
- 2
proposte sul tema Eco-Driving e per l'implementanzione di un sistema di
gestione traffico centralizzato (ARCESE);
- 4
proposte degli interporti di Padova, Fernetti e Pordenone per potenziare
efficienza e capacità operativa dei terminal con forte impatto
sull'intermodalità nel traffico di lunga distanza;
- 1
studio internazionale per individuare le misure necessarie per trasformare gli
esistenti terminal intermodali localizzati lungo il corridoio Reno-Alpino in un
network di "Smart Hub" (SITI e UNIONTRAPORTI);
- 1
analisi sui corridoi doganali con l'obiettivo di accelerare le operazioni di
sdoganamento, preclearing, sportello unico, accessi controllati con
l'opportunità congiunturale dell'Expo 2015 di Milano con capofila la Regione
Liguria.
Il Decreto legge “Sblocca Italia” ha previsto all’articolo
3, una serie di disposizioni per consentire la continuità dei cantieri in corso
o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori,
destinando 3.890 milioni di euro al Fondo (cd. "sblocca cantieri")
istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per il periodo 2014-2020, la cui destinazione
avverrà con decreti interministeriali.
Il comma 12-bis, autorizza poi la spesa di 487.000
€ per il 2014 per il completamento degli interventi infrastrutturali di
viabilità stradale necessari a garantire l'integrale attuazione della
Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970
di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 riguardante
il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria
Cuneo-Breil-Ventimiglia.
Il comma 9-bis prevede poi una procedura per il finanziamento
in via prioritaria delle opere incluse nell'XI Allegato infrastrutture,
approvato dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano già state
precedentemente qualificate come opere strategiche. A tale proposito, per
un'analisi completa ed approfondimenti sui singoli interventi compresi nel
programma infrastrutture strategiche, si possono consultare le schede-opera
della banca dati SILOS (Sistema informativo Legge Opere Strategiche,
curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati), che fornisce dati e
informazioni riguardanti tutte le opere oggetto del Programma delle
infrastrutture strategiche (P.I.S.) di cui alla legge n. 443 del 2001
("legge obiettivo"). Le opere vengono poi analizzate nel Rapporto
annuale sulle infrastrutture strategiche curato dal Servizio Studi della Camera:
il 9° Rapporto
infrastrutture è stato presentato a marzo 2015.


 km.
km.
 il
corridoio scandinavo-mediterraneo è un asse nord-sud cruciale per
l'economia europea. Attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla Svezia
e passando attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, collega i principali
centri urbani e porti della Scandinavia e della Germania settentrionale ai
centri industrializzati di produzione della Germania meridionale, dell'Austria
e del Norditalia e quindi ai porti italiani e della Valletta. I progetti più
importanti di questo corridoio sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria
di base del Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il corridoio
raggiunge quindi via mare Malta passando dall'Italia meridionale e dalla Sicilia.
Il corridoio attraversa l’Italia per tutta la sua lunghezza, dal confine con
l’Austria fino a Palermo, e prevede anche il collegamento ferroviario Napoli-Bari;
il
corridoio scandinavo-mediterraneo è un asse nord-sud cruciale per
l'economia europea. Attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla Svezia
e passando attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, collega i principali
centri urbani e porti della Scandinavia e della Germania settentrionale ai
centri industrializzati di produzione della Germania meridionale, dell'Austria
e del Norditalia e quindi ai porti italiani e della Valletta. I progetti più
importanti di questo corridoio sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria
di base del Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il corridoio
raggiunge quindi via mare Malta passando dall'Italia meridionale e dalla Sicilia.
Il corridoio attraversa l’Italia per tutta la sua lunghezza, dal confine con
l’Austria fino a Palermo, e prevede anche il collegamento ferroviario Napoli-Bari;