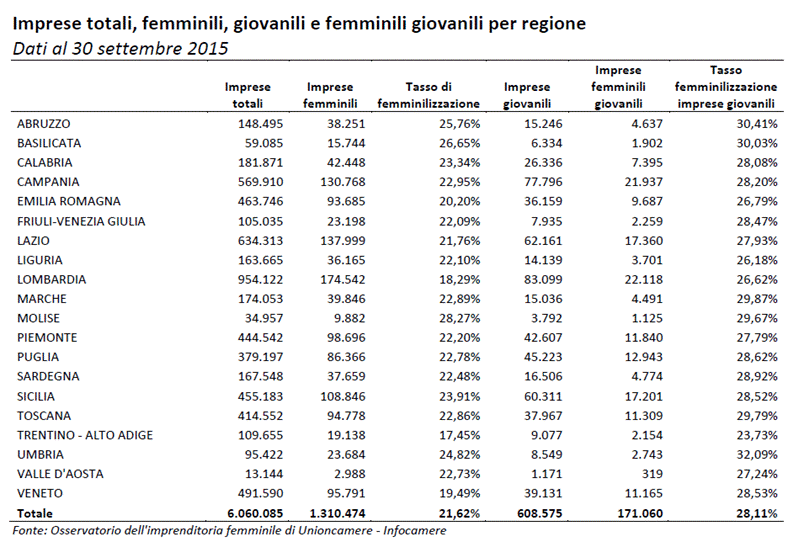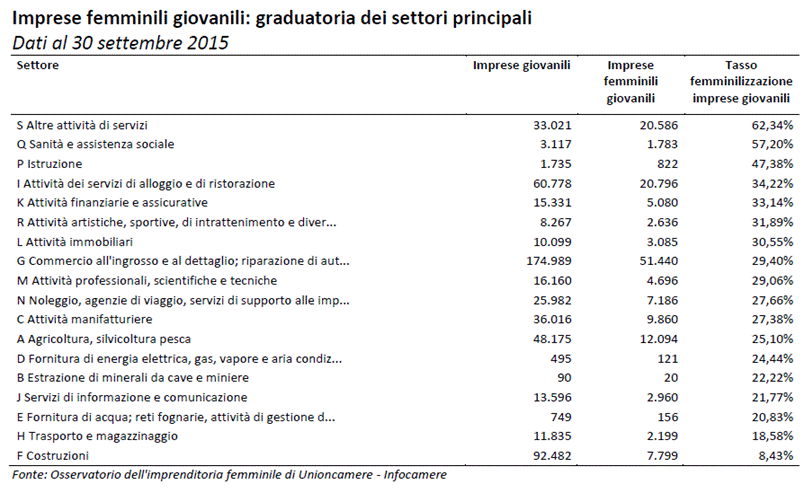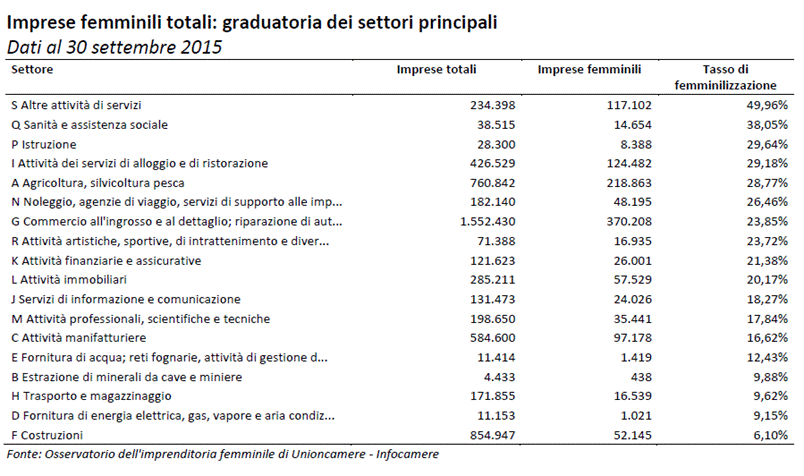Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
|
|---|
| Autore: |
Servizio Studi - Dipartimento lavoro
|
| Titolo: |
Occupazione femminile
|
| Serie: |
Documentazione e ricerche
Numero:
205
|
| Data: |
18/11/2015
|
| Organi della Camera: |
XI-Lavoro pubblico e privato
|
| Nota: |
Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale.
La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati
(ad es. presso la Biblioteca)
|
|
|
|
Camera dei deputati
|
|
XVII LEGISLATURA
|
|
|
|
|
|
|
|
Documentazione e ricerche
|
|
Occupazione
femminile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n. 205
|
|
|
|
|
|
|
|
18 novembre 2015
|
|
Servizio responsabile:
|
|
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro
( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte.
|
|
File:
LA0536.docx
|
Negli ultimi decenni
la condizione delle donne nel mercato
del lavoro in Italia è stata oggetto di numerosi interventi normativi volti
a riconoscere equiparazione dei diritti e maggiori tutele alle donne
lavoratrici (legata anche alla peculiarità delle diverse situazioni che sono
chiamate ad affrontare nel corso della loro vita lavorativa).
La Costituzione (art. 37) riconosce alla
lavoratrici gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione
riconosciuti al lavoratore, disponendo, inoltre, che le condizioni di lavoro
siano tali da consentire alla lavoratrice di adempiere alla sua funzione
familiare.
Tra i più
significativi provvedimenti organici in materia si ricorda, in primo luogo, il Testo unico per la tutela della maternità e
paternità (D.Lgs. 151/2001) che riconosce alla
madre lavoratrice una serie di prerogative volte a far sì che possa adempiere
al suo ruolo attraverso, tra l’altro, il riconoscimento: di congedi retribuiti;
del divieto di essere adibita a determinati lavori (posto a tutela della salute
sua e del bambino); di riposi giornalieri; di permessi per accudire i figli con
handicap; del divieto di licenziamento (dall’inizio della gravidanza fino al
termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un
anno di età del bambino); del diritto all’indennità di maternità anche in caso
di licenziamento o di dimissioni volontarie.
Successivamente, il Codice per le pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) ha eliminato ogni discriminazione basata
sul sesso in qualunque campo della vita. Nel campo dell’occupazione, il divieto
di discriminazione concerne, tra l’altro, l’accesso al lavoro, la progressione
di carriera e la retribuzione. Al fine di promuovere la rimozione di ogni ostacolo
alla realizzazione delle pari opportunità, si ricorda l’istituzione del “Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”, che opera nell’ambito della
competenza statale; e del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”,
istituito nelle singole amministrazioni pubbliche. Allo stesso scopo, è
prevista la nomina di una consigliera o un consigliere di parità a livello
nazionale, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta.
Infine, il D.Lgs. 5/2010 ha ulteriormente esteso la
nozione di discriminazione - comprendendovi anche, ad esempio, ogni trattamento
meno favorevole subito in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o di
paternità, nonché in conseguenza del rifiuto di atti di molestie o di molestie
sessuali - e ha inasprito le sanzioni previste in caso di inosservanza di
sentenze che accertano i comportamenti discriminatori di carattere collettivo.
Infine, un più recente
filone normativo riguarda le azioni
positive volte al raggiungimento della parità
di genere.
Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011)
Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a
favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione
giovanile e delle donne, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno
2015.
È stato altresì,
aumentato l’importo delle deduzioni IRAP per i lavoratori a tempo
indeterminato, prevedendone l’incremento per i lavoratori di sesso femminile (nonché per quelli di età inferiore
ai 35 anni).
Riforma Fornero (L. 92/2012)
La legge di riforma
del mercato del lavoro (cd. Riforma Fornero) introduce due tipi di incentivi per favorire l’occupazione
femminile.
Il primo (dal 2013) consiste
nella riduzione, nella misura del 50%, dei contributi a carico del datore di
lavoro (per un massimo di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato e di 18
mesi per quelle a tempo indeterminato) per assunzione
di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se
residenti in regioni svantaggiate, o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Il secondo (previsto,
in via sperimentale, per il periodo 2013-2015), volto a favorire il rientro al lavoro dopo la gravidanza, riconosce alla
madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione
di voucher (pari a 600 euro mensili) per
l'acquisto di servizi di babysitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
Conciliazione
vita-lavoro
Nell'attuale
legislatura, le politiche in favore delle donne in materia di lavoro
sono riconducibili in particolare a quanto previsto da uno dei decreti
legislativi attuativi del Jobs act, relativo alla conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro (d.lgs. n.80/2015).
Il decreto contiene
misure dirette, in particolare, alla tutela della maternità e a favorire
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire
adeguato sostegno alle cure parentali.
Di seguito, le
principali novità introdotte:
§ il congedo di maternità (obbligatorio e
retribuito della durata complessiva di cinque mesi):
-
in caso di parto anticipato i giorni di
maternità obbligatoria e non goduti prima del parto possono essere aggiunti a
quelli successivi alla nascita, anche se si supera il previsto limite di 5
mesi;
-
in caso di ricovero del neonato si può chiedere
la sospensione del congedo (una sola volta per ogni figlio) e goderne dalla
data di dimissioni del neonato;
§ il
congedo di paternità (ossia il
diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del
congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla
lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, o di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre) è riconosciuto anche se la madre è una lavoratrice
autonoma e, in caso di adozione internazionale, il congedo previsto per la
lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero può essere utilizzato dal
padre anche se la madre non è una lavoratrice;
§ il
congedo parentale (astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore per un limite
complessivo massimo di 10 mesi) viene esteso dall'ottavo al dodicesimo anno di
vita del bambino e la fruizione può essere anche su base oraria. Lo stesso
termine si applica anche in caso di adozione e affidamento e di prolungamento
del congedo parentale (per un periodo massimo non superiore a tre anni), in
presenza di figlio minore portatore di handicap. L’indennizzo (nella misura del
30% per un periodo massimo complessivo di 6 mesi) viene esteso dal terzo al
sesto anno di vita del bambino.
§ l’indennità di maternità (pari all’80%
della retribuzione) viene corrisposta:
-
anche nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro per giusta causa, derivante da colpa grave della lavoratrice, che si
verifichi durante i periodi di congedo di maternità;
-
alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata
INPS anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del
committente e, in caso di adozione o affidamento, per i 5 mesi successivi
dall’ingresso del minore in famiglia
-
alle lavoratrici autonome anche nel caso di
adozione o affidamento, alle stesse condizioni previste per le altre
lavoratrici;
§ tra le lavoratrici
che non possono essere obbligate a svolgere lavoro notturno, viene
inserita anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei
primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
dodicesimo anno di età (o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il
lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa);
§ in
via sperimentale, per il triennio 2016-2018, si prevede che il 10% del Fondo per la contrattazione di
secondo livello sia destinato alla promozione
della conciliazione tra lavoro e vita privata.
Legge di
riforma della P.A. (L. 124/2015)
Anche la
legge delega di Riforma della P.A. (L. 124/2015) ha introdotto alcune disposizioni
volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro.
In
particolare, in tema di passaggio di
personale tra amministrazioni diverse, dispone:
§
che il genitore,
dipendente di amministrazioni pubbliche, con figli minori fino a tre anni
di età può chiedere di essere assegnato (per un periodo non superiore a tre
anni, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di
provenienza e destinazione) ad una sede presente nella stessa provincia o
regione nella quale lavora l'altro genitore. L'eventuale dissenso deve essere
motivato.
In tema di cure
parentali, dispone che le amministrazioni pubbliche:
§ adottino
misure organizzative per l'attuazione del telelavoro
e di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali;
§ stipulino
convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzano, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto
alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica
Dimissioni
in bianco
Per contrastare
la pratica (riguardante prevalentemente le lavoratrici) delle cd. dimissioni "in bianco",
consistente nel far firmare le dimissioni al lavoratore al momento
dell'assunzione (in bianco, appunto) e quindi nel momento in cui la sua posizione
è più debole, il decreto legislativo n.151/2015 (attuativo del Jobs act) modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e
della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevedendo che le
dimissioni sono valide solo se redatte in modalità telematica su appositi
moduli, resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(attraverso il sito www.lavoro.gov.it).
Violenza
di genere
Il
decreto legislativo 80/2015 (attuativo del Jobs act)
ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere,
riconosciuto alle lavoratrici dipendenti,
pubbliche e private (con esclusione del lavoro domestico) e alle lavoratrici
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite in
percorsi certificati di protezione relativi alla violenza di genere, le quali possono
astenersi dal lavoro, per motivi legati al suddetto percorso, per un periodo
massimo di tre mesi.
Inoltre, la legge
delega di riforma della P.A. dispone che la dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici
percorsi di protezione debitamente certificati, può chiedere il trasferimento
ad altra amministrazione pubblica presente in un comune diverso da quello di
residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza che, entro
quindici giorni, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
A.C. 2014
La
proposta di legge C. 2014 (Mosca ed altri), di cui la XI Commissione (Lavoro) della
Camera ha avviato l’esame il 4 novembre 2015, detta norme per promuovere forme
di lavoro caratterizzate da una elevata flessibilità, soprattutto con
riferimento all'orario e alla sede di lavoro (cd. smart working), allo scopo di incrementare la
produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro.
Disegno di legge di stabilità 2016
L'articolo
14, comma 2, del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111 -
attualmente all'esame del Senato), prevede l’istituzione, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento
ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una
dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dal 2017.
L’articolo
12 del disegno di legge di stabilità, al fine di dare impulso allo sviluppo del
welfare aziendale, prevede che
determinati benefici (servizi di assistenza ad anziani, servizi di istruzione,
ecc.), definiti attraverso la contrattazione aziendale ed erogabili dal datore
di lavoro anche sotto forma di voucher spendibili sul mercato, godano di un
trattamento fiscale molto favorevole.
Secondo i dati più recenti (30
settembre 2015), le imprese femminili esistenti sono un milione e 310 mila e
rappresentano il 21,62% del totale delle imprese italiane.
In
molti segmenti, tuttavia, la partecipazione femminile è ben più alta: sfiora o
supera il 40% nelle agenzie di viaggio, negli altri servizi di prenotazione tra
cui quelli che riguardano le guide turistiche, negli alloggi per le vacanze,
nelle attività di biblioteche e archivi. Le imprese femminili sono inoltre più
o meno un terzo delle attività dei tour operator, degli alberghi, delle
forniture per catering, dei bar, delle attività dei musei, della gestione di
parchi divertimento e parchi tematici e di stabilimenti balneari. Superano
abbondantemente il 25% nella direzione dei campeggi, nei ristoranti, nelle
mense, nella gestione di palestre e di altre attività ricreative e di
divertimento.
La
vocazione all’accoglienza e alla cura, così tipica dell’universo femminile, si
riflette d’altronde anche in altri settori ad alto tasso di partecipazione
delle donne d’impresa: nell’assistenza sociale non residenziale, nei servizi di
assistenza sociale residenziale, in cui il tasso di femminilizzazione del
tessuto produttivo nazionale segna valori superiori al 40%. E sfiora
addirittura la metà delle imprese totali che operano nelle altre attività dei
servizi, in particolare quelli legati alla persona.
Come mostra l’Osservatorio per
l’imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCamere sulla base dei dati al 30 settembre scorso, si
rileva forte anche l’imprenditoria femminile giovanile. Le imprenditrici under
35 sono infatti, in percentuale, sopra la media delle imprese femminili
complessivamente intese: quasi un’impresa su tre tra quelle di under 35 (poco
meno di 609 mila) è un’impresa femminile. Complessivamente si tratta di oltre
171 mila imprese, pari al 28,11% del totale delle imprese giovani.
Tra le imprese femminili guidate da
under 35 si segnalano, innanzi tutto le oltre 20 mila giovani imprese femminili
che si occupano prevalentemente di servizi alla persona e le 1.800 attività
legate al mondo della sanità e dell’assistenza.
Sono questi i due ambiti in cui il peso
della presenza femminile sul totale delle imprese è maggiore, tanto nel caso
dell’universo complessivo delle capitane d’azienda, quanto in quello delle
giovani imprenditrici, dove addirittura le imprese guidate da donne sono ben
oltre la metà delle attività giovanili totali. Sempre restando nel solco della
tradizione, le imprenditrici under 35 guidano quasi la metà delle iniziative
giovanili nel settore dell’istruzione e rappresentano oltre un terzo delle
giovani imprese che operano nel turismo e nella ristorazione.
Accanto a questi settori “tradizionali”
va rilevato quello delle attività finanziarie e assicurative, ad esempio, in
cui le 5mila imprenditrici under 35 sono oltre il 33% delle giovani imprese
italiane, o le 2.600 imprese del settore artistico, sportivo e di
intrattenimento (32%), o le oltre 3mila attività immobiliari (30%) o ancora le
4.600 attività professionali, scientifiche e tecniche (29%).
Sotto
il profilo territoriale Molise, Basilicata e Abruzzo sono da tempo le regioni
in cui l’incidenza delle attività guidate da donne sul totale delle imprese è
maggiore. Tali regioni guidano infatti
la classifica per tasso di femminilizzazione dell’economia, con valori compresi
tra il 25 e il 28%. Sul fronte opposto il Trentino Alto Adige, la Lombardia e
il Veneto, in cui la presenza di donne di impresa è inferiore al 20%
Nella
classifica riferita all’universo delle imprese under 35, invece, la prima
posizione è occupata dall’Umbria, con un tasso di femminilizzazione delle
imprese giovanili del 32%. A seguire, Abruzzo e Basilicata (dove le imprese di
giovani donne sul totale delle iniziative di under 35 sono il 30%), quindi, le
Marche, quarta in questa particolare classifica ma solo ottava in quella
riferita al totale delle imprese. Da
segnalare il dato del Veneto: le imprese femminili guidate da giovani under 35
superano il 28% mentre il totale delle imprese femminili non raggiunge il 20%
del totale delle imprese complessivamente intese.
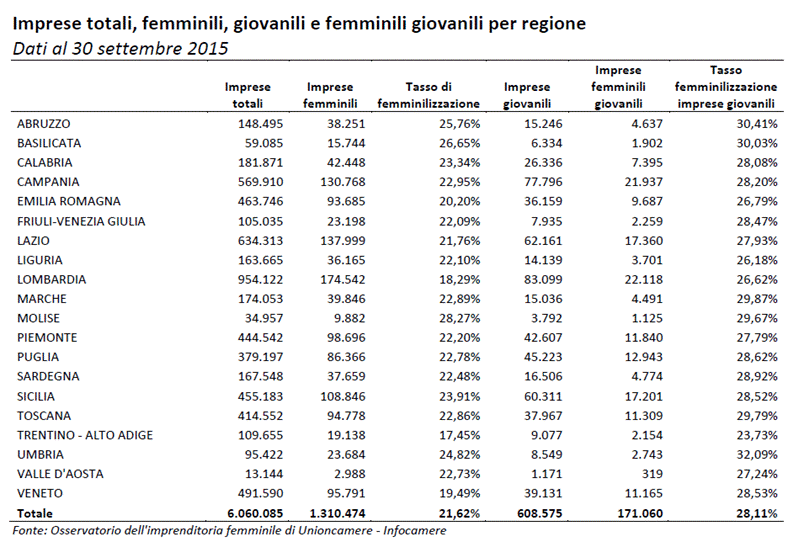
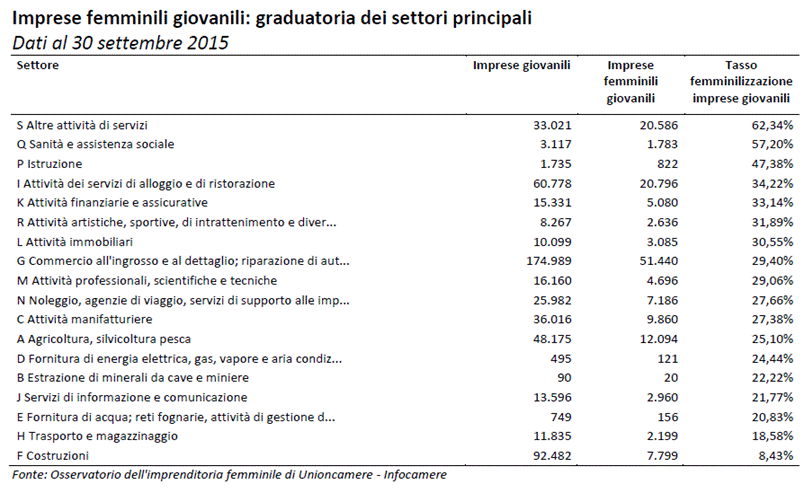
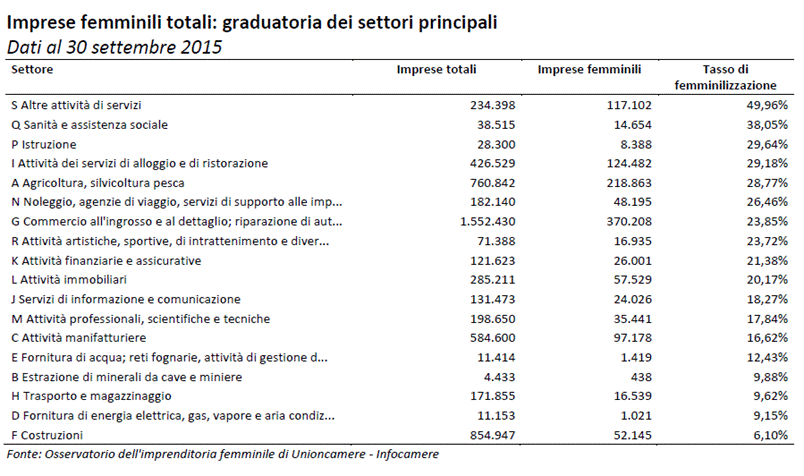
La prima
disciplina in tema di imprenditoria femminile è rappresentata dalla legge n.
215/1992, recante Azioni positive per l'imprenditoria femminile. Tale disposizione, che si prefiggeva l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza
sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e
imprenditoriale, è stata per oltre 20 anni, pur con interventi di
aggiornamento, il riferimento fondamentale in tema di sostegno alle imprese
femminili. Con l'entrata in
vigore del Codice delle pari opportunità nel 2006, oggi vigente, decreto
legislativo n. 198 del 2006, la legge n.
215/1992 è stata abrogata. Tuttavia molti dei principi e delle disposizioni
sostanziali in essa contenute sono state riportate nel codice medesimo, e,
anch’esse, successivamente aggiornate.
L'articolo 52 del
decreto legislativo n. 198 del 2006, fissa i principi generali cui si ispirano
le disposizioni del capo II del Codice, riproducendo le disposizioni dell'art.
1, commi 1 e 2, della L. 215/1992, per promuovere l'uguaglianza e le pari
opportunità tra uomini e donne nell'ambito dell'attività economica e imprenditoriale
indicando come obiettivi quelli di:
a) favorire la creazione e lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e
qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese
a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e
la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a
conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi
dei diversi settori produttivi.
L'articolo 53
individua i soggetti cui si rivolgono i principi in materia di azioni a favore
dell'imprenditoria femminile, come previsto dall'art. 2, comma 1, della
precedente legge 215/1992. In particolare:
- per le
imprese individuali: il titolare deve essere una donna;
- per le
società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non
inferiore al 60% della compagine sociale;
- per le società
di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per
almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono
essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.
L'articolo 54
riproduce le disposizioni della legge sull'imprenditoria femminile che
prevedono l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria (art. 3, co. 1, L. 215/1992).
A partire
dall’anno 2003 si è applicato il disposto dell'art. 72 della L. 289/2002
(finanziaria 2003) e del DM 2 novembre 2004 in base al quale il contributo
previsto in c/capitale sulle risorse di cui al Fondo nazionale per lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile originariamente previsto dagli articoli 5 e 6 del
DPR 314/2000, calcolato secondo le intensità massime consentite dalla vigente
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, viene concesso per il 50%
sotto forma di contributo in c/capitale e per il restante 50% sotto forma di
finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50% annuo. L'accesso alle
agevolazioni è consentito ai progetti che prevedono un investimento complessivo
ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.
Gli aiuti devono
essere riservati alle sole piccole imprese, non devono superare gli importi
fissati dalla disciplina comunitaria ed è stata esclusa la possibilità di
cumulo con agevolazioni previste da altre leggi.
Infine, l'art. 55
del codice prevede l'invio da parte del Ministero delle attività produttive di
una relazione annuale al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione
dei principi del Capo II del Codice.
Le funzioni di
competenza statale attribuite all'ex Ministero delle attività produttive in
materia di interventi a favore dell'imprenditoria femminile dalla legge 25
febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21-22 (ora previste dal DPR 101 del
2007) e 52-55 del citato Codice sono
assegnate (ai sensi della lettera g) del comma 19, art. 1, del D.L. 181/2006)
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con il D.L. 145/2013, c.d. Destinazione
Italia (convertito in legge 9/2014) si è
inteso riformare la disciplina degli incentivi all'imprenditorialità, con
misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso
migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in
prevalenza da giovani e da donne. Gli incentivi sono applicabili in
tutto il territorio nazionale: viene infatti soppressa la disposizione che ne
limitava l'applicazione alle aree svantaggiate del Paese. Durante l'esame
parlamentare è stata specificamente destinata per gli interventi a favore delle
imprese femminili una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo
di garanzia PMI alla Sezione
speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
pari opportunità" istituita presso il medesimo Fondo (articolo 2, comma
1-bis).
La Sezione
Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità" è riservata alle imprese a prevalente partecipazione
femminile. La Sezione Speciale è stata istituita con convenzione del 14 marzo
2013 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sottoscritta ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 26
gennaio 2012. La dotazione iniziale è stata pari a 10 milioni di euro, da
impiegare per la compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni
di garanzia ammissibili, con una ripartizione del 50% tra le risorse del Fondo
e quelle della Sezione Speciale che, di fatto, può contare su una dotazione
finanziaria complessiva di 20 milioni di euro. Nell'ambito della Sezione
Speciale, una quota pari al 50% della dotazione è riservata alle nuove imprese.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2013 sono
state inoltre introdotte modalità semplificate di accesso. Per quanto riguarda
i benefici, essi consistono nella concessione di mutui agevolati
per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di otto
anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa
ammissibile ai sensi della normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina
previgente, la principale novità consiste nella soppressione dei contributi
a fondo perduto. Scompare inoltre dalla tipologia di benefici concedibili
il riferimento all'assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti
e all'attività di formazione funzionale alla realizzazione del progetto.
Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti
caratteristiche:
- società
cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al
60% da donne
- società di
capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore
ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti
per almeno i due terzi da donne
- imprese
individuali gestite da donne.
Per approfondimenti si veda il
link http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html
Agevolazioni riservate a
micro e piccole nuove imprese a partecipazione giovanile o femminile.
Di recente è stato pubblicato il D.M. 8
luglio 2015, n. 140 (Regolamento
recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) del Ministero
dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze), che regola i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni
riservate a micro e piccole nuove imprese a partecipazione giovanile o
femminile.
I programmi di investimento
saranno agevolati con un finanziamento a tasso zero, a copertura del 75% delle
spese ammissibili: i progetti finanziabili dovranno essere caratterizzati da
elementi come l’innovatività e la capacità di sostenere lo sviluppo di settori
legati all’imprenditorialità giovanile, primi tra tutti la filiera
turistico-culturale e l’innovazione sociale. Le agevolazioni sono gestite da Invitalia. Per approfondimenti si veda la pagina dedicata.
La legge 12 luglio
2011, n. 120, con lo scopo di tutelare la parità di genere, intende
riequilibrare a favore delle donne l'accesso agli organi apicali delle società
quotate. A tal fine è previsto un “doppio binario” normativo:
§ per
le società non controllate da Pubbliche Amministrazioni, la disciplina in
materia di equilibrio di genere è contenuta nelle disposizioni di rango
primario. In sintesi, gli statuti e gli atti costitutivi delle società devono
assicurare l'equilibrio tra i generi negli organi di vertice delle società
quotate, con una specifica riserva di posti in favore del genere meno
rappresentato;
§ per
le società a controllo pubblico, accanto ai principi generali della legge, la
normativa di dettaglio è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. In
particolare, anche per le società pubbliche non quotate gli organi di
amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, sono costituiti
con modalità tali da garantire una riserva di posti per il genere meno rappresentato.
Sono tuttavia previste alcune peculiarità. In particolare, se per la nomina
degli organi sociali è previsto il meccanismo del voto di lista,non
è rispettato il criterio di riparto tra generi, ove le liste presentino un
numero di candidati inferiore a tre.
Nell'ordinamento
italiano si rinvengono diverse norme, sia nazionali che regionali, finalizzate
alla promozione della partecipazione delle donne alla politica e dell'accesso
alle cariche elettive, emanate in attuazione degli articoli 51, primo comma, e
117, settimo comma, della Costituzione. In questo settore, peraltro, il
Parlamento negli ultimi anni ha dato sempre maggiore attenzione al fenomeno,
approvando importanti riforme aventi come obiettivo la promozione
dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza elettorale.
La stessa riforma
costituzionale attualmente in discussione introduce all’art. 55 Cost. una disposizione in base alla quale "le leggi
che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio
tra donne e uomini nella rappresentanza".
A livello nazionale, il nuovo sistema elettorale della Camera dei
deputati (cd. Italicum),
approvato con la legge n. 52 del 2015 e che troverà applicazione dal 1° luglio
2016, detta alcune norme in favore della rappresentanza di genere per le
elezioni della Camera (non viene modificato il sistema elettorale del Senato,
in attesa della riforma costituzionale all'esame del Parlamento, che dovrebbe
superare la natura elettiva di questo organo).
Il nuovo sistema
elettorale introduce, a pena di inammissibilità, un obbligo di rappresentanza
paritaria dei due sessi nel complesso delle candidature circoscrizionali di
ciascuna lista (quindi, a livello regionale) e prevede che, nella successione
interna delle singole liste nei collegi, i candidati sono collocati secondo un
ordine alternato di genere (quindi 1-1). Inoltre è stabilito, a pena di
inammissibilità della lista, che nel numero complessivo dei capolista nei
collegi di ogni circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di
candidati dello stesso sesso. Infine, è introdotta la c.d. doppia preferenza di
genere, ossia, in caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve
scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità
della seconda preferenza.
Anche per le elezioni del Parlamento europeo sono
state introdotte nuove disposizioni volte a rafforzare la rappresentanza di
genere con la legge 22 aprile 2014, n. 65. A partire dal 2019, sono state
introdotte la composizione paritaria delle liste dei candidati e la c.d.
‘tripla preferenza di genere', in base alla quale gli elettori possono
esprimere fino a tre preferenze, purché riguardino candidati di sesso diverso,
sia nel caso di due che di tre preferenze espresse.
A livello comunale, la
legge 23 novembre 2012, n. 215 prevede strumenti diversi a seconda delle
dimensioni del comune.
Per l'elezione dei consigli comunali nei
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la legge contempla una
duplice misura volta ad assicurare il riequilibrio di genere: da un lato, nelle
liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore a due terzi (cd. quota di lista).
Dall’altro, la cd.
doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due
preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento
della seconda preferenza. Resta comunque ferma la possibilità di esprimere una
singola preferenza.
Per i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti è comunque previsto che nelle liste dei
candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Tale disposizione
ha particolare rilievo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
nei quali non si applica la quota di lista.
Ulteriori disposizioni
sono previste a livello di città metropolitane e province a seguito della
riforma prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio) che ha eliminato l'elezione diretta dei consigli
provinciali.
I consigli metropolitani (organi delle nuove città metropolitane) ed
i consigli provinciali sono divenuti
organi elettivi di secondo grado; l'elettorato attivo e passivo spetta ai
sindaci ed ai consiglieri comunali dei rispetti territori. L'elezione di questi
due organi avviene con modalità parzialmente differenti, che comunque prevedono
l'espressione di un voto di preferenza e la ponderazione del voto. Ai fini di
promuovere la rappresentanza di genere, nelle liste nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all'unità superiore per i candidati del sesso meno rappresentato, a pena di
inammissibilità. Tale disposizione troverà applicazione di fatto, dalle
elezioni del 2018. Non è prevista invece la possibilità della doppia preferenza
di genere, in quanto ritenuta incompatibile con il sistema del voto ponderato.
Anche a livello regionale, dopo la modifica
degli articoli 122 e 123 della Costituzione, tutte le regioni che hanno
adottato norme in materia elettorale hanno introdotto disposizioni specifiche
per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione
dell'art. 117, settimo comma, Cost.
Le misure introdotte
sono diverse e sono prevalentemente incentrate sulle 'quote di lista', ossia
sull'obbligo di inserire nelle liste di candidati una quota minima di candidati
del genere meno rappresentato, variabile tra un terzo e la metà. Le quote di
lista sono applicate in sistemi elettorali proporzionali, con premio di
maggioranza e con voto di preferenza. Alcune regioni hanno messo a punto lo
strumento ulteriore della ‘doppia preferenza di genere', misura adottata per la
prima volta dalla regione Campania e successivamente ripresa dalla legge
elettorale per i comuni e da altre leggi elettorali regionali.
Si segnala, infine,
che nella legislatura in corso il Parlamento ha approvato la legge 15 febbraio
2016, n. 20, che introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le
Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale,
l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra
donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
A tal fine, modifica
la legge n. 165/2004, che - in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione - reca per l'appunto i principi fondamentali concernenti il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei
consiglieri regionali. Con le modifiche introdotte, la legge nazionale non si
limita a prevedere tra i principi, come stabilito finora, la "promozione
della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso
la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere
sottorappresentato alle cariche elettive", ma indica anche le specifiche
misure adottabili, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali per
la scelta della rappresentanza dei consigli regionali.