Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
esame di atti e documenti dell’unione europea
Il pacchetto dell’Unione dell’energia
Com(2015)80
Com(2015)81
Com(2015)82
n. 32
27 marzo 2015
| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
|---|---|---|---|
| Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
| Titolo: | Il pacchetto dell'Unione dell'energia Com(2015)80 Com(2015)81 Com(2015)82 | ||
| Serie: | Bollettino commissioni Numero: 32 | ||
| Data: | 27/03/2015 | ||
| Descrittori: |
| ||
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
esame di atti e documenti dell’unione europea
Il pacchetto dell’Unione dell’energia
Com(2015)80
Com(2015)81
Com(2015)82
n. 32
27 marzo 2015
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)
I capitoli ‘Strategia energetica nazionale’ e ‘Governance dell’energia tra Autorità e Governo’ sono stati curati dal Servizio Studi, Dipartimento Attività Produttive (' 066760.9574)
________________________________________________________________
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I N D I C E
· La politica energetica dell’UE
· Il pacchetto dell’Unione dell’energia
· Strategia quadro dell’Unione dell’energia
· Interconnessione della rete elettrica
· Strategia energetica nazionale (a cura del Servizio Studi)
· Governance dell’energia tra Autorità e Governo (a cura del Servizio Studi)
|
Tipo di atto |
Comunicazioni |
|
Data di adozione |
25 febbraio 2015 |
|
Settori di intervento |
Politica energetica, Politica dell’ambiente |
|
|
|
|
Assegnazione |
6 marzo 2015 --- Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) il |
|
Segnalazione da parte del Governo |
5 marzo 2015 |
Il consumo interno lordo di energia nell'UE-28 ha mostrato nel periodo 1990-2012 un andamento tendenzialmente stabile: nel 2012 è stato inferiore dell'1% rispetto al 2011 (circa 70,5 milioni di terajoule - TJ).
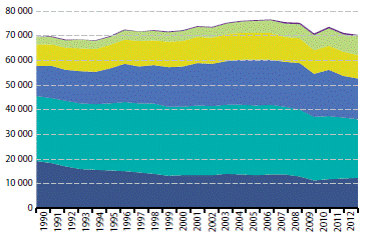 EU-28: consumo interno lordo di energia, 1990-2012 (1.000 TJ)
EU-28: consumo interno lordo di energia, 1990-2012 (1.000 TJ)
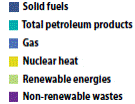 |
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
A fronte di tale andamento, si riscontra una crescita molto forte del consumo di energia (e, conseguentemente, delle emissioni di CO2) da parte delle economie più sviluppate.
Totale consumo finale di energia – 1971-2012 (MTOE)
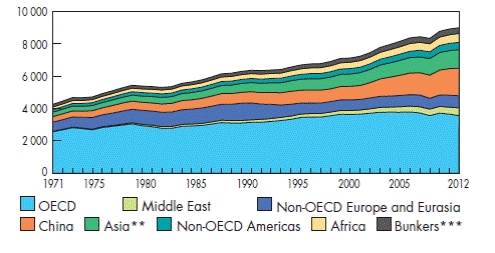 |
**Asia esclusa Cina
***Inclusi l'aviazione internazionale e i trasporti marittimi internazionali
Fonte: Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), Key World Energy Statistics, 2014
Le emissioni di gas ad effetto serra da parte delle economie più sviluppate hanno avuto il seguente andamento nel periodo 1990-2012:
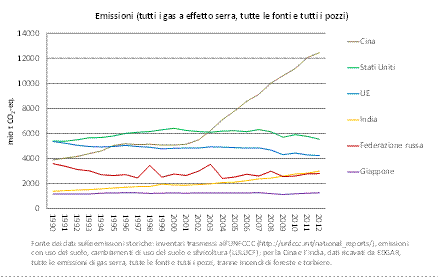 |
L’UE ha conseguito risultati generalmente valutati positivamente nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, come si evince anche dal confronto internazionale.
Emissioni di gas serra (escluso LULUCF- tonnellate CO2 equivalenti – migliaia)
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
UE 28 |
4.646,7 |
4.756,1 |
4.607,7 |
4.548,3 |
|
Germania |
912,6 |
946,3 |
928,6 |
939,0 |
|
Spagna |
359,6 |
347,1 |
345,8 |
340,8 |
|
Francia |
509,2 |
516,4 |
490,0 |
490,2 |
|
Italia |
490,3 |
499,8 |
487,4 |
461,1 |
|
Regno Unito |
593,3 |
609,6 |
565,7 |
582,8 |
|
Fonte: Agenzia europea per l’Ambiente, marzo 2015 |
||||
Emissioni di gas serra (escluso LULUCF- tonnellate CO2 equivalenti – migliaia) – 2011
|
tonnellate CO2 equiv – migl. – 2011 |
|
|
Giappone |
1.307,7 |
|
Russia |
2.320,8 |
|
Stati Uniti |
6.665,7 |
|
Brasile |
862,8 |
|
Cina |
7.465,9 |
|
India |
1.523,8 |
|
Fonte: Eurostat, The EU in the world 2014 |
|
La struttura del consumo lordo per il 2012 mostra ancora un peso preponderante del consumo di petrolio (34%), seguito dal gas (23%), dai combustibili fossili (17%). Il nucleare ha raggiunto la quota del 14% e le fonti di rinnovabili l’11%.
In questo quadro, è interessante notare come il ricorso ai combustibili fossili si è ridotto, tra il 1990 e il 2012, del 10% (dal 27% al 17%) mentre, nel medesimo periodo, il consumo di energia da fonti rinnovabili è aumentato dal 4% all’11%. La composizione dei consumi varia tra i vari Stati membri a seconda del tipo e della quantità delle risorse naturali disponibili, della struttura dell'economia e dei sistemi energetici.
EU-28: quote nazionali delle fonti di energia nel consumo interno lordo, 2012
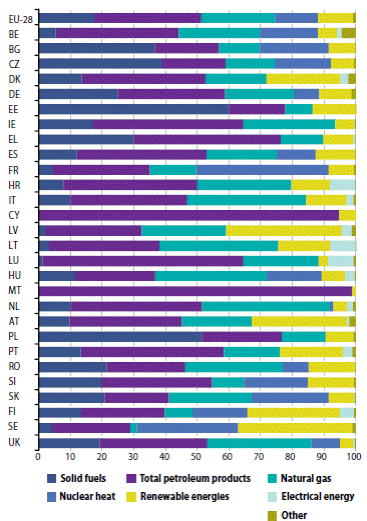 |
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
Interessante è il notevole sviluppo delle energie rinnovabili nel medesimo periodo 1990-2012.
EU-28: produzione di energia da fonti rinnovabili (1990-2012)
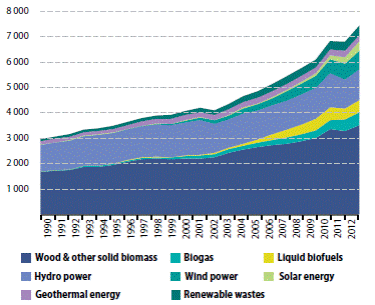
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
Il risparmio energetico è uno degli obiettivi della Strategia Europa 2020 (in tale anno, il consumo di energia primaria dovrà essere pari a 1.483 Mtoe).
EU-28: risparmio energetico 2005-2012 (%)
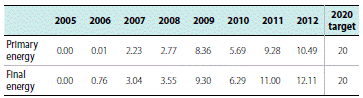 |
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico è funzionale anche alla necessità per l’Unione europea di raggiungere un maggior grado di indipendenza energetica, vista la relativa scarsità di risorse energetiche proprie.
La figura che segue illustra l’andamento delle importazioni dei più importanti prodotti energetici nel periodo 1990-2012.
UE-28, importazioni di prodotti energetici, 1990-2012 (1.000 TJ)
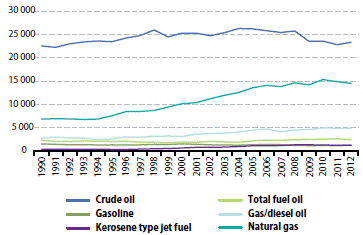
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
La principale fonte delle importazioni europee è la Russia (per tutti i tipi di prodotti: carburanti solidi, gas naturale e petrolio greggio), anche se, nel tempo, il grado di dipendenza europeo da tale paese è andato ridimensionandosi.
|
UE -28, importazioni di prodotti energetici dalla Russia, 2002-2012 (% totale importazioni extra UE) |
||||||
|
|
2002 |
2005 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Combustibili solidi |
13.1 |
23.7 |
30.0 |
26.9 |
26.2 |
25.9 |
|
Petrolio greggio |
29.5 |
22.9 |
33.5 |
34.7 |
34.8 |
33.7 |
|
Gas naturale |
45.2 |
40.7 |
33.0 |
29.5 |
31.6 |
32.0 |
|
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014 |
||||||
I dati dimostrano che, sebbene sia stato fatto uno sforzo per diversificare il grado di dipendenza dell’UE da un singolo paese esportatore, la dipendenza energetica complessiva dell’UE è rimasta, nel periodo 2002-2012, sostanzialmente stabile.
|
Dipendenza energetica totale, 2009-2012 (%) |
||||
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
UE 28 |
53.7 |
52.7 |
53.9 |
53.4 |
|
UE 18 |
63.8 |
62.1 |
62.2 |
61.0 |
|
Germania |
61.0 |
60.0 |
61.5 |
61.1 |
|
Spagna |
79.1 |
76.8 |
76.4 |
73.3 |
|
Francia |
51.0 |
49.1 |
48.7 |
48.1 |
|
Italia |
83.3 |
84.3 |
81.8 |
80.8 |
|
Regno Unito |
26.3 |
28.3 |
36.2 |
42.2 |
|
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014 |
||||
Allo scopo di ricondurre ad unità i diversi filoni di intervento in atto, la Commissione, lo scorso 25 febbraio, ha presentato il Pacchetto Unione dell’energia.
Si tratta di un insieme articolato di proposte che ha lo scopo di integrare la politica energetica e la politica ambientale dell’Unione per il raggiungimento di obiettivi successivi al 2020.
In particolare, la cornice entro cui si inseriscono tutte le iniziative del pacchetto è costituita dalla comunicazione che delinea una “Strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici” (COM(2015)80), a cui è allegata la tabella di marcia verso l’Unione dell’energia che reca l’elenco delle proposte che la Commissione intende presentare per la messa in atto della Strategia, con l’indicazione dei tempi presunti di presentazione. Il pacchetto si compone, inoltre, di una comunicazione riguardante il raggiungimento dell'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020 (COM(2015)82) e di un’ulteriore comunicazione "Il Protocollo di Parigi” (COM(2015)81) preparatoria della Conferenza di Parigi del dicembre 2015, in materia di lotta ai cambiamenti climatici.
Di seguito, si dà conto sinteticamente dei contenuti di ciascuna proposta facente parte del pacchetto.
La Strategia sulla sicurezza energetica (COM(2014)330), presentata il 28 maggio 2014 dalla Commissione, aveva messo in luce la vulnerabilità dell’Unione europea alle crisi esterne di approvvigionamento energetico e ha posto l’esigenza di scelte per ridurre la dipendenza europea da determinati combustibili, fornitori e rotte di approvvigionamento.
Basandosi sulle premesse poste da tale strategia, la Comunicazione sull’Unione dell’Energia identifica i punti deboli del sistema energetico europeo:
· coesistenza di 28 distinti quadri nazionali, tanti quanti sono gli Stati membri;
· cattivo funzionamento del mercato al dettaglio;
· invecchiamento delle infrastrutture;
· esistenza di isole energetiche.
In questo quadro, ad avviso della Commissione, anche la scelta di proseguire sulla strada già tracciata comporterebbe costi economici, sociali e ambientali, soprattutto derivanti dalla frammentazione dei mercati nazionali dell'energia. E’ pertanto opportuno adottare nuove politiche, volte a potenziare gli investimenti, approfittando anche dell’opportunità offerta dal calo dei prezzi dei prodotti petroliferi.
La strategia dell'Unione dell'energia (COM(2015)80) si articola in cinque “dimensioni”, strettamente interconnesse e che si rafforzano a vicenda, intese a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell'approvvigionamento energetico:
· sicurezza energetica, solidarietà e fiducia;
· piena integrazione del mercato europeo dell'energia;
· efficienza energetica per contenere la domanda;
· decarbonizzazione dell'economia;
· ricerca, innovazione e competitività.
I fattori chiave della sicurezza energetica sono, ad avviso della Commissione, il completamento del mercato interno dell'energia e un consumo energetico più efficiente. Il primo passo per il raggiungimento dell’obiettivo di mettere in sicurezza il sistema energetico europeo è la diversificazione dell'approvvigionamento, con riferimento alle fonti di energia, ai fornitori e alle rotte per il trasporto dei combustibili.
Le priorità identificate dalla Commissione per la diversificazione delle forniture di gas, il corridoio meridionale di trasporto del gas, di cui occorre accelerare i lavori, in vista dell''importazione del gas dai paesi dell'Asia centrale; la creazione nel Nord Europa di hub di gas liquefatto con più fornitori. La Commissione auspica che il modello sia replicato anche in Europa centrale e orientale, nonché nell'area mediterranea, dove è in procinto la costruzione di un hub gasiero mediterraneo, per al cui collocazione si sono candidate l’Italia e la Spagna (ma anche la Bulgaria).
Per fronteggiare le crisi che comportano la riduzione del flusso di gas in arrivo in Europa attraverso i gasdotti esistenti, la Commissione sta valutando l’elaborazione di un'ampia strategia per il GNL (gas naturale liquefatto), in cui sarà valutatato il potenziale di stoccaggio di gas in Europa, nonché il quadro normativo necessario per garantire una quantità sufficiente di gas stoccato per l'inverno. Il maggiore ricorso al GNL potrebbe contribuire, ad avviso della Commissione, a uniformare maggiormente i prezzi del gas naturale a livello globale.
Con l’obiettivo di diversificare gli approvvigionamenti energetici dell’Unione, la Commissione auspica anche un aumento dell’energia prodotta all’interno dell’Unione, con riferimento, in primo luogo, alle fonti rinnovabili ma non escludendo, allo stesso tempo, il ricorso ad ulteriori fonti anche non convenzionali (ad esempio, il gas di scisto).
La collaborazione tra gli Stati membri è lo strumento principale con cui raggiungere gli obiettivi, attraverso la condivisione delle scorte e la gestione comune delle crisi.
Con riferimento al petrolio, la comunicazione ricorda i passi avanti compiuti grazie all’applicazione della direttiva sulle scorte petrolifere[1] che prevede l'obbligo per gli Stati membri di costituire e mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. Per quanto riguarda il gas, la Commissione preannuncia la presentazione di piani di prevenzione e di emergenza a livello regionale e dell'UE, cui saranno associate le parti contraenti della Comunità dell'energia e la revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Infine, la Commissione valuterà la possibilità di adottare meccanismi volontari di aggregazione della domanda per acquisti collettivi di gas in caso di crisi. Maggiore preoccupazione desta il problema della sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica, caratterizzato da quadri di riferimento inadeguati e da approcci obsoleti e incoerenti. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione stabilirà una serie di livelli di rischio accettabili per le interruzioni delle forniture ed eseguirà una valutazione oggettiva e concreta della sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE che consideri la situazione nei singoli Stati membri.
Sul fronte esterno, ad avviso della Commissione, l'Unione europea dovrebbe adoperarsi per migliorare il sistema di governance globale dell'energia e per rafforzare la competitività e la trasparenza dei mercati mondiali dell'energia.
Nel quadro del rilancio di una diplomazia europea in materia di energia e clima, la Commissione propone l’istituzione di partenariati strategici nel settore dell'energia con paesi o regioni produttori e di transito che stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore (quali l'Algeria e la Turchia, l'Azerbaijan e il Turkmenistan, il Medio Oriente, l'Africa e altri potenziali fornitori) ma anche il rafforzamento del partenariato con la Norvegia (che è il suo secondo fornitore di petrolio greggio e gas naturale) e sviluppo dei partenariati con paesi quali gli Stati Uniti e il Canada.
La Commissione propone anche il potenziamento della Comunità dell'energia, per una maggiore integrazione dei rispettivi mercati dell'energia, dell'UE e della Comunità. Nell'ambito dell'esame in corso dello Strumento europeo di vicinato e partenariato si terrà conto delle relazioni nel settore energetico con i paesi del vicinato europeo.
Un ulteriore elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico (e in particolare del gas) è la piena conformità al diritto dell'UE degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi. A tale riguardo, la Commissione intende proporre la propria partecipazione alla fase di negoziazione degli accordi intergovernativi, in modo da garantire una migliore valutazione ex ante della compatibilità di tali accordi con le norme relative al mercato interno e con i criteri di sicurezza dell'approvvigionamento. La Commissione intende riesaminare, pertanto, la decisione sugli accordi intergovernativi e proporre alternative per garantire che l'UE parli con una sola voce nei negoziati con i paesi terzi.
In sede di revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, la Commissione proporrà inoltre di assicurare un'adeguata trasparenza dei contratti commerciali di fornitura di gas che possono avere un impatto sulla sicurezza energetica dell'UE.
La Commissione basa le sue proposte sulla presa d’atto della eccessiva frammentazione del mercato energetico europeo, caratterizzato da insufficienza degli investimenti, eccessiva concentrazione e debolezza della concorrenza.
Ad avviso della Commissione è necessario accelerare nella realizzazione delle interconnessioni, per raggiungere l’obiettivo specifico di interconnessione minima per l'energia elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10% della capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri[2].
Oltre all’avanzamento dei 248 progetti di infrastrutture energetiche di interesse comune (PIC), individuati nel 2013, e degli ulteriori 33 progetti infrastrutturali individuati nel 2014 dalla strategia europea di sicurezza energetica in quanto essenziali per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, la Commissione sottolinea l’importanza di ulteriori importanti investimenti nella generazione, nelle reti e nell'efficienza energetica, stimati in circa 200 miliardi di euro l'anno per il prossimo decennio, per i quali sarà importante garantire l’accesso agli strumenti finanziari europei esistenti, in primo luogo, la BEI, il meccanismo per collegare l'Europa e i finanziamenti a titolo dei fondi strutturali e d'investimento europei nonché il Fondo europeo per gli investimenti strategici.
E’ inoltre in fase di allestimento il "Portale degli investimenti", nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, il cui scopo è migliorare la trasparenza dell'iter dei progetti d'investimento nell'UE e rendere le informazioni accessibili ai potenziali investitori.
Preliminare alla realizzazione del mercato unico dell’energia è, ad avviso della Commissione, la piena attuazione da parte degli Stati membri della normativa esistente, in particolare, il 3º pacchetto sul mercato interno dell'energia, soprattutto per quanto riguarda la separazione (unbundling) e l'indipendenza dei regolatori.
La Commissione propone di rafforzare il ruolo degli organismi, istituiti dal 3° pacchetto dell’energia, incaricati di garantire la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione e le autorità di regolamentazione. In particolare, le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas (ENTSO-E/G) dovranno essere riqualificate e occorrerà creare centri operativi regionali incaricati di pianificare e gestire efficacemente i flussi transfrontalieri di elettricità e di gas. Viene anche sottolineata l’esigenza di potenziare le funzioni e l'indipendenza dell'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) per consentirle di svolgere funzioni di regolamentazione a livello europeo.
Sarà necessario anche completare l'adozione di codici di rete, anch’essi previsti dal 3° pacchetto dell’energia, per garantire un migliore funzionamento dei mercati transfrontalieri. Inoltre, la Commissione preannuncia l’elaborazione di una proposta legislativa volta a riconfigurare il mercato dell'energia elettrica integrando il commercio all'ingrosso e al dettaglio.
Ai fini di una piena integrazione del mercato, per la Commissione è necessario intervenire sui meccanismi di regolazione nazionali, superando, anche se gradualmente, gli attuali regimi di sostegno e di formazione dei prezzi. Infatti, gli orientamenti[3] e le norme[4] già esistenti per limitare gli effetti dannosi di interventi pubblici, frammentari e scoordinati tra loro non si dimostrano sufficienti al superamento delle distorsioni di mercato. Allo stesso fine, la Commissione intende anche assicurare una maggiore trasparenza nella composizione dei costi e dei prezzi dell'energia, predisponendo un monitoraggio e una rendicontazione periodici e dettagliati, anche per quanto riguarda gli impatti dei costi e dei prezzi dell'energia sulla competitività.
La Commissione sollecita il contributo degli Stati membri per approfondire la collaborazione e il coordinamento reciproco, anche perché alcuni elementi previsto dalla Strategia, quali i nuovi meccanismi dei mercati a breve termine del gas e dell'elettricità o l'integrazione degli interventi dei gestori dei sistemi di trasmissione, vanno messi a punto e attuati a livello regionale.
La Commissione auspica anche l’ulteriore sviluppo dei meccanismi esistenti, quali, ad esempio, il Forum pentalaterale dell'energia e il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP — Baltic Energy Market Interconnection Plan), nonché l’avvio di specifici meccanismi di cooperazione nell'Europa centrale e sud-orientale, data la sua situazione di particolare vulnerabilità.
Anche i consumatori rivestono un ruolo di primo piano nella proposta della Commissione, dovendo diventare protagonisti del mercato con possibilità di scelta tra i gestori e capacità di controllare i propri consumi.
A tale fine, la Commissione intende continuare a promuovere la standardizzazione, sostenere la diffusione dei contatori intelligenti a livello nazionale[5] e incoraggiare l'ulteriore sviluppo di apparecchiature e reti intelligenti, per premiare l'uso flessibile dell'energia. Svilupperà sinergie tra l'Unione dell'energia e l'agenda per il mercato unico digitale e adotterà misure per tutelare la privacy e la sicurezza informatica.
Funzionale a tale obiettivo è anche il graduale superamento delle tariffe regolamentate che, limitando lo sviluppo di una concorrenza effettiva e scoraggiando gli investimenti e l'emergere di operatori di mercato nuovi, a giudizio della Commissione, finiscono per nuocere alle classi più deboli di consumatori per i quali erano state introdotte.
Al posto dei prezzi regolamentati, gli Stati membri dovrebbero introdurre un meccanismo di tutela dei consumatori vulnerabili per mantenere bassi i costi complessivi e limitare le distorsioni derivanti dai prezzi regolamentati.
La Strategia enfatizza il ruolo dell’efficienza energetica, equiparandola ad una vera e propria fonte di energia, pari al valore dell'energia risparmiata.
Molte sono le misure già in atto a livello locale, regionale e nazionale ma la Commissione, con la strategia in esame, intende fornire la cornice entro la quale tali misure possano inquadrarsi, allo scopo di potenziare i risultati positivi riconducendoli ad unità. Inoltre, essa intende impegnarsi nei settori che ancora presentano larghi margini di miglioramento, quali l’edilizia e i trasporti.
Nel settore dell’edilizia, il riscaldamento e l'aria condizionata rappresentano insieme la principale fonte di domanda energetica in Europa e assorbono la maggior parte delle importazioni di gas. Ad avviso della Commissione, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento offrono un enorme potenziale ancora non sfruttato di miglioramenti di efficienza che sarà oggetto di una specifica strategia.
Anche in questo caso, appare fondamentale favorire gli investimenti, facendo un più ampio ricorso agli strumenti finanziari esistenti o attraverso nuovi modelli di finanziamento basati sul principio dell’aggregazione di più progetti in programmi più vasti, capaci di ridurre i costi delle transazioni e di attirare il settore privato su vasta scala.
La Commissione enfatizza il ruolo che possono avere le iniziative già in atto delle "Città e comunità intelligenti" e del Patto dei sindaci e preannuncia lo sviluppo di un'iniziativa a favore della "eccellenza mondiale nella definizione delle politiche di efficienza energetica", per contribuire al Piano d'azione per l'efficienza energetica del G20[6].
Infine, ad avviso della Commissione, i fondi dell'UE e la BEI nonché il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) possono avere un impatto decisivo anche nel finanziamento di progetti centrati sulla ristrutturazione degli edifici, per aumentarne l’efficienza energetica.
Il settore dei trasporti rappresenta più del 30 per cento del consumo finale di energia in Europa. Il risparmio di energia in tale settore può derivare, ad avviso della Commissione, da un inasprimento delle norme sulle emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni dopo il 2020, dall’introduzione di misure volte a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti e degli autobus nonché dalla promozione di una migliore gestione del traffico.
In particolare, la Commissione preannuncia la promozione dell’utilizzo di sistemi di tariffazione stradale sulla base dei principi "chi usa paga" e "chi inquina paga" e l’intensificazione degli sforzi per creare uno spazio unico europeo dei trasporti fondato su un uso più efficiente del parco veicoli. Essa auspica anche l’eliminazione degli ostacoli alle modalità di trasporto che producono meno emissioni di gas a effetto serra, quali il trasporto ferroviario, marittimo e le vie navigabili interne e intende promuovere ulteriormente l'iniziativa "Shift 2Rail"[7].
Sono previste anche l’adozione di altre iniziative per decarbonizzare il settore dei trasporti, che dipende ancora in ampissima misura dai prodotti petroliferi. anche dando impulso ad una maggiore diffusione dei carburanti alternativi. La Commissione intende continuare ad impegnarsi per promuovere la rapida realizzazione delle infrastrutture necessarie, quali le stazioni di rifornimento e ricarica[8]. Sarà dato spazio anche alla elettrificazione dei trasporti.
Uno dei perni della politica climatica europea è l'adeguato funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS).
Il sistema, istituito dalla direttiva 2003/87/CE, applica all’Europa il meccanismo di cap&trade introdotto a livello mondiale dal Protocollo di Kyoto. Esso fissa un tetto massimo (cap) al livello totale delle emissioni consentite a tutti i soggetti interessati dal sistema, ma consente ai partecipanti di acquistare o vendere sul mercato (trade) i diritti di emissione di CO2 (quote) secondo le loro necessità, all’interno del limite stabilito.
L’EU ETS coinvolge circa 11.000 operatori (dal 2012 anche nel settore aereo). Si tratta di impianti industriali, nel settore della produzione di energia e nel settore manifatturiero (in Italia, sono circa 1.300 i soggetti coinvolti, di cui il 71 per cento nel settore manifatturiero).
Dal 2013, sono coinvolti gli impianti di produzione di alluminio, calce viva, acido nitrico, acido adipico, idrogeno, carbonato e bicarbonato di sodio e gli impianti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2.
Secondo le proiezioni aggiornate degli Stati membri, in base alle misure esistenti (trasporto aereo internazionale incluso), nel 2020 le emissioni dovrebbero essere del 21 per cento inferiori rispetto al 1990 (compresi sia i settori inclusi che esclusi dal sistema ETS).
La Direttiva ETS prevede che, dal primo gennaio 2005, gli impianti dell’Unione europea con elevati volumi di emissioni non possano funzionare senza un’autorizzazione ad emettere gas serra. Ogni impianto autorizzato deve monitorare annualmente le proprie emissioni e compensarle con quote di emissione europee che possono essere comprate e vendute sul mercato. Seppure in misura, gli impianti possono utilizzare a questo scopo, ma solo fino al 2020 ed in determinate percentuali, anche crediti di emissione non europei, derivanti da progetti realizzati nell’ambito dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (Clean Development Mechanism, CDM e Joint Implementation, JI). In generale, i gestori degli impianti possono scegliere tra investire per ridurre le proprie emissioni introducendo tecnologie a basso contenuto di carbonio o attraverso misure di efficienza energetica, e acquistare quote.
Gli Stati membri dell’UE assegnano le quote agli operatori a titolo oneroso attraverso aste pubbliche europee. Gli impianti manifatturieri, in particolare quelli esposti a rischio di delocalizzazione a causa dei costi del carbonio (rischio di carbon leakage), ricevono una parte di quote a titolo gratuito in base a parametri di riferimento (benchmark), generalmente definiti per prodotto, armonizzati a livello europeo e quantificati in base alla performance del 10% degli impianti più efficienti per ciascun settore industriale.
Gli impianti possono comunque comprare e vendere quote tra loro, attraverso accordi privati o rivolgendosi al mercato secondario del carbonio. Le quote sono contabilizzate nel Registro unico dell’Unione europea, una banca dati che tiene traccia di tutti i passaggi di proprietà delle quote e consente agli operatori di compensare, annualmente, le proprie emissioni restituendo le quote agli Stati membri.
Il quantitativo totale delle quote in circolazione nel Sistema è definito a livello europeo in funzione degli obiettivi UE al 2020 (-20% emissioni rispetto ai livelli del 1990). Il cap è ridotto annualmente di un fattore lineare pari all’1,74% del quantitativo medio annuo totale di quote rilasciato dagli Stati membri nel periodo 2008-2012, e pari a oltre 38 milioni di quote. A partire dal 2021, il fattore dovrebbe passare al 2,2% annuo, per rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 40% al 2030.
Negli ultimi anni di applicazione, per effetto della crisi economica che ha determinato una riduzione delle emissioni, si è prodotta un’eccedenza di quote che, nel breve termine, rischia di compromettere il corretto funzionamento del mercato del carbonio e, a lungo termine, potrebbe influire sulla capacità del sistema ETS. Su proposta della Commissione, si è deciso nel dicembre 2013, di rinviare (“backloading”), la vendita all'asta di alcune quote (900 milioni). Inoltre, la Commissione ha presentato una proposta legislativa volta a istituire una riserva stabilità del mercato all'inizio del prossimo periodo di scambio, nel 2021 (COM(2014)20).
Fissando un prezzo significativo per le emissioni di CO2 e incentivando riduzioni, efficienti sotto il profilo dei costi, delle emissioni di gas a effetto serra, il sistema UE mira a rafforzare il funzionamento del mercato interno dell'energia e ad incoraggiare la diffusione delle energie rinnovabili e di altre tecnologie a basse emissioni di CO2 ed elevata efficienza energetica.
La Commissione, infine, preannuncia, per i settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, la fissazione di obiettivi nazionali e l’integrazione nel quadro UE 2030 del settore agroforestale, garantendo che anche questi settori beneficino degli incentivi adeguati per mitigare le emissioni di gas a effetto serra e contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.
Per la decarbonizzare l’economia europea, la Commissione intende accentuare lo sforzo di promozione delle energie rinnovabili, attuando pienamente la normativa vigente, in modo da consentire la diffusione di nuove tecnologie, reti intelligenti e meccanismi di demand response per un'efficace transizione energetica.
Funzionali a tale obiettivo sono, in primo luogo, l’introduzione di dispositivi basati sul mercato, che tengano conto delle carenze del mercato stesso e garantiscano l'efficacia in termini di costi, evitando sovracompensazioni e distorsioni; in secondo luogo, un quadro di investimenti stabile, che garantisca la fiducia degli investitori e ad attragga gli investimenti di grandi fondi internazionali; infine, la cooperazione[9] e la convergenza dei regimi di sostegno nazionali a favore di una maggiore apertura transfrontaliera.
Un’ulteriore strada per la decarbonizzazione dell’economia è costituita dall’investimento in combustibili alternativi avanzati e sostenibili, nella bioenergia sull'ambiente, nell'uso del suolo e nella produzione alimentare.
La Commissione propone una nuova strategia per la ricerca e l'innovazione (R&I) soprattutto nel campo delle tecnologie rinnovabili e delle soluzioni di stoccaggio. La nuova strategia dovrebbe comprendere un aggiornamento del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e un'agenda strategica di R&I dei trasporti.
Tale strategia dovrebbe servirebbe ad attuare una ricerca pienamente coordinata e mirata, che riunisca efficacemente i programmi dell'UE e degli Stati membri intorno a obiettivi e risultati comuni.
Facendo pienamente ricorso ai finanziamenti di Orizzonte 2020, le priorità della ricerca europea dovrebbero essere: lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie delle energie rinnovabili; la partecipazione dei consumatori alla transizione energetica; sistemi energetici efficienti; sistemi di trasporto più sostenibili; la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e la cattura e il consumo del carbonio (CCU) per i settori dell'energia e dell'industria; l’energia nucleare, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza, della gestione dei rifiuti e della non proliferazione.
Strettamente connessa alla strategia nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica è una avanzata politica industriale basata sulla stretta collaborazione fra la ricerca, l'industria, il settore finanziario e le autorità pubbliche.
Per migliorare l'accesso ai mercati esteri per le tecnologie e i servizi connessi all'Unione dell'energia nonché per proteggere il mercato dell'UE dalle pratiche commerciali sleali e sostenere altri paesi nell'istituzione di sistemi energetici moderni e sostenibili, la Commissione intende utilizzare appieno gli strumenti della politica commerciale dell'UE. Questo processo, ad avviso della Commissione, avrà delle ricadute positive anche in termini di occupazione, a patto che si proceda all'adeguamento di alcuni settori, modelli economici o profili professionali.
Ciò richiederà l’istituzione di nuovi percorsi di formazione professionale o la modifica di quello esistenti per corrispondere alle nuove esigenze delle imprese e fornire alle persone solide competenze.
La Comunicazione “Raggiungere l’obiettivo del 10% di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020” (COM(2015)82) si fonda sul presupposto che una rete energetica europea interconnessa è indispensabile per garantire la sicurezza energetica dell'Europa, rafforzare la concorrenza sul mercato interno, rendendo i prezzi più competitivi, e favorire il conseguimento degli obiettivi che l'Unione europea si è impegnata a raggiungere in materia di decarbonizzazione e politica climatica.
Nonostante quanto fatto fino ad ora per rendere la rete elettrica europea interconnessa e integrata, ancora dodici Stati membri, tra cui l’Italia, risultano al di sotto dell’obiettivo del 10% di interconnessione, restando isolati dal resto della rete, come risulta dalla tabella che segue:
|
Stati membri con un livello di interconnessione inferiore al 10% |
|
|
Irlanda |
9% |
|
Italia |
7% |
|
Romania |
7% |
|
Portogallo |
7% |
|
Regno Unito |
6% |
|
Estonia |
4% |
|
Lituania |
4% |
|
Estonia |
4% |
|
Regno Unito |
6% |
|
Spagna |
3% |
|
Polonia |
2% |
|
Cipro |
0% |
|
Malta |
0% |
|
Fonte: ENTSO-E, Scenario Outlook and Adequacy Forecast 2014. |
|
Appare pertanto necessario provvedere alla costruzione delle interconnessioni mancanti e, infatti, le infrastrutture energetiche figurano tra le priorità dell'agenda energetica europea, come affermato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, che ha sollecitato la rapida attuazione di tutte le misure necessarie al conseguimento dell’obiettivo dell’interconnessione del 10% della capacità di produzione di energia elettrica installata per tutti gli Stati membri.
Nella Comunicazione in esame, sono messi in luce nel dettaglio i vantaggi che l’Europa si assicurerebbe con il raggiungimento di tale obiettivo. In primo luogo, le interconnessioni elettriche possono rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento in Europa e la sua indipendenza energetica. Il miglioramento della qualità del servizio permetterebbe di ridurre le interruzioni dell'erogazione e le perdite di produttività nel settore commerciale e in quello industriale.
Una rete interconnessa garantirebbe prezzi più accessibili nel mercato interno, grazie all'aumento della concorrenza e dell'efficienza[10], e un utilizzo delle risorse disponibili migliore e più efficiente sotto il profilo dei costi. Si ridurrebbero, inoltre, le necessità di investire nella capacità di generazione di picco e di stoccaggio, dal momento che l’interconnessione elimina la necessità di fare ricorso nello stesso momento agli impianti di cui dispone ciascun paese.
Il miglioramento delle interconnessioni avrebbe effetti positivi anche dal punto di vista ambientale. Una rete ben interconnessa consentirebbe di integrare livelli crescenti di energie rinnovabili, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE, grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla maggiore sicurezza dell'approvvigionamento.
Ad avviso della Commissione, è necessario stimolare gli investimenti, anche alla luce della ripresa economica in atto. E’ stato già attivato il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) che prevede, tra le altre cose, l'individuazione di progetti di interconnessione in tutta l'UE e la mobilitazione delle risorse finanziarie dell'UE. Questo programma ha contribuito alla realizzazione di numerosi progetti di interconnessione tra Stati membri, non realizzati in precedenza a causa della mancanza di finanziamenti adeguati. Nell'ambito dell'EEPR sono stati spesi circa 650 milioni di EUR per le interconnessioni elettriche[11].
All’EEPR si aggiungono i progetti di interesse comune (PIC).
Il primo elenco di PIC è stato adottato nel 2013. Vi figurano 248 progetti, di cui 137 relativi all'energia elettrica, inclusi 52 interconnessioni elettriche, in 37 dei quali sono coinvolti Stati membri il cui livello di interconnessione è attualmente al di sotto del 10%.
L'elenco di PIC è flessibile e viene aggiornato ogni due anni. Sono attualmente in corso, nel contesto regionale istituito dal regolamento TEN-E, i lavori per la stesura del secondo elenco, in vista della sua adozione da parte della Commissione nell'autunno 2015. I progetti di interesse comune sono concepiti e realizzati dai gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) e da promotori privati. I progetti attuali si trovano a diversi stadi di sviluppo; per alcuni è in corso la fase di costruzione, altri invece sono nelle fasi iniziali della preparazione. È previsto il completamento entro il 2020 di circa il 75% di tutti i PIC che figurano nel primo elenco dell'Unione.
I PIC del primo elenco che riguardano l’Italia sono quattro:
1) PIC Interconnessione Francia - Italia fra Codrongianos (IT), Lucciana (Corsica, FR) e Suvereto (IT) (attualmente denominato progetto SA.CO.I.3): è attualmente in fase di studio e la data prevista di messa in servizio è il 2022. Il progetto rientra nel Corridoio prioritario "Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa occidentale" ("NSI West Electricity");
2) PIC Interconnessione Austria - Italia fra Nauders (AT) e la regione di Milano (IT), facente parte del Corridoio prioritario "Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale" ("NSI East Electricity"). E’ in fase di studio e la data prevista di messa in servizio è il 2018;
3) PIC Interconnessione Austria – Italia fra Wurmlach (AT) e Somplago (IT), anch’esso facente parte del Corridoio prioritario "Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale" ("NSI East Electricity"). Ha già ottenuto il permesso e la data prevista di messa in servizio è il 2017;
4) PIC Interconnessione Italia-Slovenia fra Salgareda (IT) e Divača - regione di Beričevo (SI), anch’esso facente parte del Corridoio prioritario "Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale" ("NSI East Electricity"). Ha già ottenuto il permesso e la data prevista di messa in servizio è il 2022.
La Commissione prevede che il completamento almeno dei progetti che coinvolgono anche la Francia e l’Austria potrebbe portare il grado di interconnessione italiana al 12 per cento entro il 2020.
Ad avviso della Commissione, un quadro normativo solido è un presupposto indispensabile all’attuazione degli investimenti nelle infrastrutture. Dal 2013 l'Unione europea ha adottato un approccio integrato alla pianificazione e alla realizzazione delle infrastrutture. La Commissione fa, in particolare, riferimento al regolamento TEN-E[12] e al Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)[13], coma agli strumenti deputati all’individuazione dei progetti necessari e alla loro rapida realizzazione.
Il regolamento sulle reti energetiche transeuropee (TEN-E) affronta per la prima volta la questione specifica dei progetti che hanno un impatto sui flussi transfrontalieri.
Esso, riconoscendo che per questi progetti è necessario un trattamento normativo specifico, propone di effettuare un'analisi costi-benefici che dimostri chiaramente i vantaggi sovranazionali che offrono e consente di ripartire i costi a livello transfrontaliero in base ai vantaggi generati negli Stati membri interessati. Il regolamento TEN-E impone inoltre alle autorità nazionali di regolamentazione di offrire incentivi regolamentari correlati ai rischi sostenuti per la realizzazione dei progetti. La maggior parte dei progetti è promossa dai gestori dei sistemi di trasmissione, mentre le autorità di regolamentazione approvano o fissano le tariffe. Alcuni progetti tuttavia, compresi alcuni PIC, sono promossi da soggetti privati. Allo scopo di superare lentezza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e quella dell'accettazione da parte del pubblico, considerati i principali ostacoli allo sviluppo delle infrastrutture, il regolamento, in primo luogo, introduce l'obbligo di non superare globalmente il limite massimo di 3,5 anni per la concessione delle autorizzazioni[14] e la centralizzazione del rilascio delle autorizzazioni ("sportello unico"). In secondo luogo, introduce nuove norme volte a rafforzare la consultazione e la trasparenza, in modo da garantire una maggiore partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione.
In considerazione del fatto che, secondo stime della Commissione, da oggi al 2020 per i progetti legati all'energia elettrica saranno necessari circa 105 miliardi di euro, di cui circa 35 miliardi per le interconnessioni che hanno acquisito lo status di PIC e sono necessarie per il conseguimento dell'obiettivo del 10% in tutta l'UE, è indispensabile il pieno utilizzo degli strumenti finanziari disponibili, cioè del Meccanismo per collegare l'Europa, dei fondi strutturali e d'investimento europei e del Fondo europeo per gli investimenti strategici.
Nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), i finanziamenti per l'energia ammontano a 5,35 miliardi di euro. Essi possono attrarre altre risorse tramite il ricorso a strumenti finanziari, come le obbligazioni per il finanziamento di progetti già utilizzate in via sperimentale durante la fase pilota nel 2012-2013.
Gli Stati membri possono anche ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei (ad esempio, la Commissione stima che per le grandi infrastrutture dell'energia elettrica e del gas dovrebbe essere stanziata una somma di circa 2 miliardi di euro a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR).
Per il finanziamento dei PIC o di altri progetti di interconnessione può essere utilizzato anche il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che tra breve sarà istituito in partenariato con la BEI[15].
Per permettere ai potenziali investitori di accedere alle informazioni, la Commissione sta lavorando alla creazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offrirà consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e fungerà da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento dei progetti nell'Unione, anche per le questioni giuridiche. La consulenza fornita dall'EIAH non si limiterà al FEIS, ma riguarderà anche altre possibilità di finanziamento già disponibili per i progetti infrastrutturali, tra cui l'MCE e i fondi strutturali e d'investimento europei.
Per il raggiungimento dell’obiettivo è fondamentale il rafforzamento della cooperazione regionale, quale quella stabilita nell'ambito dei gruppi regionali TEN-E.
In particolare, i quattro gruppi regionali per l'energia elettrica (la rete offshore nei mari del Nord, il piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'elettricità - BEMIP, le interconnessioni nord-sud nell'Europa occidentale e le interconnessioni nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale) adottano un elenco regionale di PIC in vista della successiva stesura di un elenco a livello UE. Essi seguono la realizzazione dei PIC nelle rispettive regioni, riferiscono le eventuali difficoltà riscontrate e possono proporre misure correttive.
Tuttavia, ad avviso della Commissione, è necessario portare la collaborazione regionale a un livello superiore, per affrontare priorità politiche di più ampio respiro, che vadano oltre i problemi correlati alla pianificazione e alla realizzazione dei singoli progetti. A tale scopo, la Commissione intende collaborare con gli Stati membri interessati per elaborare una strategia specifica per ciascuna regione, per affrontare i problemi più urgenti e decidere quali azioni intraprendere. Le quattro regioni definiranno un piano d'azione con tappe precise per la sua attuazione, comprese proposte concrete per l'interconnessione al fine di conseguire l'obiettivo del 10% concordato a livello di UE. L'attuazione dei piani d'azione sarà seguita da vicino dalla Commissione che promuoverà, per quanto possibile, l'armonizzazione dei metodi di lavoro dei diversi gruppi regionali.
Con la medesima finalità, la Commissione intende collaborare con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) per ampliare la portata del piano decennale di sviluppo della rete, che rappresenta l'unico strumento per la selezione dei progetti di interesse comune.
E’ prevista, infine, la convocazione, alla fine del 2015, del primo forum sulle infrastrutture dell'energia per discutere e trovare soluzioni a problemi comuni a tutte le regioni europee, eventualmente in collaborazione con i paesi vicini.
Il pieno utilizzo dei punti di forza elencati (strumenti progettuali, finanziamenti, quadro normativo e cooperazione regionale) renderà possibile, ad avviso della Commissione, il raggiungimento dell’ulteriore obiettivo del 15% di interconnessione entro il 2030, come previsto nel quadro clima/energia al 2030.
L'Unione europea è da tempo impegnata nei negoziati internazionali sul clima e la sua azione è stato importante per lo sviluppo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto. Grazie alle pressioni da parte dell'UE e di altri paesi sensibili al tema, all’interno delle Nazioni Unite sono in corso negoziati per elaborare un nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici con particolare riferimento ad una ulteriore riduzione delle emissioni globali entro il 2020.
La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi a Lima lo scorso dicembre, ha segnato il successo dell’azione diplomatica dell’Unione europea verso l’individuazione di obiettivi più ambiziosi e impegnativi per tutti i Paesi coinvolti, oggetto della prossima conferenza di Parigi, alla fine del 2015. L’accordo raggiunto prevede che ciascun Paese indichi con chiarezza i propri obiettivi per permettere alle diplomazie di preparare le proprie proposte di contributi e di orientare così la discussione nel modo più operativo e concludente possibile.
Elaborata sulla scorta delle decisioni adottate a Lima, anche in preparazione dell’ultimo ciclo di negoziati che si terranno prima della conferenza di Parigi di dicembre 2015, la comunicazione “Il Protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020”, facente parte del pacchetto Unione dell’Energia (COM(2015)81), è un elemento essenziale per l’attuazione di una delle priorità della Commissione: quella di costruire un’Unione dell’energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici. Essa intende concretizzare le decisioni prese dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ed è imperniata sulla proposta di un accordo giuridicamente vincolante, basato su impegni equi e ambiziosi di tutte le parti, per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di una riduzione di almeno il 60% delle emissioni di gas serra entro il 2050 (rispetto al 2010).
I punti salienti della comunicazione sono relativi ai seguenti aspetti:
· INDC - Intended Nationally Determined Contribution: la comunicazione, traducendo in partica la decisione presa al vertice europeo di ottobre 2014, indica l’obiettivo per le emissioni dell’UE, ossia il suo contributo previsto stabilito a livello nazionale, che deve essere presentato entro la fine del primo trimestre del 2015. Le altre Parti dell’UNFCCC dovrebbero presentare i loro INDC con ampio anticipo rispetto alla conferenza di Parigi[16];
· carattere cogente dell’accordo: la Commissione propone che l'accordo assuma la forma di un protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che entrerebbe in vigore una volta ratificato dai paesi che rappresentano l'80% delle emissioni globali[17]. Nell’ambito del protocollo, i finanziamenti, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia, come pure la costituzione di capacità a supporto dell’azione per il clima, dovrebbero favorire la partecipazione di tutti i paesi e agevolare un’attuazione efficace delle strategie di riduzione delle emissioni e di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;
· obiettivi dell’accordo: gli impegni assunti dalle Parti dovrebbero consentire di ridurre le emissioni mondiali di almeno il 60% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2010. Se il livello di ambizione fissato a Parigi non fosse sufficiente a raggiungere questo obiettivo, ad avviso della Commissione occorrerebbe stilare un programma di lavoro, da avviare nel 2016 in stretta collaborazione con il Fondo verde per il clima, per individuare altre misure di riduzione delle emissioni;
· coinvolgimento dei settori dell’aviazione civile e dei trasporti marittimi: la Commissione propone che l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e il protocollo di Montreal[18] dovrebbero adoperarsi per regolare entro la fine del 2016 le emissioni prodotte dal trasporto aereo e marittimo internazionale, nonché la produzione e il consumo di gas fluorurati;
· integrazione delle politiche: ad avviso della Commissione, anche il commercio, la ricerca scientifica, l’innovazione e la cooperazione tecnologica, la cooperazione economica e allo sviluppo, la riduzione del rischio di catastrofi e la politica ambientale, opportunamente integrate tra loro, possono contribuire al rafforzamento della politica dell’UE per il clima sul fronte internazionale.
La comunicazione è accompagnata da un piano d’azione diplomatico in materia di clima, elaborato congiuntamente dal servizio europeo per l’azione esterna e dalla Commissione. Il piano contempla le seguenti azioni:
· porre i cambiamenti climatici al centro dei dialoghi politici, in particolare in occasione delle riunioni del G7 e del G20, nonché all’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
· sostenere uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici e alle catastrofi attraverso la cooperazione allo sviluppo dell’UE;
· collegare il cambiamento climatico alle sue potenziali conseguenze a lungo termine, ivi compresi i problemi di sicurezza.
Con tale piano la Commissione punta a far guadagnare gradualmente consensi alla posizione dell'UE e a stringere alleanze con partner internazionali in prospettiva della conferenza di Parigi.
La Strategia energetica nazionale è il documento di programmazione e indirizzo nel settore energetico a livello nazionale, dopo oltre vent'anni dall'ultimo Piano Energetico Nazionale.
La Strategia energetica nazionale (SEN) contiene le linee direttrici della politica energetica italiana dei prossimi decenni. Essa indica quattro obiettivi principali:
· l'allineamento dei costi energetici a quelli europei, con una previsione di circa 9 miliardi di euro l'anno di risparmi sulla bolletta elettrica e gas a livello nazionale (sui 70 miliardi di spesa totale attuale);
· il superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei (riduzione delle emissioni di CO2, penetrazione delle rinnovabili, riduzione del consumo di energia). Questi includono la riduzione delle emissioni di gas serra del 21% rispetto al 2005 (obiettivo europeo: 18%), riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale (obiettivo europeo: 20%) e raggiungimento del 19-20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi (obiettivo europeo: 17%). In particolare, ci si attende che le rinnovabili diventino la prima fonte nel settore elettrico al pari del gas con un'incidenza del 35-38%;
· il rafforzamento della nostra sicurezza ed indipendenza di approvvigionamento, con una riduzione di circa 14 miliardi l'anno di acquisti energetici dall'estero (rispetto ai 62 miliardi attuali, e -19 rispetto alle importazioni tendenziali 2020), con la riduzione dall'84 al 67% della dipendenza dall'estero. Ciò equivale a circa 1% di PIL addizionale e, ai valori attuali, sufficiente a riportare in attivo la bilancia dei pagamenti, dopo molti anni di passivo;
· la spinta alla crescita economica guidata dal settore energetico, con una previsione di circa 180 miliardi di euro di investimenti di qui al 2020, sia nella green e white economy (rinnovabili e efficienza energetica), sia nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi). Si tratta di investimenti privati, solo in parte supportati da incentivi, e con notevole impatto in termini di competitività e sostenibilità del sistema.
Per ottenere questi obiettivi, la SEN individua 7 priorità d'azione, ciascuna dettagliata in misure concrete da prendere:
· Efficienza energetica
· Mercato competitivo del gas e hub sud-europeo
· Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili
· Sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico
· Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione carburanti
· Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali
· Modernizzazione del sistema di governance
La "Strategia energetica nazionale" era stato introdotta nell'ordinamento nel 2008, quale strumento di indirizzo e programmazione della politica energetica nazionale. Al centro della Strategia era originariamente prevista la attivazione di una nuova politica per l'energia nucleare. Il decreto-legge 34/2011 ha dettato una nuova formulazione che manteneva l'istituto della "Strategia energetica" senza però riferimento al nucleare; anche questa nuova formulazione è stata tuttavia abrogata dal referendum del 12 e 13 giugno 2011. L'adozione della SEN da parte del Governo era subordinata ad una procedura che prevedeva, tra l'altro, il parere delle Commissioni. In assenza, dunque, di una norma espressa che disciplini il procedimento d'adozione della SEN, il Governo ha utilizzato lo strumento del decreto interministeriale, previa consultazione pubblica.
Il documento è infatti frutto di un processo di consultazione avviato a metà ottobre 2012 in seguito all'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento di proposta e proseguito con il confronto con le istituzioni, le associazioni di categoria, le parti sociali e sindacali, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, enti di ricerca e centri studi. Sono stati inoltre ricevuti suggerimenti e contributi da cittadini e singole aziende attraverso la consultazione pubblica che si è svolta on-line sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico.
Aggiornata per tenere conto delle osservazioni pervenute, la SEN è stata approvata con decreto interministeriale firmato dai ministri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente allo scadere della XVI legislatura (decreto 8 marzo 2013).
Per approfondimenti, si veda il Tema dell’attività parlamentare sulla SEN e i relativi approfondimenti.
Nel settore energetico ritroviamo una compresenza di funzioni del Governo – prevalentemente, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – e dell’Autorità di regolazione.
L’Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) è un organismo indipendente, istituito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso attività di regolazione e di controllo. Con il decreto-legge n. 201/2011 (cd. Salva Italia) all'Autorità sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici, da esercitare con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva n. 481/95.
L’Autorità ha dunque il compito di individuare gli strumenti tecnici ed economici più adatti a perseguire efficacemente e al minimo costo gli indirizzi e gli obiettivi di politica energetica nazionale definiti dal Parlamento e dal Governo e di monitorarne l’attuazione. In tal modo si garantisce anche continuità nell’attuazione di tali obiettivi, indipendentemente dai fisiologici cicli politici e dal succedersi delle Legislature.
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell'Unione europea. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate dal c.d. “Terzo Pacchetto Energia” europeo (direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) anche per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento.
L'Autorità adotta le proprie decisioni sulla base della
legge istitutiva e definisce le procedure ed i regolamenti per l'organizzazione
interna, il funzionamento e la contabilità.
Le risorse per il funzionamento non provengono dal bilancio dello Stato ma da
un contributo sui ricavi degli operatori regolati: tale contributo è stato
ridotto (volontariamente dall'Autorità) allo 0,3 per mille rispetto all'1 per
mille previsto dalla legge.
Tale modello di governance opera in un contesto, come quello energetico, che attraversa da vari anni un periodo di eccezionale cambiamento. Nella legislatura in atto, ad esempio, sono intervenuti numerosi provvedimenti che incidono in materia di energia, nei quali si prevede che intervengano sia l’Autorità, che il Ministero. L’ambito di azione dei due soggetti però, non è delimitato secondo uno schema uniforme. Tra le possibilità più frequenti, vi è la previsione che il Ministero provveda con proprio decreto “sentita l’Autorità”, oppure “previo parere” dell’Autorità. Ancora più limitate sono poi le ipotesi in cui l’adozione di un atto avviene su proposta dell’Autorità. Ancora in altre ipotesi la suddivisione di competenze tra Autorità e Ministero è delineata secondo meccanismi variabili, determinati caso per caso a seconda della specifica funzione presa in considerazione dalla norma. Nel seguito riportiamo alcuni esempi.
La legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013), prevede all’art. 1, comma 153, che il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità e sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisca un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità (c.d. capacity payment), nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete, e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell’energia elettrica per i clienti finali.
Il decreto legge n. 145/2013 (cd. Destinazione Italia), contiene numerose e rilevanti disposizioni in materia energetica, racchiuse essenzialmente nei diversi commi di cui si compone l’art. 1. Il comma 3 prevede una riduzione della componente A3 della bolletta energetica – il cosiddetto “spalma-incentivi volontario” – secondo cui i produttori possono continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, oppure optare per una rimodulazione dell’incentivo, consistente nella fruizione di un incentivo ridotto di una percentuale specifica, a fronte però di una proroga di sette anni del periodo di incentivazione. La percentuale di riduzione, specifica per ciascuna tipologia di impianto, sarà definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell’Autorità. Il comma 6-bis stabilisce che, al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, applicati al consumo di gas, e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall’Autorità, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo gli indirizzi emanati dal Ministero dello sviluppo economico.
In tema di c.d. “imprese elettriche minori”, il comma 6-octies stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità, avvii un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili e definendo gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.
Vi è poi (comma 11) un intervento di carattere pro-concorrenziale, diretto, nello specifico, a sopprimere la norma che prevedeva l’assegnazione tramite gara, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis. Conseguentemente, il comma 12 attribuisce alla Regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente. Al vincitore della gara è assicurato l’acquisto, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto, fino al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un apposito incentivo. Il comma 13 pone, quindi, a carico del sistema elettrico italiano gli oneri derivanti dall’attuazione del predetto comma 12, con corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, secondo modalità definite dall’Autorità, mentre il successivo comma 14 rinvia a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la determinazione degli elementi e dei criteri per la valutazione delle offerte di gara e le modalità dell’audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi.
Per quanto concerne il mercato del gas naturale, il comma 16- ter prevede che qualsiasi soggetto che immette gas nella rete nazionale – e la cui quota superi il 10% - sia soggetto, dall’1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all’obbligo di offerta sul Mercato a termine gestito dal GME per un volume di gas corrispondente al 5% del totale annuo immesso, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo e con una differenza di prezzo tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto non superiore a un valore definito dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità, che stabilisce anche le modalità di adempimento del suddetto obbligo.
Del decreto-legge 91/2014 si richiama l’articolo 26 – cosiddetto spalma incentivi obbligatorio – volto a generare risparmi sull'incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici. In questo caso si prevede che l'Autorità, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema. Nell’articolo 29, che mira alla limitazione dell'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI), con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime.
[1] Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
[2] La Commissione preannuncia la sua intenzione di proporre nel 2016 un ulteriore obiettivo di interconnessione al 15 per cento entro il 2030.
[3] Cfr. la comunicazione "Realizzare il mercato interno dell'energia elettrica e sfruttare al meglio l'intervento pubblico", C(2013) 7243 final.
[4] Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).
[5] Cfr. la relazione "Analisi comparativa dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nell'UE‑27, in particolare nel settore dell'elettricità", COM(2014) 356 final.
[6] Tale piano intende promuovere l'adozione di obiettivi e traguardi ambiziosi di efficienza energetica in sedi quali l'iniziativa delle Nazioni Unite "Energia sostenibile per tutti" e l'Agenzia internazionale per l'energia.
[7] Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail.
[8] Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
[9] Diversi Stati membri stanno valutando l'opportunità di utilizzare i meccanismi di cooperazione della direttiva sulle energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi nazionali in modo economicamente efficiente. La Commissione ha sostenuto questo processo aiutando gli Stati membri a trovare soluzioni per le problematiche tecniche e finanziarie connesse a tali meccanismi transfrontalieri.
[10] La Commissione quantifica tali risparmi tra i 12 e i 40 miliardi di euro l'anno entro il 2030.
[11] Tra i progetti cofinanziati dal programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), si segnala l'interconnessione Malta-Italia (Pembroke - Marina di Ragusa), un cavo sottomarino HVAC a 250 MVA che porrà fine all'isolamento della rete elettrica maltese dal resto dell'Europa.
[12] Regolamento n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU L 115 del 25.4.2013).
[13] Regolamento n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (GU L 348 del 20.12.2013).
[14] Ciò dovrebbe ridurre notevolmente i tempi medi attualmente necessari, che vanno dai 10 ai 13 anni.
[15] Le risorse a disposizioni del fondo sono costituite da 16 miliardi di euro dal bilancio dell’UE e 5 miliardi di euro dalla BEI. Secondo le stime della Commissione, tale fondo, tra le cui priorità rientra anche l’energia, potrà mobilitare almeno 315 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati.
[16] Ad avviso della Commissione, la Cina, gli Stati Uniti e altri paesi del G20, così come i paesi a reddito medio e alto, dovrebbero essere in grado di farlo entro il primo trimestre del 2015, mentre ai paesi meno sviluppati dovrebbe essere accordata maggiore flessibilità.
[17] Si tratta essenzialmente dell'Unione europea (9% delle emissioni globali) e di Cina (24%) e Stati Uniti (12%).
[18] Si tratta di un accordo, adottato nel 1987, che ha fissato gli obiettivi e le misure per la riduzione delle produzioni e degli usi delle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico.