
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
esame di atti e documenti dell’unione europea
“Priorità per la normazione delle TIC
per il mercato unico digitale”
(Comunicazione COM(2016)176)
n. 59
25 maggio 2016
| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |
|---|---|
| Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea |
| Titolo: | 'Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale' (Comunicazione COM(2016)176) |
| Serie: | Bollettino commissioni Numero: 59 |
| Data: | 25/05/2016 |

Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
esame di atti e documenti dell’unione europea
“Priorità per la normazione delle TIC
per il mercato unico digitale”
(Comunicazione COM(2016)176)
n. 59
25 maggio 2016
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)
Il capitolo ‘Il regolamento 1025/2012: la standardizzazione dei prodotti hi tech’ è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Trasporti, poste e telecomunicazioni (' 066760.2614- * st_trasporti@camera.it)
________________________________________________________________
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I N D I C E
Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale
· La definizione delle norme tecniche
Il contenuto della comunicazione
× Dati
· Le principali ripercussioni sull'industria e i consumatori
· Esame presso altri Parlamenti nazionali
Il Regolamento 1025/2012: la standardizzazione dei prodotti hi tech (a cura del Servizio Studi)
|
Tipo di atto |
Comunicazione |
|
Data di adozione |
19 aprile 2016 |
|
Settori di intervento |
Industria dell'informatica, normalizzazione, mercato unico, specifica tecnica, tecnologia dell'informazione, applicazione dell'informatica, tecnologia digitale |
|
|
|
|
Esame presso le istituzioni dell’UE |
Trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 19 aprile 2016 – assegnata alla Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori |
|
|
|
|
Assegnazione |
26 aprile 2016 --- IX Trasporti e X Attività produttive |
|
Segnalazione da parte del Governo |
21 aprile 2016 |
La comunicazione relativa alla normazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) COM(2016)176 mira a sviluppare norme tecniche comuni, al fine di consentire che dispositivi connessi (telefoni, computer e sensori) possano comunicare in modo sicuro e senza difficoltà, indipendentemente dal produttore, dai dettagli tecnici o dal Paese d’origine.
L'introduzione di norme tecniche comuni costituisce il fondamento per un mercato unico digitale efficace, poiché assicura che le tecnologie possano integrarsi in modo fluido e affidabile, consente le economie di scala, promuove la ricerca e l'innovazione e mantiene i mercati aperti.
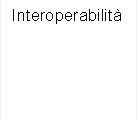 In
particolare, le norme aperte garantiscono l’interoperabilità e promuovono
l'innovazione e l'abbassamento delle barriere all'ingresso nel mercato
unico digitale, anche per l'accesso ai mezzi di comunicazione e ai contenuti
didattici e culturali. Viceversa, il ricorso a norme tecniche nazionali
discordanti può rallentare in modo significativo l'innovazione e mettere le
imprese europee in posizione di svantaggio nei confronti del resto del mondo.
In
particolare, le norme aperte garantiscono l’interoperabilità e promuovono
l'innovazione e l'abbassamento delle barriere all'ingresso nel mercato
unico digitale, anche per l'accesso ai mezzi di comunicazione e ai contenuti
didattici e culturali. Viceversa, il ricorso a norme tecniche nazionali
discordanti può rallentare in modo significativo l'innovazione e mettere le
imprese europee in posizione di svantaggio nei confronti del resto del mondo.
Le norme avrebbero, a giudizio della Commissione, notevoli effetti economici positivi in quanto:
• promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno;
• incoraggiano lo sviluppo di nuovi prodotti e di migliori condizioni di offerta;
• rafforzano la concorrenza e riducono i costi di produzione e di vendita;
• migliorano la qualità e aumentano la sicurezza per i consumatori.
La Commissione, inoltre, ritiene che sia necessario garantire un’adeguata tutela dei diritti fondamentali, poiché la normazione potrebbe avere implicazioni nell’ambito dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché alla libertà d'impresa e al diritto di proprietà.
In particolare, la Commissione si concentra su cinque settori prioritari: cloud computing, Internet of things, 5G, cybersicurezza e tecnologie dei dati.
Viene preannunciato, inoltre, il cofinanziamento di prove e sperimentazioni di tecnologie per accelerare l’elaborazione delle norme tecniche, anche attraverso partenariati pubblico-privato, per garantire la definizione di norme tecniche atte a stimolare l’innovazione e la crescita delle imprese.
 Infine, la Commissione si impegna
a:
Infine, la Commissione si impegna
a:
· dalla metà del 2016, studiare le possibilità di istituire e finanziare meccanismi di sostegno per rafforzare la partecipazione europea alla definizione di norme a livello mondiale, attraverso il monitoraggio delle attività di normazione globali nel settore delle TIC, e sostenere una maggiore partecipazione di esperti europei;
a) migliorare l’accessibilità e l’affidabilità delle informazioni sul campo di applicazione dei brevetti, comprese misure volte ad aumentare la trasparenza e la qualità delle dichiarazioni sui brevetti essenziali per le norme;
b) precisare gli elementi essenziali di una metodologia equa, efficace e applicabile per le concessioni delle licenze, sulla base di condizioni ragionevoli e non discriminatorie;
c) favorire un metodo di risoluzione delle controversie efficace ed equilibrato.
L’obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione può riguardare diversi elementi, come le diverse categorie e dimensioni dei prodotti o le specifiche tecniche di prodotti e servizi per i quali la compatibilità o l’interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali.
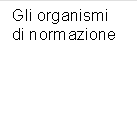 Le
norme europee sono adottate dagli organismi di normazione europei, ossia
il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di
normazione elettrotecnica (Cenelec), basati sul principio della
rappresentanza nazionale, e l’Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione (ETSI).
Le
norme europee sono adottate dagli organismi di normazione europei, ossia
il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di
normazione elettrotecnica (Cenelec), basati sul principio della
rappresentanza nazionale, e l’Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione (ETSI).
Gli organismi di normazione nazionali (per l’Italia, UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione e CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano) devono incoraggiare e facilitare la partecipazione dei soggetti interessati.
La normazione si fonda sui principi riconosciuti dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC): coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza.
All’interno dell’UE le norme sono adottate anche da organismi nazionali di normazione ed è quindi possibile che esse contrastino tra loro, creando ostacoli tecnici sul mercato interno. Per tale motivo è necessario mantenere lo scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione in merito alle attività attuali e future di normazione, ivi compresa l’applicazione del principio del mantenimento dello status quo applicabile agli organismi nazionali nel quadro delle organizzazioni europee di normazione, che prevede il ritiro delle norme nazionali dopo la pubblicazione di una nuova norma europea.
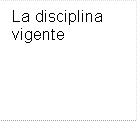 In
ambito europeo la materia è attualmente disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012
sulla normazione europea, che prevede norme riguardanti:
In
ambito europeo la materia è attualmente disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012
sulla normazione europea, che prevede norme riguardanti:
· la cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione;
· l’elaborazione di norme europee per i prodotti e per i servizi;
· l’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC cui fare riferimento negli appalti pubblici;
· il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei soggetti interessati.
Per quanto riguarda l’individuazione delle specifiche tecniche delle TIC, il suddetto regolamento prevede che la Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro, può decidere di identificare, modificare o ritirare le specifiche tecniche delle TIC per consentire l’interoperabilità in materia di appalti pubblici per l’acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell’informazione. Le decisioni sono adottate previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC, che comprende le organizzazioni europee di normazione, gli Stati membri e i soggetti interessati. Tale previsione non impedisce, tuttavia, alle organizzazioni europee di normazione di continuare a elaborare norme nel settore delle TIC, al fine di garantire la coerenza ed evitare la frammentazione o la duplicazione.
La comunicazione si richiama, inoltre, al “piano integrato di normazione per individuare e determinare le priorità fondamentali nel settore, concentrandosi sulle tecnologie e i settori considerati d'importanza critica per il mercato unico digitale", previsto dalla Strategia per il mercato unico digitale, per la cui predisposizione, tuttavia, allo stato non risultano ancora adottate iniziative puntuali.
Tutti i settori dell'economia fanno sempre più affidamento sulle tecnologie digitali, che si evolvono sempre più rapidamente, superando la velocità di cambiamento dei settori e delle industrie tradizionali. La definizione tempestiva e armonizzata di norme per le TIC è, quindi, necessaria per consentire all’industria europea di competere e di immettere nuovi prodotti sul mercato mondiale.
D’altra parte, il valore dei sistemi digitali deriva sempre più da applicazioni e dati transettoriali e dalla convergenza di tecnologie. Questo rende più difficili i processi di definizione delle norme tecniche, per cui occorrono soluzioni interoperabili basate su sistemi e interfacce aperti.
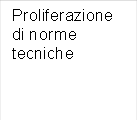 Attualmente
sussiste una proliferazione di norme tecniche con diverse comunità
coinvolte nella definizione delle stesse (ad esempio, nel settore
dell'Internet of things, esistono oltre 600 norme strettamente
correlate tra loro). In tali casi, è essenziale procedere, in primo luogo, alla
mappatura di tutte le norme tecniche pertinenti per consentire agli
organismi di normazione di orientarsi in tale complessità.
Attualmente
sussiste una proliferazione di norme tecniche con diverse comunità
coinvolte nella definizione delle stesse (ad esempio, nel settore
dell'Internet of things, esistono oltre 600 norme strettamente
correlate tra loro). In tali casi, è essenziale procedere, in primo luogo, alla
mappatura di tutte le norme tecniche pertinenti per consentire agli
organismi di normazione di orientarsi in tale complessità.
La crescente complessità ha ripercussioni anche sui diritti di accesso alle norme tecniche. Infatti, la convergenza di molte tecnologie può generare un rischio di incertezza sull’identificazione dei titolari di brevetti essenziali per le norme, sui costi dei diritti di proprietà intellettuale e sulla metodologia usata per calcolare il valore delle condizioni di licenza.
La Commissione ribadisce che la normazione delle TIC continuerà ad essere principalmente volontaria, ottenuta per consenso e basata su principi di trasparenza, apertura, imparzialità, consenso, efficacia, pertinenza e coerenza. Tuttavia, ad avviso della Commissione, un elenco più chiaro di priorità per la normazione delle TIC motiverebbe gli organismi di normazione nel settore delle TIC a lavorare con più partenariati intersettoriali, rafforzando la cooperazione con gli organismi europei di normazione, nonché con una maggiore convalida delle norme tramite esperimenti di ricerca e sviluppo.
 Il suddetto
regolamento 1025/2012 prevede il finanziamento della normazione europea a
favore delle organizzazioni di normazione e di altre organizzazioni europee
che rispondano a determinati requisiti. I finanziamenti avvengono sotto
forma di sovvenzioni, con o senza invito a presentare proposte, o contratti
successivi a procedure di appalti pubblici.
Il suddetto
regolamento 1025/2012 prevede il finanziamento della normazione europea a
favore delle organizzazioni di normazione e di altre organizzazioni europee
che rispondano a determinati requisiti. I finanziamenti avvengono sotto
forma di sovvenzioni, con o senza invito a presentare proposte, o contratti
successivi a procedure di appalti pubblici.
Gli stanziamenti possono coprire anche le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie, inclusi studi, riunioni, attività d’informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d’informazioni, nonché qualsiasi altra spesa per l’assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normazione.
La comunicazione in esame presenta un piano d'azione prioritario per la normazione delle tecnologie nell'economia digitale.
In primo luogo, viene identificato un elenco di ambiti prioritari per i quali il miglioramento della normazione delle TIC è ritenuto più urgente, accompagnato da un calendario.
In secondo luogo, la Commissione propone un processo politico ad alto livello, per convalidare, monitorare e adattare l'elenco delle priorità.
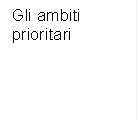 Entrambe
le parti del piano prioritario saranno portate avanti congiuntamente.
Entrambe
le parti del piano prioritario saranno portate avanti congiuntamente.
La Commissione ha individuato i seguenti ambiti prioritari:
· il cloud computing;
· l'Internet delle cose (IoT);
· le reti di comunicazione 5G;
· la cybersicurezza;
· le tecnologie di dati e di big data.
Tali settori sono stati selezionati in base al parere della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC, che riunisce le parti interessate dell'industria, gli organismi di normazione, i Governi e i rappresentanti della società civile.
Poiché si tratta di tecnologie convergenti, le azioni di normazione delle TIC non sarebbero limitate ad un unico ambito. Infatti, dalle priorità proposte trarrebbero benefici anche settori quali la sanità elettronica (eHealth), le reti energetiche intelligenti, i sistemi di trasporto intelligenti e i veicoli connessi e automatizzati, compresi i treni, le tecnologie produttive avanzate, le abitazioni, le città e l'agricoltura intelligenti. Per rispondere ai cambiamenti nelle tecnologie e nella società è prevista una revisione periodica delle priorità.
Tale contesto è illustrato in modo sintetico dalla seguente figura:
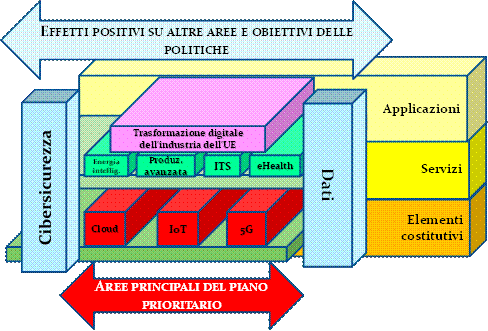
Le azioni individuate integreranno altri strumenti di normazione previsti per la politica di normazione europea, come:
· il programma continuativo per la normazione delle TIC, previsto nell’ambito dell’Agenda digitale europea, che identifica in dettaglio i settori in cui le norme potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmatici legati alle TIC, anche attraverso azioni complementari di sensibilizzazione e di prova dell'interoperabilità, volte a garantire l'effettiva adozione delle norme;
· l’iniziativa congiunta sulla normalizzazione europea prevista dalla Strategia per il mercato unico digitale (con cui la Commissione intende ammodernare il partenariato esistente per la definizione di norme in collaborazione con gli interlocutori interessati - industria, organizzazioni europee di normalizzazione, PMI - con l’obiettivo di fare dell'UE un hub internazionale della normalizzazione);
· il quadro europeo di interoperabilità per i servizi pubblici europei, di cui alla comunicazione COM(2010) 744.
Per quanto riguarda il cloud computing – per il quale si rinvia per ulteriori approfondimenti al dossier relativo alla comunicazione sull'iniziativa europea per il cloud computing COM(2016)178 – si sottolinea l'importanza di ampliare la base degli utenti delle reti di ricerca e istruzione, ideali per progettare, specificare, testare e distribuire le norme tecniche.
L'adozione dei servizi di cloud computing da parte delle imprese, dei consumatori, delle pubbliche amministrazioni e del settore scientifico richiede un accesso agevole e senza interruzioni, ma anche il rispetto di adeguati livelli di protezione dei dati, di sicurezza e di servizio. La comunicazione sull'iniziativa europea per il cloud computing sottolinea la necessità di far uso delle norme e delle certificazioni esistenti, prospettando anche l’eventualità di creare una certificazione e un’etichettatura a livello europeo.
Le norme comuni aperte favorirebbero l'accesso degli utenti a nuovi servizi, mentre la portabilità delle applicazioni e dei dati tra diversi fornitori di servizi cloud consentirebbero di evitare il "lock-in", ossia la dipendenza da un unico fornitore.
In tale ambito, la Commissione intende:
· sostenere il finanziamento dello sviluppo e dell'uso delle norme TIC necessarie all’interoperabilità e alla portabilità del cloud, con un utilizzo maggiore di elementi open source, ossia con codice sorgente aperto (entro la fine del 2016);
· agevolare l'adozione dei servizi di cloud computing, sostenendo la definizione di norme internazionali sul livello di servizio, al fine di garantire trasparenza e qualità agli utenti finali, soprattutto alle PMI (entro la metà del 2017);
· chiedere agli organismi europei di normazione di aggiornare la mappatura delle norme del cloud e gli orientamenti per gli utenti finali (soprattutto PMI e settore pubblico), in collaborazione con gli organismi di normazione internazionale, i fornitori di servizi cloud e gli utenti finali (entro la metà del 2017).
L'IoT è una tecnologia emergente che collega più oggetti ad Internet: elettrodomestici, dispositivi elettronici indossabili, veicoli, sensori e così via. Si prevede che il numero di tali dispositivi connessi supererà i 20 miliardi entro il 2020. L'IoT ha, inoltre, il potenziale per offrire soluzioni in ambiti importanti, quali il cambiamento climatico o l’efficienza energetica e delle risorse.
Il contesto dell'IoT è attualmente molto frammentato per effetto delle numerose soluzioni proprietarie o semi-chiuse e delle molteplici norme già esistenti.
Anche in tale settore, ad avviso della Commissione, è necessario creare un sistema di norme aperte che integrino diverse tecnologie, basato sulla cooperazione internazionale e su un quadro normativo che tuteli i diritti di proprietà intellettuale, con un accesso equo ed agevole ai brevetti essenziali per le norme tecniche.
In tale ambito, la Commissione intende:
· promuovere un ambiente interoperabile, in collaborazione con gli organismi di normazione. In fase di verifica dei progressi compiuti, la Commissione valuterà anche la necessità di ulteriori iniziative per i casi di mancata interoperabilità e la possibilità di adottare misure giuridiche per raccomandare norme appropriate;
· promuovere uno spazio di numerazione interoperabile per l'IoT che superi i limiti geografici e un sistema aperto per l'identificazione e l'autenticazione degli oggetti;
· valutare l'elaborazione di norme a tutela della vita privata e della sicurezza, ad esempio attraverso un'etichetta "trusted IoT" (IoT affidabile);
· promuovere la diffusione delle norme IoT negli appalti pubblici al fine di evitare il lock-in, soprattutto nel settore dei servizi delle città, compresa la fornitura di acqua e energia.
Data la natura globale e le connessioni che crea tra il settore delle TIC e gli altri settori, la rete 5G dipende in modo decisivo dalle norme tecniche per garantire l'interoperabilità, la sicurezza, la tutela della vita privata e la protezione dei dati.
La Commissione intende sviluppare un piano d'azione per la rete 5G per la diffusione su ampia scala delle reti 5G nell'UE oltre il 2020, che farà leva sulla diffusione di norme tecniche 5G.
Una delle priorità della Commissione è di garantire che il processo di normazione della rete 5G supporti fin dall'inizio i modelli di business digitali innovativi dei mercati verticali (automobilistico, della sanità, dell'industria manifatturiera). Per quanto concerne le norme tecniche di accesso radio, le soluzioni che hanno la priorità sono quelle che garantiscono la retrocompatibilità con i sistemi esistenti (2G, 3G, 4G) e che migliorano l'efficienza di uso dello spettro, in linea con la politica dell'UE in materia di spettro radio.
In tale ambito, la Commissione intende:
· favorire l'emergere di norme tecniche industriali globali sotto la leadership dell'UE per le tecnologie 5G più importanti[1] e le architetture di rete, sfruttando i risultati del partenariato pubblico-privato per il 5G avviato dalla Commissione nel dicembre 2013, per il quale l’UE investirà 700 milioni di euro per sette anni attraverso il programma Horizon 2020;
· garantire che le norme 5G siano compatibili con i modelli di business digitali innovativi dei mercati verticali (automobilistico, della sanità, dell'industria manifatturiera), attraverso una più ampia partecipazione delle industrie con esigenze settoriali specifiche agli organismi di normazione del 5G (nel 2016).
La cybersicurezza costituisce il fondamento della fiducia e dell'affidabilità del mercato unico digitale. Pertanto, sono necessari sistemi di autenticazione sicuri, interoperabili e senza discontinuità tra oggetti, dispositivi, persone ed enti per garantire un accesso e uno scambio di dati trasparente.
Ad avviso della Commissione, potranno essere necessari nuovi protocolli di autenticazione, per infondere fiducia nei sistemi di identificazione e autenticazione elettronica senza soluzione di continuità, supportati anche da norme di interoperabilità trasversale globale basate su analoghi regimi di autenticazione.
L'integrazione di principi di sicurezza fin dalla progettazione (security-by-design) è ritenuta essenziale per la cybersicurezza in tutte le norme TIC. A tal fine, sono considerati necessari progetti pilota di implementazione in contesti reali, per testare e convalidare le prestazioni di tali norme, insieme ad un approccio coordinato in materia di etichettature e certificazioni di cybersicurezza.
In tale ambito, la Commissione intende:
· invitare gli organismi di normazione e le parti interessate a elaborare orientamenti per quanto riguarda l'IoT, il 5G, il cloud, i big data e le fabbriche intelligenti (entro la fine del 2016). Sulla base dei progressi, la Commissione valuterà l'adozione di una raccomandazione entro la fine del 2017 per l'integrazione della cybersicurezza e l'applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati;
· invitare gli organismi di normazione e le parti interessate a elaborare norme che sostengano l'interoperabilità globale e l'autenticazione affidabile senza discontinuità tra dispositivi, oggetti, persone fisiche e giuridiche sulla base di modelli di fiducia analoghi, in linea con il quadro normativo eIDAS[2] (entro la fine del 2018);
· sostenere gli organismi di normazione e le iniziative pubblico-privato nell'elaborazione di orientamenti, basati su norme tecniche, per la gestione del rischio in materia di cybersicurezza per le imprese e di audit per le autorità con responsabilità di sorveglianza (nei prossimi tre anni).
Ogni minuto in tutto il mondo vengono generati 1,7 milioni di miliardi di byte di dati, più di 6 megabyte di dati a testa ogni giorno. Si tratta di informazioni che provengono da fonti diverse (persone, macchine, sensori) e consistono in dati sul clima, immagini satellitari, immagini e video digitali, registrazioni di operazioni o segnali GPS. Secondo quanto riportato dalla Commissione europea, il settore dei dati cresce del 40% l’anno, sette volte più velocemente del mercato generale dell’informazione e della comunicazione, e le imprese che fondano i processi decisionali sulle conoscenze generate dai dati registrano un incremento di produttività intorno al 5-6%.
Ad avviso della Commissione, le norme aperte, così come le iniziative quali il portale Open Data[3], possono aiutare a superare gli ostacoli alla condivisione dei dati tra tecnologie, discipline scientifiche e Paesi. Le future infrastrutture di dati, compresa l’infrastruttura di dati europea annunciata nella comunicazione sul cloud computing, richiederanno norme non solo per la sicurezza e la tutela della vita privata, ma anche per i metadati, la conservazione dei dati, la semantica e i valori dei dati.
In tale ambito, la Commissione intende:
· aumentare gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare per norme e interoperabilità dei dati (a partire dal 2016);
· individuare le norme mancanti e progettare un’architettura di riferimento dei big data, tenendo conto degli attuali approcci a livello internazionale (entro il 2018), anche attraverso il partenariato pubblico-privato H2020 con Big Data Value Association[4], per il quale l’Ue stanzia più di 500 milioni di euro a valere sul programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 per 5 anni (2016-2020), cui dovrebbero corrispondere investimenti dei partner privati pari ad almeno il quadruplo (2 miliardi di euro). In base alle finalità del PPP, gestire i megadati potrebbe significare: fino al 30% del mercato mondiale dei dati a disposizione dei fornitori europei; 100.000 nuovi posti di lavoro connessi ai dati in Europa entro il 2020; il 10% in meno di consumi energetici, migliore assistenza sanitaria e macchinari industriali più redditizi;
· sostenere servizi infrastrutturali per l’accesso ai dati scientifici e per la loro conservazione a lungo termine, in linea con i requisiti del Cloud per la scienza aperta dell’iniziativa europea per il cloud computing (a partire dal 2016).
Dopo aver individuato i 5 settori prioritari, la comunicazione analizza le principali ripercussioni sull'industria e i consumatori, considerato che gli ambiti tecnologici prioritari identificati sono presenti in diversi settori industriali.
Vengono, quindi, riportati a titolo di esempio gli effetti attesi delle tecnologie prioritarie in settori specifici.
In materia di sanità elettronica, la Commissione europea ha adottato un piano d’azione per il periodo 2012-2020. Nel piano con il termine sanità elettronica (eHealth) si indica “l’uso delle TIC nei prodotti, servizi e processi sanitari accompagnato da cambiamenti di ordine organizzativo nei sistemi sanitari e nuove competenze, finalizzato a un miglioramento della salute dei cittadini, dell’efficienza e della produttività in ambito sanitario, nonché a un maggiore valore economico e sociale della salute; eHealth riguarda l’interazione tra pazienti e prestatori di servizi sanitari, la trasmissione di dati tra le varie istituzioni o la comunicazione inter pares tra pazienti e/o professionisti in ambito sanitario”.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che sistemi eHealth interoperabili potrebbero sostenere l'implementazione di reti europee, come previsto dalla direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, che prevede la diffusione della telemedicina (ossia la prestazione di servizi di assistenza sanitaria a distanza) su larga scala.
Una migliore interoperabilità permetterebbe un uso più efficiente dei dati sanitari e accrescerebbe la sicurezza nel settore medico, attraverso lo scambio delle cartelle cliniche elettroniche (che permettono la comunicazione dei dati del paziente tra le diverse figure professionali: medici di medicina generale, specialisti, care-team, farmacie), a cominciare dai dati riepilogativi sui pazienti e dalle prescrizioni elettroniche, in linea con le disposizioni in materia di dati personali.
In tale ambito, la Commissione afferma che continuerà a promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nella rete eHealth e nella comunità della ricerca per affrontare la questione dell’interoperabilità tra sistemi sanitari.
La Commissione incoraggerà, inoltre, le azioni volte a:
· promuovere la sicurezza e l’interoperabilità delle applicazioni di sanità mobile mHealth (alcuni esempi di mHealth sono applicazioni che misurano parametri vitali come la pressione del sangue, che aiutano a somministrare la giusta dose di insulina a un diabetico, che ricordano ai pazienti di assumere un farmaco, che danno consigli dietetici e per restare in forma e in buona salute). Secondo i dati diffusi dalla Commissione, oggi sono disponibili quasi 100.000 applicazioni di mHealth sulle diverse piattaforme (iTunes, Google Play, Windows Marketplace e BlackBerry World). Le 20 app gratuite più diffuse sono già installate su 231 milioni di dispositivi in tutto il mondo. Entro il 2017 saranno 3,4 miliardi le persone in possesso di uno smartphone e la metà di loro utilizzerà app di sanità mobile. Nello stesso anno, sfruttando tutte le potenzialità offerte da questa tecnologia, si potrebbero risparmiare ben 99 miliardi di euro di spese del sistema sanitario. Restano, tuttavia, da affrontare importanti questioni, quali la sicurezza delle app, l’uso dei dati e l’assenza di interoperabilità tra le soluzioni disponibili;
· accelerare la diffusione e l’ampliamento di scala della telemedicina e del telemonitoraggio (un servizio di telemedicina il cui obiettivo è sorvegliare le condizioni di salute dei pazienti a distanza);
· sostenere lo sviluppo e l’adozione di terminologie e di norme internazionali.
La promozione della diffusione senza discontinuità di veicoli connessi e automatizzati comporterebbe un notevole miglioramento delle prestazioni, della sicurezza e dell'efficienza del sistema dei trasporti. I veicoli connessi generano quantità di dati sempre maggiori e possono comunicare attraverso reti wireless con altri veicoli e con le infrastrutture di trasporto.
I rappresentanti delle parti interessate (partecipanti alla piattaforma cooperativa ITS, alla tavola rotonda del settore automobilistico e delle telecomunicazioni e al gruppo di alto livello Gear 2030) si sono impegnati a collaborare per sviluppare e promuovere:
· norme relative alla sicurezza e alla connettività;
· un'interfaccia avanzata e sicura, che consenta un accesso equo e non discriminatorio ai dati del veicolo, rendendo possibili i servizi di guida connessa e automatizzata;
· l'elaborazione di norme per le verifiche tecniche e di norme che garantiscano l'interoperabilità nell'implementazione.
Il lavoro svolto sulle norme relative ai veicoli connessi costituirà la base anche per i futuri veicoli automatizzati, che necessiteranno di norme di elevata qualità, che consentano di eseguire funzioni affidabili e sicure.
La tecnologia digitale è già pienamente applicata nel trasporto ferroviario e le imprese dell’UE sono tra i principali fornitori. Anche il settore ferroviario trarrà vantaggio dalla normazione delle TIC, compresi i trasporti intermodali.
Anche nel settore del trasporto merci la presenza di diversi operatori determina un’ampia varietà di sistemi con scarsa interoperabilità, impedendo il riutilizzo dei dati fra i diversi paesi e i diversi modi di trasporto e ostacolando lo sviluppo di nuove applicazioni e di nuovi servizi digitali multimodali.
Ad avviso della Commissione, è dunque necessario sviluppare norme per lo scambio di dati nel settore della logistica intermodale (compresa l’armonizzazione intermodale delle norme, la definizione di un vocabolario comune, e l’accordo sulle norme in merito a messaggi e contenuti dei documenti di trasporto per i diversi modi di trasporto).
Le soluzioni basate su smart grids (definite come “reti elettriche ottimizzate cui si aggiungono la comunicazione digitale bidirezionale fornitore-consumatore e sistemi di misurazione e controllo”) porterebbero a un risparmio dei costi e, insieme agli apparecchi intelligenti, consentiranno di gestire e di ridurre il consumo di energia. Le norme di sicurezza di alta qualità garantiscono che i sistemi energetici siano al sicuro.
In tale ambito, sono stati compiuti notevoli progressi dalla task force della Commissione per le reti e per gli apparecchi intelligenti, mentre sono ancora in corso le attività relative alla normazione per case e edifici intelligenti. La task force sulle reti intelligenti è stata istituita dalla Commissione europea nel 2009 con funzioni consultive su questioni legate all’impiego delle reti intelligenti. Essa è composta da cinque gruppi di esperti che si occupano di settori specifici.
Anche in tale ambito, ad avviso della Commissione, è necessario un impegno per affrontare la mancanza di interoperabilità tra le soluzioni attivate dagli Stati membri e concordare specifiche funzionali.
Infine, la comunicazione fa riferimento all’adozione di tecnologie di produzione avanzate da parte dell’industria, compresi l’agricoltura e il settore agroalimentare, per una produzione intelligente e una gestione intelligente dei processi, al fine di migliorare la produttività, ridurre i rifiuti e l’inquinamento e abbassare i costi della produzione.
I sistemi di produzione avanzati richiedono un livello senza precedenti di integrazione sistemica che superi le barriere tra discipline, gerarchie e fasi del ciclo di vita. La Commissione intende incoraggiare una stretta collaborazione tra ricercatori, industria e organismi di normazione al fine di creare le condizioni necessarie.
Ciò premesso, la Commissione s’impegna a collaborare con gli organismi di normazione delle TIC per fare sì che le loro strategie tengano conto delle esigenze che emergono dalla digitalizzazione dei settori industriali dei veicoli, dell’energia e della sanità elettronica.
In particolare, la Commissione intende:
· promuovere lo sviluppo di norme tecniche di interoperabilità, di architetture di riferimento europee e di piattaforme aperte intersettoriali per la digitalizzazione dell’industria europea (compresi la sperimentazione, la convalida e l'interoperabilità delle strutture di verifica tecnica, le etichette di affidabilità e i sistemi di certificazione);
· avviare progetti pilota di riferimento, al fine di convalidare su ampia scala le norme per i mercati del futuro, compresi i banchi di prova sperimentali, nel quadro dell’impresa comune Electronic Components & Systems for European Leadership (ECSEL). Si tratta di un partenariato pubblico-privato da 5 miliardi di euro, finalizzato a sostenere e rilanciare la capacità europea di produzione e progettazione nel settore dell'elettronica. L’iniziativa è al centro della Strategia europea per l'elettronica, che mira a mobilitare 100 miliardi di euro in investimenti privati e creare più di 250.000 posti di lavoro in Europa entro il 2020.
In conclusione, la Commissione ritiene che non sia sufficiente limitarsi a definire le priorità in materia di normazione delle TIC per il mercato unico digitale; occorre un impegno ad alto livello per la normazione da parte di un'ampia base di soggetti interessati, tra cui l’industria, gli organismi di normazione e la comunità scientifica, nonché le istituzioni dell’UE e le amministrazioni nazionali.
La Commissione propone pertanto un processo ad alto livello per realizzare le azioni prioritarie, che si baserà:
· sulla piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC;
· sul programma continuativo per la normazione delle TIC;
· sul programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea.
Gli elementi del processo sono:
· 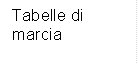 la convalida
delle priorità e il miglioramento dell’efficienza del processo di definizione
delle norme: la Commissione collaborerà con gli organismi europei di
normazione per elaborare calendari e tabelle di marcia annuali per
ciascuno dei prodotti della normazione descritti;
la convalida
delle priorità e il miglioramento dell’efficienza del processo di definizione
delle norme: la Commissione collaborerà con gli organismi europei di
normazione per elaborare calendari e tabelle di marcia annuali per
ciascuno dei prodotti della normazione descritti;
· 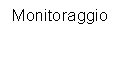 il monitoraggio
periodico dei progressi compiuti: la Commissione informerà periodicamente
il Parlamento europeo e il Consiglio, evidenziando in particolare le priorità
stabilite per le norme delle TIC per la realizzazione del mercato unico
digitale;
il monitoraggio
periodico dei progressi compiuti: la Commissione informerà periodicamente
il Parlamento europeo e il Consiglio, evidenziando in particolare le priorità
stabilite per le norme delle TIC per la realizzazione del mercato unico
digitale;
· 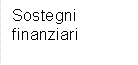 il sostegno
alla normazione prioritaria delle TIC: a partire dal 2016, la Commissione
intende sfruttare i fondi di Horizon 2020 e del meccanismo per collegare
l’Europa per rafforzare l'attività di normazione attuale e sviluppare
quella orientata al futuro, concentrandosi sulla promozione di norme aperte. La
Commissione finanzierà anche progetti pilota su larga scala negli ambiti
prioritari individuati, al fine di convalidare e migliorare l’adozione delle
norme. Al momento di stanziare fondi per gli organismi europee di normazione,
la Commissione terrà conto delle priorità nella normazione delle TIC;
il sostegno
alla normazione prioritaria delle TIC: a partire dal 2016, la Commissione
intende sfruttare i fondi di Horizon 2020 e del meccanismo per collegare
l’Europa per rafforzare l'attività di normazione attuale e sviluppare
quella orientata al futuro, concentrandosi sulla promozione di norme aperte. La
Commissione finanzierà anche progetti pilota su larga scala negli ambiti
prioritari individuati, al fine di convalidare e migliorare l’adozione delle
norme. Al momento di stanziare fondi per gli organismi europee di normazione,
la Commissione terrà conto delle priorità nella normazione delle TIC;
· politica equilibrata in materia di diritti di proprietà intellettuale, che tenga conto di diverse esigenze: un ritorno sugli investimenti; la sostenibilità del processo di normazione; un'ampia disponibilità delle tecnologie; le difficoltà delle PMI. In tale contesto, ad avviso della Commissione, servirebbe un approccio a livello mondiale per la concessione delle licenze, che garantisca un ritorno sugli investimenti equo per i titolari di brevetti essenziali per le norme e un accesso equo ai brevetti essenziali per le norme a tutte le parti interessate, soprattutto le PMI;
· rafforzamento della presenza dell’UE nel dialogo e nella cooperazione internazionale: la Commissione continuerà a collaborare in modo attivo con i principali partner internazionali (Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea del Sud) per garantire l’allineamento delle priorità a livello mondiale nel settore delle TIC ed evitare le duplicazioni delle attività.
Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l’esame dell’atto risulta avviato da parte di: Germania, Lussemburgo, Polonia, Svezia e Regno Unito.
In linea generale, si può rilevare che la comunicazione prefigura un complesso di iniziative molto ambizioso e a largo spettro che, rispetto alla disciplina vigente – il citato regolamento (UE) n. 1025/2012 - non si limitano a definire il quadro giuridico generale dell’attività di normazione, ma individuano specifici settori di intervento prioritario e specifici obiettivi riferiti a ciascuno dei medesimi settori. In tal senso, potrebbe risultare opportuno valutare se la materia possa essere interamente demandata alle norme tecniche cui la comunicazione rinvia ovvero se non si debba ipotizzare l’individuazione di una disciplina di rango legislativo che fissi parametri e obiettivi e disponga le opportune risorse da assegnare, anche al fine di garantire maggiore trasparenza nei processi di definizione delle regole e di consentire agli Stati membri di monitorare e valutare il dettaglio delle regole che si prefigura di adottare.
La standardizzazione è un'attività essenziale per uniformare l'offerta di tecnologie presenti nel mercato ed è un elemento determinante nel moderno processo di sviluppo industriale. Molti settori dell'industria moderna sono governati da standard e in ragione di ciò si può sostenere che proprio la creazione di standard internazionali è nata per consentire l'interoperabilità delle tecnologie o metodologie anche fuori dai confini nazionali. In altre parole si può sostenere che senza standard internazionali è molto difficile "globalizzare" il mercato.
Per queste ragioni, sia i tecnici esperti dei vari settori industriali sia i fautori di politiche pubbliche riconoscono l'importanza degli standard come strumento strategico per le economie nazionali. Gli standard stabiliscono la dimensione, la forma o la capacità di un prodotto, di un processo o di un sistema. Essi possono anche definire i termini d'uso di tecnologie in modo tale che non vi sia nessun equivoco nell'applicazione e nell'utilizzo delle tecniche incluse in uno standard.
Sotto il profilo giuridico gli standard sono regole tecniche o norme tecniche che stabiliscono le specificazioni e le varie procedure relative al know-how per assicurare l'affidabilità di materiali, prodotti, metodi e/o servizi. Fra i vari comparti economici caratterizzati dalla presenza di standard, quelli contraddistinti da una cospicua mole di brevetti hi-tech, su tutti il settore dell'Information and Communication Technology (ICT), presentano problemi notevolmente complessi. Gli standard del settore ICT sono essenziali per garantire l'interoperabilità e l'interconnessione fra dispositivi tecnologici diversi fra loro ed il loro corretto funzionamento.
Il Regolamento n. 1025/2012 del 25 ottobre 2012 è volto a disciplinare il tema degli standard e stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione, l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, l'identificazione delle specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento, il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea.
Si segnala che l’articolo 8, comma 1, del disegno di legge di Delegazione europea, attualmente all’esame del Senato (A.S. 2345) prevede una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea ed alla direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
L'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione può riguardare svariati elementi come la normazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali.
I soggetti coinvolti nel procedimento di normazione a livello europeo sono: il comitato europeo di normazione (CEN), il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec), Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).
Tutti i soggetti menzionati svolgono le loro attività sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza.
Altri soggetti che sono interessati alla normazione e partecipano al procedimento di normazione a livello nazionale sono: le autorità pubbliche nazionali, le piccole e medie imprese (PMI) e, infine, gli organismi di normazione nazionali, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e le parti sociali.
L’accesso alle norme da parte delle PMI
Gli organismi di normazione nazionali incoraggiano e facilitano l'accesso delle PMI alle norme e ai processi di sviluppo delle stesse, al fine di conseguire un più alto livello di partecipazione al sistema di normazione, per esempio tramite:
a) l'individuazione, nel quadro dei rispettivi programmi di lavoro annuali, di progetti di normazione di particolare interesse per le PMI;
b) la concessione alle PMI dell'accesso alle attività di normazione senza obbligo di adesione a un organismo di normazione nazionale;
c) la concessione di un accesso gratuito o di tariffe speciali per partecipare alle attività di normazione;
d) la concessione dell'accesso gratuito ai progetti di norme;
e) la messa a disposizione gratuita di estratti di norme sui rispettivi siti Internet;
f) l'applicazione di tariffe speciali per la fornitura di norme o l'offerta di pacchetti di norme a prezzo ridotto.
Gli organismi di normazione nazionali trasmettono alle organizzazioni europee di normazione una relazione annuale concernente le attività di normazione e qualsiasi altro provvedimento posto in essere per migliorare le condizioni di uso delle norme da parte delle PMI e la partecipazione di queste ultime al processo di elaborazione delle norme.
Gli organismi di normazione nazionali pubblicano tali relazioni sui propri siti web.
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norma nazionale in fase di elaborazione da parte di UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione e di CEI, raccolti per organo tecnico di competenza.
I due documenti hanno un aggiornamento periodico in modo da fornire un panorama sempre attuale delle attività che si stanno sviluppando.
Programma di normazione nazionale UNI
Programma di normazione nazionale CEI
Si ricorda che UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione – e CEI, sono stati nominati in sede europea, quale organismi nazionale di normazione tecnica ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.
UNI è un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione europea, che da quasi 100 anni elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le norme UNI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Sono soci UNI le imprese, i professionisti, le associazioni, gli enti pubblici, i centri di ricerca, gli istituti scolastici e accademici, le rappresentanze dei consumatori e dei lavoratori, il terzo settore e le organizzazione non governative, che insieme costituiscono una piattaforma multi-stakeholder di confronto tecnico unica a livello nazionale.
UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO) e organizza la partecipazione delle delegazioni nazionali ai lavori di normazione sovranazionale, con lo scopo di:
promuovere l’armonizzazione delle norme necessaria al funzionamento del mercato unico,
sostenere e trasporre le peculiarità del modo di produrre italiano in specifiche tecniche che valorizzino l’esperienza e la tradizione produttiva nazionale.
Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano è un'Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con la partecipazione diretta - su mandato dello Stato Italiano - nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e internazionale (IEC – International Electrotechnical Commission).
Fondato nel 1909 e riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'Unione europea (Regolamento Europeo), il CEI propone, elabora, pubblica e divulga Norme tecniche che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola dell’arte” di prodotti, processi, sistemi e impianti elettrici.
La Legge italiana n. 186 del 1º marzo 1968 stabilisce infatti che “Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte” e che gli stessi “realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte”.
Le Norme CEI, in larga maggioranza recepimenti di documenti normativi internazionali, costituiscono anche uno strumento univoco e ben codificato per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione nazionale ed europea.
Il processo di normazione tecnica si basa sul principio del consenso, a seguito della partecipazione e della collaborazione di tutte le parti interessate. Un progetto di norma nasce per rispondere a specifiche esigenze espresse dal mercato di disporre di riferimenti condivisi a livello nazionale (europeo o internazionale). Il progetto di Norma CEI si sviluppa nell’ambito dei Comitati Tecnici di riferimento in cui lavorano oltre 3.000 Esperti nazionali, designati dai Soci di Diritto, Promotori ed Effettivi e provenienti da Ministeri, Enti pubblici e privati, Università, Centri di ricerca e prove, Organismi di certificazione, Aziende industriali, Ordini professionali, Associazioni di categoria e culturali.
[1] Rete di accesso radio (RAN), rete centrale (core network)
[2] Il regolamento c.d. “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature), in vigore dal 17 settembre 2014, reca le condizioni per il riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica e le regole comuni per le firme elettroniche, l’autenticazione web ed i relativi servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.
[3] Il portale fornisce un catalogo di metadati che dà accesso ai dati delle istituzioni e di altri organi dell’UE. Per agevolarne il riutilizzo, i metadati si basano su norme comuni di codifica e vocabolari standard. I dati sono disponibili in formati che ne permettono la lettura da parte di persone o di computer e possono essere riutilizzati gratuitamente, a condizione di citare la fonte. A un numero limitato di dati si applicano condizioni specifiche di riutilizzo, dovute principalmente alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
[4] Associazione senza scopo di lucro di cui fanno parte, tra gli altri, società quali Atos, Nokia Solutions and Networks, Orange, Sap, Siemens e istituti di ricerca come il Fraunhofer e il centro di ricerca tedesco sull’intelligenza artificiale.