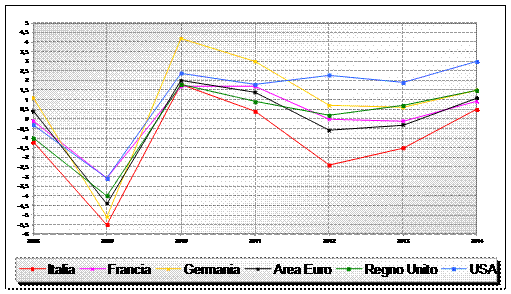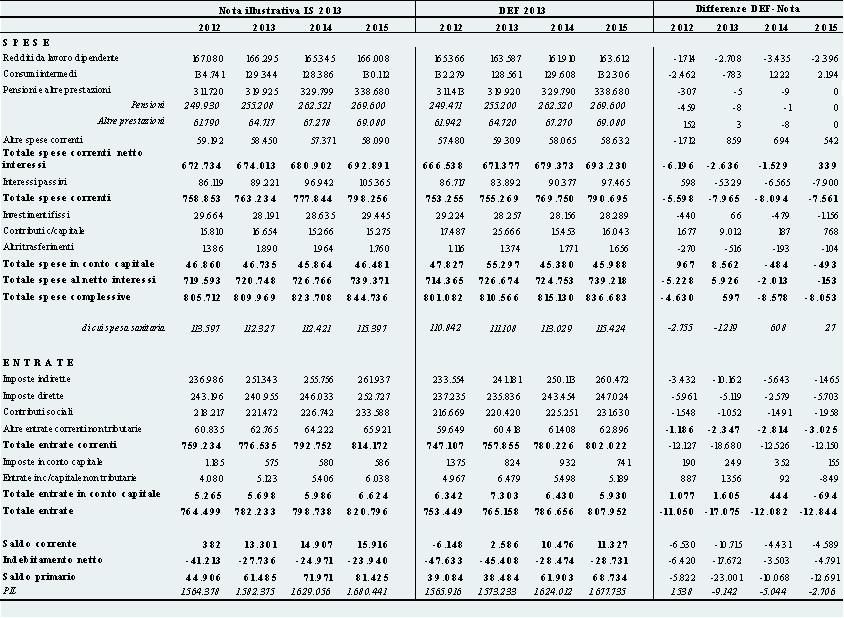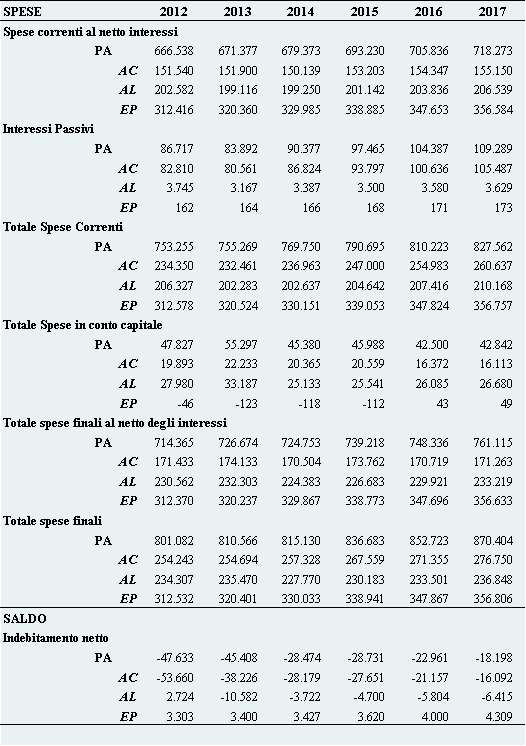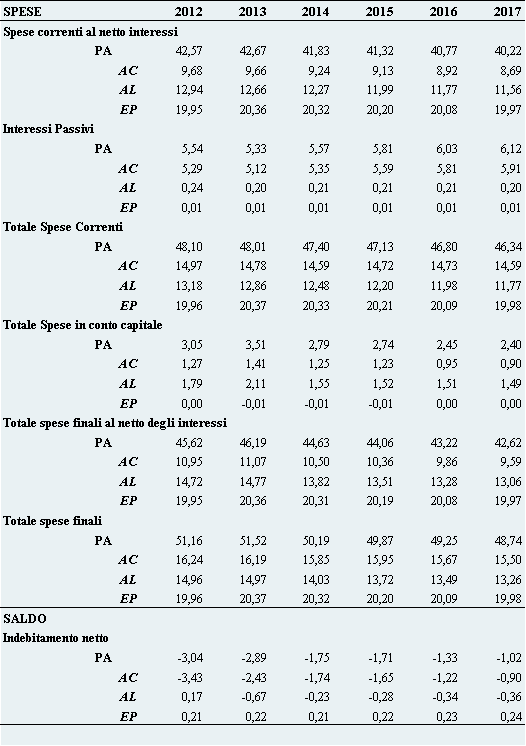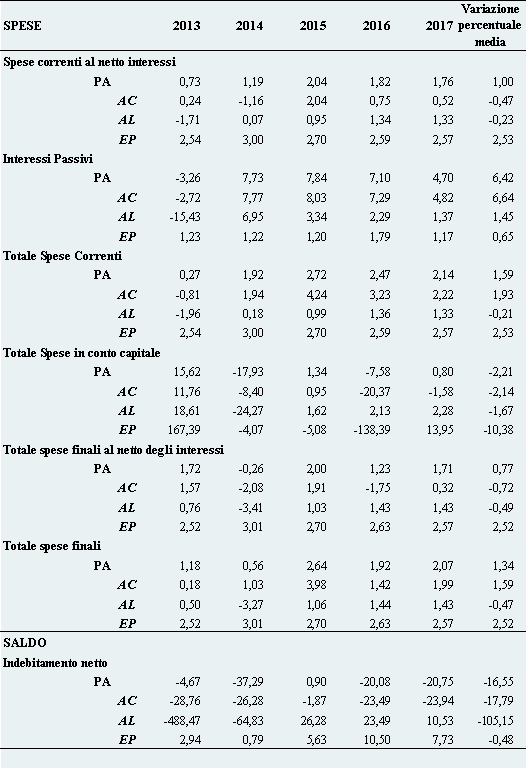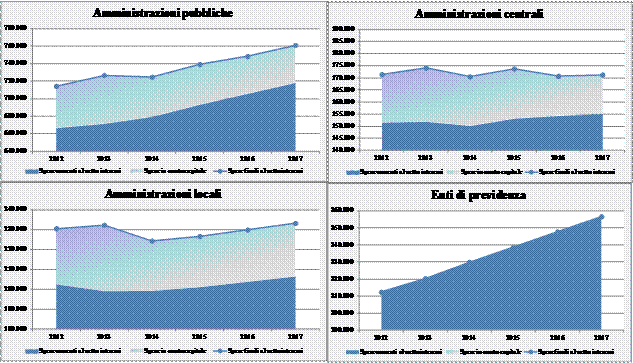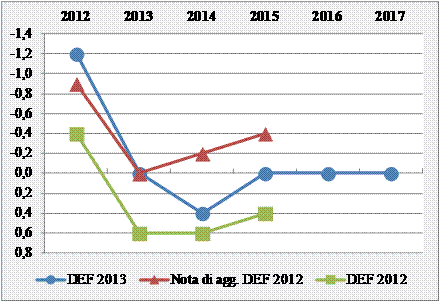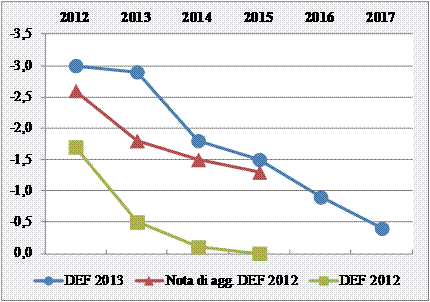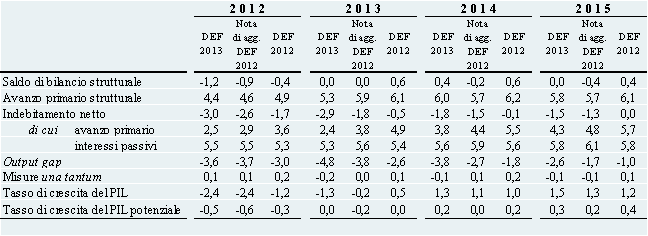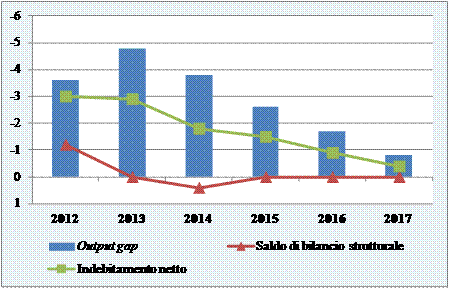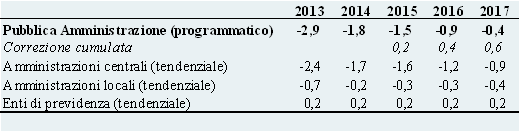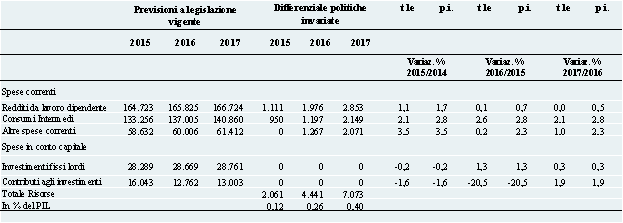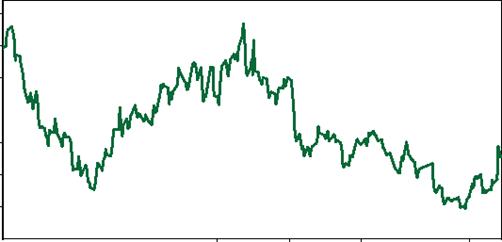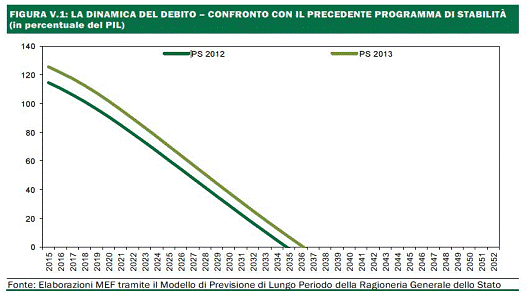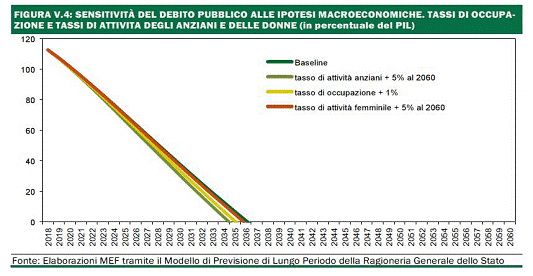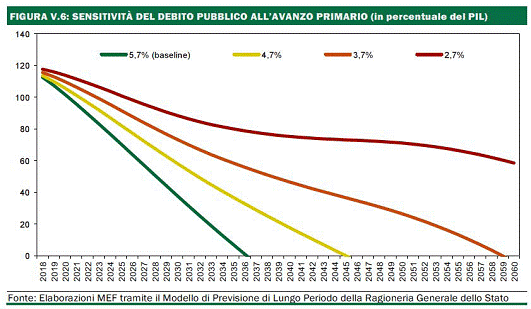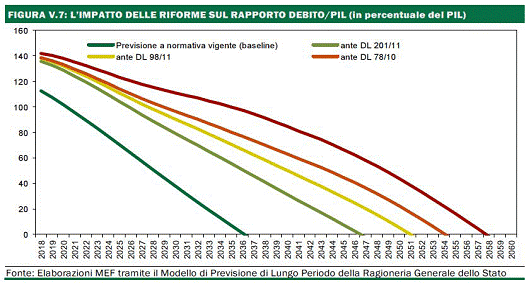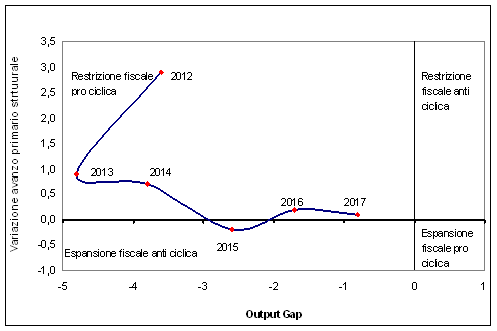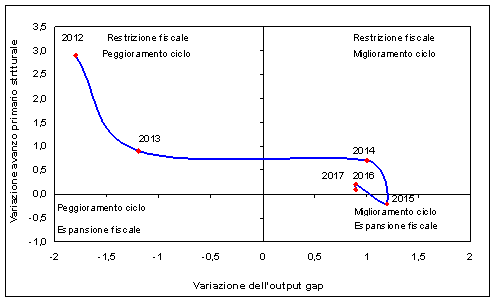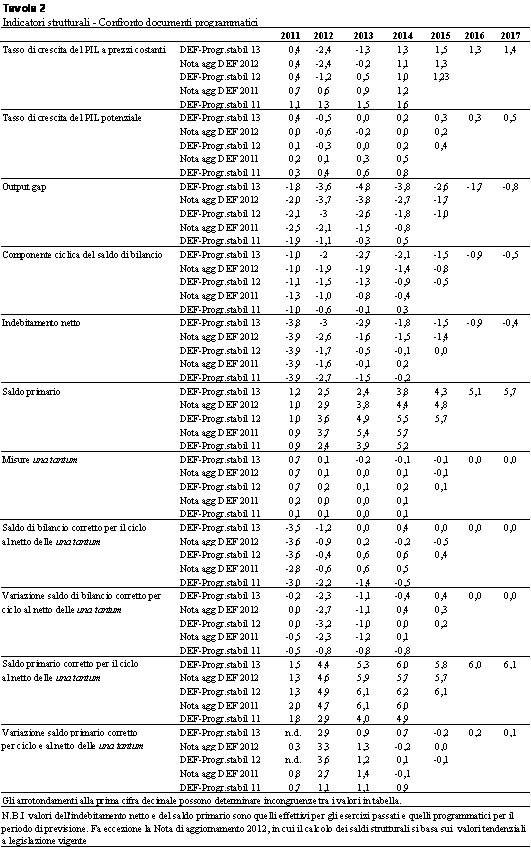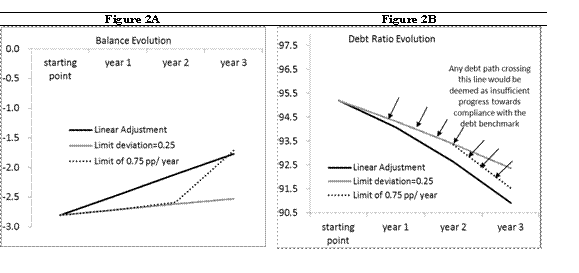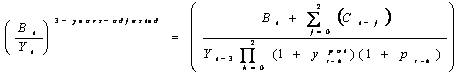Premessa
Ai sensi della legge di contabilità, il Documento di
economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione
della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di
medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze
pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche,
adottati dall’Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita
europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente,
sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020. Il DEF
enuncia, pertanto, le modalità e la tempistica attraverso le quali l’Italia
intende conseguire il risanamento strutturale dei conti pubblici e perseguire
gli obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione
sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell’ambito dell’Unione
europea.
Il documento, che s’inquadra al centro del nuovo processo di
coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri
dell’UE - il cd. Semestre europeo – è presentato alle Camere, per le conseguenti
deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine
di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di
politica economica in tempo utile per l’invio al Consiglio dell'Unione europea
e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di
Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR) contenuti,
rispettivamente, nella prima e nella terza sezione del Documento.
Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di
una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema
del Programma di Stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le
informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare,
dal nuovo Codice di condotta[1]
sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento
agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione
del debito pubblico.
La sezione
contiene gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza
pubblica almeno per il triennio successivo; l’indicazione degli obiettivi
programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il
debito delle PA, articolati per i sottosettori della PA, accompagnata anche da
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di
raggiungere gli obiettivi. La sezione deve, inoltre, contenere le previsioni
di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende
adottare per garantirne la sostenibilità, nonché le diverse ipotesi di
evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno
lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.
Nella seconda sezione sono indicate le regole
generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in
linea con l’esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme
efficaci di controllo dell’andamento della spesa pubblica.
La sezione reca,
tra l’altro, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle
amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti
rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il
triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e
del saldo di cassa; l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica, di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni
pubbliche; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i
principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio
successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni
dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a
quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità,
nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
All’interno della sezione deve inoltre essere dato conto anche delle risorse
destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei
fondi nazionali addizionali. In allegato alla sezione è riportata una nota
metodologica che espone analiticamente i criteri di formulazione delle
previsioni tendenziali.
La terza sezione reca, infine, lo schema del
Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di
Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi
nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati
dalla nuova Strategia “Europa 2020” (cfr. Approfondimento n. 1). In
tale ambito sono indicati:
§
lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli
conseguiti;
§
gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di
natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
§
le priorità del Paese, con le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli
obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità;
§
i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di
crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema
economico e di aumento dell'occupazione.
Come sarà più
diffusamente illustrato in seguito, si segnala che il PNR 2013, essendo
stato presentato dal Governo in concomitanza con lo svolgimento delle procedure
per la formazione di un nuovo Esecutivo, non contiene quest’anno un’agenda di
priorità per il futuro, limitandosi invece a riportare un’analisi dettagliata
delle riforme adottate e dei relativi primi risultati, nonché a indicare le
aree di policy dove è maggiormente necessario intervenire per il futuro.
In allegato al DEF – ovvero alla Nota di aggiornamento del
medesimo da presentare ogni anno entro il 20 settembre – sono indicati gli
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,
da presentarsi alle Camere entro il mese di gennaio.
In base alla legge di contabilità nazionale, in allegato
al DEF devono essere riportate una serie d’informazioni supplementari:
a)
una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle
aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, in cui è evidenziato il
contributo dei fondi nazionali addizionali, con particolare riguardo alla
coesione sociale, alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione
territoriale degli interventi;
b)
il Programma delle infrastrutture strategiche, previsto
dalla “Legge obiettivo”, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma
relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
c)
un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente, relativo
allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra derivanti dagli obblighi internazionali
assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi;
d)
un documento recante l’esposizione, con riferimento agli ultimi
dati di consuntivo disponibili, delle risorse del bilancio dello Stato
destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie
economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali
e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
e)
il rapporto sullo stato di attuazione della legge di
contabilità e finanza pubblica e sullo stato di attuazione delle norme
finalizzate all’armonizzazione delle regole contabili degli enti territoriali,
prevista dalla legge di attuazione del federalismo fiscale.
Il DEF, nella prima sezione relativa al Programma di
Stabilità, evidenza come nel 2012 l’economia mondiale abbia registrato un
rallentamento rispetto al 2011, risultato più accentuato nel quarto trimestre
dell’anno.
Il PIL mondiale, secondo
i dati del Fondo Monetario internazionale, risulterebbe cresciuto nel 2012
ad un tasso del 3,2 per cento e il commercio del 2,5 per cento,
a livelli nettamente inferiori rispetto al 2011.
Tabella
1.1
Il
recupero del commercio mondiale (variazioni
percentuali)
|
FMI
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Commercio internazionale
|
6,0
|
2,5
|
3,6
|
5,3
|
6,1
|
6,2
|
6,4
|
|
PIL mondiale
|
4,0
|
3,2
|
3,3
|
4,0
|
4,4
|
4,5
|
4,5
|
Fonte: FMI, World Economic
Outlook, aprile 2013, Database.
Nel complesso, si confermano le tendenze già emerse negli
ultimi anni relativamente al differenziale dei tassi di crescita tra i paesi
avanzati e quelli emergenti e di più recente industrializzazione, che
manifestano una maggiore reazione nella fase attuale di congiuntura, con una crescita
sensibilmente più elevata. Permane, inoltre, un certo grado di asimmetria tra
le aree più industrializzate.
In questo scenario, il DEF
evidenzia come nell’area dell’euro la graduale attenuazione delle
turbolenze sui mercati finanziari non si sia ancora pienamente trasmessa
all’economia reale, soprattutto nei paesi cosiddetti “periferici”, e come ciò
abbia determinato nel 2012 una contrazione del PIL dello 0,6 per cento e
un incremento del tasso di disoccupazione all’11,4 per cento. A
tale deterioramento delle prospettive macroeconomiche ha in parte contribuito
la debolezza della domanda interna, registrata in particolare nei paesi
che hanno adottato politiche di aggiustamento fiscale; nell’ultimo trimestre
dell’anno il rallentamento ha interessato anche la Germania.
Il Bollettino
Economico di Banca d’Italia dell’aprile 2013, evidenzia, con riferimento
ai risultati dell’Area dell’euro, come il deterioramento delle attività economiche
verificatosi nel quarto trimestre del 2012 abbia riflesso il temporaneo
venir meno del sostegno delle esportazioni, atteso che le vendite
all’estero hanno segnato il primo calo congiunturale dopo tre anni di
espansione, nonché l’andamento debole della domanda interna. Nonostante
il lieve recente recupero degli indicatori di fiducia di famiglie e imprese
rispetto ai valori minimi dell’autunno scorso, le informazioni congiunturali
confermano il prolungarsi della debolezza della domanda interna, cui
contribuiscono l’incertezza sulle prospettive cicliche, il permanere, in alcuni
paesi, delle difficoltà di accesso al credito e, nel caso dei consumi delle
famiglie, il calo del reddito disponibile in termini reali.
Di converso, negli Stati Uniti l’andamento del ciclo
economico è stato favorevole, essendosi registrata una crescita del PIL del
2,2 per cento e una diminuzione del tasso di disoccupazione all’8,1
per cento. Anche in Giappone il PIL è cresciuto del 2 per
cento, mentre tassi di crescita nettamente superiori a quelli dei paesi
avanzati hanno continuato a registrarsi nei paesi emergenti e di più
recente industrializzazione: la Cina è cresciuta del 7,8 e l’India
del 4,9 per cento e anche le prospettive per l’anno in corso sono favorevoli.
Le previsioni per il
2013
I segnali di rallentamento emersi nell’ultima fase del 2012 si
sono riflessi, in parte, anche nei primi mesi dell’anno in corso, inducendo una
revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell’economia
globale per il 2013. Secondo le indicazioni contenute nel DEF 2013, le
stime di espansione del prodotto si attesterebbero, per l’anno in corso, al 3,2
per cento e quelle del commercio mondiale al 3,6 per cento.
In questo scenario, nell’Area
dell’euro è attesa per il 2013 una contrazione del prodotto
dello 0,3 per cento e un aumento del tasso di disoccupazione
al 12,2 per cento.
Negli Stati Uniti è invece
prevista una crescita dell’1,9 per cento, mentre la disoccupazione dovrebbe
ridursi al 7,6 per cento; il Giappone dovrebbe crescere dell’1,0 per
cento e la Cina a tassi prossimi all’8 per cento. I paesi emergenti
continuerebbero a reagire meglio all’attuale congiuntura, con tassi di crescita
più intensi rispetto alle economie avanzate che forniscono un rilevante
contributo all’andamento dell’economia globale.
Nel Bollettino di
aprile 2013, la Banca Centrale Europea conferma che tra le economie
avanzate la ripresa resterà probabilmente difforme e l’attività dovrebbe
accelerare solo gradualmente per l’azione di freno esercitata dal processo di
aggiustamento dei bilanci, dall’inasprimento fiscale e dalle condizioni di
credito tuttora restrittive. Al tempo stesso, la BCE rileva che nelle economie
emergenti l’attività si sta già intensificando e dovrebbe mantenersi più
robusta che nei paesi avanzati. In particolare, in Cina gli indicatori delle
indagini congiunturali segnalano che l’economia ha continuato a espandersi a
ritmi robusti; il settore manifatturiero è sospinto da nuovi ordinativi, mentre
gli indicatori relativi agli investimenti hanno evidenziato una forte
accelerazione; anche le esportazioni sono notevolmente aumentate e ciò ha
determinato l’avanzo commerciale cumulato su dodici mesi più ampio da giugno
2009.
Più robusti segnali di stabilizzazione del contesto
internazionale comincerebbero a manifestarsi nel 2014, con una
previsione della crescita del PIL mondiale stimata nel DEF al 3,9 per
cento (rispetto al 4 per cento indicato dal FMI ed esposto nella Tabella 1.1.).
Le previsioni di
graduale recupero dell’economia mondiale espresse nel DEF risultano
sostanzialmente in linea con quanto previsto dal FMI nel recente World
Economic Outlook di aprile 2013, il quale rileva come nell’anno in
corso l’economia mondiale stia iniziando a mostrare una ripresa dopo
l’indebolimento manifestatosi nel corso del 2012. In particolare, l’attività
economica nelle economie avanzate ha raggiunto una stabilizzazione, mentre nei
mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo è migliorata. Le severe
misure adottate in sede europea hanno contribuito a migliorare la fiducia e le
condizioni finanziarie. I policy makers americani hanno evitato
l’inasprimento fiscale, ma non sono riusciti a trovare una soluzione duratura
agli altri rischi finanziari di breve termine. Le indicazioni dell’FMI trovano
conferma anche nell’ultimo Bollettino economico della Banca d’Italia,
nel quale si rileva come nel primo trimestre del 2013 siano emersi segnali di
rafforzamento congiunturale negli Stati Uniti e in alcune economie emergenti,
dopo l’accentuata a fase di debolezza nell’ultimo trimestre del 2012. Anche il
commercio mondiale si è rafforzato, sospinto dall’espansione dei flussi fra i
paesi emergenti dell’Asia. Nel complesso la crescita mondiale nell'anno in
corso, secondo l’Istituto, dovrebbe rimanere modesta, per rafforzarsi dal 2014.
Sono comunque evidenziate le incertezze in ordine a possibili sviluppi della
politica di bilancio negli Stati Uniti e all’evoluzione della crisi del debito
sovrano in Europa.
Le prime indicazioni provenienti dal contesto internazionale
inducono, secondo il Governo, ad un moderato ottimismo.
In particolare, il DEF sottolinea come gli elevati tassi
di crescita dei paesi emergenti possano fungere da volano per la ripresa
dei paesi sviluppati, analogamente alla prevista diminuzione dei prezzi
delle materie prime – energetiche, alimentari e industriali –, che dovrebbe
comportare riflessi positivi anche sull’inflazione.
Pur in presenza di segnali di
stabilizzazione del contesto internazionale, continuano tuttavia a persistere elementi
di incertezza per il futuro.
Nei paesi sviluppati gli elementi di criticità che
influiscono sulla ripresa economica continuano a essere connessi agli effetti
delle politiche fiscali restrittive che sono state adottate per contenere gli
ampi livelli d’indebitamento raggiunti a seguito della crisi finanziaria.
In particolare, nell’area dell’euro gli elementi
d’incertezza sono connessi a una possibile recrudescenza delle tensioni sui
mercati finanziari, che ancora permangono, come dimostra la recente crisi
bancaria di Cipro.
Negli Stati Uniti, nonostante la politica monetaria
accomodante finora adottata dalla Federal Reserve, si registrano i
rischi connessi al possibile combinarsi di tagli alla spesa e maggiori tasse,
derivanti dalle misure decise alla fine dello scorso anno per evitare il c.d. “fiscal
cliff” e dai tagli automatici ai programmi di spesa pubblica disposti per i
prossimi dieci anni (il c.d. sequester); ulteriori incertezze sono
connesse all’approvazione di un piano di consolidamento fiscale a medio termine
e al raggiungimento del tetto al debito pubblico previsto, in mancanza di un
accordo tra l’Amministrazione e il Congresso per la sua elevazione, nella
seconda metà di maggio. In Giappone, invece, le recenti innovative
azioni di politica monetaria riflettono l’esigenza di tornare a crescere a
ritmi sostenuti.
La politica monetaria
Secondo quanto riportato nel
Bollettino Economico di Banca d’Italia dell’aprile 2013, le banche centrali
delle maggiori economie avanzate hanno reso ancora più accomodante
l’intonazione delle rispettive politiche monetarie. Negli Stati Uniti la
Riserva Federale ha lasciato invariato l’intervallo obiettivo per il tasso
d’interesse sui federal funds tra 0 e 0,25 per cento, riaffermando che
il tasso sarà mantenuto su valori eccezionalmente bassi fino a quando
permarranno elevati tassi di disoccupazione (superiori al 6,5 per cento) e
basse aspettative di inflazione. Ha, inoltre, deciso di proseguire con il piano
di acquisti a titolo definitivo di mutui cartolarizzati per 40
miliardi di dollari al mese e di obbligazioni del Tesoro a lungo
termine per ulteriori 45 miliardi.
La Banca del Giappone, dopo aver introdotto in
gennaio un obiettivo esplicito per la stabilità dei prezzi pari al 2 per cento
- in sostituzione del precedente tasso di inflazione di riferimento nel breve
termine (1 per cento) - ha varato, in aprile, un nuovo ampio programma di
espansione quantitativa, finalizzato al raggiungimento del target di
inflazione entro due anni. Il nuovo regime determinerà un raddoppio della
base monetaria nel corso del prossimo biennio, diventando il nuovo
obiettivo operativo della politica monetaria; nel medesimo arco temporale verrà
raddoppiata la quantità di attività finanziarie detenute nel portafoglio
della Banca centrale e più che raddoppiata la vita media residua degli
acquisti di obbligazioni pubbliche.
La Banca d’Inghilterra ha invece lasciato
invariato lo stock di attività finanziarie nel proprio portafoglio a 375
miliardi di sterline.
La Banca centrale europea
(BCE) ha mantenuto un orientamento di politica monetaria accomodante, lasciando
allo 0,75 per cento il tasso di riferimento per le operazioni di
rifinanziamento principali. La liquidità in eccesso si è mantenuta ampia, anche
se sono diminuiti di circa 220 miliardi di euro i
finanziamenti complessivi forniti dall’Eurosistema alle banche operanti
nell’area mediante le operazioni di rifinanziamento in ragione della
restituzione anticipata di una parte dei fondi ottenuti nelle due operazioni di
rifinanziamento con durata triennale (LTRO) condotte a dicembre del 2011 e a
febbraio del 2012. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che
l’orientamento di politica monetaria rimarrà accomodante con piena
aggiudicazione della liquidità richiesta dalle banche fino a quando necessario;
ha inoltre chiarito di essere pronto a ulteriori azioni sulla base della
valutazione delle informazioni in arrivo nel prossimo futuro.
Con riferimento al cambio, si ricorda infine
che all’inizio dell’anno in corso l’euro si è deprezzato dell’1,1 per
cento rispetto al dollaro, ma si è rafforzato nei confronti dello yen del 14
per cento, in seguito all’ulteriore allentamento delle condizioni monetarie in
Giappone; è comunque proseguito il trend di apprezzamento avviatosi
nel 2012 in termini effettivi nominali. Analogamente a quanto avvenuto in
Francia e in Germania, il guadagno di competitività accumulato
dall’Italia a partire dal 2010, che ha favorito il miglioramento del saldo
delle partite correnti, è stato in parte ridotto, dallo scorso agosto, dalla
rivalutazione nominale dell’euro.
Il DEF espone l’analisi del quadro macroeconomico italiano
nel 2012 e le previsioni per l’anno in corso e per il periodo 2014-2017, che riflettono
gli elementi d’incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.
I risultati nel 2012
Con riferimento all’anno 2012, il DEF evidenzia come la
recessione, manifestatasi nuovamente nella seconda metà del 2011 - dopo i
moderati segnali di ripresa di inizio anno – si sia protratta, in
Italia, per tutto il 2012.
Nel complesso, nel 2012 il PIL
ha registrato una contrazione del 2,4 per cento, a fronte della
crescita dello 0,4 per cento del 2011 (dato, quest’ultimo, in netto
rallentamento rispetto alla crescita dell’1,7 per cento manifestatasi nel
2010).
La contrazione del prodotto registrata nel 2012 è risultata in
linea con le previsioni formulate nella Nota di aggiornamento del DEF,
presentata a settembre 2012. In merito il Documento
sottolinea che la fase recessiva dell’economia italiana, che ha attraversato
l’intero arco dell’anno 2012, si è inasprita nella fase finale dell’anno,
segnando nell’ultimo trimestre una variazione negativa superiore alle attese. Nel
quarto trimestre del 2012 si è, infatti, registrato un brusco
peggioramento dell’andamento dell’economia italiana, con una contrazione
del PIL dello 0,9 per cento sul trimestre precedente.
Secondo quanto rilevato nel Comunicato
ISTAT dell’11 marzo 2013, nel IV trimestre 2012 tutti i principali
aggregati della domanda interna hanno segnato diminuzioni significative. In
particolare, rispetto il trimestre precedente, i consumi finali nazionali hanno
registrato un calo dello 0,5 per cento e gli investimenti fissi lordi si sono
contratti dell’1,2 per cento. Le importazioni sono diminuite dello 0,9 per
cento, a fronte di un lieve aumento dello 0,3 per cento delle esportazioni. La contrazione dell’attività economica dell’Italia
nell’ultimo trimestre dell’anno è risultata, inoltre, più accentuata di
quella verificatasi nell’Area dell’euro nello stesso periodo (-0,6 per
cento) e più marcata di quella registrata nei principali paesi europei, quali
Germania (-0,6 per cento), Francia (-0,3 per cento), Regno Unito (-0,3 per
cento) e Spagna (-0,8 per cento).
La caduta del PIL registrata nell’anno 2012 ha quasi
annullato la risalita verificatasi nei due anni precedenti, facendo scendere il
prodotto, in volume, leggermente al di sotto del livello registrato nel 2009.
Tabella
1.2
Andamento del PIL in volume (valori
concatenati – anno di riferimento 2005 – mld di euro)
|
o
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
PIL
|
1.394,3
|
1.418,4
|
1.423,7
|
1.389,9
|
|
Variazione %
|
-5,5
|
1,7
|
0,4
|
-2,4
|
Sul risultato complessivo ha inciso, in maniera rilevante,
il debole andamento della domanda interna, il cui contributo negativo
alla variazione del PIL è stato particolarmente ampio, pari a -4,8 punti
percentuali.
La contrazione del PIL nel 2012 è stata, inoltre, accompagnata
da una diminuzione delle importazioni di beni e servizi del 7,7 per
cento, che ha accentuato la contrazione delle risorse disponibili (-3,6 per
cento). Un apporto positivo è, invece, disceso dalla domanda estera
(3 punti percentuali).
Sul punto il DEF evidenzia come mentre il precedente
episodio di caduta del PIL, culminato nel 2010, era stato caratterizzato da un
vistoso calo delle esportazioni, nel corso del 2012 il principale impulso
recessivo è venuto dalle ripercussioni negative sull’economia dovute alla crisi
finanziaria. L’apertura di un differenziale molto elevato tra i titoli di
stato italiani e quelli tedeschi e le tensioni sul mercato interbancario
europeo si sono infatti trasmesse sul finanziamento al settore privato sia in termini
di tassi di interesse più elevati, sia in termini di contrazione del credito
totale all’economia.Al contempo, l’ampio sforzo
di consolidamento fiscale resosi necessario per stabilizzare le aspettative
dei mercati e per ottemperare agli impegni interni e internazionali di anticipo
del pareggio strutturale di bilancio al 2013, ha fornito ulteriore impulso
negativo all’economia, cui si aggiunta una drastica caduta di fiducia di
famiglie e imprese che ha contribuito alla congiuntura sfavorevole. Da tali
fattori è discesa una nuova rilevante flessione del PIL generata dalla contrazione
di tutte le componenti della domanda interna.
In particolare, nel 2012, si
è verificata nuovamente una flessione degli investimenti fissi lordi
dell’8 per cento, risultata più intensa nel comparto delle macchine e
attrezzature (-10,6 per cento) a seguito delle incertezze della domanda, che ha
fatto registrare un sensibile calo della produzione industriale. Il settore
delle costruzioni registra nel 2012, per il quinto anno consecutivo, un
valore negativo, con una riduzione del 6,2 per cento.
La
diminuzione della spesa delle famiglie residenti è stata intensa (-4,3
per cento), risentendo della compressione del reddito disponibile e
dell’accelerazione dell’inflazione.
La spesa pubblica, per
effetto delle misure di correzione fiscale, si è anch’essa ridotta del 2,9 per
cento.
Come già ricordato, la
dinamica delle esportazioni si è invece mantenuta positiva,
evidenziando una crescita del 2,3 per cento, mentre il rallentamento
della domanda interna ha inciso fortemente sull’andamento delle importazioni,
ridotte del 7,7 per cento, a fronte del +0,5 per cento registrato nell’anno
precedente.
Per quanto concerne, in
particolare, il commercio con l’estero, il DEF evidenzia che nell’anno
2012 l’interscambio ha mostrato un rallentamento. Nel complesso il saldo
commerciale è risultato negativo per circa 11 miliardi (0,8 per cento del PIL),
in miglioramento rispetto al disavanzo di oltre 25 miliardi dell’anno
precedente. Il contributo al miglioramento del saldo è stato fornito, in
particolare, dai flussi verso l’area extra-europea. In particolare, le
esportazioni sono cresciute soprattutto verso i paesi dell’area dell’Opec, il
Giappone e gli Stati Uniti, mentre le importazioni, che hanno subito in via
generale una riduzione, hanno registrato un lieve incremento solo dai paesi
dell’area dell’Opec.
L’andamento degli investimenti
diretti esteri in entrata in Italia è stato pari, nel 2012, a 6,8 miliardi,
in netta diminuzione rispetto al 2011 di 17,8 miliardi. Tale andamento è
confermato anche negli altri paesi dell’Area euro, salvo la Francia e il Regno
Unito, che hanno, invece, registrato un incremento dei flussi in entrata.
Quanto al mercato del
lavoro, il DEF rileva come la recessione abbia avuto riflessi significativi
sull’occupazione, la quale, misurata in ULA (unità di lavoro standard) ha
registrato nel 2012 una riduzione dell’1,1 per cento. Il calo degli occupati,
in termini di rilevazione di forze di lavoro è stato più contenuto a seguito
del maggior ricorso alla Cassa Integrazione (CIG) e dell’aumento dei lavoratori
a tempo parziale. In particolare, le ore autorizzate di CIG sono risultate
superiori al miliardo, avvicinandosi al massimo storico del 2010. Contrariamente
a quanto accaduto in altri episodi di recessione, il 2012 si è caratterizzato
per un aumento del tasso di partecipazione legato a una maggiore offerta di
lavoro non solo da parte di donne e giovani, ma in particolare di persone della
classe d’età compresa tra i 55 e i 64 anni a seguito delle riforme
pensionistiche più recenti.
Con riferimento al
deterioramento della condizione del mercato del lavoro in Italia, il recente comunicato
ISTAT dell’11 aprile 2013, che ha fornito gli indicatori complementari al
tasso di disoccupazione aggiornati al 2012, in coordinamento con Eurostat, ha
evidenziato che nel 2012 gli inattivi disponibili a lavorare sono circa 3
milioni, in aumento rispetto al 2011. La quota di questi inattivi sulle forze
di lavoro, pari all’11,6 per cento, è oltre tre volte superiore a quella media
europea (3,6 per cento).
Inoltre, gli inattivi
disponibili a lavorare risultano più numerosi dei disoccupati in senso stretto,
mentre nella media europea si verifica l’opposto: i disoccupati (circa 25
milioni) sono più del doppio di questo segmento di inattivi (8 milioni e 800
mila). All’interno di questo gruppo di inattivi, gli scoraggiati, cioè quelli
che dichiarano di non aver cercato lavoro perché convinti di non trovarlo, sono
il 43 per cento del totale.
Con riferimento
all’evoluzione dei prezzi, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo è
aumentato al 3,3 per cento, riflettendo anche i rialzi delle aliquote IVA e di
altre accise introdotti nella seconda metà del 2011.
Le prospettive
dell’economia italiana
Il DEF 2013 sottolinea come le prospettive di recupero
dell’economia italiana siano fortemente influenzate dagli sviluppi della crisi
in Europa e, al contempo, dall’evoluzione dello scenario economico globale.
A tale ultimo riguardo, il Documento ipotizza una
progressiva ripresa della domanda internazionale già a partire dal 2013, dopo
il rallentamento della seconda metà del 2012, che dovrebbe riflettersi positivamente
sulla crescita delle esportazioni italiane.
Nel PNR, presentato nella
terza sezione del DEF, il Governo mette tuttavia in luce, con riferimento alle
prospettive di crescita economica del Paese, i problemi strutturali che, sul
piano interno, sono alla base di un progressivo indebolimento della capacità di
crescita dell’economia italiana, tra i quali vi è soprattutto la scarsa
dinamica della produttività, il cui andamento in Italia è comparativamente
più debole rispetto a quello registrato nell’area dell’euro ed è entrato in
territorio negativo nell’ultimo decennio. A
causa dell’andamento stagnante della produttività, la graduale riduzione della
dinamica salariale non si è tradotta in un miglioramento della competitività di
prezzo.
In linea con quanto già indicato nella Relazione al
Parlamento 2013, presentata nel marzo scorso, il DEF conferma la revisione
al ribasso delle prospettive di crescita dell’economia italiana, stimando per
il 2013 una contrazione del PIL pari a -1,3 per cento,
rispetto al -0,2 per cento indicato nella Nota di aggiornamento del DEF del settembre
scorso.
Tabella 1.3
Confronto sulle
previsioni di crescita del PIL (variazioni
percentuali)
|
|
Nota di agg. DEF 2012
settembre 2012
|
DEF
2013
aprile 2013
|
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
PIL
|
-0,2
|
1,1
|
1,3
|
-1,3
|
1,3
|
1,5
|
1,3
|
1,4
|
Tale revisione delle stime di crescita per l’anno in corso
riflette, oltre agli effetti di trascinamento negativo (pari a circa un punto
percentuale) ereditati dall’ultima parte del 2012, anche i segnali
ancora poco confortanti dell’andamento congiunturale dei primi mesi dell’anno,
in cui si prefigura, secondo i dati attualmente disponibili, un' ulteriore contrazione
del PIL nel primo trimestre 2013.
Il livello delle attività
economiche è atteso permanere debole nella prima metà dell’anno, in
ragione della debolezza della domanda interna; a una sostanziale
stabilizzazione del prodotto nel secondo trimestre dovrebbe seguire una crescita
nella seconda parte dell’anno, favorita anche dall’immissione di liquidità
nel sistema economico derivante dal recente provvedimento d’urgenza adottato in
tema di pagamento dei debiti pregressi della PA e di rimborsi fiscali, attualmente
all’esame della Commissione speciale della Camera dei deputati.
Come rilevato anche da Banca
d’Italia nel Bollettino economico n. 72 di aprile 2013, la debolezza
ciclica dell’attività economica in Italia è proseguita, pur attenuandosi
all’inizio del 2013. L’andamento del prodotto risente soprattutto della
flessione del reddito disponibile delle famiglie e dell’incertezza che grava
sulle scelte d’investimento delle imprese, mentre le esportazioni avrebbero
ripreso a crescere dopo il forte rallentamento degli ultimi tre mesi del 2012.
Nelle più recenti valutazioni degli imprenditori non emergerebbero ancora,
tuttavia, segnali d’immediato miglioramento delle condizioni per investire. Secondo
i dati mensili recentemente diffusi da ISTAT, l’indice del clima di fiducia
dei consumatori italiani è diminuito –a marzo 2013 - di quasi un punto rispetto
a quanto registrato a febbraio (85,2 a fronte dell’86 di febbraio),
attestandosi su valori più bassi di quelli rilevati a dicembre 2012. Anche il
clima di fiducia delle imprese risulta diminuito, attestandosi a febbraio a 77,4
a fronte dell’80 del mese precedente.
Per l’anno 2014, il DEF,
confermando quanto previsto nella Relazione di marzo, stima una più decisa
ripresa delle attività economiche, con un livello di crescita del PIL
che dovrebbe attestarsi all’1,3 per cento, ossia superiore di due decimi
di punto percentuale rispetto alle previsioni indicate nella Nota di
aggiornamento al DEF 2012 .
Tale previsione, come quella per l’anno in corso, sconta gli
effetti positivi sulla domanda interna derivanti dal D.L. n. 35/2013 in tema di
accelerazione del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche
amministrazioni. Sul punto, il DEF precisa che in mancanza delle misure
adottate con il citato decreto-legge la crescita del PIL nel 2014 sarebbe stata
all’incirca dello 0,6 per cento.
Gli effetti positivi delle misure di accelerazione dei
pagamenti dei debiti della PA influenzeranno l’andamento del prodotto anche
negli anni successivi. In particolare, il PIL è previsto crescere dell’1,5 per
cento nel 2015, dell’1,3 per cento nel 2016 e dell’1,4 per
cento nel 2017.
Analisi delle
componenti del quadro macroeconomico italiano
La tabella che segue riporta le previsioni per gli anni
2013-2017 dei principali indicatori del quadro macroeconomico
complessivo esposto nel DEF 2013, posti a raffronto con i dati di consuntivo degli
ultimi due anni.
Tabella 1.4
Il
quadro macroeconomico (variazioni
percentuali)
|
|
Consuntivi
|
Previsioni
|
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
PIL
|
0,4
|
-2,4
|
-1,3
|
1,3
|
1,5
|
1,3
|
1,4
|
|
Importazioni
|
0,5
|
-7,7
|
-0,3
|
4,7
|
4,4
|
4,1
|
3,8
|
|
Consumi finali nazionali
|
-0,2
|
-3,9
|
-1,7
|
0,9
|
1,0
|
0,9
|
1,0
|
|
- spesa delle famiglie
|
0,1
|
-4,3
|
-1,7
|
1,4
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
- spesa delle P.A. e I.S.P.
|
-1,2
|
-2,9
|
-1,7
|
-0,4
|
0,7
|
0,3
|
0,1
|
|
Investimenti fissi lordi
|
-1,8
|
-8,0
|
-2,6
|
4,1
|
3,2
|
2,6
|
2,4
|
|
- macchinari,
attrezzature e vari*
|
-1,0
|
-9,9
|
-3,0
|
5,1
|
4,4
|
3,8
|
3,4
|
|
- costruzioni
|
-2,6
|
-6,2
|
-2,2
|
3,1
|
2,0
|
1,5
|
1,4
|
|
Esportazioni
|
5,9
|
2,3
|
2,2
|
3,3
|
4,1
|
4,0
|
3,9
|
|
|
|
Occupazione (ULA)
|
0,1
|
-1,1
|
-0,3
|
0,6
|
0,8
|
0,7
|
0,8
|
|
Tasso di disoccupazione
|
8,4
|
10,7
|
11,6
|
11,8
|
11,6
|
11,4
|
10,9
|
|
|
|
Deflatore PIL
|
1,3
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
|
Inflazione programmata
|
2,0
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
* Tale voce ricomprende gli investimenti in macchinari
e attrezzature, in trasporti e in beni immateriali.
Fonte: DEF 2013, Sezione
II: Analisi e tendenze di Finanza pubblica, Tab. I.1-1.
Come si evince dalla tabella, tutti i principali indicatori macroeconomici
manifestano nell’anno 2013 un valore negativo rispetto al 2012, salvo
l’andamento positivo indicato per le esportazioni (+2,2 per cento).
In particolare, i consumi privati sono attesi
mantenersi nel 2013 ancora su livelli deboli (-1,7 per cento), quale riflesso delle
persistenti difficoltà di recupero dell’economia. L’andamento dei consumi
privati torna positivo nel 2014 (+0,9 per cento), anche grazie agli effetti di
trascinamento del provvedimento di accelerazione del pagamento dei debiti della
P.A.
In particolare, i consumi delle famiglie, previsti
ancora in calo nel 2013, recuperano circa 3 punti percentuali nel 2014, anno in
cui tornano a crescere dell’1,4 per cento.
Il dato positivo della previsione dei consumi delle famiglie
indicato per il 2014 (+1,4 per cento) e per gli anni successivi (in media +1,1
per cento) riflette in maniera più evidente l’effetto positivo che dovrebbe
derivare sulla domanda interna dall’immissione di liquidità nel sistema
economico connessa alle misure prospettate in tema di accelerazione dei
pagamenti dei debiti della PA..
Al netto delle suddette misure, infatti, secondo le
indicazioni fornite nel DEF, i consumi delle famiglie registrerebbero nel 2013
una contrazione superiore, pari a -2,1 per cento, mentre il recupero dei
consumi nel 2014 non andrebbe al di là di un modesto +0,5 per cento.
Per quanto concerne gli altri
indicatori, le importazioni manifesterebbero ancora nel 2013 una contrazione
(-0,3 per cento) rispetto al 2012, tornando su valori positivi, tuttavia, già nel
2014 (+4,7 per cento) e mantenendosi su una crescita media del 4 per cento nel
triennio successivo.
Gli investimenti fissi lordi
sono previsti in calo per il terzo anno consecutivo, in riduzione nel 2013 del ‑2,6
per cento rispetto al 2012, anno in cui la contrazione era stata pari al ‑8
per cento sul 2011.
Ad avviso del Governo l’iniezione di liquidità derivante dal
provvedimento di liquidazione dei debiti della PA dovrebbe avere un impatto
positivo su tale voce già dal 2013, e stimato in crescita negli anni
successivi, favorendo la revisione dei piani di investimento delle imprese. Il
DEF evidenzia, infatti, che nel 2013 la contrazione degli investimenti fissi
avrebbe raggiunto il -3,3 per cento senza l’intervento delle suddette misure.
Nel 2014 è prevista una netta ripresa degli investimenti
fissi lordi, con una crescita del 4,1 per cento, di circa 2,8 punti percentuali
superiore a quanto si sarebbe realizzato in mancanza del provvedimento di
sblocco dei pagamenti dei debiti della P.A. L’andamento degli investimenti si
mantiene su livelli positivi anche negli anni successivi, anche se ad un ritmo
inferiore di quello previsto nel 2014.
Le esportazioni – che hanno trainato
la crescita economica nel 2010 e nel 2011 ed hanno costituito l’unico apporto
positivo alla crescita del PIL nel 2012 – continuerebbero a manifestare un
andamento positivo anche nell’anno 2013 (+2,2 per cento). Le esportazioni sono
attese in crescita anche nel 2014 (+3,3 per cento) e nel triennio successivo, a
un livello medio del 4 per cento.
Per quanto concerne la bilancia dei pagamenti, il saldo
corrente è stimato migliorare nel 2013, passando da -0,6 per cento nel 2012 a
+0,1 per cento. Negli anni successivi, tuttavia, il saldo tornerebbe su valori
negativi, mediamente pari a -0,1 per cento.
Il grafico seguente indica l’andamento delle principali
variabili del quadro macroeconomico a partire dal 2008 sino alla fine del
periodo di previsione indicato del DEF 2013.
Grafico
1.1
Conto economico delle risorse e degli impieghi (variazioni
% a prezzi costanti)
|
|
|
|
|
|
2013-2015
obiettivi Governo
|
|
|
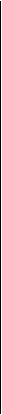 |
|
Quanto all’andamento dei prezzi, il deflatore del PIL
è stimato in crescita nell’anno in corso all’1,8 per cento (rispetto all’1,6
del 2012).
Esso si manterrebbe stabile intorno all’1,8 per cento nel
restante periodo.
L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), valutato
al netto dei prodotti energetici, è stimato attestarsi al 2 per cento nel 2013,
in netta discesa rispetto al 2012, in cui l’indice ha raggiunto il 3,0 per
cento.
Mercato del lavoro
Per quanto concerne il mercato del lavoro, il DEF,
confermando quanto già esposto nella Relazione al Parlamento presentata a marzo
scorso, stima per l’anno 2013 una contrazione dell’occupazione, in
termini di ULA, dello 0,3 per cento rispetto al 2012, anno in cui
l’occupazione si è ridotta dell’1,1 per cento.
Una ripresa occupazionale è attesa realizzarsi
soltanto a partire dal 2014, anno in cui l’occupazione segnerebbe una
evoluzione positiva (+0,6 per cento), fino a giungere allo 0,8 per cento
nel 2017.
Il grafico seguente mostra l’andamento dell’occupazione in
Italia a partire dal 2008, con le previsioni 2013-2017 contenute nel DEF.
Grafico 1.2
Andamento dell’occupazione (variazioni
%)
Il tasso di disoccupazione si manterrebbe al di sopra
del livello registrato nel 2012 (10,7 per cento) per tutto il periodo di
previsione, attestandosi all’11,6 per cento nel 2013 e all’11,8
per cento nel 2014.
Il DEF ipotizza che soltanto alla fine del periodo di
previsione il tasso possa tornare, scontando comunque un progressivo aumento
del tasso di partecipazione, al di sotto della soglia dell’11 per cento, atteso
che con la ripresa dell’economia gli aumenti dell’occupazione saranno
probabilmente meno che proporzionali rispetto alle variazioni del PIL.
Per ciò che concerne
l’andamento del mercato del lavoro, nel Bollettino economico di aprile, la Banca
d’Italia rileva che gli andamenti osservati nei primi mesi del 2013
indicherebbero il protrarsi della debolezza del quadro occupazionale. Secondo i
dati provvisori della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’ISTAT, nel
primo bimestre del 2013 l’occupazione avrebbe continuato a diminuire e il tasso
di disoccupazione sarebbe cresciuto ancora, sebbene a febbraio si siano
registrati andamenti di segno opposto. Le ore di CIG autorizzate tra gennaio e marzo
sono aumentate del 12,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, nonostante il blocco amministrativo dei pagamenti della componente
in deroga. Le aspettative delle imprese desunte dalle inchieste congiunturali condotte
a marzo prefigurano un’ulteriore perdita di posti di lavoro nei mesi
primaverili. Il deterioramento della situazione occupazionale italiana è
evidenzato anche dal Fondo Monetario Internazionale nelle nuove
previsioni per il 2013-2014, che stimano per l’Italia una crescita del tasso di
disoccupazione intorno al 12 per cento nel 2013 e al 12,4 per cento nel 2014.
Il grafico che segue mostra l’andamento del tasso di
disoccupazione a partire dal 2008 per i principali paesi della UE e per gli
Stati Uniti, tratte dal recente rapporto del Fondo monetario internazionale
(Word Economic Outlook, aprile 2013).
Grafico 1.3
Andamento del tasso di
disoccupazione (variazione
percentuale)
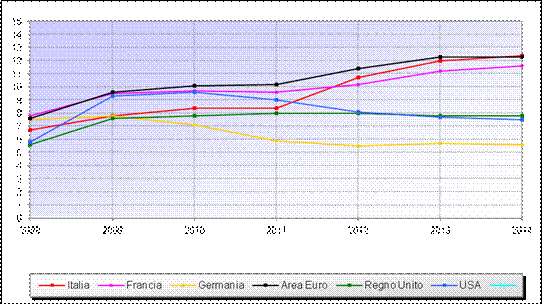 Fonte: Per
i consuntivi 2008-2012, per i paesi della UE, dati della Commissione Europea,
per USA, dati FMI. Per le previsioni 2013-2014, FMI, Word Economic Outlook (aprile
2013)
Fonte: Per
i consuntivi 2008-2012, per i paesi della UE, dati della Commissione Europea,
per USA, dati FMI. Per le previsioni 2013-2014, FMI, Word Economic Outlook (aprile
2013)
Con riferimento al costo del lavoro per unità di prodotto
(CLUP), misurato in termini di rapporto sul PIL, esso è previsto
crescere ancora nell’anno 2013 del 2 per cento del PIL,
registrando un ulteriore deterioramento della produttività. Per gli anni
2014-2017 e successivi la crescita del CLUP si attesterebbe su livelli più
moderati, pari in media allo 0,8 per cento nel periodo considerato.
Nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale (Word
economic outlook – aprile 2013), le previsioni per l’economia dell’area
dell’euro risultano riviste al ribasso.
In tale ambito, con riferimento all’area dell’euro, le
revisioni più significative rispetto alle precedenti stime hanno riguardato l’Italia
e la Francia, paesi per i quali l’FMI ha indicato una contrazione del PIL
nel 2013 pari a -1,5 per cento per l’Italia (superiore di mezzo
punto percentuale rispetto a quanto previsto a gennaio) e a -0,1 per
cento per la Francia (a fronte di una previsione di crescita dello 0,3
per cento).
Nel complesso, nell’Area euro si prevede una flessione
del prodotto nel 2013 pari allo 0,3 per cento.
Nel 2014, l’espansione del PIL in Italia è
prevista a un ritmo più modesto di quanto indicato dal Governo nel DEF, pari allo
+0,5 per cento. Tale previsione non include, tuttavia, l’impatto
economico derivante dal provvedimento sull’accelerazione dei pagamenti
dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n.
35/2013. Ciò considerato, la previsione dell’FMI si pone sostanzialmente in
linea con quanto indicato nel DEF, il quale stima, in assenza del citato
intervento, una crescita dell’Italia nel 2014 di poco superiore allo 0,5 per
cento.
Tabella
1.5
Prodotto
interno lordo – Confronti internazionali (variazioni %)
|
|
DEF 2013
aprile 2013
|
WEO Update
gennaio 2013
|
WEO
aprile 2013
|
|
|
2013
|
2014
|
2013
|
2014
|
2013
|
2014
|
|
Economie avanzate
|
|
Italia
|
-1,3
|
1,3
|
-1,0
|
0,5
|
-1,5
|
0,5
|
|
Francia
|
|
|
0,3
|
0,9
|
-0,1
|
0,9
|
|
Germania
|
|
|
0,6
|
1,4
|
0,6
|
1,5
|
|
Spagna
|
|
|
-1,5
|
0,8
|
-1,6
|
0,7
|
|
area euro
|
|
|
-0,2
|
1,0
|
-0,3
|
1,1
|
|
Regno Unito
|
|
|
1,0
|
1,9
|
0,7
|
1,5
|
|
Usa
|
|
|
2,0
|
3,0
|
1,9
|
3,0
|
|
Giappone
|
|
|
1,2
|
0,7
|
1,6
|
1,4
|
|
Economie emergenti
|
|
cina
|
|
|
8,1
|
8,5
|
8,0
|
8,2
|
|
india
|
|
|
5,9
|
6,3
|
5,7
|
6,2
|
|
brasile
|
|
|
3,5
|
3,9
|
3,0
|
4,0
|
|
russia
|
|
|
3,1
|
3,8
|
3,4
|
3,8
|
Secondo quanto riportato nel World Economic Outlook, le
revisioni alle stime di crescita operate nel mese in corso si basano sulla
considerazione di fondo per cui ciò che appariva una ripresa a due velocità, si
configura ora in modo più netto come una ripresa a tre velocità, che
vede da un lato i mercati emergenti - i quali continuano a procedere su
ritmi sostenuti di crescita-, e dall’altro le economie avanzate, le
quali, però mostrano una biforcazione: gli Stati Uniti da una
parte, stimati crescere sui livelli sostanzialmente già prospettati nel
precedente Outlook di gennaio, e l’Area euro dall’altra, i cui
tassi di crescita economica sono invece più deboli.
La crescita nei paesi emergenti è, infatti, prevista
raggiungere nel 2013 il 5,3 per cento ed il 5,7 per cento nel 2014.
Negli Stati Uniti la stima per il 2013 si attesta intorno
all’1,9 per cento e al 3 per cento nel 2014.
Al contrario, l’Area euro decrescerebbe dello 0,3 per cento
nel 2013 per riprendere debolmente a crescere dell’1,1 per cento nel 2014.
In particolare, per ciò che concerne l’Area Euro, la
crescita negativa riflette – secondo le valutazioni dell’FMI - non solo la
debolezza dei paesi periferici, ma anche una qualche debolezza nel nucleo
stesso dell’Area, atteso che anche la Germania, pur confermando una espansione
del prodotto, manifesterebbe una crescita ben al di sotto dell’1 per cento. Le
previsioni per la Francia sono, invece, più negative nel 2013, così come quelle
per l’Italia e la Spagna.
Il grafico che segue mostra l’andamento del PIL dei
maggiori Stati dell’Unione europea e degli Stati Uniti per gli anni 2008-2012
(a consuntivo) e 2013-2014 (dati previsionali FMI).
Grafico
1.4
Prodotto
interno lordo - Confronti internazionali (variazioni
percentuali)
Approfondimento
1. Il Programma nazionale di Riforma
Il Programma Nazionale di
Riforma (PNR), contenuto nella Sezione III del DEF, ha, da un lato, la funzione
di verificare – in termini di effetti, portata e conformità con gli
obiettivi europei - le riforme intraprese dopo l’approvazione del PNR
dello scorso anno, e, dall’altro, dovrebbe prospettare un’agenda di
interventi per il futuro funzionali al conseguimento degli obiettivi della Strategia
Europa 2020 e all’attuazione degli indirizzi di policy che le
istituzioni comunitarie, nel quadro della nuova governance economica
europea, hanno diretto all’Italia.
La presentazione del PNR
2013 viene tuttavia a cadere, come afferma la premessa al DEF, in un
momento particolare della vita politica e istituzionale del Paese, che vede in
via di svolgimento le procedure per la formazione di un nuovo Esecutivo e
induce il Governo dimissionario, in carica per il disbrigo degli affari
correnti, a rilevare l’impossibilità di formulare orientamenti per il
futuro che presuppongano scelte d’indirizzo politico-legislativo o
l’avvio di nuove politiche di vasto respiro che non siano già state
condivise dal Parlamento. Per tali ragioni, il PNR 2013 non contiene
quest’anno un'agenda di priorità per il futuro, limitandosi invece a riportare
un’analisi dettagliata delle riforme adottate e dei relativi primi
risultati, nonché a indicare le aree di policy dove è maggiormente
necessario intervenire per il futuro. Spetterà al nuovo Governo la facoltà
d’integrare il quadro prospettato, presentando un’agenda di riforme, con le
relative compatibilità finanziarie, volta a proseguire il percorso di
avvicinamento agli obiettivi della Strategia Europa 2020.
Quadro di sintesi del contenuto del PNR
Dal
punto di vista dei contenuti, la struttura del PNR 2013, ampiamente rivista
rispetto a quella dello scorso anno, è articolata in sei capitoli più
un’appendice.
Nel primo
capitolo si descrivono sinteticamente le riforme introdotte nel
periodo di riferimento previsto dal Semestre Europeo, evidenziandone la coerenza
con:
a)
gli impegni presi dal Paese
nell’ambito del Patto Euro Plus, con il quale gli Stati membri hanno
convenuto un coordinamento rafforzato delle politiche economiche volto a conseguire
quattro obiettivi prioritari: 1) stimolare la competitività; 2) favorire
l’occupazione; 3) migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche; 4):
rafforzare la stabilità finanziaria;
b)
gli indirizzi indicati
dalla Commissione europea nell’ambito dell’analisi annuale delle
crescita 2013 con cui si avvia il Semestre Europeo, che ha ribadito,
con l’avallo del Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013, le seguenti priorità:
1) risanare il bilancio in modo differenziato e favorevole alla crescita; 2)
ripristinare la normale erogazione di prestiti all’economia; 3) promuovere la
crescita e la competitività nel breve e nel lungo periodo; 4) lottare contro la
disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; 5) modernizzare la
Pubblica Amministrazione;
c)
gli obiettivi della Strategia
Europa 2020 espressi in termini di target europei declinati a
livello nazionale;
d)
le sette iniziative prioritarie
(Flagship Initiatives) sulla base delle quali l'UE e i governi nazionali
sostengono i loro sforzi per realizzare la predetta Strategia: 1) agenda
digitale europea;.2) unione dell’innovazione; 3) giovani in movimento; 4)
un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; 5) una politica
industriale per l’era della globalizzazione; 6) agenda per nuove competenze e
lavoro; 7) piattaforma europea contro la povertà.
Nell’ambito
di questa cornice il PNR 2013 illustra il percorso compiuto sulla strada delle
riforme sollecitate dalle istituzioni europee, sottolineando come gli sforzi
compiuti abbiano affrontato sia i problemi urgenti di breve periodo causati
dalla crisi, sia le questioni strutturali dalla cui soluzione dipende il
benessere economico di lungo periodo del Paese. In questa prospettiva, il
documento annovera tra le principali misure adottate:
·
il piano per il conseguimento del pareggio
strutturale del bilancio anticipato al 2013 e l’inserimento nella
Costituzione del principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese e della
sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni;
·
la strategia di riduzione del
debito pubblico da attuarsi con la dismissione e la valorizzazione dei beni
pubblici;
·
la profonda riforma delle pensioni,
che ha reso il sistema previdenziale italiano uno dei più sostenibili in
Europa;
·
le misure per il contenimento
della spesa pubblica (c.d. spending review), la riduzione del
carico amministrativo per le imprese e il miglioramento dell’ambiente
imprenditoriale;
·
la riforma del mercato del
lavoro, volta ad aumentare la flessibilità e a ridurre la segmentazione;
·
la politica di sviluppo nazionale
per l’imprenditoria a favore dell’innovazione e dell’internazionalizzazione;
·
le misure di razionalizzazione ed
efficientamento del sistema sanitario;
·
il migliore utilizzo delle risorse
comunitarie.
Il
Governo sottolinea, inoltre, come le riforme strutturali volte a stimolare la
competitività e la crescita siano state adottate senza mai perdere di vista
l’obiettivo della stabilità finanziaria e come ciò abbia accresciuto la
credibilità internazionale e favorito il riconoscimento, da parte del Consiglio
Europeo del 14-15 marzo 2013, della necessità di un risanamento di bilancio
differenziato che permetta all'Italia di utilizzare spazi di
flessibilità controllata per azioni di sostegno volte a rilanciare, nel
rispetto della stabilità finanziaria, la crescita e l’occupazione,
azioni nel cui ambito s’innesta il provvedimento d’urgenza recentemente
adottato per la liquidazione dei debiti pregressi della pubblica amministrazione.
Si
ricorda, in particolare, che nelle conclusioni del Consiglio europeo:
-
si invitano gli Stati membri
ad intervenire contestualmente sul versante delle spese e delle entrate
adottando misure “mirate a breve termine per promuovere la crescita e
sostenere la creazione di posti di lavoro, in particolare dei giovani”,
dando la priorità agli investimenti favorevoli alla crescita;
-
si ribadisce l’esigenza di
proseguire riforme strutturali, nonché di assicurare un equilibrato riparto
del carico fiscale attraverso il recupero dell’evasione (anche
mediante accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio con Paesi
terzi), di avviare politiche attive per l’occupazione, l’istruzione e la
formazione, di sfruttare il potenziale dell’economia verde, di completare
l’unione bancaria e di portare a compimento la riforma della governance
economica attraverso la piena operatività del c.d. Two pack e del c.d. Fiscal
compact;
-
si riafferma la necessità di
realizzare la Strategia Europa 2020 mediante il completamento del
mercato interno dell’energia, le politiche per l’innovazione, il completamento
della cosiddetta agenda digitale, l’integrazione dell’industria europea della
difesa e la competitività dell’industria europea, mentre non è prevista alcuna
azione specifica per quanto concerne l’eventuale revisione delle regole e
degli obiettivi connessi al Patto di stabilità e crescita.
Il secondo
capitolo del PNR contiene la valutazione degli impatti macroeconomici
connessi alle riforme attuate con:
a)
i decreti legge n.83/2012 e
n. 179/2012, recanti un insieme eterogeneo di misure volte a rilanciare
la crescita e l’efficienza del sistema economico, dai quali
dovrebbe discendere un aumento del prodotto interno lordo dello 0,3 e dello 0,5
per cento rispettivamente al 2015 e al 2020, e dello 0,7 per cento nel lungo
periodo;
b)
la riforma del mercato del
lavoro di cui alla legge n.92/2012, la quale determinerebbe mediamente, in
base ai diversi esercizi di simulazione elaborati, un impatto positivo sul PIL
pari allo 0,4 per cento nel 2015 (mentre l’occupazione rimarrebbe
sostanzialmente invariata nello stesso periodo) e destinato a crescere al 2020,
quando l’aumento del prodotto, rispetto allo scenario base, raggiungerebbe
mediamente l’1 per cento, a fronte di un’occupazione in crescita dello 0,9 per
cento. Nel lungo periodo lo scostamento rispetto allo scenario base per il
prodotto e l’occupazione risulterebbe, rispettivamente, dell’1,4 e 1,2 per
cento.
L’impatto
macroeconomico dell’insieme delle riforme strutturali varate dal Governo
nel 2012 – comprendenti gli interventi per la crescita, la riforma del
mercato del lavoro, nonché le misure in tema di liberalizzazioni e
semplificazioni già oggetto di stima nel precedente PNR – determina, rispetto
allo scenario di base, un incremento del PIL pari a 1,6 punti
percentuali al 2015 e a 3,9 punti nel 2020, sino a
raggiungere i 6,9 punti percentuali nel lungo periodo.
Il PNR reca altresì l’analisi
dell’impatto finanziario delle misure in esso indicate, articolate in dieci
aree di politiche pubbliche in cui sono aggregate le nuove misure
d’intervento tratte dai provvedimenti vigenti dall’aprile 2012, che
includono anche disposizioni afferenti a misure già poste in essere negli anni
precedenti, riportate quale aggiornamento normativo e finanziario dei PNR 2012
e 2011. Gli effetti finanziari sono valutati in termini di maggiori/minori
entrate e maggiori/minori spese e quantificati con riferimento ai relativi
saldi. Per il 2013 si riportano i risultati dell’analisi d’impatto sul bilancio
dello Stato. Le predette aree di policy, cui sono associate le
relative misure di intervento, sono le seguenti:
§
contenimento ed efficientamento
della spesa pubblica;
§
federalismo;
§
efficienza amministrativa;
§
mercato dei prodotti e
concorrenza;
§
lavoro e pensioni;
§
innovazione e capitale umano;
§
sostegno alle imprese;
§
sostegno al sistema finanziario;
§
energia e ambiente;
§
infrastrutture e sviluppo.
Il terzo
capitolo del PNR illustra le misure che il Paese ha adottato in risposta
alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo, nonché le iniziative più
rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali della
Strategia Europa 2020 (in materia di tasso di disoccupazione,
investimenti in ricerca e sviluppo, fonti rinnovabili, efficienza energetica,
abbandoni scolastici, istruzione universitaria, contrasto alla povertà).
Alla fine del capitolo è altresì riportata una sintesi dei risultati
dell’utilizzo dei Fondi comunitari e indicazioni in ordine alla nuova
fase di programmazione 2014-2020.
Limitando la presente sintesi
alle indicazioni fornite nel PNR con riferimento ai “prossimi passi” da
compiere in risposta alle predette raccomandazioni del Consiglio
dell’Unione europea, si segnalano le seguenti questioni:
a)
riduzione del debito
pubblico: ferma restando la
strategia di riduzione della spesa pubblica e di consolidamento fiscale, che
consentirà di raggiungere nell’anno in corso il pareggio di bilancio in termini
strutturali e di mantenere un avanzo primario di bilancio di oltre il 4 per
cento del PIL a partire dal 2015, occorre completare il censimento del
patrimonio pubblico, nonché costituire la prevista Società di Gestione del
Risparmio per la relativa valorizzazione e dismissione. Sarà, inoltre, esteso
all’intero territorio nazionale il Progetto “Valore Paese” per la
valorizzazione d’immobili non utilizzati appartenenti al patrimonio dello Stato
e degli enti pubblici e proseguita la dismissione di alloggi di servizio delle
Forze Armate;
b)
efficienza e qualità della spesa pubblica e uso dei
fondi strutturali: nel 2013 proseguirà il processo di contenimento e
riqualificazione della spesa (avvio della terza fase della spending review),
indirizzata in particolare all’articolazione periferica delle amministrazioni
statali; in linea con la legge di stabilità 2013, saranno inoltre adottati i
provvedimenti legislativi di riordino delle Province e d’istituzione delle
città metropolitane. Proseguirà, inoltre, l’attuazione del Piano di Azione e
Coesione è sarà necessario accelerare l’attuazione dei Programmi operativi,
aumentando i target nazionali intermedi di spesa per evitare la
concentrazione delle spese negli anni 2014-2015, in coincidenza con l’avvio del
nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali; in relazione a tale nuovo
ciclo saranno definiti, sulla base del confronto istituzionale e con il
partenariato economico- sociale e del negoziato con la Commissione europea, gli
strumenti d’intervento, nonché le più appropriate condizionalità ex ante
volte ad assicurare la piena operatività dei requisiti di efficacia degli
interventi;
c)
disoccupazione giovanile, percorsi formativi e abbandoni scolastici:
nel corso del 2013 proseguiranno, in accordo con le Regioni, le azioni di
diffusione e incentivazione del contratto di apprendistato. Sarà rafforzata la
semplificazione degli oneri amministrativi e dei servizi alle imprese, nonché
l’erogazione di un’offerta formativa adeguata. Specifiche misure saranno
adottate per rafforzare la capacità di collocamento dei servizi per l'impiego
pubblici e privati, dando priorità all’interoperabilità di tutte le componenti
del sistema formativo e al monitoraggio delle azioni svolte dai servizi per
l'impiego. Proseguirà inoltre il monitoraggio degli effetti della riforma del
lavoro, al fine di raccogliere una base informativa e registrare eventuali
criticità che potrebbero suggerire ulteriori interventi di revisione; in tale
ambito una particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti della flessibilità
d’ingresso nel mercato del lavoro. Sarà poi rafforzata l’azione di contrasto
agli abbandoni scolastici, anche mediante
la promozione dell’apprendimento
permanente e il potenziamento del rapporto tra scuola ed esigenze del mercato
del lavoro. Il migliore utilizzo dei fondi strutturali contribuirà a
contrastare l’insuccesso formativo, soprattutto nelle Regioni del Sud. Infine,
nel corso dell’anno saranno adottate misure per rafforzare la formazione
continua degli insegnanti e promuovere un loro ricambio generazionale;
d)
mercato del lavoro e
competitività: in tali ambiti
occorrerà, in primo luogo, rafforzare e monitorare l’attuale sistema di tutele
relativo all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituto entrato in
vigore dal 1° gennaio 2013 e consiste nell'erogazione di un'indennità mensile ai
lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di
cooperative di lavoro e i lavoratori a termine della PA, che hanno perso
involontariamente il lavoro. Devono inoltre essere integrati gli strumenti di
conciliazione tra lavoro e famiglia già introdotti o rafforzati dal Governo al
fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Per la
tutela di donne e giovani è necessario esaminare modalità per un intervento di
abolizione dei ricongiungimenti previdenziali onerosi, che penalizzano coloro
che sono costretti a cambiare lavoro. In via generale, si sottolinea, inoltre,
la necessità di accompagnare il percorso di ripresa con politiche attente
all’investimento sociale, evidenziando come il nuovo Governo dovrà affrontare
la questione del finanziamento della spesa per la rete degli interventi e
servizi sociali territoriali, al fine, in particolare, di favorire i servizi
socio-educativi per la prima infanzia, i servizi di cura per le persone con
disabilità e gli anziani non autosufficienti, i servizi residenziali per le
fragilità e gli strumenti locali di contrasto alla povertà, valutando a tale
ultimo proposito l’estensione, dal punto di vista territoriale e dei
beneficiari, della sperimentazione della nuova social card, anche
tramite con il sostegno dei fondi strutturali;
e)
lotta all’evasione e riforma fiscale: nell’ambito di una
strategia di politica fiscale incentrata sulla lotta all’evasione e
all’elusione fiscale e sullo spostamento della tassazione dal lavoro e dal
reddito al patrimonio e al consumo, si segnala per il futuro l’esigenza di
riprendere i principi contenuti nel disegno di legge di delega fiscale, il cui iter
parlamentare non si è completato nella scorsa legislatura, e di portare a
termine la riforma del catasto e il processo di semplificazione fiscale. Per
quanto concerne il carico fiscale, andranno introdotti interventi correttivi
soprattutto a tutela delle fasce più deboli e delle famiglie numerose, mentre
sul versante delle attività produttive è segnalato l’apporto che potrà derivare
dalla graduale eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile
dell’IRAP, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché l’esigenza di
continuare a favorire l’occupazione incentivando le imprese e favorendo
l’investimento degli utili in azienda. Specifico rilievo viene inoltre dato
alla necessità di rinforzare gli incentivi occupazionali per giovani e donne
tenendo conto delle peculiarità territoriali;
f)
concorrenza, infrastrutture e ambiente imprenditoriale:
in tali settori d’intervento, viene in primo luogo segnalata l’esigenza di
potenziare le infrastrutture critiche legate all’ambiente e all’energia (quali,
ad esempio, gli impianti per il trattamento dei rifiuti, le reti idriche, le smart
grids) e l’azione di messa in sicurezza del territorio. Sarà inoltre
riesaminato Il credito d’imposta per le infrastrutture realizzate in project
financing al fine di superare la logica delle “grandi opere” estendendo
l’agevolazione alle opere d’importo inferiore ai 500 milioni di euro. Specifico
rilievo, nell’ottica della velocizzazione dell’attuazione dei progetti di
dotazione infrastrutturale viene attribuito alla prosecuzione del programma di
semplificazione delle procedure e, in particolare, alla semplificazione dei
livelli decisionali tra Stato, Regioni ed Enti locali, cui potrebbe contribuire
la proposta di legge costituzionale di revisione del Titolo V della
Costituzione presentata nel 2012 e non ancora approvata. Tra le opere
infrastrutturali di rilievo sono richiamati il Piano contro il dissesto
idrogeologico, quello sui depuratori e il Piano per le scuole.
Oltre all’impegno della PA di fornire liquidità al
tessuto imprenditoriale attraverso l’accelerazione dei pagamenti dei debiti
pregressi, è poi segnalata l’esigenza di potenziare l’accesso delle imprese
agli strumenti finanziari, agendo a tal fine sul funzionamento del Fondo di
Garanzia per le PMI e sulla relazione tra banche e imprese. Con riferimento al
miglioramento dell’ambiente imprenditoriale, si sottolinea la necessità di
potenziare l’opera di semplificazione amministrativa con una cospicua riduzione
delle procedure inutili, adottando a tal fine, previa consultazione telematica
e su intesa con Regioni ed Enti Locali, un nuovo programma per la misurazione e
la riduzione degli oneri regolatori e dei tempi. Le semplificazioni in materia
di attività produttive e di autorizzazioni ambientali, l’utilizzo sempre più
esteso di procedure telematiche, lo snellimento delle procedure autorizzative e
la completa operatività dello Statuto delle imprese, sono qualificati come
impegni imprescindibili. Per quanto concerne la competitività sarà in primo
luogo data attuazione all’apposito fondo per finanziare la ricerca e
l’innovazione costituito con la Legge di stabilità 2013 e sarà esaminata la
possibilità di rendere strutturale il credito d’imposta per le imprese che
investono. Dovranno inoltre essere portate avanti le azioni di sostegno alle start
up innovative e per i giovani imprenditori.
Con riferimento al processo di liberalizzazione del
mercato e rafforzamento della concorrenza, specifico rilievo è dato
all’esigenza di non rinviare ulteriormente la riforma dei servizi pubblici locali, eliminando l’attuale
incertezza normativa che costituisce il principale ostacolo allo sviluppo e
agli investimenti nel settore. Viene poi sottolineata la necessità di
completare e monitorare l’attuazione degli interventi disposti con il decreto
legge sulle liberalizzazioni, con particolare riguardo all’operatività
dell’Autorità dei Trasporti, alle assicurazioni RC-Auto e al settore dei taxi,
valutando al contempo l’impatto delle nuove norme nel settore delle farmacie. Per estendere
progressivamente il perimetro delle liberalizzazioni e perfezionare quelle già
in atto sarà, inoltre, necessario
vigilare sull’elaborazione e implementazione della legge annuale sulla
concorrenza.
Infine, occorrerà proseguire l’opera di
razionalizzazione della macchina giudiziaria, assicurando una maggiore
deflazione della domanda di giustizia, attraverso una revisione della normativa
sulla mediazione, e una maggiore efficienza ed efficacia degli uffici
giudiziari, attraverso: il completamento della riforma della geografia
giudiziaria; la prosecuzione del processo d’informatizzazione degli uffici; la
diffusione delle buone prassi organizzative; il monitoraggio del funzionamento
dei Tribunali delle Imprese, anche per verificare l’utilità di possibili
successivi ampliamenti delle materie di specializzazione. Per quanto attiene
alla deflazione del contenzioso, andranno considerate misure, anche di
carattere straordinario, per affrontare le cause pendenti, specie nelle Corti
d’Appello. Va inoltre istituito un osservatorio per l’analisi degli effetti
delle riforme e completata la creazione di una banca dati automatizzata, con lo
scopo di monitorare l’impatto delle riforme, identificarne le criticità e
raccogliere le buone pratiche.
Nel quarto capitolo
del PNR è contenuta l’analisi degli squilibri macroeconomici che
incidono sulla competitività del paese. Il processo di sorveglianza degli
squilibri macroeconomici dei Paesi dell’Area dell’Euro, che rientra nel ciclo
annuale del Semestre europeo, prevede una valutazione
periodica da parte della Commissione europea dei rischi derivanti dagli
squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro, effettuata sulla base
di un quadro di riferimento costituito da dieci indicatori economici (scoreboard).
Gli indicatori sono distinti
tra quelli che monitorano gli squilibri esterni e quelli riferiti agli squilibri
interni, come evidenzia la seguente tabella. Per ciascuno di essi sono
stabilite delle soglie di allerta, che possono individuare sia livelli
eccessivamente alti, sia eccessivamente bassi della variabile.
|
Squilibri esterni
|
|
indicatore
|
Saldo
del conto corrente
in % del PIL
|
Posizione
netta degli investimenti
in % del PIL
|
Tasso di cambio effettivo reale
Variazione in % del PIL con deflatori IACP
|
Quote di mercato delle esportazioni Variazione in % (su 5 anni)
|
Costo nominale del lavoro per unità di prodotto (CLUP) Variazione in % (su tre anni)
|
|
Squilibri interni
|
|
indicatore
|
Indice delle quotazioni
reali immobiliari
Variazione % su base annua
|
Flussi di credito al
settore privato
in % del PIL
|
Debito del settore
privato
in % del PIL
|
Debito pubblico in % del PIL
|
Tasso
di disoccupazione Media su tre anni
|
Passività
totali del settore finanziario Variazione
% su base annua
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il
riscontro di “gravi squilibri” tali da mettere in rischio il funzionamento
dell’Unione economica e monetaria può determinare l’attivazione di una
procedura correttiva, comprendente anche elementi sanzionatori, volta a
condurre lo Stato interessato ad adottare le misure correttive necessarie.
La
valutazione in questione è stata per la prima volta attivata nel 2012,
quando la Commissione ha pubblicato il primo Rapporto di Allerta (COM
(2012)68),in cui s’indicava che 12
Paesi, tra cui l’Italia, necessitavano di una “analisi approfondita” per
valutare possibili squilibri eccessivi. Nel Rapporto si evidenziava, in
particolare, come l’Italia, con riferimento ai risultati 2010, abbia superato
i valori soglia di due indicatori, costituiti dalla perdita di competitività
- desumibile dalla contrazione delle quote di mercato delle esportazioni -
e dal livello elevato del debito pubblico. Nelle analisi approfondite
pubblicate nel successivo mese di maggio del 2012, tali squilibri sono
stati giudicati “seri”, ma non eccessivi e l'Italia è stata
pertanto inclusa nella procedura preventiva.
Anche
il successivo Rapporto di Allerta include l’Italia tra i Paesi
che, presentando “seri” squilibri, necessitano di un’analisi
approfondita, che è stata pubblicata il 10 aprile scorso.
La
relazione approfondita sugli squilibri macroeconomici in alcuni Stati membri
dell’area euro presentata dalla Commissione europea il 10 aprile scorso
(COM(2013)199) – che si colloca nell’ambito della procedura di sorveglianza
macroeconomica disciplinata da due appositi regolamenti del cd. six pack
- rileva l’esistenza di squilibri macroeconomici in tredici Stati
membri dell’UE: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Ungheria,
Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Per ciascuno di
questi Paesi la Commissione ha predisposto un documento di lavoro recante
un’analisi specifica. Soltanto nel caso della Spagna e della Slovenia
la Commissione ritiene che gli squilibri macroeconomici rilevati siano eccessivi
e richiedano, pertanto, un piano correttivo.
La
Commissione osserva, in via generale, che in tutti i Paesi dell’UE, inclusi i
13 sopra richiamati, è già in atto un aggiustamento macroeconomico, anche se
con differenze nella natura e nel ritmo di attuazione, evidenziando al contempo
la necessità di ulteriori e più decisi interventi in vari ambiti. Per quanto
concerne specificamente l’Italia, l’esame approfondito della
Commissione, nel rilevare l’esistenza di squilibri macroeconomici che
richiedono un attento monitoraggio e misure di correzione in coerenza con le
raccomandazioni specifiche per Paese che saranno adottate dal Consiglio in
esito al semestre europeo 2013, evidenzia, in particolare che:
·
in un contesto di modesta
crescita, la perdita di quote nel mercato nelle esportazioni e la
sottostante perdita di competitività, unitamente al livello elevato
di indebitamento pubblico, devono essere oggetto di un'attenzione costante
in un più ampio programma di riforme, al fine di ridurre il rischio di
effetti negativi sul funzionamento dell'economia italiana e dell’Unione
economica e monetaria nel suo complesso;
·
in un contesto di elevata
avversione al rischio da parte dei mercati finanziari, l’alto debito
pubblico si riverbera negativamente sulle prospettive di crescita
del Paese, generando una serie di effetti negativi: l’aumento della pressione
fiscale necessaria per pagare gli interessi sul debito, la difficoltà del
sistema bancario e – di riflesso – di imprese e famiglie a finanziarsi a costi
contenuti; un margine molto limitato per le politiche fiscali anticicliche e di
stimolo alla crescita. La Commissione riconosce che il Governo italiano, al
fine di mettere l'elevato rapporto debito-PIL pubblico su un percorso di
discesa costante, ha perseguito una rilevante strategia di consolidamento
fiscale, ma le prospettive negative in termini di crescita rendono ancora
più essenziale raggiungere e mantenere un avanzo primario (differenza
tra entrate e uscite dello Stato al netto degli interessi sul debito)
consistente;
·
la produttività stagnante
ha comportato un aumento dei costi per unità di lavoro rispetto agli altri
Paesi e, unitamente all'apprezzamento considerevole del tasso di cambio
effettivo nominale in Italia tra il 2003 e il 2009, ha ulteriormente minato la
competitività di costo dei prodotti italiani;
·
la pressione fiscale si
mantiene elevata, soprattutto sul lavoro e capitale;
·
il mercato delle esportazioni
continua a soffrire di una specializzazione di prodotto sfavorevole, e la debole
dotazione di capitale umano ostacola il passaggio a un modello di
specializzazione tecnologicamente più avanzato;
·
la complessità del quadro
istituzionale e normativo, nonché la struttura proprietaria e gestionale
delle imprese, ostacolano la capacità delle aziende italiane di crescere,
limitando gli incrementi di produttività e l’espansione su scala
internazionale. Questi fattori limitano anche l'afflusso d’investimenti
diretti esteri;
·
la recessione ha seriamente
indebolito la capacità del settore bancario italiano di sostenere l'aggiustamento
necessario per affrontare gli squilibri.
Il
DEF rileva, quindi, che analogamente allo scorso anno anche nel 2013 il
meccanismo di sorveglianza degli squilibri evidenzia, per l’Italia, valori
sopra la soglia di allerta per il debito pubblico e per le quote di
mercato delle esportazioni, la cui contrazione sarebbe legata alla perdita
di competitività verificatasi a partire dall’introduzione dell’euro.
Nell’analisi
degli squilibri macroeconomici riportata nel PNR si rileva come tra il 2000
e il 2011 la quota dell’Italia sul totale del commercio
mondiale sia scesa dal 3,8 al 3,3 per cento. Salvo una fase di
recupero realizzatasi nel 2001-2014, si è registrata una tendenza negativa
durata sino al 2010; i dati più recenti segnalano, peraltro, una decisa
attenuazione della velocità di caduta della quota, con una sua sostanziale
stabilizzazione a partire dal 2011. La contrazione delle quote di mercato
italiane presenta un profilo simile a quello di altri Paesi dell’area
dell’euro, anche se in termini di variazione percentuale i risultati sono
peggiori rispetto a quelli della media dei Paesi dell’area; su tale media pesa,
tuttavia, in misura rilevante il livello elevato delle esportazioni delle
Germania, al netto delle quali la dinamica registrata in Italia non appare
sostanzialmente difforme da quella di altri principali paesi europei.
In
questo quadro, il principale ostacolo per riguadagnare competitività e
migliorare le prospettive di crescita economica è costituito dalla bassa
produttività. Secondo le valutazioni della Commissione, un fattore di
debolezza è costituito, in particolare, dal livello elevato, rispetto alla
media dell’Area dell’euro, del costo unitario del lavoro, imputabile
anche a una dinamica salariale non allineata a quella della produttività.
Si
ricorda che già il PNR dello scorso anno identificava una serie di debolezze di
fondo del sistema economico nazionale, segnalando nella progressiva riduzione
della produttività totale dei fattori, accompagnata da un alto costo unitario
del lavoro rispetto agli altri paesi UE, una delle principali ragioni della
bassa crescita italiana. In particolare, il costo del lavoro per unità di
prodotto (CLUP), incidendo in modo rilevante sulla competitività di prezzo,
costituisce è uno degli indicatori preso a riferimento per la valutazione degli
squilibri esterni. Pur non oltrepassando, al momento della valutazione, il
valore soglia individuato dalla Commissione, il PNR 2013 rileva come
l’aumento del CLUP sia strettamente connesso con la perdita di competitività e
di quote di mercato dell’Italia e sia legato principalmente all’andamento
stagnante della produttività. Nel quadro di una crescita pressoché nulla
della produttività del lavoro iniziata dalla fine degli anni ’90, il costo
unitario del lavoro per l’intera economia ha continuato ad aumentare nel
periodo successivo alla crisi anche in termini reali, poiché la dinamica del
reddito pro-capite, seppure in moderazione nei trimestri più recenti, è
risultata maggiore di quella della produttività. Una causa
dell’andamento ancora insoddisfacente dell’indicatore è attribuibile, ad avviso
del Governo, ad aspetti ciclici e a un diverso comportamento del mercato del
lavoro rispetto a quello dei beni. La contrazione dell’occupazione è stata
molto meno marcata rispetto alla caduta del prodotto interno lordo. In
prospettiva, è atteso invece un ribilanciamento di queste due componenti, posto
che con la ripresa dell’economia gli aumenti dell’occupazione saranno
probabilmente meno che proporzionali rispetto alle variazioni del PIL.
Resta tuttavia cruciale, prosegue il Governo, ottenere maggiori incrementi di
produttività che non vadano a scapito di aumenti di occupazione. In proposito,
già il PNR dello scorso anno includeva, tra le principali cause della riduzione
della produttività italiana, la minore qualificazione del capitale umano, un
modello di sviluppo basato sulle piccole e medie imprese che mostrano una
minore capacità di assorbimento delle nuove tecnologie e di penetrazione sui
mercati internazionali. Per quanto concerne l’altra componente che determina il
CLUP, ossia la variazione dei salari nominali, essa è risultata
sostanzialmente in linea con la media europea e si ritiene pertanto che
questa variabile non abbia giocato, al contrario della bassa produttività, un
ruolo rilevante nella perdita di competitività. Il Governa ricorda, inoltre,
come alla necessità di perseguire un maggiore allineamento tra il comportamento
dei salari e le variazioni della produttività sia stata data una risposta
rafforzando la negoziazione salariale di secondo livello tramite il recente
accordo sulla produttività. Si rileva, infine, come alla necessità di far
recuperare competitività di prezzo all’economia italiana si contrapponga
l’esigenza di non deprimere ulteriormente la domanda interna, particolarmente
rilevante in una fase congiunturale ancora molto delicata come quella attuale.
Per
quanto concerne le variabili finanziarie, salvo il livello del debito
pubblico, l’Italia non presenta valori critici: i flussi di credito sono
considerati dal DEF nella norma e il livello dell’indebitamento del settore
privato presenta dimensioni molto contenute rispetto alla media europea. Non si
rilevano, inoltre, variazioni eccessive nelle passività del settore
finanziario.
In
particolare, la situazione complessiva della ricchezza delle famiglie,
reale e finanziaria, è da considerarsi tra le più solide in Europa. Il settore
delle imprese non finanziarie risulta, come in tutte le economie
avanzate, strutturalmente in una posizione debitoria, con un livello d’indebitamento
sostanzialmente in linea con la media europea, anche se i prestiti
contratti nei confronti delle banche rappresentano una percentuale più alta
rispetto al benchmark europeo, anche in ragione della composizione del
tessuto produttivo, composto da imprese di piccole e medie dimensioni che
trovano difficoltà ad accedere in maniera diretta al mercato dei capitali e
risultano più vulnerabili a situazioni di restrizione del credito. Le imprese
finanziarie hanno riqualificato le attività patrimoniali a favore di
crediti meno rischiosi e le principali banche, dando seguito alla
raccomandazione della European Banking Authority del dicembre 2011,
hanno provveduto ad effettuare ricapitalizzazioni e rilevanti operazioni di deleveraging.
Nel complesso, il settore bancario italiano è considerato solido
perché presenta un’esposizione contenuta verso attività rischiose e un valore
ridotto della leva finanziaria rispetto alla media europea. La solidità
strutturale del sistema finanziario, comprovata dalle analisi effettuate
dall’autorità di vigilanza e confermata dal FMI al termine della missione
svoltasi nel marzo del 2013, implica, ad avviso del Governo, che non appena se
ne verificassero le condizioni il settore bancario potrebbe tornare ad
espandere il credito all’economia.
Un
elemento di preoccupazione, in base alle valutazioni della Commissione
riportate nel PNR, attiene all’elevato costo dei finanziamenti alle imprese,
il cui divario rispetto ai principali paesi dell’Area dell’euro rifletterebbe
le tensioni sui debiti sovrani e la conseguente difformità di trasmissione
della politica monetaria nelle varie economie dell’Area. Analogamente a quanto
affermato lo scorso anno, la Commissione rileva, tuttavia, che l’indebitamento
del settore privato è inferiore alla media dell’Area dell’euro.
In
via generale, il PNR evidenzia, infine, come le politiche di aggiustamento
fiscale e le riforme attuate abbiano condotto ad un miglioramento
strutturale complessivo dal punto di vista degli squilibri macroeconomici,
anche se la fase congiunturale, ancora sfavorevole, ha reso più difficile il
pieno palesarsi dei risultati conseguiti. Segnali positivi sono riscontrabili
sia dal lato della competitività – ove gli scambi con l’estero sono
caratterizzati da un deciso miglioramento del saldo delle partite correnti, da
un buon andamento delle esportazioni e da una sostanziale stabilizzazione delle
quote di prodotti italiani nei mercati internazionali – sia sotto il profilo
dei mercati finanziari, ove si è registrato un deciso calo del differenziale
di rendimento tra i BTP e i Bund tedeschi rispetto ai picchi registrati nei
momenti più acuti della crisi, il quale contribuirà al graduale venire meno
delle tensioni sul mercato del credito e, in generale, su tutti gli indicatori
finanziari monitorati a livello europeo.
Il quinto capitolo del
PNR illustra, nel dettaglio, il complesso delle riforme nazionali
adottate nel 2012 – che qui per brevità non è possibile richiamare- anche
attraverso specifichi approfondimenti tecnici e l’indicazione delle “azioni in
itinere’” per le iniziative governative che non sono riuscite ad arrivare alla
fine del processo parlamentare ancorché deliberate dal Consiglio dei Ministri.
Nel capitolo sono altresì riportate informazioni sullo stato di attuazione dei
provvedimenti adottati.
Il sesto
capitolo del PNR indica le principali azioni intraprese dalle
amministrazioni locali nell’ambito del processo del Semestre europeo.
In allegato
al PNR è, infine, riportata appendice con quattro griglie di
dettaglio recanti una disaggregazione degli impatti macroeconomici delle
riforme, la sintesi di tutte le nuove misure introdotte nel periodo 2012-2013 e
l’aggiornamento attuativo delle misure del precedente PNR, nonché il dettaglio
delle misure introdotte a livello regionale.
Approfondimento
2. Il semestre europeo
La procedura del semestre
europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche è volta
a garantire la coerenza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati
membri, da approvare nella seconda metà dell'anno, con le raccomandazioni
approvate dalle istituzioni dell'UE nella prima metà dell’anno.
A questo scopo, il semestre
europeo prevede le seguenti fasi secondo una serrata scansione temporale:
·
gennaio: presentazione da parte della
Commissione dell’analisi annuale sulla crescita (la presentazione
dell’analisi relativa al 2013 è stata anticipata al 28 novembre 2012, in
considerazione della necessità di prospettare misure condivise ed urgenti alla
crisi economica);
·
febbraio/marzo: il Consiglio europeo elabora
le linee guida di politica economica e di bilancio a livello
UE e a livello di Stati membri (per il 2013 vedi paragrafo
successivo);
·
metà aprile: gli Stati membri sottopongono
contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati
nell’ambito della nuova Strategia per la crescita e l’occupazione UE 2020) ed
i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito
del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal
Consiglio europeo;
·
fine maggio-inizio
giugno: sulla base dei
PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni
di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri
(la presentazione delle raccomandazioni per il 2013 è attesa per il 29 maggio);
·
giugno: il Consiglio ECOFIN e,
per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali,
approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche
sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;
·
seconda metà
dell’anno (c.d. semestre nazionale):
gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo
conto delle raccomandazioni ricevute nonché dei vincoli procedurali
prospettati dal c.d. two pack, in corso di adozione;
·
nell’indagine annuale
sulla crescita dell’anno successivo, la Commissione dà conto dei
progressi conseguiti dai Paesi membri nell’attuazione delle raccomandazioni
stesse.
Priorità del Consiglio
europeo di primavera
Il Consiglio europeo del
14-15 marzo 2013 ha stabilito le seguenti priorità per il semestre
europeo 2013, avallando le indicazioni contenute enunciate nell'analisi
annuale della crescita 2013 (che peraltro confermano quelle già definite
per il 2012):
·
portare avanti un risanamento
di bilancio differenziato e favorevole alla crescita;
·
ripristinare la
normale erogazione di prestiti all'economia;
·
promuovere la crescita e la competitività;
·
lottare contro la
disoccupazione e le
conseguenze sociali della crisi;
·
modernizzare la
pubblica amministrazione.
Nelle conclusioni del
Consiglio europeo, inoltre:
-
si invitano gli Stati membri
ad intervenire contestualmente sul versante delle spese e delle entrate
adottando misure “mirate a breve termine per promuovere la crescita e
sostenere la creazione di posti di lavoro, in particolare dei giovani”,
dando la priorità agli investimenti favorevoli alla crescita;
-
si ribadisce l’esigenza di
proseguire riforme strutturali nonché di assicurare un equilibrato riparto
del carico fiscale attraverso il recupero dell’evasione (anche
mediante accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio con Paesi
terzi), di avviare politiche attive per l’occupazione, l’istruzione e la
formazione, di sfruttare il potenziale dell’economia verde, di
completare l’unione bancaria e di portare a compimento la riforma della governance
economica attraverso la piena operatività del cosiddetto Two pack e del
cosiddetto Fiscal compact;
-
si riafferma la necessità di
realizzare la cosiddetta Strategia 2020 mediante completamento del mercato
interno dell’energia, le politiche per l’innovazione, il completamento della
cosiddetta agenda digitale, all’integrazione dell’industria europea della
difesa, alla competitività dell’industria europea, mentre non è prevista alcuna
azione specifica per quanto concerne l’eventuale revisione delle regole
e degli obiettivi connessi al Patto di stabilità e crescita.
Il Documento di Economia e Finanza (DEF) riporta l'analisi del
conto economico delle amministrazioni pubbliche (PA) a legislazione vigente,
integrato con le informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2012 (Tabella
2.1). I conti a legislazione vigente, presentati nella sezione II del DEF,
vengono rappresentati nella versione conforme alle regole di Contabilità
Nazionale, differenziandosi rispetto ai quelli contenuti nella sezione I, che
sono redatti ai sensi del Regolamento CE 1500/2000.
L’indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni
I dati di
consuntivo Istat attestano un indebitamento netto della PA per il 2012 pari a
47.633 milioni (3 per cento del PIL), in
riduzione di 0,8 punti rispetto all’esercizio precedente.
Rispetto alle
stime oggetto della Nota di aggiornamento del DEF 2012 presentata dal
Governo nel settembre scorso (‑2,6 per cento), il deficit é risultato più
elevato per effetto di una dinamica sfavorevole delle entrate (‑0,8 punti
percentuali rispetto alla Nota) solo parzialmente compensata da una minore
spesa primaria (‑0,4 punti), a fronte di un aumento contenuto della spesa
per interessi.
Tali
variazioni si riflettono sull’avanzo primario, pari al 2,5 per cento del PIL
(1,2 per cento nel 2011) e inferiore di 0,4 punti alle previsioni, mentre la
spesa per interessi si attesta al 5,5 per cento del prodotto, in aumento di
mezzo punto rispetto al precedente esercizio.
Nonostante il
peggioramento delle previsioni, il valore del deficit complessivo delle
pubbliche amministrazioni si attesta come si è detto al 3 per cento,
coincidente con la soglia di riferimento prevista dal Trattato di Maastricht:
ciò dovrebbe, pertanto, consentire la chiusura della procedura per disavanzi
eccessivi avviata nel 2009.
La procedura per deficit eccessivo
Il
superamento della soglia del 3 per cento del rapporto indebitamento netto/PIL
nel 2009 ha comportato per l’Italia, così come per la maggior parte dei paesi
europei colpiti dalla crisi economico-finanziario, l’attivazione della
procedura per disavanzi eccessivi prevista dai regolamenti europei ed il conseguente
impegno del nostro Paese a rientrare sotto tale soglia nel 2012.
Nel
giugno 2012 il Consiglio Europeo ha approvato le raccomandazioni sul Programma
nazionale di riforma 2012 dell'Italia ed il parere sul Programma di stabilità
per gli anni 2012-2015. Con riferimento a
quest’ultimo, il Consiglio raccomandava di attuare la strategia di bilancio
prevista dai documenti di finanza pubblica presentati dal Governo italiano e di
garantire che il disavanzo eccessivo fosse corretto nel 2012. Il Consiglio
rilevava che il programma di stabilità confermava l’obiettivo di medio termine
(OMT) relativo ad una posizione di bilancio di sostanziale equilibrio in
termini strutturali da raggiungere nel 2013, a fronte di uno sforzo medio annuo
superiore allo 0,5 per cento e di una evoluzione della spesa in linea con il
parametro di riferimento. Tale percorso, contraddistinto da avanzi primari
strutturali positivi, consentiva di riportare il rapporto debito/Pil su un trend
decrescente già dal 2013.
Il dati di consuntivo
Istat (marzo 2013), con riferimento all’esercizio appena trascorso, indicano un
indebitamento netto più elevato rispetto a quello stimato nel PdS - DEF 2012
(-1,7 per cento) e nella successiva Nota di aggiornamento (-2,6 per cento) e
pari al 3 per cento: tale valore coincide con la soglia di riferimento prevista
dal Trattato.
Le entrate nel conto consolidato della P.A.
Le entrate complessive delle Amministrazioni Pubbliche
realizzate nel 2012 hanno risentito di due fattori rilevanti che hanno
determinato effetti di segno opposto: da un lato, la fase ciclica negativa ha
comportato una riduzione della base imponibile tributaria e contributiva con
conseguente contrazione del gettito; dall’altro lato, le manovre approvate
nella seconda metà del 2011 hanno determinato un incremento del carico fiscale
a carico dei contribuenti.
Nel complesso – anche in considerazione della contestuale
contrazione del PIL nel 2012 rispetto al 2011 – le entrate totali sono
risultate superiori, in rapporto al PIL, a quelle del 2011 e la pressione
fiscale è aumentata di 1,4 punti percentuali passando dal 42,6 per cento al 44
per cento.
Rispetto alle stime contenute
nella Nota di aggiornamento al DEF 2012 (settembre 2012), i risultati
registrano una contrazione delle entrate complessive di 11.049 milioni, cui
contribuisce la riduzione delle entrate tributarie per 9.203 milioni e dei
contributi sociali per 1.548 milioni.
Con riferimento al comparto Stato
(che registra uno scostamento tra stime e consuntivo pari a -8.092), la
riduzione delle imposte dirette è attribuibile alle maggiori compensazioni –
rispetto a quelle stimate - per circa 2.600 milioni di euro dovuti al credito
d’imposta a favore degli enti creditizi e finanziari delle imposte anticipate
iscritte a bilancio, in presenza di perdita di esercizio,
mentre la contrazione delle imposte indirette (pari a circa 10.200 milioni) è
attribuibile principalmente ad una dinamica dei consumi meno favorevole
rispetto a quanto stimato, che ha comportato una contrazione dell’IVA di circa
5.300 milioni, delle accise per circa 1.000 milioni e altre imposte indirette
per circa 3.900: tale importo include, tra l’altro, il risultato dell’imposta
di bollo sui titoli risultato inferiore di circa 1.900 milioni rispetto alle
previsioni.
Il comparto degli enti territoriali, invece, presenta un
saldo positivo tra consuntivo e stime per 1.175 milioni, attribuibile in via
prevalente alle maggiori entrate IMU per la quota di spettanza degli enti
locali pari a circa 1.700 milioni di euro, per effetto degli aumenti delle
aliquote IMU sulle abitazioni principali e sugli immobili. Tali maggiori
entrate, insieme a quelle registrate anche per l’addizionale comunale IRPEF,
hanno compensato la perdita di gettito IRAP realizzata pari a circa 1.500
milioni.
L’analisi per componenti economiche
delle minori entrate tributarie della PA evidenzia una riduzione delle imposte
indirette pari a 3.432 milioni e delle imposte dirette pari a 5.961 milioni:
tali effetti sono in parte giustificati dalla riclassificazione operata
dall’ISTAT della quota IMU di spettanza erariale dalle imposte sul reddito alle
imposte indirette.
Le spese
Le spese
finali nel 2012 mostrano un incremento contenuto rispetto al precedente
esercizio (+0,6 per cento), passando da 796.080 milioni del 2011 a 801.082
milioni del 2011. Tale risultato si determina a fronte di una riduzione della
spesa primaria (-3,4 miliardi, -0,5 per cento) e di un aumento della spesa per
interessi (+8,4 miliardi, +10,7 per cento).
Nonostante tale dinamica contenuta, in presenza di una
contrazione anche in termini nominali del prodotto, le spese totali aumentano
la loro incidenza sul PIL, passando dal 50,4 per cento del 2011 al 51,2 del
2012. Sull’aumento complessivo pesa per 5 punti la maggiore spesa per interessi
(da 5 a 5,5 per cento) e, rispettivamente, di 2 punti e 1 punto la spesa
corrente (da 42,4 a 42,6 per cento) e quella in conto capitale (dal 3 al 3,1
per cento).
Al netto delle maggiori entrate derivanti dall’asta delle
frequenze registrate nel 2011 (3.827 milioni, pari a 0,24 punti percentuali di
PIL) che, in base alle regole di contabilità nazionale sono portate in
riduzione della spesa in conto capitale, quest’ultima registrerebbe invece una
diminuzione nel 2012 di circa 0,1 punti.
Alla dinamica mostrata dalla spesa primaria corrente
contribuisce una variazione positiva (+2,4 per cento rispetto al 2011) delle
prestazioni in denaro, a fronte di una riduzione dei redditi da lavoro
dipendente (-2,3 per cento), dei consumi intermedi (-2,6 per cento) e delle
altre spese correnti (-4,6 per cento). Evidenzia una variazione negativa anche
la spesa in conto capitale (-0,6 per cento), che risulterebbe più accentuata
ove si scomputasse dall’aggregato 2011 l’importo dell’asta delle frequenze.
Rispetto alla Nota di aggiornamento dello scorso
settembre, si evidenzia una riduzione di 1,7 miliardi per i redditi da lavoro
dipendente. A tale differenza contribuisce la rilevazione a consuntivo degli
effetti di minor spesa conseguenti all’applicazione delle misure recate dal
decreto legge 78/2010: in occasione dell’esame
del disegno di legge di conversione del decreto legge, non erano stati ascritti
effetti finanziari in relazione all’introduzione di alcune norme di risparmio,
rilevabili prudenzialmente ex-post.
Tale variazione, insieme a quella relativa ai consumi
intermedi (-2,5 miliardi) si riflette su un andamento migliore del previsto
della spesa sanitaria (-2,7 miliardi), che a sua volta incorpora anche il
consolidamento del risultato 2011, in riduzione di 500 milioni rispetto alle
precedenti stime di contabilità nazionale.
Sostanzialmente in linea con le precedenti previsioni la
spesa per pensioni e altre prestazioni (-307 milioni).
L’aumento rilevato nella spesa in conto capitale (+ 1
miliardo) è da attribuire ai contributi in conto capitale (+1,7 miliardi) a
fronte di una riduzione degli investimenti fissi lordi della voce “altri
trasferimenti”.
Il DEF
presenta le stime relative al periodo 2013-2015 aggiornate - rispetto a quelle
presentate nel settembre scorso - sulla base delle informazioni di consuntivo
del 2012, della revisione del quadro macroeconomico e dell'impatto delle
normative introdotte successivamente: in particolare, la legge di stabilità
2013, i provvedimenti adottati entro il mese di marzo e il D.L. 35/2012
sull’accelerazione del rimborso dei debiti della PA presentato il 6 aprile e
attualmente all’esame del Parlamento.
Viene,
inoltre, presentata per la prima volta la stima relativa agli esercizi 2016 e
2017.
L’indebitamento netto della PA
Il conto economico esposto dal DEF evidenzia un
indebitamento netto pari a -2,9 per cento del PIL nel 2013, superiore di 1,1
punti rispetto alle previsioni (-1,8 per cento) contenute nel quadro
programmatico della Nota illustrativa della legge di stabilità (v. tabella 2.2).
Tale variazione, secondo il documento, è ascrivibile ai
seguenti fattori:
·
+ 0,5 punti agli effetti dei più elevati pagamenti della PA
autorizzati dal D.L. 35/2013;
·
+ 0,9 punti alla revisione delle stime di crescita per il 2013
·
- 0,3 punti a minori spese per interessi, in relazione ad un
andamento dei tassi più favorevole rispetto a quello previsto nel mese di
settembre.
L’aggiornamento delle stime per l’esercizio in corso
comporta una revisione anche nel successivo biennio di 0,3 punti l’anno:
·
‑1,8 per cento nel 2014 rispetto a ‑1,5 per cento
della Nota
·
‑1,7 per cento nel 2015 rispetto a -1,4 per cento.
Per gli anni successivi, le stime contenute nel Documento
evidenziano un deficit pari all’1,3 per cento nel 2016 e all’1 per cento nel
2017.
Con riferimento al periodo 2015-2017 si rileva, tuttavia,
come le previsioni contenute nel conto economico esposto nel DEF - II sezione
(Tavola II.2.1 e ss) scontino la conferma degli effetti del regime sperimentale
IMU, dei coefficienti catastali maggiorati e di altre voci di maggiori entrate.
Tali entrate, invece, vengono meno alla fine del 2014.
Il quadro di finanza pubblica, redatto in base al
criterio della legislazione vigente, non dovrebbe invece scontare gli effetti
di tali misure, per la cui conferma è necessario un provvedimento normativo.
Il venir meno di tali entrate determina, (v. nota alla
Tavola I.1 del PdS) un indebitamento netto più elevato e pari a -2,5 per cento
nel 2015, a -2,1 per cento nel 2016 e a -1,8 per cento nel 2017.
Le entrate
Il Documento in esame chiarisce che le previsioni sono
costruite considerando gli effetti finanziari associati sia ai provvedimenti
legislativi approvati a tutto marzo 2013 sia al decreto legge n. 35 del 2013
recante disposizioni in materia di accelerazione dei pagamenti dei debiti delle
pubbliche amministrazioni.
Nel 2013 le entrate totali presentano un incremento rispetto
al PIL di 0,5 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente, per effetto
principalmente delle misure previste dal DL n. 201/2011 e della legge di
stabilità 2013.
Le entrate tributarie, che passano dal 30,2 per cento del
PIL del 2012 al 30,1 per cento del 2017, considerano oltre alle variazioni del
quadro macroeconomico e agli effetti dei provvedimenti legislativi anche
l’effetto di trascinamento dei risultati 2012, che hanno fatto registrare una
riduzione di 9.203 milioni rispetto alle stime della Nota di aggiornamento al
DEF 2012.
In particolare, le previsioni per il 2013 (+5.677 milioni
rispetto al 2012) rappresentano un impatto differenziale netto sul 2013 delle
misure fiscali adottate; negli anni successivi rilevano le variazioni in
aumento dell’IRPEF e dell’IVA correlate al miglioramento del quadro
macroeconomico nonché la dinamica delle entrate territoriali. Rispetto a queste
ultime, il Documento afferma che le previsioni riflettono l’effetto delle
disposizioni in materia di IMU introdotte dalla legge di stabilità 2013, che
hanno attribuito l’intero gettito direttamente ai comuni con l’eccezione di
quello relativo agli immobili iscritti al catasto nella categoria D.
Le disposizioni in materia di IMU introdotte dalla legge
di stabilità 2013 hanno modificato le modalità di attribuzione del gettito,
lasciando tuttavia invariato l’ammontare delle risorse complessivamente
spettanti ai comuni. Infatti, a fronte di un incremento del gettito IMU
riscosso direttamente dai comuni è stata ridotta la dotazione del fondo di
solidarietà comunale. Si segnala, pertanto, che a fronte dell’incremento delle
entrate tributarie indicate dal Documento in esame le previsioni dovrebbero
scontare una contestuale riduzione dei trasferimenti erariali operati mediante
l’utilizzo del fondo di solidarietà comunale richiamato, ma tale riduzione non
si evince dalle tabelle del Conto economico dei sottosettori.
Si osserva, inoltre, che le disposizioni contenute nella
richiamata legge di stabilità 2013 hanno un carattere transitorio per gli anni
2013 e 2014. A decorrere dal 2015, in base alla normativa vigente, si
applicheranno le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 23 del 2011
il quale, tra l’altro, esclude l’imposizione dell’abitazione principale e
relative pertinenze e considera, per la determinazione della base imponibile, i
coefficienti previgenti ai fini ICI. Tali entrate dovrebbero, pertanto, non
essere considerate dal quadro tendenziale a legislazione vigente.
I valori in base alla normativa vigente, che scontano
quindi il minor gettito IMU a decorrere dal 2015, sembrano altresì essere presi
in considerazione nella valutazione della “regola della spesa”.
Le previsioni dei contributi sociali registrano una rapporto
sostanzialmente stabile rispetto al PIL e sono costruite anche tenendo conto
dell’aumento delle aliquote contributive disposto dal D.L. 201/2011.
La pressione fiscale passa dal 44 per cento del 2012 al 43,8
per cento del 2017; la variazione appare imputabile in via prevalente alle
componente tributaria.
Le spese
Al miglioramento dei saldi nel periodo 2013-2017
contribuisce una dinamica contenuta della spesa corrente al netto degli
interessi (+0,7 per cento nell’anno in corso, +1,2 per cento nel 2014 e +1,9
nella media nel successivo triennio), che consente una riduzione dell’incidenza
sul prodotto di 2,5 punti percentuali: il peso sul PIL passa, infatti, dal 42,7
per cento del 2013 al 40,2 per cento nel 2017.
Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente,
continua il trend decrescente osservato negli anni precedenti, prevedendosi una
riduzione in valore assoluto della spesa nel 2013 e nel 2014 in conseguenza del
blocco della contrattazione collettiva, della limitazione del turn over
e del blocco delle progressioni di carriera. Nel 2015, la cessazione di alcune
di queste misure e la considerazione della vacanza contrattuale comportano una
variazione positiva dell’1 per cento della spesa, che si stabilizza negli anni
2016 e 2017. L’aggregato riduce pertanto il suo peso sul prodotto, passando dal
10,4 per cento del 2013 (10,6 per cento nel 2012) al 9,2 per cento del 2017.
Anche i consumi intermedi
si riducono nel 2013 (-2,8 per cento) per effetto delle manovre di contenimento
della spesa degli anni precedenti, per poi aumentare dello 0,8 per cento nel
2014 e, più sensibilmente (+2,3 per cento in media annua) negli anni
successivi. Tale dinamica comporta una riduzione dell’incidenza sul PIL dall’8,2
per cento dell’esercizio in corso (8,4 per cento nel 2012) al 7,8 per cento del
2017.
Con riferimento alla quota di questa voce di spesa di
competenza delle Amministrazioni centrali, si ricorda quanto già osservato in
occasione dell’esame del D.L. 35/2013, con riferimento alle disposizioni
che autorizzano un finanziamento di 500 milioni per il 2013 per il pagamento
dei debiti delle Amministrazioni statali. Tali risorse sono
dirette a consentire il pagamento di debiti “fuori bilancio” dei Ministeri, a
fronte dei quali non sussistono residui passivi, anche perenti. Le obbligazioni
sono state, pertanto, assunte senza il corrispondente impegno dei capitoli
iscritti negli stati di previsione, presumibilmente per una loro insufficienza.
Tale fenomeno, di cui non si conosce ancora la dimensione
definitiva, avviene dopo numerose manovre aventi per oggetto tagli lineari
degli stanziamenti di bilancio ed in particolare delle spese c.d. rimodulabili.
Di queste, una voce rilevante è appunto costituita dalle spese per consumi
intermedi, in cui rientrano gli acquisti di beni e servizi che hanno generato i
debiti in esame.
Il D.L. 35/2013 introduce disposizioni dirette ad
assicurare la ricognizione delle somme dovute dalle Amministrazioni e dovrebbe
consentire una rimozione delle cause della loro continua formazione, anche
mediante le operazioni di spending review.
Problematiche ulteriori si pongono poi per le
Amministrazioni locali, per le quali il provvedimento citato autorizza per il
ripiano di debiti verso fornitori, tramite anticipazioni di credito,
l’erogazione di apposite risorse in favore degli enti che non dispongano di
liquidità adeguata.
In questo caso il provvedimento, pur consentendo il pagamento
di quota parte dei debiti accumulati, non rimuove le cause della loro continua
formazione, insite da un lato nei vincoli del patto di stabilità interno, che
impongono in molti casi l’accumulo di posizioni di avanzo, dall’altro nei tagli
delle risorse attribuite alle amministrazioni locali.
L’evoluzione descritta dei
redditi da lavoro dipendente e dei consumi intermedi si riflette sulla spesa
sanitaria che, dopo la riduzione in valore assoluto nel 2011 e nel 2012,
cresce dello 0,2 per cento nel 2013 e dell’1,7 nel 2014, a fronte di una
variazione positiva media dell’1,9 per cento nel successivo triennio. In
percentuale del PIL, l’aggregato riduce la sua incidenza dal 7,1 per cento del
2013 al 6,7 per cento del 2017.
Anche in tale comparto si è verificato un ritardo nel
pagamento di debiti verso fornitori, che ha reso necessario una iniezione di
liquidità per complessivi 14 miliardi nel biennio 2013-2014.
Secondo quanto rilevato nella relazione tecnica allegata al provvedimento
citato, tali difficoltà sono state causate non da una insufficienza di fondi
destinati alla sanità, ma dal mancato conferimento delle risorse di cassa da
parte delle regioni agli enti del SSN, a fronte di risorse conferite dallo
Stato o destinate dalle medesime regioni al finanziamento della sanità.
Ribadita l’opportunità che il Governo fornisca una stima
dei suddetti importi, suddivisi per regione, si rileva che considerato che i
Tavoli di verifica e il Comitato LEA svolgono, secondo procedure ormai
consolidate, un monitoraggio attento dei costi e ricavi sanitari e quindi
dell’equilibrio economico del settore, così come della quantità e qualità delle
prestazioni rese, dovrebbe essere chiarito quali sono i meccanismi di controllo
– anche al di fuori delle suddette procedure di verifica e/o di competenza di
altri soggetti - che non hanno, invece, permesso di rilevare tempestivamente
l’utilizzo da parte delle regioni delle risorse per finalità extra-sanitarie ed
i conseguenti squilibri di cassa degli enti del SSN.
Per quanto riguarda la spesa per prestazioni sociali, essa
evidenzia una dinamica in linea con le precedenti previsioni: a fronte di una
crescita del 2,7 per cento nel 2013 e del 3,1 per cento nel 2014, nel periodo
successivo cresce in media annua al 2,3 per cento medio. L’incidenza sul PIL si
attesta a fine periodo sul 20 per cento, in lieve riduzione rispetto al dato
relativo al 2013 (20,3 per cento).
Le previsioni tendenziali mostrano un andamento complessivamente
decrescente per la spesa in conto capitale, che a fine periodo si attesta su un
valore pari a 42,8 miliardi, inferiore di circa 5 miliardi rispetto al valore
registrato nel 2012. Fa eccezione il 2013, in cui si prevede un aumento della
spesa per circa 7,5 miliardi rispetto all’anno precedente: nell’esercizio in
corso si esplicano, infatti, gli effetti, in termini di indebitamento netto,
dei maggiori pagamenti di parte capitale previsti dal D.L. 35/2013 e
quantificati dal prospetto riepilogativo allegato al provvedimento in 7
miliardi.
L’andamento descritto viene confermato dalla dinamica della
spesa in termini di PIL, che dopo l’aumento dal 3,1 per cento del 2012 al 3,5
per cento del 2013 scende al 2,4 per cento a fine periodo.
Al riguardo, si rileva che l’incremento della spesa conseguente
all’accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni
risulta contabilizzato (anche alla luce delle variazioni delle stime
evidenziate dal confronto tra il dato contenuto nel DEF rispetto a quello
risultante dalla Nota illustrativa della Legge di stabilità) alla voce
“contributi capitale”. Atteso che sembrerebbe trattarsi, almeno in prevalenza,
di maggiori spese per investimento degli enti locali, non è chiaro perché esse
non siano state contabilizzate alla voce relativa agli investimenti fissi
lordi.
Tabella 2.1
Conto economico della P.A. a legislazione vigente (mln di euro)
|
|
DEF 2013
|
|
|
|
S P E S E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Redditi
da lavoro dipendente
|
169.209
|
165.366
|
163.587
|
161.910
|
163.612
|
163.849
|
163.871
|
|
Consumi
intermedi
|
135.879
|
132.279
|
128.561
|
129.608
|
132.306
|
135.808
|
138.711
|
|
Pensioni
e altre prestazioni
|
304.262
|
311.413
|
319.920
|
329.790
|
338.680
|
347.440
|
356.350
|
|
Pensioni
|
243.608
|
249.471
|
255.200
|
262.520
|
269.600
|
276.980
|
284.700
|
|
Altre
prestazioni
|
60.654
|
61.942
|
64.720
|
67.270
|
69.080
|
70.460
|
71.650
|
|
Altre
spese correnti
|
60.263
|
57.480
|
59.309
|
58.065
|
58.632
|
58.739
|
59.341
|
|
Totale
spese correnti netto interessi
|
669.613
|
666.538
|
671.377
|
679.373
|
693.230
|
705.836
|
718.273
|
|
Interessi
passivi
|
78.351
|
86.717
|
83.892
|
90.377
|
97.465
|
104.387
|
109.289
|
|
Totale
spese correnti
|
747.964
|
753.255
|
755.269
|
769.750
|
790.695
|
810.223
|
827.562
|
|
Investimenti
fissi
|
31.097
|
29.224
|
28.257
|
28.156
|
28.289
|
28.669
|
28.761
|
|
Contributi
c/capitale
|
18.507
|
17.487
|
25.666
|
15.453
|
16.043
|
12.762
|
13.003
|
|
Altri
trasferimenti
|
-1.488
|
1.116
|
1.374
|
1.771
|
1.656
|
1.069
|
1.078
|
|
Totale
spese in conto capitale
|
48.116
|
47.827
|
55.297
|
45.380
|
45.988
|
42.500
|
42.842
|
|
Totale
spese al netto interessi
|
717.729
|
714.365
|
726.674
|
724.753
|
739.218
|
748.336
|
761.115
|
|
Totale
spese complessive
|
796.080
|
801.082
|
810.566
|
815.130
|
836.683
|
852.723
|
870.404
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
di
cui spesa sanitaria
|
111.593
|
110.842
|
111.108
|
113.029
|
115.424
|
117.616
|
119.789
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E
N T R A T E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imposte
indirette
|
222.080
|
233.554
|
241.181
|
250.113
|
260.472
|
267.070
|
273.858
|
|
Imposte
dirette
|
225.926
|
237.235
|
235.836
|
243.454
|
247.024
|
255.016
|
263.642
|
|
Contributi
sociali
|
216.963
|
216.669
|
220.420
|
225.251
|
231.630
|
237.655
|
243.301
|
|
Altre
entrate correnti non tributarie
|
59.761
|
59.649
|
60.418
|
61.408
|
62.896
|
64.204
|
65.550
|
|
Totale
entrate correnti
|
724.730
|
747.107
|
757.855
|
780.226
|
802.022
|
823.945
|
846.351
|
|
Imposte
in conto capitale
|
6.981
|
1.375
|
824
|
932
|
741
|
749
|
758
|
|
Entrate
in c/capitale non tributarie
|
4.353
|
4.967
|
6.479
|
5.498
|
5.189
|
5.068
|
5.097
|
|
Totale
entrate in conto capitale
|
11.334
|
6.342
|
7.303
|
6.430
|
5.930
|
5.817
|
5.855
|
|
Totale
entrate
|
736.064
|
753.449
|
765.158
|
786.656
|
807.952
|
829.762
|
852.206
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
corrente
|
-23.234
|
-6.148
|
2.586
|
10.476
|
11.327
|
13.722
|
18.789
|
|
Indebitamento
netto
|
-60.016
|
-47.633
|
-45.408
|
-28.474
|
-28.731
|
-22.961
|
-18.198
|
|
Saldo
primario
|
18.335
|
39.084
|
38.484
|
61.903
|
68.734
|
81.426
|
91.091
|
|
PIL
|
1.578.497
|
1.565.916
|
1.573.233
|
1.624.012
|
1.677.735
|
1.731.311
|
1.785.918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2.2
Conto economico della P.A. in % del PIL
|
|
DEF 2013
|
|
|
|
S P E S E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Redditi
da lavoro dipendente
|
10,7
|
10,6
|
10,4
|
10,0
|
9,8
|
9,5
|
9,2
|
|
Consumi
intermedi
|
8,6
|
8,4
|
8,2
|
8,0
|
7,9
|
7,8
|
7,8
|
|
Pensioni
e altre prestazioni
|
19,3
|
19,9
|
20,3
|
20,3
|
20,2
|
20,1
|
20,0
|
|
Pensioni
|
15,4
|
15,9
|
16,2
|
16,2
|
16,1
|
16,0
|
15,9
|
|
Altre
prestazioni
|
3,8
|
4,0
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,0
|
|
Altre
spese correnti
|
3,8
|
3,7
|
3,8
|
3,6
|
3,5
|
3,4
|
3,3
|
|
Totale
spese correnti netto interessi
|
42,4
|
42,6
|
42,7
|
41,8
|
41,3
|
40,8
|
40,2
|
|
Interessi
passivi
|
5,0
|
5,5
|
5,3
|
5,6
|
5,8
|
6,0
|
6,1
|
|
Totale
spese correnti
|
47,4
|
48,1
|
48,0
|
47,4
|
47,1
|
46,8
|
46,3
|
|
Investimenti
fissi
|
2,0
|
1,9
|
1,8
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,6
|
|
Contributi
c/capitale
|
1,2
|
1,1
|
1,6
|
1,0
|
1,0
|
0,7
|
0,7
|
|
Altri
trasferimenti
|
-0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Totale
spese in conto capitale
|
3,0
|
3,1
|
3,5
|
2,8
|
2,7
|
2,5
|
2,4
|
|
Totale
spese al netto interessi
|
45,5
|
45,6
|
46,2
|
44,6
|
44,1
|
43,2
|
42,6
|
|
Totale
spese complessive
|
50,4
|
51,2
|
51,5
|
50,2
|
49,9
|
49,3
|
48,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
di
cui spesa sanitaria
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,0
|
6,9
|
6,8
|
6,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E
N T R A T E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imposte
indirette
|
14,1
|
14,9
|
15,3
|
15,4
|
15,5
|
15,4
|
15,3
|
|
Imposte
dirette
|
14,3
|
15,1
|
15,0
|
15,0
|
14,7
|
14,7
|
14,8
|
|
Contributi
sociali
|
13,7
|
13,8
|
14,0
|
13,9
|
13,8
|
13,7
|
13,6
|
|
Altre
entrate correnti non tributarie
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
|
Totale
entrate correnti
|
45,9
|
47,7
|
48,2
|
48,0
|
47,8
|
47,6
|
47,4
|
|
Imposte
in conto capitale
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Entrate
in c/capitale non tributarie
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
Totale
entrate in conto capitale
|
0,7
|
0,4
|
0,5
|
0,4
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
|
Totale
entrate
|
46,6
|
48,1
|
48,6
|
48,4
|
48,2
|
47,9
|
47,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
corrente
|
-1,5
|
-0,4
|
0,2
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
1,1
|
|
Indebitamento
netto
|
-3,8
|
-3,0
|
-2,9
|
-1,8
|
-1,7
|
-1,3
|
-1,0
|
|
Saldo
primario
|
1,2
|
2,5
|
2,4
|
3,8
|
4,1
|
4,7
|
5,1
|
|
PIL
|
1.578.497
|
1.565.916
|
1.573.233
|
1.624.012
|
1.677.735
|
1.731.311
|
1.785.918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2.3
Conto economico della P.A. - variazione % annua
|
|
DEF
|
|
|
|
S P E S E
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Redditi
da lavoro dipendente
|
-2,3
|
-1,1
|
-1,0
|
1,1
|
0,1
|
0,0
|
|
Consumi
intermedi
|
-2,6
|
-2,8
|
0,8
|
2,1
|
2,6
|
2,1
|
|
Pensioni
e altre prestazioni
|
2,4
|
2,7
|
3,1
|
2,7
|
2,6
|
2,6
|
|
Pensioni
|
2,4
|
2,3
|
2,9
|
2,7
|
2,7
|
2,8
|
|
Altre
prestazioni
|
2,1
|
4,5
|
3,9
|
2,7
|
2,0
|
1,7
|
|
Altre
spese correnti
|
-4,6
|
3,2
|
-2,1
|
1,0
|
0,2
|
1,0
|
|
Totale
spese correnti al netto interessi
|
-0,5
|
0,7
|
1,2
|
2,0
|
1,8
|
1,8
|
|
Interessi
passivi
|
10,7
|
-3,3
|
7,7
|
7,8
|
7,1
|
4,7
|
|
Totale
spese correnti
|
0,7
|
0,3
|
1,9
|
2,7
|
2,5
|
2,1
|
|
Investimenti
fissi
|
-6,0
|
-3,3
|
-0,4
|
0,5
|
1,3
|
0,3
|
|
Contributi
c/capitale
|
-5,5
|
46,8
|
-39,8
|
3,8
|
-20,5
|
1,9
|
|
Altri
trasferimenti
|
-175,0
|
23,1
|
28,9
|
-6,5
|
-35,4
|
0,8
|
|
Totale
spese in conto capitale
|
-0,6
|
15,6
|
-17,9
|
1,3
|
-7,6
|
0,8
|
|
Totale
spese al netto interessi
|
-0,5
|
1,7
|
-0,3
|
2,0
|
1,2
|
1,7
|
|
Totale
spese complessive
|
0,6
|
1,2
|
0,6
|
2,6
|
1,9
|
2,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
di
cui spesa sanitaria
|
-0,7
|
0,2
|
1,7
|
2,1
|
1,9
|
1,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E
N T R A T E
|
|
|
|
|
|
|
|
Imposte
indirette
|
5,2
|
3,3
|
3,7
|
4,1
|
2,5
|
2,5
|
|
Imposte
dirette
|
5,0
|
-0,6
|
3,2
|
1,5
|
3,2
|
3,4
|
|
Contributi
sociali
|
-0,1
|
1,7
|
2,2
|
2,8
|
2,6
|
2,4
|
|
Altre
entrate correnti non tributarie
|
-0,2
|
1,3
|
1,6
|
2,4
|
2,1
|
2,1
|
|
Totale
entrate correnti
|
3,1
|
1,4
|
3,0
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
|
Imposte
in conto capitale
|
-80,3
|
-40,1
|
13,1
|
-20,5
|
1,1
|
1,2
|
|
Entrate
in conto capitale non tributarie
|
14,1
|
30,4
|
-15,1
|
-5,6
|
-2,3
|
0,6
|
|
Totale
entrate in conto capitale
|
-44,0
|
15,2
|
-12,0
|
-7,8
|
-1,9
|
0,7
|
|
Totale
entrate
|
2,4
|
1,6
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIL
nominale
|
-0,8
|
0,5
|
3,2
|
3,3
|
3,2
|
3,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2.5
Conto della P.A. – differenze tra DEF e Nota
illustrativa in % PIL
|
|
Nota illustrativa LS 2013
|
|
DEF 2013
|
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S P E S E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redditi
da lavoro dipendente
|
10,7
|
10,5
|
10,1
|
9,9
|
|
10,6
|
10,4
|
10,0
|
9,8
|
|
Consumi
intermedi
|
8,6
|
8,2
|
7,9
|
7,7
|
|
8,4
|
8,2
|
8,0
|
7,9
|
|
Pensioni
e altre prestazioni
|
19,9
|
20,2
|
20,2
|
20,2
|
|
19,9
|
20,3
|
20,3
|
20,2
|
|
Pensioni
|
16,0
|
16,1
|
16,1
|
16,0
|
|
15,9
|
16,2
|
16,2
|
16,1
|
|
Altre
prestazioni
|
3,9
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
|
4,0
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
|
Altre
spese correnti
|
3,8
|
3,7
|
3,5
|
3,5
|
|
3,7
|
3,8
|
3,6
|
3,5
|
|
Totale
spese correnti netto interessi
|
43,0
|
42,6
|
41,8
|
41,2
|
|
42,6
|
42,7
|
41,8
|
41,3
|
|
Interessi
passivi
|
5,5
|
5,6
|
6,0
|
6,3
|
|
5,5
|
5,3
|
5,6
|
5,8
|
|
Totale
spese correnti
|
48,5
|
48,2
|
47,7
|
47,5
|
|
48,1
|
48,0
|
47,4
|
47,1
|
|
Investimenti
fissi
|
1,9
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
|
1,9
|
1,8
|
1,7
|
1,7
|
|
Contributi
c/capitale
|
1,0
|
1,1
|
0,9
|
0,9
|
|
1,1
|
1,6
|
1,0
|
1,0
|
|
Altri
trasferimenti
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Totale
spese in conto capitale
|
3,0
|
3,0
|
2,8
|
2,8
|
|
3,1
|
3,5
|
2,8
|
2,7
|
|
Totale
spese al netto interessi
|
46,0
|
45,5
|
44,6
|
44,0
|
|
45,6
|
46,2
|
44,6
|
44,1
|
|
Totale
spese complessive
|
51,5
|
51,2
|
50,6
|
50,3
|
|
51,2
|
51,5
|
50,2
|
49,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
di
cui spesa sanitaria
|
7,3
|
7,1
|
6,9
|
6,9
|
|
7,1
|
7,1
|
7,0
|
6,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E
N T R A T E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imposte
indirette
|
15,1
|
15,9
|
15,7
|
15,6
|
|
14,9
|
15,3
|
15,4
|
15,5
|
|
Imposte
dirette
|
15,5
|
15,2
|
15,1
|
15,0
|
|
15,1
|
15,0
|
15,0
|
14,7
|
|
Contributi
sociali
|
13,9
|
14,0
|
13,9
|
13,9
|
|
13,8
|
14,0
|
13,9
|
13,8
|
|
Altre
entrate correnti non tributarie
|
3,9
|
4,0
|
3,9
|
3,9
|
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,7
|
|
Totale
entrate correnti
|
48,5
|
49,1
|
48,7
|
48,4
|
|
47,7
|
48,2
|
48,0
|
47,8
|
|
Imposte
in conto capitale
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
|
Entrate
c/capitale non tributarie
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
|
0,3
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
|
Totale
entrate in conto capitale
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
0,4
|
0,5
|
0,4
|
0,4
|
|
Totale
entrate
|
48,9
|
49,4
|
49,0
|
48,8
|
|
48,1
|
48,6
|
48,4
|
48,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
corrente
|
0,0
|
0,8
|
0,9
|
0,9
|
|
-0,4
|
0,2
|
0,6
|
0,7
|
|
Indebitamento
|
-2,6
|
-1,8
|
-1,5
|
-1,4
|
|
-3,0
|
-2,9
|
-1,8
|
-1,7
|
|
Saldo
primario
|
2,9
|
3,9
|
4,4
|
4,8
|
|
2,5
|
2,4
|
3,8
|
4,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2.6
Conto della P.A. – differenze tra DEF e Nota
illustrativa - variazione % annua
|
|
Nota illustrativa LS 2013
|
|
DEF 2013
|
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
S P E S E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redditi
da lavoro dipendente
|
-1,4
|
-0,5
|
-0,6
|
0,4
|
|
-2,3
|
-1,1
|
-1,0
|
1,1
|
|
Consumi
intermedi
|
-0,8
|
-4,0
|
-0,7
|
1,3
|
|
-2,6
|
-2,8
|
0,8
|
2,1
|
|
Pensioni
e altre prestazioni
|
2,2
|
2,6
|
3,1
|
2,7
|
|
2,4
|
2,7
|
3,1
|
2,7
|
|
Pensioni
|
2,3
|
2,1
|
2,9
|
2,7
|
|
2,4
|
2,3
|
2,9
|
2,7
|
|
Altre
prestazioni
|
1,5
|
4,7
|
4,0
|
2,7
|
|
2,1
|
4,5
|
3,9
|
2,7
|
|
Altre
spese correnti
|
-3,3
|
-1,3
|
-1,8
|
1,3
|
|
-4,6
|
3,2
|
-2,1
|
1,0
|
|
Totale
spese correnti al netto interessi
|
0,2
|
0,2
|
1,0
|
1,8
|
|
-0,5
|
0,7
|
1,2
|
2,0
|
|
Interessi
passivi
|
10,1
|
3,6
|
8,7
|
8,7
|
|
10,7
|
-3,3
|
7,7
|
7,8
|
|
Totale
spese correnti
|
1,2
|
0,6
|
1,9
|
2,6
|
|
0,7
|
0,3
|
1,9
|
2,7
|
|
Investimenti
fissi
|
-7,4
|
-5,0
|
1,6
|
2,8
|
|
-6,0
|
-3,3
|
-0,4
|
0,5
|
|
Contributi
c/capitale
|
-11,8
|
5,3
|
-8,3
|
0,1
|
|
-5,5
|
46,8
|
-39,8
|
3,8
|
|
Altri
trasferimenti
|
-171,9
|
36,4
|
3,9
|
-10,4
|
|
n.s.
|
23,1
|
28,9
|
-6,5
|
|
Totale
spese in conto capitale
|
-2,5
|
-0,3
|
-1,9
|
1,3
|
|
-0,6
|
15,6
|
-17,9
|
1,3
|
|
Totale
spese al netto interessi
|
0,0
|
0,2
|
0,8
|
1,7
|
|
-0,5
|
1,7
|
-0,3
|
2,0
|
|
Totale
spese complessive
|
1,0
|
0,5
|
1,7
|
2,6
|
|
0,6
|
1,2
|
0,6
|
2,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
di
cui spesa sanitaria
|
1,4
|
-1,1
|
0,1
|
2,6
|
|
-0,7
|
0,2
|
1,7
|
2,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E
N T R A T E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imposte
indirette
|
6,4
|
6,1
|
1,8
|
2,4
|
|
5,2
|
3,3
|
3,7
|
4,1
|
|
Imposte
dirette
|
7,5
|
-0,9
|
2,1
|
2,7
|
|
5,0
|
-0,6
|
3,2
|
1,5
|
|
Contributi
sociali
|
0,9
|
1,5
|
2,4
|
3,0
|
|
-0,1
|
1,7
|
2,2
|
2,8
|
|
Altre
entrate correnti non tributarie
|
1,3
|
3,2
|
2,3
|
2,6
|
|
-0,2
|
1,3
|
1,6
|
2,4
|
|
Totale
entrate correnti
|
4,7
|
2,3
|
2,1
|
2,7
|
|
3,1
|
1,4
|
3,0
|
2,8
|
|
Imposte
in conto capitale
|
n.s
|
n.s
|
0,9
|
1,0
|
|
n.s
|
n.s
|
13,1
|
-20,5
|
|
Entrate
in conto capitale non tributarie
|
1,8
|
25,6
|
5,5
|
11,7
|
|
14,1
|
30,4
|
-15,1
|
-5,6
|
|
Totale
entrate in conto capitale
|
n.s
|
8,2
|
5,1
|
10,7
|
|
n.s
|
15,2
|
-12,0
|
-7,8
|
|
Totale
entrate
|
3,8
|
2,3
|
2,1
|
2,8
|
|
2,4
|
1,6
|
2,8
|
2,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
corrente
|
-101,5
|
3381,9
|
3802,4
|
19,7
|
|
-73,5
|
-142,1
|
-270,4
|
338,0
|
|
Indebitamento
|
-33,3
|
-32,7
|
-39,4
|
-13,7
|
|
-20,6
|
-4,7
|
-40,2
|
-36,7
|
|
Saldo
primario
|
172,7
|
36,9
|
60,3
|
32,4
|
|
113,2
|
-1,5
|
58,4
|
78,6
|
|
PIL
nominale
|
-1,0
|
1,2
|
4,1
|
3,2
|
|
-0,8
|
0,5
|
3,2
|
3,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Approfondimento
3. Un esame di alcune voci di spesa
I redditi da lavoro dipendente
Il DEF fornisce una nuova
previsione dei dati di consuntivo 2012 e tendenziali per quinquennio 2013-2017
relativi alla spesa per redditi da lavoro dipendente. Tali dati sono
raffrontati, limitatamente al quadriennio 2012-2015 con quelli recati, da
ultimo, nella nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di
stabilità 2013.
Tabella
Spesa per redditi da lavoro dipendente (milioni
di euro)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
tecnico-illustrativa L.S.
|
167.080
|
166.295
|
165.345
|
166.008
|
n.d.
|
n.d.
|
|
DEF
2013
|
165.366
|
163.587
|
161.910
|
163.612
|
163.849
|
163.871
|
|
Differenze
tra le due previsioni
|
-1.714
|
-2.708
|
-3.435
|
-2.396
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Variazione
annua degli importi prevista in:
|
|
|
|
|
|
|
|
-Nota
|
|
-785
|
-950
|
663
|
n.d.
|
n.d.
|
|
-DEF
|
|
-1.779
|
-1.677
|
1.702
|
237
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: DEF 2013
|
|
|
|
|
|
|
Rispetto a quanto rilevato
nello scorso mese di settembre si assume che il dato di consuntivo 2012 possa
evidenziare un miglioramento di 1,7 miliardi. Dato questo miglioramento di
partenza, la diminuzione che si presume di riscontrare per il 2013 passa da 785
a 1.779 milioni e quella per il 2014 da 950 a 1.677 milioni. La differenza
cumulata tra le due previsioni comporta una riduzione della spesa complessiva
pari a 3.435 milioni nel 2014. Nel 2015 entrambi i documenti ipotizzano una
crescita della spesa, per 663 milioni secondo la Nota tecnico-illustrativa
mentre è di 1.702 milioni nel DEF con una differenza di circa un miliardo. La
revisione delle stime sembra doversi ricondurre anche alla contabilizzazione
dei risparmi connessi all’entrata in vigore di alcune norme contenute nel
decreto legge n. 78/2010 i cui effetti, secondo la relazione tecnica allegata
al disegno di legge di conversione, sarebbero stati registrati a consuntivo. La
recente pubblicazione dei dati del Conto annuale 2011 ha, verosimilmente,
consentito di effettuare una prima quantificazione di tali risparmi e
determinato, in conseguenza, la revisione delle stime. Tale ricostruzione
sembra asseverata anche dal testo DEF che con riguardo ai risultati relativi
all’anno 2012 afferma che hanno inciso sull’ammontare della spesa i seguenti
interventi:
- la razionalizzazione del comparto scuola;
- il blocco dei rinnovi contrattuali per il periodo
2010-2012;
- l’introduzione di un limite di spesa individuale
rapportato alla retribuzione percepita nell’anno 2010;
- il riconoscimento solo ai fini giuridici delle
progressioni di carriera disposte nel triennio 2011-2013;
- la riduzione in base al numero del personale
cessato dell’ammontare delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa;
- la rimodulazione delle limitazioni all’assunzione
di personale con modalità diversificate in base alla tipologia di comparto
interessato (ad esclusione dei soli comparti Scuola/AFAM e Forze armate).
In particolare le misure
indicate nei punti da 3 a 5 sono, appunto, quelle per le quali si prevedeva di
quantificare a consuntivo gli effetti finanziari. L’efficacia di tale misure è
destinata, tuttavia, come anche specificato nel DEF, a cessare a decorrere
dall’anno 2015 e, pertanto, se la revisione delle stime fosse unicamente ad
esse correlata, l’incremento di spesa ipotizzato nel 2015 avrebbe dovuto
corrispondere all’intera misura delle minori spese valutata con riferimento al
triennio 2012-2014: viceversa a fronte di una riduzione in diminuzione del dato
2014 per circa 3,4 miliardi, il dato 2015 è incrementato di solo 1 miliardo di
euro. Ne consegue che la variazione delle stime potrebbe registrare e
trascinare negli anni 2013 e 2014 anche una tendenza alla diminuzione delle
spese di personale riscontrata dalla Ragioneria generale dello Stato a fronte
dell’esame dei dati di preconsutivo 2012.
Il DEF precisa anche che la
previsione per l’anno 2015 sconta anche l’indennità di vacanza contrattuale
relativa al triennio 2015-2017, la cui spesa è stata stimata sulla base di un
tasso di inflazione programmato dell’1,5 per cento.
Negli anni 2016 e 2017, a
legislazione vigente,la spesa per redditi è sostanzialmente allineata alla
stima relativa al 2015.
Appare pertanto,
necessario, che siano forniti elementi di maggior dettaglio circa i singoli
elementi che hanno determinato la revisione delle stime di spesa. Con
riferimento a ciascun elemento dovrebbe essere separatamente indicata la
variazione di spesa ipotizzata e la natura permanente e temporanea di tale
variazione.
Il DEF chiarisce, infine, che
gli effetti di slittamento salariale sono stimati prudenzialmente sulla base
delle risultanze statistiche dell’ultimo quinquennio.
Con slittamento salariale si indica la differenza tra i salari
effettivamente percepiti dai lavoratori e quelli stabiliti dalla contrattazione
collettiva; può derivare da pagamenti di lavoro straordinario, da premi di
operosità o da altro tipo di elargizioni.
Prestazioni sociali in denaro
Il DEF espone i dati relativi
alla spesa per prestazioni sociali in denaro 2012 e aggiorna
le previsioni relative al triennio 2013-2015. Per la prima volta sono
presentate le stime relative agli anni 2016 e 2017.
Tabella
Prestazioni sociali in denaro (milioni
di euro –% )
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
|
(milioni
di euro)
|
|
Prestazioni
sociali in denaro
|
304.262
|
311.413
|
319.920
|
329.790
|
338.380
|
347.440
|
356.350
|
|
Pensioni
|
243.608
|
249.471
|
255.200
|
262.520
|
269.600
|
276.980
|
284.700
|
|
Altre
prestazioni sociali
|
60.654
|
61.942
|
64.720
|
67.270
|
69.080
|
70.460
|
71.650
|
|
|
(tasso
di variazione annua)
|
|
Prestazioni
sociali in denaro
|
2,0
|
2,4
|
2,7
|
3,1
|
2,7
|
2,6
|
2,6
|
|
Pensioni
|
2,6
|
2,4
|
2,3
|
2,9
|
2,7
|
2,7
|
2,8
|
|
Altre
prestazioni sociali
|
-0,7
|
2,1
|
4,5
|
3,9
|
2,7
|
2,0
|
1,7
|
|
|
(%
PIL)
|
|
Prestazioni
sociali in denaro
|
19,3
|
19,9
|
20,3
|
20,3
|
20,2
|
20,1
|
20,0
|
|
Pensioni
|
15,4
|
15,9
|
16,2
|
16,4
|
16,1
|
16,0
|
15,9
|
|
Altre
prestazioni sociali
|
3,8
|
4,0
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,1
|
4,0
|
|
Per
memoria: var % PIL
|
1,7
|
-0,8
|
0,5
|
3,2
|
3,3
|
3,2
|
3,2
|
|
Fonte: DEF 2013
|
Il consuntivo 2012
La spesa per prestazioni
sociali in denaro per l’anno 2012 è stata pari a 311.413 milioni registrando,
in rapporto al PIL, un'incidenza pari al 19,9 per cento ed un tasso di
incremento rispetto all'anno 2011 pari a 2,4 per cento. Tali risultati sono
sostanzialmente in linea con le precedenti previsioni.
Con riferimento alla spesa
pensionistica, l’incremento del 2,4 per cento si verifica in conseguenza
dell’indicizzazione ai prezzi applicata al 1°gennaio 2012,
dell’incremento del numero delle pensioni in liquidazione, sia in termini
numerici che di importo, nonché delle ricostituzioni di importo delle pensioni
in essere e della liquidazione di arretrati.
La spesa per le altre
prestazioni sociali in denaro è cresciuta del 2,1 per cento: tale risultato è
frutto della riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in
particolare nel settore del pubblico impiego), dell’incremento della spesa per
ammortizzatori sociali (da ascrivere all’incremento sia della spesa per indennità
di disoccupazione e indennità di mobilità sia della spesa per integrazioni
salariali) a fronte di un incremento significativamente più contenuto di altre
componenti di spesa.
Nel DEF si evidenzia che la
spesa per prestazioni sociali in denaro, a livello complessivo, ha rallentato
la dinamica di crescita nel corso dell’ultimo periodo. Tale rallentamento
risulta evidente sia confrontando i dati 2010-2012 (tasso di variazione medio
annuo pari a circa il 2,2 per cento) con quelli del triennio 2007-2009 (+ 5 per
cento), sia prendendo in considerazione l’intero decennio 1999-2009 (+4,4 per
cento, prendendo come base l’anno 1999). In considerazione della dimensione
dell’aggregato in esame, tale riduzione della dinamica registrata nel periodo
più recente ha contribuito in modo significativo al contenimento della dinamica
della complessiva spesa delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, al
processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica dal 2009 al
2012.
Le previsioni a legislazioni vigente per il 2013 e per il periodo 2014
-2017
Le previsioni della spesa per
prestazioni sociali in denaro, elaborate sulla base della normativa vigente e
del quadro macroeconomico di riferimento, evidenziano per il 2013 una spesa
pari a 319,9 miliardi, sostanzialmente in linea con le precedenti previsioni.
Contribuiscono a determinare
un aumento del 2,7 per cento circa rispetto al precedente esercizio:
·
una crescita della spesa
pensionistica del 2,3 per cento. Tale crescita tiene conto del numero di
pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione, della rivalutazione
delle pensioni in essere ai prezzi, delle ricostituzioni degli importi delle
pensioni in essere, nonché degli effetti conseguenti anche alle disposizioni
contenute nel Decreto-legge n. 201/2011, che limita la rivalutazione delle
pensioni ai prezzi per l’anno 2013. Le previsioni relative agli anni 2013 e
successivi tengono anche conto degli interventi normativi diretti ad
incrementare il numero di lavoratori salvaguardati dall’innalzamento dei
requisiti di accesso al pensionamento stabilito dalla legge n. 214/2011 e a
prevedere misure di agevolazione in materia di cumulo di periodi assicurativi
presso differenti gestioni previdenziali. La previsione tiene altresì conto
degli elementi emersi nell’ambito dell’attività di monitoraggio ai fini della
stima dei risultati per l’anno 2012 e dei primi elementi disponibili per l’anno
2013;
·
una crescita della spesa per altre
prestazioni sociali in denaro del 4,5 per cento. Tale previsione tiene conto delle
misure connesse ai complessivi strumenti di ammortizzatori sociali previste
dalla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro e dalla legge n.
228/2012, tra le quali l’incremento del rifinanziamento dei c.d. ammortizzatori
sociali in deroga, nonché degli elementi emersi nell’ambito dell’attività di
monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l’anno 2012 e dei primi
elementi disponibili per l’anno 2013.
Per il periodo 2014-2017 si
ipotizza che la spesa complessiva per prestazioni sociali in denaro evidenzi un
tasso di variazione medio del 2,7 per cento, a fronte di una crescita della
spesa pensionistica del 2,8 per cento e della spesa per altre prestazioni
sociali in denaro del 2,6 per cento.
Per quanto riguarda la spesa
pensionistica gli andamenti tengono conto, fra l’altro, delle disposizioni di
cui al D.L. 201/2011 prima ricordate, comprese quelle relative ai lavoratori
c.d. esodati e al cumulo di periodi assicurativi; mentre per le altre
prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di variazione risentono delle
specifiche basi tecniche riferite alle diverse tipologie di prestazione e degli
aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano.
La spesa sanitaria
Il DEF espone i dati relativi
alla spesa sanitaria 2012 e aggiorna le previsioni per il triennio 2013-2015.
Per la prima volta sono presentate le previsioni relative al 2016-2017.
I risultati 2012 e le previsioni per il 2013
Tabella
La spesa sanitaria nel conto della P.A. (milioni
di euro - %)
|
DEF 2013
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
valore assoluto
|
112.526
|
111.593
|
110.842
|
111.108
|
|
var % su anno precedente
|
1,86
|
-0,83
|
-0,67
|
0,24
|
|
incidenza % su spesa netto interessi
|
15,59
|
15,55
|
15,52
|
15,29
|
|
incidenza % su Pil
|
7,25
|
7,07
|
7,08
|
7,06
|
|
Nota illustrativa L.S. 2013
|
|
|
|
|
|
valore assoluto
|
112.742
|
112.039
|
113.597
|
112.327
|
|
var % su anno precedente
|
2,05
|
-0,62
|
1,39
|
-1,12
|
|
incidenza % su spesa netto interessi
|
15,57
|
15,57
|
15,79
|
15,58
|
|
incidenza % su Pil
|
7,26
|
7,09
|
7,26
|
7,10
|
|
Fonte: DEF 2013
e Nota illustrativa LS 2013
|
Sulla base dei dati acquisiti
al IV trimestre, nel 2012 la spesa è risultata pari a 110.842 milioni,
segnando una riduzione dello 0,7 per cento rispetto all’anno precedente. Si
conferma al 15,5 l’incidenza sulla spesa al netto degli interessi, mentre si riduce
di un decimo di punto il peso in quota PIL (7,1 per cento).
Tale risultato é inferiore di
oltre 2,7 miliardi rispetto al pre-consuntivo indicato nella Nota
tecnico-illustrativa della legge di stabilità 2013: la revisione incorpora anche
la variazione delle stime relative al 2011, riviste in riduzione per circa 500
milioni.
Tabella
Spesa sanitaria: risultato 2012 e previsioni 2013 (milioni
di euro - %)
|
|
2012
|
2013
|
2012
|
2013
|
|
|
(milioni)
|
(var
%)
|
|
Spesa
sanitaria
|
110.842
|
111.108
|
|
0,2
|
|
Beni
e servizi da produttori non market
|
66.586
|
66.104
|
n.d.
|
-0,7
|
|
di
cui
|
|
|
|
|
|
Redditi
da lavoro dipendente
|
36.708
|
36.758
|
-1,5
|
0,1
|
|
Consumi
intermedi
|
29.685
|
29.346
|
+2,4
|
-1,1
|
|
Beni
e servizi da produttori market
|
39.578
|
39.792
|
-2,0
|
0,5
|
|
Farmaci
|
9.145
|
8.725
|
-7,3
|
-4,6
|
|
medicina
di base
|
6.736
|
6.748
|
+0,2
|
0,2
|
|
altre
prestazioni (ospedaliera , specialistica, riabilitative, integrative, altra
assistenza)
|
23.697
|
24.319
|
-0,5
|
2,6
|
|
Altre
componenti di spesa
|
4.871
|
5.211
|
-1,3
|
7,0
|
|
Fonte: DEF 2013
|
|
|
|
|
All’interno delle prestazioni
relative a produttori non market (assistenza ospedaliera e altri
servizi sanitari offerti direttamente dagli operatori pubblici), la spesa per
il personale dipendente è diminuita dell’1,5 per cento.
Su tale evoluzione incide il blocco del
turnover nelle regioni in piano di rientro e le politiche di contenimento delle
assunzioni per le regioni non in piano. Incidono inoltre favorevolmente gli
effetti di contenimento della spesa conseguenti all’obbligo per le regioni di
garantire con appositi accantonamenti la copertura integrale degli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali. Ciò ha comportato una maggiore congruità
nella valutazione dei relativi costi e una riduzione delle sopravvenienze
passive di rilevante entità negli esercizi finanziari successivi a quello della
sottoscrizione del contratto.
Aumentano del 2,4 per cento i
consumi intermedi. Tale dinamica sconta le misure di contenimento previste dal
D.L. 95/2012, che comportano una riduzione del 5 per cento dei corrispettivi
per l’acquisto di beni e servizi e dei corrispondenti volumi di acquisto per
tutta la durata residua dei contratti, nonché l’obbligo per le aziende
sanitarie di rinegoziare i contratti (ed eventualmente recedere) qualora i
prezzi unitari siano superiori del 20 per cento rispetto ai prezzi di
riferimento
La variazione osservata
riflette inoltre la conferma della scelta di molte regioni di ricorrere alla
distribuzione diretta dei farmaci ai fini del controllo della spesa
farmaceutica complessiva: ciò determina tuttavia un aumento della componente
riferita alla farmaceutica ospedaliera e quindi del complessivo aggregato
relativo ai produttori non market.
Il documento non fornisce
indicazioni circa la spesa farmaceutica ospedaliera, che negli esercizi
precedenti ha costantemente superato il tetto previsto (2,4 per cento del
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato).
Per quanto riguarda la spesa
dei produttori market, al risultato complessivo (-2 per cento
rispetto all’esercizio precedente) contribuisce, in primo luogo la riduzione
della farmaceutica (-7,3 per cento), sulla quale influiscono l’aumento della
compartecipazione a carico dei cittadini(+6 per cento rispetto al 2011), sia
nelle regioni in piano di rientro che nelle restanti realtà territoriali,
la riduzione del prezzo medio dei farmaci (-8 per cento nel 2012 rispetto ad
una riduzione media del 3 per cento nel triennio precedente) e le misure di
contenimento varate negli anni precedenti.
Il documento precisa che sulla riduzione della farmaceutica
convenzionata influisce il contenimento dei consumi, favorito a sua volta da un
numero di ricette nell’anno 2012 sostanzialmente stabile rispetto al 2011
(aumentate invece del 2,2 per cento nella media del precedente triennio),
grazie anche al monitoraggio delle prescrizioni attraverso la tessera sanitaria
Tra gli interventi normativi
più recenti vi é la rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica
territoriale (voce in cui confluisce la spesa farmaceutica convenzionale) dal
13,3 per cento del finanziamento cui concorre lo Stato del 2011 al 13,1 per
cento per il 2012 (11,35 per cento dal 2013) e la modifica del meccanismo di
ripiano dell’eventuale sforamento della spesa.
Si rileva, inoltre, un
aumento della spesa sia per l’assistenza medico-generica (+0,2 per cento) a
fronte di una riduzione che per le altre prestazioni (che comprendono la
specialistica, l’ospedaliera convenzionata, la riabilitativa ed altra
assistenza) (-0,5 per cento).
Al risultato di queste ultime
contribuisce la riduzione in misura percentuale fissa (0,5 per cento rispetto
al valore registrato consuntivo nel 2011) degli importi e dei volumi degli
acquisti da erogatori privati prevista dal D.L. 95/2012
e, più in generale, la migliore regolazione, anche nelle regioni in disavanzo,
dell’accreditamento degli operatori privati con l’assegnazione di tetti di
spesa e l’attribuzione di budget, e la tendenza a trasferire gli oneri di
carattere socio-sanitario al di fuori della sanità. Per quanto riguarda la
specialistica, un effetto di contenimento della spesa è ascrivibile anche alla
reintroduzione dei ticket.
Le altre componenti di spesa
evidenziano, infine, una riduzione dell’1,3 per cento.
Con riferimento al 2013,
come precisato dal DEF, le previsioni sono elaborate sulla base del quadro
macroeconomico e dei dati ufficiali Istat concernenti il conto consolidato
della Sanità 2009-2012 aggiornato al IV trimestre 2012, delle rettifiche
operate sul 2010 e dell’acquisizione dei dati di consuntivo 2011.
La spesa prevista, pari a
111.108 milioni (+0,2 per cento rispetto al precedente esercizio) evidenzia una
riduzione di oltre 1,2 miliardi rispetto alle stime contenute nella Nota
illustrativa della legge di stabilità 2013, che sconta l’effetto di
trascinamento del miglior risultato 2012.
All’interno della spesa dei produttori
non market, il complesso dei redditi da lavoro dipendente aumenta
dello 0,1 per cento. Tale variazione sconta i dati sul costo del personale
rilevati al IV trimestre del 2012 e il limite al riconoscimento di incrementi
retributivi stabilito dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda i consumi
intermedi, sono previsti ridursi dell’1,1 per cento rispetto al 2012. Su tale
riduzione incidono le misure di contenimento della spesa adottate nell’ultimo
biennio
In particolare:
-
La riduzione del 10 per cento dei
corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi (con esclusione dei farmaci
ospedalieri) e dei corrispondenti volumi d’acquisto per tutta la durata residua
dei contratti in essere, con la possibilità per le regioni di adottare misure
alternative di contenimento della spesa, nel rispetto degli obiettivi
programmati e dell’equilibrio finanziario[28];
-
l’obbligo, per le aziende
sanitarie di rinegoziare con i fornitori i contratti per l’acquisto di beni e
servizi (con possibilità di recesso dagli stessi) qualora i prezzi unitari in
essi previsti risultino superiori al 20,0 per cento rispetto ai prezzi di
riferimento individuati dall’Osservatorio per i contratti pubblici;
-
la fissazione di un tetto alla
spesa per l’acquisto di dispositivi medici, in misura pari al 4,8 per cento del
fabbisogno sanitario standard;
-
la rideterminazione del tetto
sulla spesa farmaceutica ospedaliera al 3,5 per cento
con fissazione al 50 per cento della quota di ripiano dello sfondamento del
tetto a carico delle aziende farmaceutiche, attraverso il meccanismo del pay-back.
All’interno della spesa dei produttori
market, che aumenta complessivamente dello 0,5 per cento, la farmaceutica
è attesa ridursi del 4,6 per cento. La previsione sconta le misure prima
ricordate e l’abbassamento del tetto stabilito per la farmaceutica territoriale
all’11,35 per cento.
A fronte di un aumento dello
0,2 per cento della medicina di base, le altre prestazioni in convenzione
presentano una variazione positiva del 2,6 per cento.
Il documento precisa che tale stima incorpora la riduzione
dell’1 per cento rispetto al valore 2011 degli importi e dei volumi degli
acquisti da erogatori privati (ai sensi dell’articolo 15 del D.L. 95/2012), nonché
i maggiori costi (pari a 65 milioni per il solo anno in corso) connessi al
finanziamento a carico dello Stato delle attività dei Policlinici universitari
e degli ospedali non statali[32].
Le altre componenti di spesa
(pari a 5,1 miliardi nel 2013) sono previste in aumento del 7 per cento.
Le previsioni per gli anni 2014-2017
Tabella
La spesa sanitaria nel conto della P.A. (milioni
di euro - %)
|
Previsioni DEF (aprile 2013)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
valore assoluto
|
111.108
|
113.029
|
115.424
|
117616
|
119.789
|
|
var % su anno precedente
|
0,2
|
1,7
|
2,1
|
1,9
|
1,8
|
|
incidenza % su spesa netto interessi
|
15,29
|
15,60
|
15,61
|
15,72
|
15,74
|
|
incidenza % su Pil
|
7,1
|
7,0
|
6,9
|
6,8
|
6,7
|
|
Nota illustrativa L.S. 2013
|
|
|
|
|
|
|
valore assoluto
|
112.327
|
112.421
|
115.397
|
n.d.
|
n.d.
|
|
var % su anno precedente
|
-1,1
|
0,1
|
2,6
|
n.d.
|
n.d.
|
|
incidenza % su spesa netto interessi
|
15,58
|
15,47
|
15,61
|
n.d.
|
n.d.
|
|
incidenza % su Pil
|
7,1
|
6,9
|
6,9
|
n.d.
|
n.d.
|
Nel periodo 2014-2017, la spesa sanitaria cresce ad un ritmo dell’1,9
per cento medio annuo, inferiore alla variazione attesa del PIL nominale (+3,2
per cento annuo): l’incidenza della spesa sul prodotto pertanto si riduce,
passando dal 7,1 per cento del 2013 al 6,7 per cento del 2015. Aumenta invece
di 0,4 punti l’incidenza sulla spesa corrente al netto degli interessi per la quale
si prevede una variazione più contenuta.
Come precisato dal DEF, la dinamica osservata sconta gli effetti della
non applicabilità - a seguito della sentenza n. 187/2012 della Corte
costituzionale - di quanto disposto
dall’articolo 17, comma 1, lett. d, del D.L. 98/2011 che prevedeva , attraverso
un regolamento ai sensi della legge 400/1988, l’introduzione di misure di
compartecipazione alla spesa per un importo pari a 2 miliardi a decorrere dal
2014. I tendenziali di spesa sono stati pertanto rivisti in aumento per tale
importo.
La misura suddetta era diretta ad aumentare le risorse da
compartecipazione destinate al finanziamento della sanità, a fronte delle quali
veniva corrispondentemente disposta una riduzione del livello di finanziamento
del SSN cui contribuisce lo Stato. Stante il vincolo per le regioni di coprire
eventuali disavanzi, il venir meno della disposizione citata comporta pertanto,
a parità di spesa, la necessità di reperire ulteriori risorse.
Le previsioni scontano
inoltre il quadro macroeconomico previsto per il periodo di riferimento, i
risultati per il 2012 del conto della sanità, nonché l’efficacia nel 2014 delle
misure di contenimento della spesa adottate negli anni precedenti.
Come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica,
la Sezione II del DEF (Analisi e tendenze della finanza pubblica) riporta le
previsioni tendenziali dei conti economici delle pubbliche amministrazioni (PA)
e dei suoi sottosettori: amministrazioni centrali (AC), amministrazioni locali
(AL) ed enti di previdenza (EP).
La presente analisi si concentra sulle previsioni relative
alle spese, articolate per sottosettore. Le tabelle 2.7, 2.8 e 2.9 riportano,
rispettivamente in milioni di euro, in percentuale del PIL e in tassi di
variazione percentuale, la spesa delle PA ottenuta dal consolidamento delle
spese tendenziali dei sottosettori istituzionali.
La figura 2.1 mostra l'andamento delle spese correnti
primarie, delle spese in conto capitale e delle spese finali primarie per le PA
e i sottosettori istituzionali. Con riferimento alla spesa corrente,
l'articolazione per sottosettori evidenzia che il moderato aumento della spesa
al netto degli interessi delle PA nel periodo di programmazione (1 per cento) è
riferibile agli EP, la cui spesa primaria aumenta in media del 2,53 per cento
annuo, compensando la riduzione negli altri sottosettori. Se considerata in
percentuale del PIL, d'altra parte, la spesa primaria (sia corrente che
capitale) risulta contrarsi nelle AC e nelle AL. Tali andamenti riescono a
compensare il previsto aumento della spesa per interessi consentendo al totale
delle spese finali di risultare in diminuzione in entrambi i sottosettori.
Tabella 2.7
Spesa consolidata della PA (milioni
di euro)
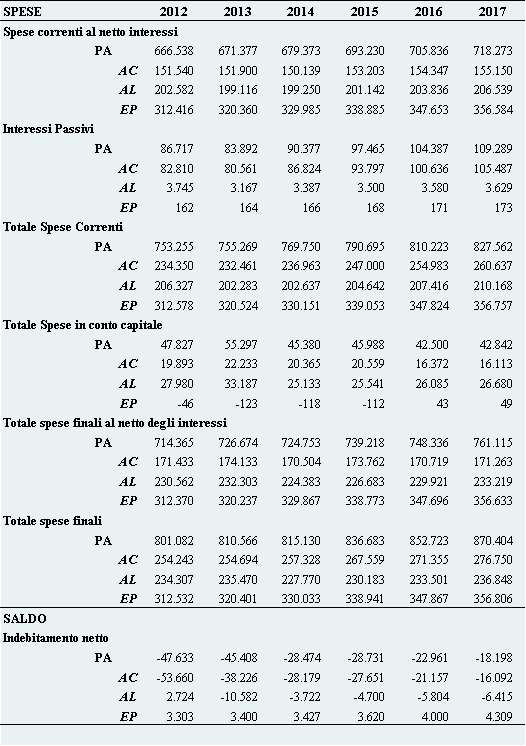
Fonte:
elaborazioni su DEF 2013
Tabella 2.8
Spesa consolidata della PA (in
percentuale del PIL)
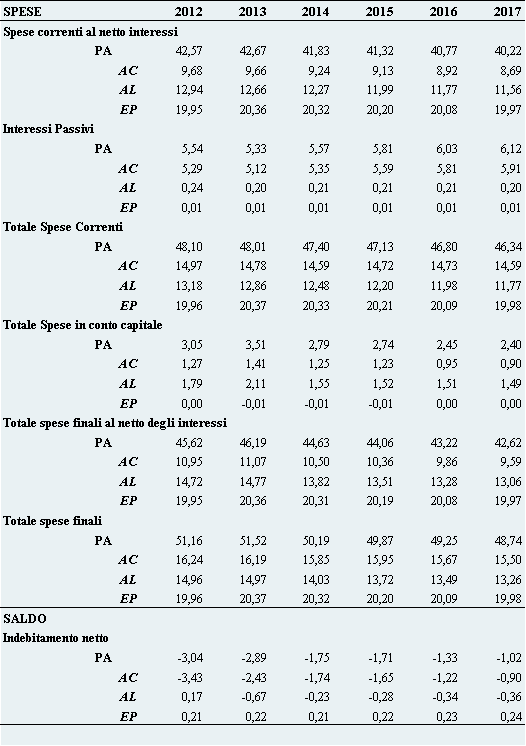
Tabella
2.9
Spesa consolidata della PA (variazioni
percentuali)
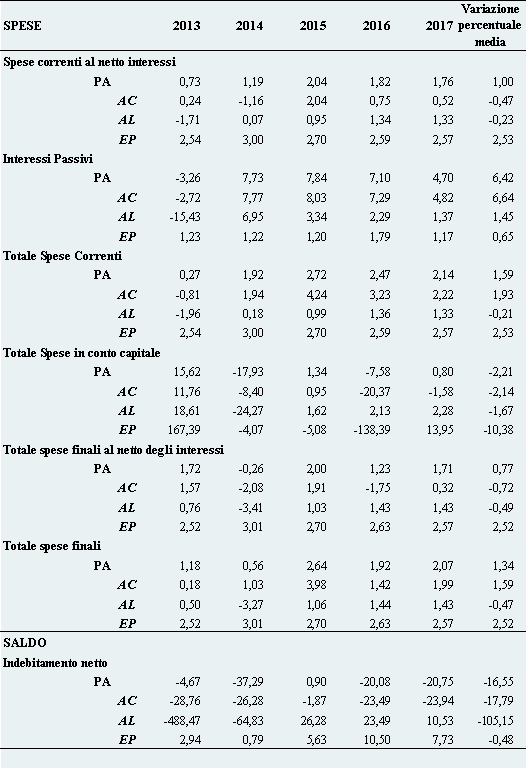
Grafico 2.1
Spesa consolidata della PA (milioni
di euro)
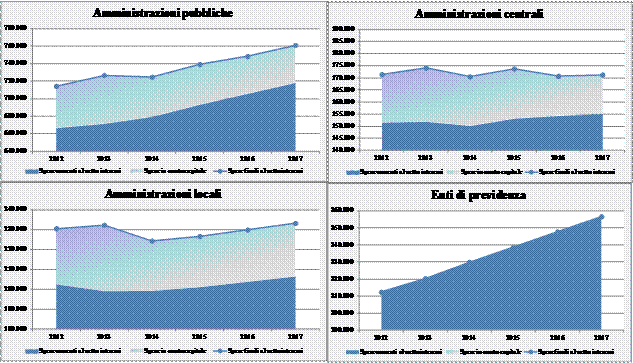
Nota:
le scale dei grafici sono tra loro diverse.
Il Documento di economia e finanza per il 2013 indica saldi
programmatici coerenti con quanto prescritto a livello europeo dal rinnovato
quadro di regole di bilancio.
I saldi programmatici strutturali (al netto del ciclo e
delle misure una tantum) confermano il raggiungimento del pareggio di
bilancio nel 2013, l'emersione di un lieve surplus nel 2014 e il ritorno al
pareggio strutturale a partire dall'esercizio successivo. Il miglioramento
strutturale del saldo in ciascun esercizio rispetto al precedente, già molto
significativo nel 2012 (-2,3 rispetto al 2011), è pari a -1,1 per il 2013 e
-0,4 nel 2014. Tale quadro programmatico appare in linea con le Raccomandazioni
del Consiglio, nelle quali l'Italia
veniva sollecitata a operare per perseguire la chiusura della procedura per
disavanzo eccessivo entro il 2012, nonché realizzare progressi adeguati verso
il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine. Gli obiettivi strutturali
definiti nel DEF 2013 risultano più ambiziosi di quelli evidenziati nell'ultimo
documento programmatico (grafico 3.1).
Sulla base della stima aggiornata della componente ciclica
(rivista nel presente documento sulla base delle nuove previsioni
macroeconomiche), gli obiettivi di
indebitamento netto del conto economico della pubblica amministrazione sono
pari a -2,9 per cento nel 2013, -1,8 per cento nel 2014, -1,5 per cento nel
2015, -0,9 per cento nel 2016 e -0,4 per cento nel 2017. I valori
programmatici, pur rimanendo negativi, evidenziano una rapida discesa nell'arco
di programmazione, posizionandosi in modo deciso al di sotto della soglia
limite dell'ordinamento europeo, pari al 3 per cento di disavanzo sul PIL.
Rispetto alla Nota di aggiornamento, il peggioramento della posizione economica
del paese implica una correzione ciclica maggiore e quindi un disavanzo ciclico
consentito più ampio (grafico 3.2).
Grafico 3.1
Saldo strutturale programmatico: confronto tra DEF
2012, Nota di aggiornamento 2012 e DEF 2013
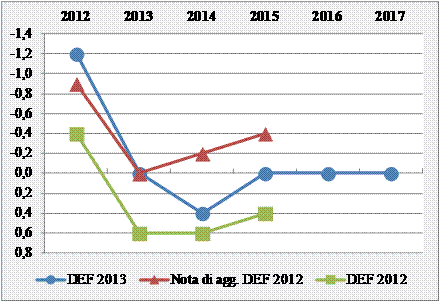
Fonti:
DEF 2013, Nota di aggiornamento del DEF 2013 e DEF 2012
Grafico 3.2
Indebitamento netto programmatico: confronto tra DEF
2012, Nota di aggiornamento 2012 e DEF 2013
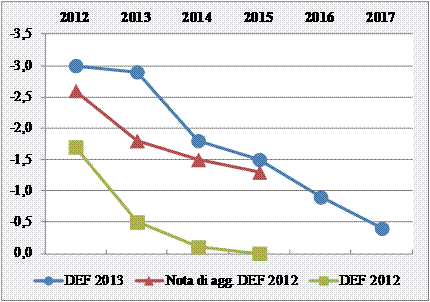
Fonti:
DEF 2013, Nota di aggiornamento del DEF 2013 e DEF 2012
Il grafico 3.3 mostra l’evoluzione dell'indebitamento netto
programmatico in relazione agli obiettivi strutturali e all’andamento stimato
dell’output gap, cioè della misura del divario tra andamento economico
effettivo e potenziale. Esso evidenzia che - in presenza di pareggio
strutturale - l'entità dell’output gap determina la misura del disavanzo
consentito, cioè la misura della stabilizzazione consentita per far fronte alla
posizione ciclica negativa. Gli obiettivi nominali - dopo un picco nel 2013 riflesso
dell'ampliamento dell'output gap nel 2013 - si riducono di entità, in
conseguenza della progressiva chiusura attesa dell'output gap.
L’avanzo primario viene mantenuto su livelli significativi,
crescenti in tutto il periodo di programmazione, passando dal 2,4 per cento del
PIL nel 2012 al 5,7 nel 2017. Gli interessi sono moderatamente crescenti,
passando da 5,5 nel 2012 a poco più di 6 punti di PIL nel 2017.
La tabella 3.1 espone le stime per gli anni 2012-2015 dei
principali saldi programmatici di finanza pubblica in rapporto al PIL, come
rappresentati nel DEF 2013 (aprile 2013), nella Nota di aggiornamento al DEF
2012 (settembre 2012) e nel DEF 2012 (aprile 2012).
Si segnala che il DEF 2013 non presenta i valori
programmatici per entrata e spesa, i quali sembrerebbero, invece, richiesti dal
Codice di condotta. L'evoluzione dei principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche viene infatti rappresentata a legislazione vigente, nell'ipotesi
della prosecuzione del regime di tassazione degli immobili vigente ad oggi.
Tabella
3.1
Obiettivi programmatici della P.A. Rapporti sul PIL
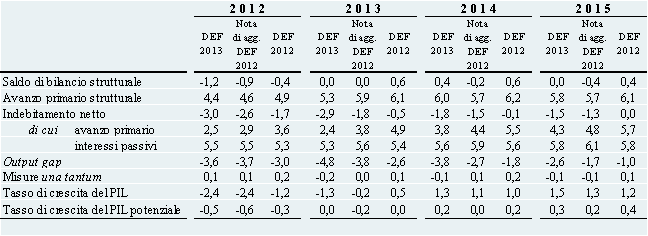
Fonti:
DEF 2013, Nota di aggiornamento del DEF 2012 e DEF 2012
Grafico 3.3
Andamento del saldo nominale
e strutturale in relazione all'output gap
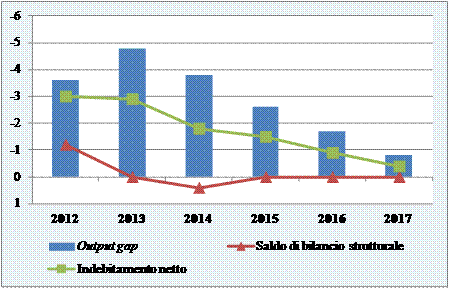
Nota: il grafico presenta i
valori del saldo nominale, strutturale e output gap a segni invertiti
Fonte: elaborazione su DEF 2013
Il confronto tra saldi programmatici e stime tendenziali evidenzia
che, per gli esercizi 2013 e 2014, non vi è necessità di operare una correzione
netta dei saldi, coincidendo i saldi programmatici con la dinamica tendenziale
dei conti. Il raggiungimento degli obiettivi programmatici richiederà invece
una azione di correzione a partire dal 2015.
Il DEF 2013 espone un quadro di previsione tendenziale che
include la prosecuzione del vigente regime di prelievo sugli immobili, in base
al quale sarebbero necessarie esigenze di correzione netta pari a 0,2 per
cento, 0,4 e 0,6 punti di PIL rispettivamente in ciascuno degli esercizi
2015-2017.
La nota alla Tavola I.1 indica che, in assenza di
prosecuzione, la misura della correzione richiesta per raggiungere gli
obiettivi programmatici sarebbe pari a 0,9 per cento del PIL nel 2015 e a 1,2 e
1,4 rispettivamente per il 2016 e il 2017.
Si ricorda che la legge di contabilità richiede che le
previsioni tendenziali siano costruite sulla base della legislazione vigente. Una
ricognizione della seppur complessa legislazione relativa al prelievo degli
immobili (caratterizzato da una normativa transitoria e a una a regime)
sembrerebbe suggerire che, a decorrere dal 2015, dovrebbe venir meno le misure
adottate alla fine del 2011.
Si ricorda inoltre che la legge di contabilità richiede
che la sezione I del DEF indichi l'articolazione della manovra necessaria per
il conseguimento degli obiettivi almeno per un triennio, nonché un'indicazione
di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i
predetti obiettivi (art. 10, comma 2, lett. f)).
Il DEF 2013 espone l’obiettivo di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche; viene altresì indicato il saldo a legislazione
vigente dei sottosettori della PA: amministrazioni centrali, amministrazioni locali
ed enti di previdenza (tabella 3.2).
Il DEF 2013 evidenzia che gli enti di previdenza
registrerebbero un saldo tendenziale stabile nell'intero periodo di
programmazione (pari a 0,2 punti di PIL), il disavanzo delle amministrazioni
locali registrerebbe un disavanzo più marcato nel 2013 (-0,7 per cento),
verosimilmente riconducibile alle misure per l'accelerazione del pagamento dei
debiti della PA e disavanzi in media pari allo 0,3 per cento nel corso del
periodo di previsione. Il percorso di contenimento dell’indebitamento netto
della PA viene riflesso nell'obiettivo delle amministrazioni centrali, per le
quali il saldo passa dal -1,7 per cento del Pil nel 2013 al -0,9 per cento nel
2017.
Si rileva che - poiché il DEF 2013 non indica la
ripartizione per sottosettore delle azioni di correzione richieste a partire
dal 2015 - non è possibile desumere i saldi programmatici per sottosettore. Si
ricorda che la legge di contabilità richiede che i saldi programmatici siano
articolati per sottosettore (art. 10, comma 2, lett. e)).
Si segnala, inoltre, che l’analisi per sottosettore (così
come quella del conto tendenziale dell’intera PA) si basa sull’ipotesi che in
futuro venga confermato il vigente regime di tassazione degli immobili, quindi
prefigurando l'esigenza di correzione ridotta negli anni 2015-2017. Tenuto
conto che il gettito che verrebbe a mancare nell'altra ipotesi (mancata
conferma del vigente regime di prelievo degli immobili) è di competenza sia
dello Stato che delle amministrazioni locali, sarebbe utile acquisire elementi
informativi sui saldi tendenziali per sottosettore (e sulle connesse esigenze
di correzione) che emergerebbero qualora non fosse confermato il regime del
prelievo vigente.
Tabella 3.2
Indebitamento netto per sottosettore (in
percentuale del PIL)
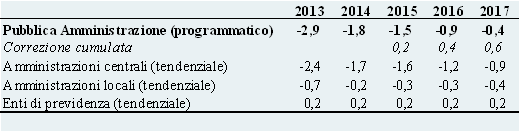
Fonte: DEF 2013
Nota:
eventuali incongruenze tra le cifre sono dovute agli arrotondamenti
Una migliore comprensione del contesto di finanza pubblica
nell'ambito del quale si muove il documento di programmazione in esame richiede
l'analisi delle previsioni tendenziali a politiche invariate. Il quadro
programmatico e la misura della correzione netta necessaria per il
raggiungimento di tali obiettivi non sarebbero infatti sufficienti ad indicare le
esigenze di correzione lorda, cioè di reperimento di risorse destinate a
consentire la prosecuzione delle politiche pubbliche. Lo stesso Codice di
condotta raccomanda agli stati membri di presentare nei propri programmi di
stabilità il quadro tendenziale dei conti a politiche invariate.
Il DEF - in coerenza con le norme di contabilità - illustra
lo scenario a politiche invariate nel quale presenta le entrate e le spese a
politiche invariate in rapporto al PIL per gli anni 2015-2017, indicando anche
il dettagli delle voci di spesa. L'analisi evidenzia somme aggiuntive rispetto
ai tendenziali pari a circa 2 mld per il 2015, 4,5 mld per il 2016 e 7 mld per
il 2017 (tabella 3.3); tali somme sono anche utilizzate nell'ambito della
verifica del rispetto della regola sulla spesa, nell'ambito della Sezione I.
Il DEF-Sezione II spiega che non sviluppa le previsioni a
politiche invariate per gli esercizi precedenti, "... in quanto gli anni
2013-2014 sono ancora interessati dalle manovre correttive di finanza
pubblica". Inoltre il documento in esame chiarisce che le previsioni a
politiche invariate non rappresentano un peggioramento dei saldi di finanza
pubblica rispetto ad uno scenario definito sulla base dell’applicazione del
criterio della legislazione vigente in quanto, ai sensi dell’art 81, quarto
comma della Costituzione, ogni nuova o maggiore spesa e/o minore entrata
rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente dovrà trovare apposita
copertura con misure compensative di pari importo e durata.
Occorrerebbe chiarire se lo scenario a politiche invariate
presentato nel DEF sia coerente con le stime presentate nella Sezione I per i
principali aggregati delle amministrazioni pubbliche nella Tavola III.2. Una
nota alla tavola stessa ricorda che i dati relativi al totale delle entrate e
delle spese differiscono da quelli del conto delle amministrazioni pubbliche
esposto nella Sezione II del DEF per una diversa metodologia di
rappresentazione del conto: secondo il Regolamento CE n. 1500/2000 nella
Sezione I e secondo la versione tradizionale nella Sezione II.
Una nota alla Tavola III.5 della I Sezione, Scenario a
politiche invariate evidenzia che le previsioni a politiche invariate sono
coerenti con il Conto delle amministrazioni pubbliche esposto nella Sezione II
del DEF 2013.
Sarebbe utile la predisposizione di uno schema di
raccordo tra le informazioni contenute nella I e nella II Sezione del DEF.
Tabella 3.3
Conto economico delle amministrazioni pubbliche nello
scenario a politiche invariate (milioni di euro)
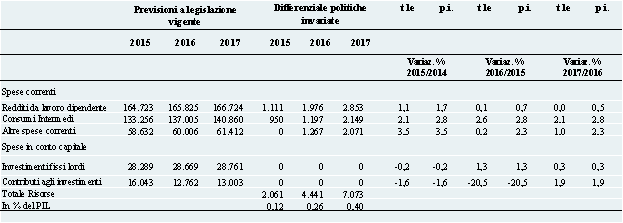
Fonte:
DEF 2013
Le recenti modifiche alla governance economica
europea (cd. six pack) rafforzano le procedure di sorveglianza e
sanzione vigenti a livello sovranazionale. Come noto, la nuova governance
economica europea, consolidata poi con il Trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (cd. Fiscal
Compact), prevede che gli obiettivi in termini di saldo strutturale (gli
OMT, specifici da paese a paese e rappresentati, per l’Italia, dal pareggio di
bilancio), siano integrati da due ulteriori regole: una regola di evoluzione
della spesa e - per i paesi con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per
cento - una regola di evoluzione del rapporto debito/PIL.
I nuovi regolamenti europei introducono nell'ambito del
braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita, un vincolo sulla
evoluzione della spesa. Il DEF 2013 evidenzia
che il limite massimo per la crescita dell’aggregato di spesa consentito
all'Italia nel biennio 2012-2013 è pari a -0,8 per cento l'anno. Nel triennio
successivo, 2014-2016, il limite massimo è stato aggiornato a -1,1 per cento
nel caso di non conseguimento dell'MTO e 0,0 per cento nel caso contrario.
La tabella 3.4 riporta le spese da escludere nel calcolo
dell'aggregato di spesa di riferimento che deve rispettare la regola, mentre la
tabella 3.5 indica i passaggi e gli importi necessari per calcolare il tasso di
crescita dell'aggregato stesso nonché il relativo limite massimo consentito
dalla regola (benchmark).
Tabella
3.4
Spese
da escludere dalla regola della spesa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
|
Livello (1)
|
In % del PIL
|
In % del PIL
|
|
Spese per programmi UE
pienamente coperte da fondi UE
|
4.499
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
Componente ciclica della
spesa per sussidi di disoccupazione (2)
|
3.777
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
Entrate discrezionali
varate nel 2012 (3)
|
20.380
|
1,3
|
1,8
|
1,6
|
0,9
|
0,9
|
0,8
|
|
Incrementi di entrata già
individuati per legge
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1) milioni di euro
2) In prima applicazione,
sull'orizzonte di previsione (2013-2017) la componente ciclica è stata
identificata nello scostamento fra il valore previsto ed il valore medio della
spesa negli anni 2008-2012 incrementata del 2 per cento per ciascuno degli anni
di previsione. Per l'anno 2012 lo scostamento è stato calcolato con riferimento
al valore medio sul periodo 2007-2011 incrementato del 2 per cento. La
variabile di spesa considerata è la 'spesa per prestazioni in denaro di
ammortizzatori sociali', che costituisce un sottoinsieme della categoria D62
del SEC95.
3) Le entrate discrezionali
includono gli effetti netti, di riduzione delle entrate, derivanti dalle misure
previste nella manovra di bilancio (D.L n.95/2012 e Legge di Stabilità
2013-2015) e gli incrementi di entrate disposti da provvedimenti precedenti
(D.L. n.201/2011; D.L. n.70/2011; D.L. n.98/2011; D.L. n.138/2011 al netto
clausola di salvaguardia su tax expenditures).
Fonte: DEF 2013
Tabella 3.5
Applicazione della regola della spesa (milioni
di euro)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
1. Totale spesa
|
788.894
|
794.512
|
804.087
|
808.264
|
829.391
|
845.137
|
862.595
|
|
2. Maggiori spese a politica
invariata
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.061
|
4.441
|
7.073
|
|
3. Spese finanziate da UE
|
3.508
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
4.499
|
|
4. Componente ciclica dei
sussidi di disoccupazione
|
2.828
|
3.777
|
3.961
|
4.493
|
3.811
|
3.560
|
3.335
|
|
5. Interessi
|
78.351
|
86.717
|
83.892
|
90.377
|
97.465
|
104.387
|
109.289
|
|
6. Investimenti fissi lordi
|
31.097
|
29.224
|
28.257
|
28.156
|
28.289
|
28.669
|
28.761
|
|
7. Investimenti fissi lordi
- media sugli ultimi 4 anni
|
34.260
|
32.760
|
30.240
|
29.184
|
28.482
|
28.343
|
28.469
|
|
8. Step 1: Aggregato di
spesa di riferimento (1+2-3-4-5-6+7)
|
707.370
|
703.054
|
713.717
|
709.923
|
725.869
|
736.806
|
752.252
|
|
9. Entrate discrezionali (2)
|
5.036
|
20.380
|
27.624
|
26.784
|
27.668
|
27.722
|
27.188
|
|
10.Step 2: Aggregato di
spesa di riferimento (8-9)
|
702.334
|
682.675
|
686.093
|
683.138
|
699.201
|
709.084
|
725.064
|
|
11.Step 3: Tasso di crescita
dell'aggregato di spesa in termini nominali
|
-1,3
|
-2,8
|
0,5
|
-0,4
|
2,2
|
1,6
|
2,3
|
|
12.Step 4: Tasso di
crescita dell'aggregato di spesa in termini reali
|
-3,2
|
-4,7
|
-1,4
|
-2,3
|
0,4
|
-0,2
|
0,5
|
|
13.Benchmark (limite
massimo alla crescita dell’aggregato di spesa)
|
-0,8
|
-0,8
|
-0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Il benchmark di
riferimento è coerente con il raggiungimento dell’MTO nel 2013 e il
mantenimento dello stesso negli anni successivi. L'aggregato di spesa di
riferimento è coerente con i valori presentati nel conto della P.A (Tavola
III.2), sottraendo al totale delle spese a politiche invariate l’ammontare
della spesa per interessi, delle spese finanziate con fondi UE, la componente
ciclica delle indennità di disoccupazione e considerando la spesa media per
investimenti (calcolata sugli anni da t a t-3). Sono inoltre sottratte le
misure discrezionali sulle entrate (Tavola III.5). Il tasso di crescita della
spesa di riferimento è stato deflazionato per mezzo dei tassi forniti dalla
Commissione negli anni 2011-2013, mentre negli anni successivi è stato utilizzato
il tasso di crescita del deflatore del PIL esposto nella Tavola II.2b.
2) In linea con la
definizione concordata nell’Output Gap Working Group, le misure discrezionali
sulle entrate corrispondono a misure già adottate e a quelle programmate con un
margine di certezza (European Commission, Methodological requirements for the
reporting of discretionary revenues measures, Note for the OGWG, 3 October
2012). Si veda anche (European
Commission, Complementary information on the functioning of the expenditure and
debt benchmarks, Note for the Alternates of the Economic and Financial
Committee, 27 June 2012). Per il 2011 il
dato indica l’incremento atteso nelle entrate tributarie totali, rispetto ai
dati di consuntivo del 2010, derivante dai principali provvedimenti varati nel
corso del biennio 2010-2011.
Fonte: DEF 2013
Il DEF 2013 evidenzia che la regola sulla spesa risulta
rispettata per tutto il periodo di riferimento ad eccezione del 2015 e del
2017.
Con riferimento
all'importo delle entrate discrezionali, la regola della spesa richiede che
venga riportato l'impatto netto delle misure discrezionali adottate e che si
intendono adottare che comportino variazioni delle entrate in ciascuno degli
anni interessati dalla regola. Pertanto, sarebbe
opportuno che il Governo fornisse ulteriori elementi per la determinazione
degli importi indicati nella riga 9 della tabella 3.4, i quali sembrano far
riferimento ai livelli delle entrate discrezionali anziché alla loro variazione
rispetto all'anno precedente richiesta dalla regola. Tale procedura si potrebbe
ritenere fondata soltanto nel caso in cui le proiezioni di base
("baseline") delle entrate non incorporassero gli effetti delle
misure discrezionali negli anni successivi alla loro introduzione.
Si osserva, inoltre, che
gli importi degli investimenti fissi lordi riportati nella Tavola II.2-1 della
Sezione II del DEF per gli anni 2012 e 2013 non risultano significativamente
diversi rispetto a quelli riportati nella Tavola 2 della Relazione al
Parlamento 2013, mentre si evidenziano differenze rilevanti per i Contributi in
c/capitale. Questo potrebbe essere dovuto alla contabilizzazione della quota in
conto capitale dei pagamenti dei debiti della PA disposti con il DL n. 35 del
2013, pari a 7.850 milioni di euro. A tal proposito sarebbe opportuno avere dal
Governo ulteriori chiarimenti anche in merito alle motivazioni di tale scelta
di contabilizzazione.
Con riferimento alle
spese a politiche invariate, il fatto che la seconda riga della tabella 3.5
riporti il valore zero in corrispondenza del 2013 e del 2014 sembra far ritenere
che il Governo ritenga le risorse stanziate per tali anni (con i provvedimenti
adottati nel 2012 e in particolare con la legge di stabilità 2013, il cui
orizzonte temporale copre il periodo 2013-2015) sufficienti a consentire la
prosecuzione delle politiche vigenti; o in alternativa che eventuali spese
ulteriori (rispetto a quelle preventivate) dovranno essere compensate con
riduzioni di altre spese. Nel caso in cui, invece, si intendesse provvedere al
finanziamento di tale eventuali ulteriori spese con un incremento di entrate
discrezionali, lo schema applicativo della regola sulla spesa (indicato a
livello europeo) sembrerebbe richiedere di evidenziare tale opzione sin da ora,
nella stessa tabella 3.5.
Si rileva che - nel caso in cui nella riga relativa alle
Entrate discrezionali vengano inserite le variazioni tra ciascun anno e il
precedente, anziché i livelli delle entrate stesse - la regola potrebbe non
essere rispettata anche nel 2013, esercizio nel quale incidono le maggiori
spese in conto capitale derivanti dallo sblocco dei pagamenti della PA verso i
propri fornitori (DL n. 35 del 2013).
Il DEF 2013 evidenzia una crescita del rapporto debito/PIL,
al lordo dei contributi italiani a sostegno dell'area dell'euro, dal 127 per
cento del 2012 al 130,4 per cento del 2013, mentre negli esercizi successivi è
prevista una progressiva riduzione dal 129 per cento del 2014 al 117,3 per
cento del 2017. Tale dinamica è realizzata scontando - sin dal 2013 - introiti
da privatizzazioni pari 1 punto percentuale di PIL.
Rispetto all'andamento programmatico riportato nella Nota di
aggiornamento al DEF 2012, le stime del DEF 2013 risultano mediamente maggiori
di circa 5 punti percentuali di PIL nel periodo 2013-2015. Inoltre, l'inizio
della riduzione del rapporto debito/PIL è stato posticipato dal 2013 (Nota di
aggiornamento al DEF 2012) al 2014 (DEF 2013).
La conformità da parte dell'Italia alla regola del debito -
introdotta dalla nuova governance economica europea - verrà valutata dalla
Commissione e dal Consiglio europeo nel 2015, cioè al termine del periodo di
transizione previsto dopo la chiusura della procedura per deficit eccessivo a
cui è sottoposto il paese. Si ricorda che tale regola richiede di verificare se
la riduzione del rapporto debito/PIL è pari a 1/20 all'anno nella media dei tre
precedenti esercizi (limite massimo retrospettivo); in caso negativo, viene
chiesto di valutare se il mancato rispetto è riconducibile alla posizione dell'economia
(limite massimo prospettico); se anche in questo caso la regola non risulta
rispettata, possono essere valutati i cd. fattori rilevanti.
La serie del rapporto debito/PIL impiegata nell'applicazione
è calcolata al lordo dei contributi EFSF/ESM, dei prestiti bilaterali alla
Grecia e di altri fattori di aggiustamento stock-flusso relativi al
periodo 2012-2014.
Il debito programmatico lordo per il 2015 è stimato pari al
125,5 per cento del PIL. Tale valore non rispetterebbe il limite massimo retrospettivo
(cosiddetto backward-looking benchmark) del 122,2 per cento. Applicando
la correzione per la componente ciclica del rapporto, il limite sarebbe invece
rispettato. Analogamente, il profilo temporale del rapporto debito/PIL
risulterebbe conforme alla regola del debito applicata con riferimento agli
anni successivi al 2015 (cosiddetto forward-looking benchmark) che fissa
un limite massimo del debito per il 2017 pari al 118,86 per cento del PIL.
Per cercare di comprendere meglio i fattori alla base dell'aggiustamento
del rapporto debito/PIL verso il benchmark è utile far riferimento
all'analisi convenzionale della sostenibilità del debito, la quale si fonda su
una semplice relazione contabile secondo cui la variazione del rapporto
debito/PIL si scompone in tre elementi:
·
L'avanzo primario riflette la politica di bilancio. A
parità di altre condizioni, un avanzo primario riduce il rapporto debito/PIL.
·
Il cosiddetto effetto snow-ball riflette l'effetto
combinato dei tassi di interesse e del tasso di crescita del PIL. A parità di
altre condizioni, un aumento dei tassi di interesse produce un aumento del
rapporto debito/PIL, mentre un aumento del tasso di crescita del PIL agisce in
direzione contraria.
·
Il cosiddetto aggiustamento stock-flusso fa
riferimento alle variazioni del rapporto debito/PIL riconducibili a: 1)
differenza tra la contabilizzazione per cassa e quella per competenza; 2)
acquisizione netta di attività finanziarie; 3) variazioni del valore del debito
pubblico denominato in valuta estera dovute a fluttuazioni del tasso di cambio;
2) transazioni finanziarie relative al sostegno pubblico a favore di
istituzioni finanziarie nazionali (ad es. banche) o internazionali (ad es.
EFSF).
Assumendo un aggiustamento stock-flusso nullo
e un effetto snow-ball (cioè un eccesso del tasso di interesse rispetto
al tasso di crescita del PIL reale), è necessario conseguire elevati avanzi
primari per ridurre o stabilizzare il rapporto debito/PIL. Analogamente, in
presenza di un aggiustamento stock-flusso positivo (ad esempio a
causa di interventi di sostegno alle istituzioni finanziarie), l'esigenza di
stabilizzazione del debito richiederà un ancor maggiore avanzo primario.
Sulla scorta di questo schema di analisi, la tabella 3.6
riporta i dati forniti dal DEF 2013. Valori negativi delle
tre componenti suddette (Avanzo Primario, Effetto snow-ball,
Aggiustamento Stock-Flussi) e delle relative sotto-componenti della
Tabella implicano un contributo alla riduzione del debito.
Tabella 3.6
Determinanti della variazione del debito pubblico
(in
percentuale del PIL)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Livello (al netto sostegni)
(2)
|
120,0
|
124,3
|
126,9
|
125,2
|
121,8
|
117,8
|
113,8
|
|
Impatto di sostegni (3)
|
0,8
|
2,7
|
3,5
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,5
|
|
Livello (al lordo sostegni)
(2)
|
120,8
|
127,0
|
130,4
|
129,0
|
125,5
|
121,4
|
117,3
|
|
Variazioni rispetto all’anno
precedente
|
1,5
|
6,2
|
3,4
|
-1,4
|
-3,5
|
-4,1
|
-4,1
|
|
Fattori che determinano le
variazioni del debito pubblico (in percentuale del PIL)
|
|
Avanzo Primario (Competenza
Economica)
|
-1,2
|
-2,5
|
-2,4
|
-3,8
|
-4,3
|
-5,1
|
-5,7
|
|
Effetto snow-ball
|
3,0
|
6,5
|
4,7
|
1,5
|
1,7
|
2,1
|
2,4
|
|
di cui: Interessi
(competenza economica)
|
5,0
|
5,5
|
5,3
|
5,6
|
5,8
|
6,0
|
6,1
|
|
Aggiustamento Stock-Flussi
|
-0,3
|
2,2
|
1,1
|
0,9
|
-0,9
|
-1,1
|
-0,8
|
|
di cui: Differenza tra cassa
e competenza
|
-0,4
|
0,0
|
-0,3
|
-0,1
|
-0,8
|
-0,8
|
-0,4
|
|
Accumulazione netta di asset
finanziari (4)
|
0,6
|
-0,4
|
-0,2
|
-0,6
|
-0,5
|
-0,7
|
-0,8
|
|
di cui: Introiti da
Privatizzazioni
|
0,0
|
-0,5
|
-1,0
|
-1,0
|
-1,0
|
-1,0
|
-1,0
|
|
Effetti di valutazione del
Debito
|
0,5
|
0,5
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
|
Altro (5)
|
-1,0
|
2,1
|
1,3
|
1,4
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
|
p. m. : Tasso di interesse
implicito sul Debito
|
4,2
|
4,5
|
4,2
|
4,4
|
4,7
|
4,9
|
5,2
|
Valori negativi delle tre componenti
suddette (Avanzo Primario, Effetto snow-ball, Aggiustamento Stock-Flussi)
e delle relative sotto-componenti della Tavola implicano un contributo alla
riduzione del debito.
1) Gli arrotondamenti alla
prima cifra decimale possono determinare incongruenze tra i valori presentati
nella tavola.
2) Al netto e al lordo della
quota di pertinenza dell’Italia dei prestiti EFSF diretti alla Grecia e del
programma ESM. Per gli anni 2011 2012 l’ammontare di tali prestiti agli Stati
membri dell'UEM (bilaterali o attraverso EFSF) è pari rispettivamente a 13.118
e 36.932 miliardi. Le stime per gli anno 2013-2017 includono i proventi da
privatizzazioni per un ammontare pari a circa 1 punto percentuale di PIL
all’anno
3) Include gli effetti del
contributo italiano a sostegno dell'Area Euro: contributi programma Greek Loan
Facility (GLF), EFSF e ESM.
4) Include gli effetti dei
contributi per GLF e programma ESM.
5) La voce altro, residuale
rispetto alle precedenti, comprende: variazioni dei depositi attivi del MEF
presso la Banca d'Italia; discrepanze statistiche; contributi a sostegno
dell'Area Euro previsti dal programma EFSF; effetti del D.L. n.35/2013.
Fonte: DEF 2013
Nel 2013 l'avanzo primario del 2,4 per cento rispetto al PIL
non riesce a controbilanciare il contributo negativo alla variazione del debito
prodotto dall'effetto snow-ball (4,7 per cento), principalmente
riconducibile alla spesa per interessi, e dall'aggiustamento stock-flussi
(1,1 per cento) riferibile quasi interamente all'impatto del DL n. 35 del 2013
riguardante il pagamento dei debiti pregressi della PA (incluso nella voce
Altro della tabella 3.6). Dalla combinazione di tali fattori il rapporto debito/PIL
programmatico del 2013 risulta in aumento di 3,4 punti percentuali rispetto al
2012.
Negli anni 2014 e 2015, invece, lo stesso rapporto risulta
in diminuzione di 1,4 e 3,5 punti percentuali rispettivamente. Nel 2014 tale
risultato è dovuto all'avanzo primario programmato (3,8 per cento del PIL) e
alla ripresa della crescita economica, mentre l'aggiustamento stock-flusso
agisce in direzione contraria (cioè verso un aumento del debito/PIL)
soprattutto a causa delle misure previste per il pagamento dei debiti pregressi
della PA. Nel 2015 l'impatto di tale misura si esaurisce e anche
l'aggiustamento stock-flusso contribuisce alla riduzione del rapporto
debito/PIL seppur in grado minore rispetto all'elevato avanzo primario e alla
ripresa economica.
La tabella evidenzia come, su tutto l'orizzonte
programmatico, incidano sul rapporto gli introiti da privatizzazioni pari 1
punto percentuale di PIL, in grado di più che compensare gli effetti del
contributo italiano a sostegno dell'area dell'euro (contributi al programma Greek
Loan Facility, EFSF e ESM).
Il ruolo dei fattori
rilevanti nella valutazione del debito
Nel caso di mancato rispetto della regola del debito, sia
retrospettiva che prospettica, prima di aprire una procedura per debito
eccessivo, la Commissione europea è tenuta a prendere in considerazione
eventuali "fattori rilevanti" che possano influire sull'evoluzione
programmatica del debito. Particolare rilevanza
assumono i contributi finanziari di sostegno alla stabilità finanziaria
dell'area dell'euro (EFSF, ESM e contributi bilaterali alla Grecia) nonché la
composizione degli aggiustamenti stock-flusso.
Il Programma di stabilità evidenzia che per l'Italia i
principali fattori rilevanti aventi effetti sul livello programmatico del
debito tra il 2012 e il 2014 sono i contributi in conto capitale all'ESM, le
erogazioni all'EFSF, i prestiti bilaterali alla Grecia e la liquidazione dei
debiti pregressi della PA disposti dal DL n. 35 del 2013. Tali fattori ammontavano
complessivamente all'1,9 per cento del PIL nel 2012, mentre sono stimati pari
al 2,1 per cento nel 2013 e all'1,6 per cento nel 2014.
La spesa per
interessi
Nelle nuove stime del Documento di economia e finanza 2013,
la spesa per interessi nel 2012 risulta pari a 86.717 milioni, con un
incremento rispetto al dato del 2011 di 8.366 milioni.
Dal confronto con i dati contenuti nella Nota di
aggiornamento 2012 e nella Relazione al Parlamento di marzo 2013, si osserva
che la stima attuale per l’anno 2012 conferma sostanzialmente le ipotesi
adottate in precedenza: la revisione delle stime mostra una correzione in
aumento della spesa, rispetto al valore stimato nel DEF 2012, pari a 2.500
milioni e di 598 milioni rispetto alla Nota di aggiornamento.
Negli anni 2013 e 2014 le previsioni mostrano
una spesa per interessi pari rispettivamente a 83.892 milioni (con una
riduzione rispetto al 2012 di 2.825 milioni) e a 90.377 milioni. Rispetto alle
stime della Nota di aggiornamento al DEF 2012 che prevedeva per il 2013 un
valore pari a 89.243 e, per il 2014, un valore pari a 96.971, si osserva una
netta correzione al ribasso, dovuta, in base a quanto affermato dal documento
in esame, ad un livello dei tassi di interesse più favorevole di quello
previsto in sede di Nota di Aggiornamento di settembre 2012.
In termini di incidenza sul PIL, la spesa passa dal 5,5 per
cento del 2012 al 5,8 per cento del 2015, con una riduzione di mezzo punto
rispetto alla Nota. Alla fine del 2017 la spesa per interessi si dovrebbe
attestare al 6,1 per cento di Pil.
Si rileva che con decreto legge n. 35 del 2013,
il Governo ha autorizzato l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a
20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. A tale ammontare,
così come affermato dalla RT allegata al citato DL, (sulla base dei tassi di
mercato attesi e tenendo conto dell’ordinaria gestione dei flussi di cassa che
il MEF normalmente adotta per la conduzione del debito pubblico) corrisponde
una spesa per interessi pari, per il bilancio dello Stato, a 922,5 milioni di
euro nel 2014 e a 1.599 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017.
L’aumento della spesa per interessi per emissione di nuovi titoli di Stato è in
parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli
enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità. Dagli effetti scontati nel
prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al DL 35/2013 deriva
un effetto netto di maggiore spesa per interessi, sul solo SNF, pari a 559,5
milioni di euro nel 2014 e 570,4 milioni di euro a decorrere dal 2015. Con
riferimento agli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento, la Relazione
presentata dal Governo al Parlamento il 21 marzo scorso, ai sensi dell’art.
10-bis, comma 6, della legge di contabilità e di finanza pubblica (legge n
196/2009) precisava che di essi si era tenuto conto nell’effettuazione delle
nuove stime. Tuttavia, né la
Relazione di marzo 2013, né il successivo decreto, né il Documento in esame
hanno specificato quale importo risulti effettivamente incorporato nelle
previsioni tendenziali riferite ai suddetti saldi. In particolare non appare
chiaro se gli importi incorporati nei tendenziali riferiti al fabbisogno e
all’indebitamento netto tengano conto anche della posta riferita agli interessi
attivi, parzialmente compensativa della maggiore spesa per interessi passivi a
carico del bilancio dello Stato a fronte delle emissioni di titoli.
Con riferimento all’anno 2012, il DEF - PdS precisa che
l’incremento della spesa per interessi, di circa 8 miliardi rispetto al 2011 è
imputabile in larga parte alle Amministrazioni Centrali ed in particolare alle
principali categorie di titoli di Stato domestici, degli incrementi, quelli più
rilevanti sono stati quelli relativi ai BOT e ai BTP/BTP€i. Il Documento
precisa che, per i BOT, ciò è spiegabile con il maggior quantitativo emesso
rispetto all’anno precedente e con tassi storicamente elevati a cui sono stati
piazzati tali titoli a fine 2011 e nel periodo giugno-luglio 2012; per i
BTP/BTP€i, ciò è dovuto principalmente all’effetto dei tassi all’emissione,
storicamente alti (in particolare quelli di fine 2011 e del periodo
marzo-luglio 2012), oltre che, sebbene in misura più modesta, all’incremento in
valore assoluto dello stock rispetto al 2011. Il Documento precisa, inoltre,
che il costo medio ponderato sulle nuove emissioni è tornato a scendere nel
2012 rispetto al 2011, arrivando al 3,11 per cento contro il 3,61 per cento.
Con riferimento alle stime della spesa per interessi
relativa agli anni 2013-2017, il DEF precisa che esse sono state formulate
utilizzando i tassi impliciti nella curva dei rendimenti italiana rilevata a
metà marzo 2013: da essi deriva un livello di spesa rispetto al PIL, nel 2013,
pari al 5,3 per cento, in lieve riduzione rispetto al 2012 e incrementi annui
modesti fino al 6,1 per cento nel 2017. In particolare il Documento afferma
che, sebbene l’attuale conformazione della curva dei rendimenti faccia
prevedere tassi in rialzo soprattutto sulle scadenze a breve e medio termine, e
nonostante una ridotta velocità di discesa del rapporto debito/PIL, la dinamica
piuttosto lenta di incremento degli interessi è da ricondurre principalmente
alla struttura del debito e ai volumi assoluti da emettere nei prossimi anni
che risultano stabili sui livelli del 2013.
Tabella 4.1
Spesa per interessi: confronto tra
Documento di economia e finanza 2012, Nota di aggiornamento del DEF 2012, e
Documento di economia e finanza 2013
(milioni
di euro - % PIL)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF
2012
|
|
|
|
|
|
|
|
Spesa
per interessi
|
84.217
|
88.456
|
93.832
|
99.249
|
-
|
-
|
|
Variazione
assoluta
|
6.196
|
4.239
|
5.376
|
5.417
|
-
|
-
|
|
Variazione
percentuale
|
7,9
|
5,0
|
6,1
|
5,8
|
-
|
-
|
|
in % del PIL
|
5,3
|
5,4
|
5,6
|
5,8
|
-
|
-
|
|
PIL
nominale
|
1.588,7
|
1.626,9
|
1.672,8
|
1.725,5
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
di aggiornamento al DEF 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
Spesa
per interessi
|
86.119
|
89.243
|
96.971
|
105.394
|
-
|
-
|
|
Variazione
assoluta
|
7.894
|
3.124
|
7.728
|
8.423
|
-
|
-
|
|
Variazione
percentuale
|
10,1
|
3,6
|
8,7
|
8,7
|
-
|
-
|
|
in % del PIL
|
5,5
|
5,6
|
6,0
|
6,3
|
-
|
-
|
|
PIL nominale
|
1.564,4
|
1.582,4
|
1.629,6
|
1.680,4
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
Spesa
per interessi
|
86.717
|
83.892
|
90.377
|
97.465
|
104.387
|
109.289
|
|
Variazione
assoluta
|
8.366
|
-2.825
|
6.485
|
7.088
|
6.922
|
4.902
|
|
Variazione
percentuale
|
10,7
|
-3,3
|
7,7
|
7,8
|
7,1
|
4,7
|
|
in % del PIL
|
5,5
|
5,3
|
5,6
|
5,8
|
6,0
|
6,1
|
|
PIL nominale
|
1.565,9
|
1.573,2
|
1.624,1
|
1.677,7
|
1.731,3
|
1.785,9
|
|
|
Fonte:
Elaborazioni su dati MEF
Il Documento sottolinea, inoltre, che le previsioni effettuate
nel mese di aprile dell’anno in corso, indicano che ad un aumento istantaneo e
permanente di un punto percentuale delle curve dei rendimenti sui titoli di
Stato corrisponde un impatto sul’onere del debito di 0,15 punti di Pil nel
primo anno, 0,33 punti di Pil nel secondo e 0,46 punti nel terzo. Tale
incremento si trasferisce interamente sul costo del debito dopo 5,51 anni. Il
DEF ritiene che questi valori, inferiori per i primi due anni rispetto a quelli
del DEF 2012, trovano giustificazione nella stima di un minor ricorso
all’emissione della componente del debito legata alle fluttuazioni dei tassi
(BOT e CCTeu), nonché nella riduzione delle attività di indebitamento annuale
complessiva, che risulta stabilizzarsi per via o delle minori scadenze o del
ridotto livello atteso del fabbisogno del Settore statale da coprire.
Tabella 4.2
Ipotesi utilizzate per i tassi di
interesse
(%
PIL)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tasso
di interesse a breve termine
|
0,8
|
1,2
|
2,7
|
3,7
|
4,4
|
4,9
|
|
Tasso
di interesse a lungo termine
|
5,7
|
4,8
|
5,3
|
5,7
|
6,0
|
6,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N.B. per tasso di interesse a breve termine si intende la media
dei tassi previsti sui titoli di Stato a 3 mesi in emissione durante l’anno.
Per tasso di interesse a lungo termine si intende la media dei tassi previsti
sui titoli di Stato a 10 anni in emissione durante l’anno
|
|
|
Fonte: PdS-DEF 2013
Con riferimento ai rendimenti dei titoli di Stato, in base a
quanto rilevato dalla Banca d’Italia, tra la fine di
settembre 2012 e la metà di gennaio 2013 il differenziale di rendimento fra il
BTP decennale e il corrispondente titolo tedesco è sceso da 365 a 271 punti
base; diminuzioni significative si sono registrate anche sulle scadenze più
brevi. Vi hanno inciso soprattutto gli effetti dell’introduzione delle Outright
Monetary Transactions (OMT) da parte della BCE e le nuove decisioni prese
in ambito europeo riguardo agli aiuti alla Grecia.
Lo spread ha subito un nuovo incremento dopo la seconda
metà di gennaio, a causa dell’incertezza relativa all’esito delle elezioni
politiche italiane ed alla crisi cipriota, acuitasi nella prima metà di marzo. Nel
periodo successivo, il differenziale di rendimento fra il BTP decennale e il
corrispondente titolo tedesco ha confermato tuttavia una tendenza alla riduzione
(in data 15 aprile 2013 risultava pari a 308 punti base).
Si segnala infine che, con decorrenza dall’11 luglio 2012, il
Consiglio direttivo della BCE ha deliberato una riduzione di 25 punti base del
tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, portandolo allo
0,75 per cento.
Grafico 4.1
Differenziale di rendimento BTP-BUND-BENCHMARK10 anni
|
550
500 450 400 350 300 250 200
|
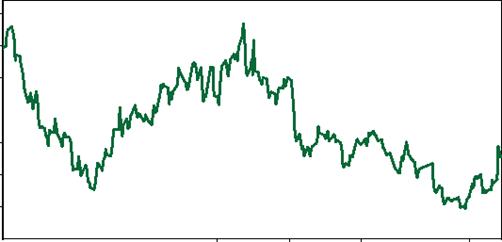
|
gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12
set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 feb-13
Nota :
grafico tratto dal Pds-DEF 2013
Il fabbisogno del settore pubblico
I risultati del 2012
Il fabbisogno, corrispondente
alla differenza (negativa) tra il totale degli incassi e il totale dei
pagamenti (correnti, in conto capitale e finanziari), è un indicatore
utilizzato per il monitoraggio e la gestione della finanza pubblica secondo il
profilo di cassa.
Per il calcolo del fabbisogno
il MEF effettua la somma algebrica fra il saldo del conto economico e quello
delle attività finanziarie, al netto dell’accensione e del rimborso di
prestiti. Non incidono sulla determinazione del fabbisogno le garanzie fornite
dallo Stato sulle emissioni di titoli effettuate dallo European Financial
Stability Fund (EFSF); ciò in quanto tali garanzie sono attivate solo nel
caso in cui l’EFSF non adempia i propri obblighi nei confronti dei creditori.
Sono esclusi, inoltre, dalla determinazione del fabbisogno, i proventi delle
dismissioni di azioni e partecipazioni in quanto destinati al fondo
ammortamento del debito pubblico.
Pertanto, il fabbisogno
rappresenta l’ammontare di liquidità necessaria per finanziare l’attività
pubblica. Poichè tale liquidità è reperita sul mercato con l’emissione di
titoli del debito pubblico, il fabbisogno rappresenta la principale componente
della variazione annuale dello stock di debito pubblico.
Nel 2012 il settore pubblico
ha registrato incassi totali per 771.190 milioni e pagamenti totali per 821.421
milioni da cui risulta un fabbisogno pari a - 50.231 milioni di euro.
Considerando i pagamenti al netto della voce interessi passivi (pari, nel 2012,
a 82.841 milioni) si ottiene un saldo primario pari a + 32.610 milioni.
La tabella 4.3 consente un confronto del dato relativo al
fabbisogno pubblico del 2012 con quello degli anni precedenti.
Tabella 4.3
|
|
milioni di euro
|
percentuale del PIL
|
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Incassi correnti
|
717.131
|
736.680
|
752.400
|
45,8
|
46,7
|
48,0
|
|
Incassi in conto
capitale
|
6.325
|
9.516
|
6.900
|
0,4
|
0,6
|
0,4
|
|
Incassi partite
finanziarie
|
4.057
|
2.675
|
11.890
|
0,3
|
0,2
|
0,8
|
|
TOTALE INCASSI
|
727.513
|
748.871
|
771.190
|
46,5
|
47,4
|
49,2
|
|
Pagamenti correnti
|
729.630
|
745.937
|
755.331
|
46,6
|
47,3
|
48,2
|
|
di cui interessi
passivi
|
71.802
|
77.605
|
82.841
|
4,6
|
4,9
|
5,3
|
|
Pagamenti in conto
capitale
|
56.773
|
54.274
|
52.239
|
3,6
|
3,4
|
3,3
|
|
Pagamenti partite
finanziarie
|
9.330
|
12.025
|
13.851
|
0,6
|
0,8
|
0,9
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
795.733
|
812.235
|
821.421
|
50,8
|
51,5
|
52,5
|
|
Saldo di parte
corrente
|
-12.499
|
-9.257
|
-2.931
|
-0,8
|
-0,6
|
-0,2
|
|
Saldo primario
|
3.582
|
14.241
|
32.610
|
0,2
|
0,9
|
2,1
|
|
Fabbisogno
|
-68.220
|
-63.364
|
-50.231
|
-4,4
|
-4,0
|
-3,2
|
L’andamento positivo registrato, nel triennio considerato,
dal fabbisogno risulta più attenuato di quello relativo al saldo primario in
quanto la voce degli interessi passivi presenta un andamento crescente.
Rispetto al 2011, il 2012 evidenzia un incremento degli
incassi correnti (in gran parte imputabili alle entrate tributarie passate da
467.830 milioni a 481.551 milioni) e delle operazioni di carattere finanziario
(include la quota della vendita a Cassa Depositi e Presiti S.p.A delle
partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e
Simest S.p.A.). Anche sul lato dei pagamenti si registra un incremento di
quelli di natura corrente e quelli relativi ad operazioni finanziarie (questi
ultimi includono le erogazioni relative alla quota di sottoscrizione del
capitale al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) pari a circa 5.700 milioni di
euro).
La tabella 4.4 riporta l’analisi
distinta del fabbisogno pubblico riferito ai settori delle Amministrazioni
centrali e delle Amministrazioni locali. I dati evidenziano
un’evoluzione favorevole nel comparto delle Amministrazioni centrali, che ha
registrato un miglioramento pari a 13.986 milioni (passando da 62.712 milioni
del 2011 a 48.726 milioni nel 2012) e un lieve deterioramento nel comparto
delle Amministrazioni locali il cui fabbisogno cresce da 651 mln del 2011 a
1.505 mln nel 2012.
Tabella 4.4
(milioni di euro)
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Amministrazioni
centrali
|
|
Incassi correnti
|
404.431
|
409.706
|
416.454
|
|
Incassi in conto capitale
|
3.389
|
4.003
|
2.401
|
|
Incassi partite finanziarie
|
3.419
|
3.780
|
3.877
|
|
TOTALE INCASSI
|
411.239
|
417.489
|
422.732
|
|
Pagamenti correnti
|
438.584
|
439.429
|
430.263
|
|
Pagamenti in conto capitale
|
34.427
|
32.394
|
33.017
|
|
Pagamenti partite finanziarie
|
5.612
|
8.379
|
8.179
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
478.623
|
480.202
|
471.459
|
|
Fabbisogno Amministrazioni centrali
|
-67.384
|
-62.713
|
-48.727
|
|
in percentuale del PIL
|
-4,3
|
-4,0
|
-3,1
|
|
Amministrazioni
locali
|
|
Incassi correnti
|
229.174
|
227.536
|
219.860
|
|
Incassi in conto capitale
|
15.464
|
13.746
|
12.982
|
|
Incassi partite finanziarie
|
2.649
|
2.587
|
9.419
|
|
TOTALE INCASSI
|
247.287
|
243.869
|
242.261
|
|
Pagamenti correnti
|
210.110
|
211.100
|
212.627
|
|
Pagamenti in conto capitale
|
34.778
|
29.922
|
27.799
|
|
Pagamenti partite finanziarie
|
3.233
|
3.498
|
3.340
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
248.121
|
244.520
|
243.766
|
|
Fabbisogno Amministrazioni locali
|
-834
|
-651
|
-1.505
|
|
in
percentuale del PIL
|
-0,1
|
0,0
|
-0,1
|
Con riferimento al comparto delle Amministrazioni
centrali, gli incassi tributari correnti registrano un incremento di 5.032
milioni rispetto al 2011 imputabile, in via prevalente, alla riserva erariale
del gettito IMU. Gli incassi in conto
capitale registrano, invece, un decremento rispetto al 2011 dovuto in via
prevalente alle assegnazioni di diritti d’uso delle frequenze radio elettriche
che hanno comportato un introito nel 2011 di 2.855 milioni di euro. L’andamento
dei pagamenti correnti è stato influenzato dalla sospensione per un triennio
del sistema della “tesoreria mista” – con il ripristino della tesoreria unica
tradizionale, che ha comportato l’afflusso sui conti della tesoreria statale
delle disponibilità detenute presso le banche dagli enti territoriali, dalle
università, e dagli altri enti pubblici; sono state incluse nel sistema della
tesoreria unica anche le istituzioni scolastiche ed educative statali. I
pagamenti in conto capitale includono i maggiori trasferimenti alle famiglie
per la ricostruzione post-terremoto in Abruzzo (714 milioni).
Il comparto delle Amministrazioni locali
evidenzia un lieve peggioramento ascrivibile, in larga parte, al deterioramento
dei conti della Sanità che incrementa il proprio fabbisogno da 386 milioni nel
2011 a 1.517 milioni nel 2012.
Sul lato delle entrate, a fronte di una riduzione dei
trasferimenti derivanti da altre amministrazioni pubbliche (-17.240 mln rispetto
al 2011) si registra un incremento delle entrate tributarie (+8.689 mln,
imputabile all’andamento positivo dell’addizionale IRPEF e dell’IMU) e degli
introiti di natura finanziaria (+ 6.832 mln) dovuti in larga misura allo
smobilizzo dei depositi bancari a seguito delle disposizioni transitorie sulla
tesoreria unica (fino al 31 dicembre 2014).
Sul lato dei pagamenti, la contrazione evidenziata nel 2012
rispetto al 2011 è il risultato netto tra la riduzione delle spese di personale
e degli investimenti fissi lordi da un lato e dell’incremento delle spese per
beni e servizi, dall’altro lato.
Più in dettaglio, per quanto concerne le Regioni:
-
il finanziamento del settore statale è diminuito da 90,9 mld del
2011 a 86,6 mld del 2012;
-
gli incassi tributari hanno registrato un incremento con
riferimento sia alle imposte dirette che alle imposte indirette;
-
i depositi bancari sono diminuiti, principalmente per la
sospensione del regime di tesoreria mista, di circa 821 milioni;
-
sono stati assunti nuovi prestiti (per esigenze legate al
fabbisogno e al rimborso dei prestiti in corso) per un totale di 7.478 milioni
di cui 5.456 milioni rappresentati da anticipazioni di tesoreria;
-
i pagamenti, al netto di quelli relativi alla spesa sanitaria e
alle partite finanziarie, registrano una riduzione di 1.456 milioni imputabile
sia alla riduzione di spese correnti (spese del personale e spese per acquisti
di beni e servizi) sia alla riduzione di spese in conto capitale;
-
le disponibilità presso le contabilità speciali di tesoreria
unica intestate a tutte le regioni presentano un aumento di 2.283 milioni
passando da 11.902 milioni del 1° gennaio 2012 a 14.185 milioni. Le giacenze
dei conti correnti intestati a tutte le Regioni, presso la Tesoreria Statale,
relativi all’IRAP e all’addizionale IRPEF hanno registrato un lieve aumento
complessivo pari a 147 milioni.
Per quanto concerne, invece, i Comuni e le Province:
-
i pagamenti per rimborso di prestiti agli istituti di credito
sono stati pari a 11.568 milioni, di cui 6.322 milioni per restituzione di
anticipazioni di tesoreria;
-
sono stati assunti nuovi prestiti per 11.252 milioni, di cui
3.396 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti, 31 milioni dal collocamento sul
mercato di prestiti obbligazionari e 6.206 milioni per anticipazioni di
tesoreria;
-
gli incassi registrano una contrazione dovuta in via prevalente
alla riduzione dei trasferimenti correnti dal settore statale (- 71,9 per cento).
Tale riduzione appare imputabile anche all’anticipo del regime IMU e alla
contestuale soppressione dei trasferimenti erariali;
-
le entrate tributarie registrano un rilevante incremento sia per
le imposte dirette (+ 21,3 per cento) che per le imposte indirette (+ 20,3 per
cento);
-
gli incassi relativi alle partite finanziarie registrano un
incremento di 3.832 milioni dovuto, prevalentemente, alla riduzione dei
depositi bancari in conseguenza della normativa sulla tesoreria unica.
Nel seguente prospetto sono evidenziate le voci che
consentono il raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico e l’indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche riferito all’anno 2011.
L’indebitamento netto della PA è l’indicatore
determinato in base a criteri economici con riferimento alle pubbliche
amministrazioni. Le voci che consentono il raccordo tra fabbisogno e
indebitamento sono: le partite finanziarie (che rilevano ai fini del fabbisogno
ma non dell’indebitamento), le differenze di valutazioni di singole operazioni
per competenza e per cassa e la riclassificazione di operazioni.
Tra queste ultime sono stati inseriti i debiti commerciali
legati alle operazioni di factoring con la clausola pro-soluto i quali –
a seguito della decisione Eurostat del 31 luglio 2012 – sono stati
riclassificati come strumenti di debito pubblico.
Tabella 4.5
Raccordo tra fabbisogno del settore pubblico e
indebitamento netto delle PA.
(milioni di euro)
|
|
2011
|
|
Fabbisogno del
settore pubblico
|
-61.932
|
|
|
|
|
Partite finanziarie
attive comprese nel Fabbisogno (variazioni)
|
8.956
|
|
Concessione di
prestiti (+)
|
8.370
|
|
Riscossione di
prestiti (-)
|
-2.355
|
|
Acquisizione di
partecipazioni azionarie (+)
|
803
|
|
Vendite di azioni
(-)
|
-278
|
|
Aumenti/Riduzioni di
altre attività finanziarie (+/-)
|
2.416
|
|
|
|
|
Differenza tra
valutazioni per competenza e per cassa
|
-6.488
|
|
Entrate (+)
|
478
|
|
Uscite al netto
degli interessi passivi (-)
|
-4.424
|
|
Interessi passivi
(EDP) (-)
|
-2.542
|
|
|
|
|
Riclassificazioni di
operazioni
|
-2.007
|
|
Cancellazioni di
debiti dei Paesi in via di sviluppo
|
-567
|
|
Riclassificazioni di
altre partite finanziarie (crediti e partecipazioni)
|
-216
|
|
Riclassificazioni
dei superdividendi (da incassi di capitali a vendita di partecipazioni)
|
-50
|
|
Riclassificazioni
degli introiti derivanti dalle somme confiscate
|
-30
|
|
Riclassificazioni
degli introiti derivanti dai conti dormienti
|
-175
|
|
Riclassificazioni
per investimenti realizzati mediante contratti
di partenariato
pubblico privato (ppp)
|
-461
|
|
Riclassificazioni
degli introiti derivanti da operazioni di cartolarizzazioni di
crediti
contributivi INPS a seguito delle decisioni Eurostat
|
265
|
|
Decisione Eurostat
del 31 luglio 2012 – Riclassificazione dei debiti commerciali legati alle
operazioni di
factoring
prosoluto co società di factoring e con banche in strumenti di debito
pubblico (prestiti)
|
-773
|
|
Discrepanza
statistica
|
-288
|
|
|
|
|
Indebitamento netto
|
-61.758
|
Tabella 4.6 (milioni
di euro)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Fabbisogno
settore pubblico
|
|
Incassi correnti
|
774.006
|
793.830
|
815.807
|
836.163
|
857.395
|
|
Incassi in conto capitale
|
6.954
|
6.861
|
6.312
|
6.146
|
5.829
|
|
Incassi partite finanziarie
|
2.091
|
2.038
|
1.929
|
1.872
|
1.274
|
|
TOTALE INCASSI
|
783.051
|
802.729
|
824.048
|
844.181
|
864.498
|
|
Pagamenti correnti
|
769.899
|
776.560
|
791.428
|
808.930
|
829.709
|
|
Pagamenti in conto capitale
|
52.643
|
50.035
|
47.062
|
44.364
|
44.114
|
|
Pagamenti partite finanziarie
|
15.143
|
7.905
|
9.917
|
6.986
|
5.306
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
837.685
|
834.500
|
848.407
|
860.280
|
879.129
|
|
Fabbisogno ante DL 35/2013
|
-54.635
|
-31.770
|
-24.359
|
-16.099
|
-14.631
|
|
in percentuale del PIL
|
-3,5%
|
-2,0%
|
-1,5%
|
-0,9%
|
-0,8%
|
|
Effetti DL n. 35/2013
|
-20.000
|
-20.000
|
0
|
0
|
0
|
|
Fabbisogno post DL 35/2013
|
-74.635
|
-51.770
|
-24.359
|
-16.099
|
-14.631
|
|
in percentuale del PIL
|
-4,7%
|
-3,2%
|
-1,5%
|
-0,9%
|
-0,8%
|
|
Comparto
amministrazioni centrali
|
|
Incassi correnti
|
434.830
|
447.041
|
457.022
|
468.964
|
481.353
|
|
Incassi in conto capitale
|
2.250
|
2.153
|
1.604
|
1.556
|
1.206
|
|
Incassi partite finanziarie
|
2.752
|
3.070
|
3.053
|
2.990
|
2.389
|
|
TOTALE INCASSI
|
439.832
|
452.264
|
461.679
|
473.510
|
484.948
|
|
Pagamenti correnti
|
447.277
|
447.152
|
454.675
|
461.142
|
471.597
|
|
Pagamenti in conto capitale
|
35.224
|
32.614
|
30.102
|
27.479
|
27.130
|
|
Pagamenti partite finanziarie
|
10.736
|
3.290
|
532
|
556
|
558
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
493.237
|
483.056
|
485.309
|
489.177
|
499.285
|
|
Fabbisogno ante DL 35/2013
|
-53.404
|
-30.791
|
-23.630
|
-15.667
|
-14.338
|
|
in percentuale del PIL
|
-3,4%
|
-1,9%
|
-1,4%
|
-0,9%
|
-0,8%
|
|
Effetti DL n. 35/2013
|
-20.000
|
-20.000
|
0
|
0
|
0
|
|
Fabbisogno post DL 35/2013
|
-73.404
|
-50.791
|
-23.630
|
-15.667
|
-14.338
|
|
in percentuale del PIL
|
-4,7%
|
-3,1%
|
-1,4%
|
-0,9%
|
-0,8%
|
|
Comparto
amministrazioni locali
|
|
Incassi correnti
|
218.417
|
216.528
|
221.356
|
219.665
|
219.098
|
|
Incassi in conto capitale
|
12.453
|
12.450
|
12.419
|
12.452
|
12.487
|
|
Incassi partite finanziarie
|
1.565
|
1.248
|
1.089
|
1.091
|
1.094
|
|
TOTALE INCASSI
|
232.435
|
230.226
|
234.864
|
233.208
|
232.679
|
|
Pagamenti correnti
|
206.137
|
203.660
|
203.813
|
204.637
|
205.489
|
|
Pagamenti in conto capitale
|
24.825
|
24.815
|
24.375
|
24.446
|
24.541
|
|
Pagamenti partite finanziarie
|
2.704
|
2.730
|
7.404
|
4.554
|
2.942
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
233.666
|
231.205
|
235.592
|
233.637
|
232.972
|
|
Fabbisogno ante DL 35/2013
|
-1.229
|
-979
|
-729
|
-430
|
-292
|
|
in percentuale del PIL
|
-0,1%
|
-0,1%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Fabbisogno di cassa del
settore pubblico: previsioni tendenziali 2013‑2017
Le previsioni del fabbisogno del settore pubblico, e della
sua analisi per comparti, è riportata nella seguente tabella 4.6.
Negli anni dal 2013 al 2017 è stimato nel Documento in esame
un fabbisogno del settore pubblico in costante miglioramento fino a
raggiungere, nel 2017, il valore di – 14.631 milioni (-0,8 per cento rispetto
al PIL).
Le previsioni indicate non considerano tutti gli effetti del
decreto sui pagamenti dei debiti commerciali (decreto legge n. 35 del 2013). In
particolare, precisa il Documento, le stime non tengono conto degli esborsi per
20.000 euro negli anni 2013 e 2014, mentre sono coerenti con il nuovo quadro
macroeconomico. Tuttavia, nelle tabelle è esposta un’informativa sugli esiti
complessivi del provvedimento.
Il fabbisogno del 2013 registra un incremento
rispetto a quello registrato nel 2012 (da -50.231 milioni a -54.635 milioni);
tale andamento è in larga parte imputabile al deterioramento del saldo delle
partite finanziarie che nel 2012 ha risentito del riversamento nella tesoreria
statale delle giacenze detenute sul sistema bancario. La stima degli anni 2013
e 2014 tiene conto del perdurare del regime di tesoreria unica tradizionale
mentre, a partire dal 2015, si prevede un progressivo ritorno al regime di
tesoreria mista.
Il regime transitorio
(2012-2014) del ritorno alla tesoreria unica in luogo della tesoreria mista è
stato disposto dall’art. 35, commi da 8 a 10, del decreto legge n. 1 del 2012.
L’ammontare delle giacenze stimato, iscritto come effetto positivo ai fini del
fabbisogno in quanto riversato nella Tesoreria unica, è pari a 8,6 miliardi nel
2012. Tale riversamento non produce effetti fino al 2014 (termine del periodo
transitorio).
In merito alle stime riferite alle annualità successive
al 2015 andrebbero forniti dei chiarimenti sulla valutazione “progressiva” del
ritorno al regime di tesoreria mista.
La stima per l’anno 2013, rispetto a quella contenuta nella
Nota di aggiornamento al DEF 2012 come integrata degli effetti della legge di
stabilità per il 2013, sconta un peggioramento per effetto dei pagamenti
relativi alla sottoscrizione del capitale BEI e degli interventi di sostegno al
Monte dei Paschi di Siena.
La partecipazione dell’Italia
all’aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata
disposta dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, c.172). Il contributo
complessivo ammonta a 1.617 milioni di euro da versare in un’unica soluzione
nell’anno 2013.
Gli articoli da 23-sexies
a 23-duodecies del DL n. 95 del 2012 hanno previsto la sottoscrizione,
da parte del MEF, di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di
Siena. Le risorse necessarie
per la sottoscrizione sono state individuate con DPCM 28/12/2012 per un importo
di circa 2.000 milioni attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico a
medio-lungo termine.
Nel 2014 il fabbisogno registra una importante
contrazione (quasi 23 miliardi di euro) conseguente al significativo aumento
del gettito tributario e dei contributi sociali, legato alla prevista ripresa
economica, nonché ai maggiori incassi IVA derivanti
dall’accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali.
Appaiono necessari dei chiarimenti in merito
all’inclusione degli effetti positivi relativi al gettito IVA derivante
dall’accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali. In particolare,
andrebbe in primo luogo precisato se gli effetti richiamati nel Documento siano
quelli considerati nel prospetto riepilogativo allegato al decreto legge n. 35
del 2013 (600 milioni nel 2014) ovvero se si tratta di ulteriori effetti –
tenuto conto che il pagamento dei debiti di fornitura ammonta a 20 miliardi in
ciascuno dei due anni 2013 e 2014. In ogni caso, si segnala che l’inclusione di
effetti positivi non appare in linea con la mancata iscrizione degli effetti
negativi conseguenti al pagamento dei medesimi debiti.
Il fabbisogno 2013 e 2014 include i versamenti relativi alla
quota di sottoscrizione del capitale del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES):
complessivamente, l’impegno per l’Italia ammonta a circa 14.300 milioni da
versare in cinque tranches, delle quali due già versate nel 2012 e le
altre tre da pagare nel 2013 e nel 2014 per un ammontare, rispettivamente, di
circa 5.700 e 2.800 milioni.
Per quanto concerne gli anni successivi, il Documento si
limita, per l’anno 2015, a riportare il dato stimato; per gli anni 2016
e 2017 viene precisato che il miglioramento del saldo è attribuibile alla
ripresa di gettito tributario.
L’andamento della stima degli incassi
tributari presenta, nel periodo considerato, un andamento crescente (da 481
mld del 2013 a 547 mld del 2013) che rispecchia, sostanzialmente, la crescita
del prodotto interno lordo: infatti, il valore in rapporto dal PIL passa dal
30,6 per cento del 2013 al 30,7 per cento del PIL del 2017.
La stima degli incassi dei contributi sociali,
invece, presenta una crescita più contenuta rispetto al PIL: in rapporto al PIL
si passa dal 13,6 per cento del 2013 al 13,2 per cento del 2017. Tale
circostanza dipende dalla presenza di previsioni di moderata crescita nel 2013
e di una graduale ripresa nell’orizzonte di previsione che riflette la dinamica
dell’attività economica e dell’occupazione nel periodo considerato.
La spesa per il personale presenta una
flessione nel 2013 e nel 2014 ed un incremento nel 2015, per il venir meno
degli effetti di alcune delle misure contenitive della spesa per il personale
attualmente vigenti, in particolare in relazione alle limitazioni ai
trattamenti economici individuali, al blocco della contrattazione collettiva
nazionale ed alle progressioni di carriera. Per il biennio successivo si
prevede una sostanziale invarianza.
La spesa per l’acquisto di beni e servizi evidenzia una
contrazione negli anni 2013 e 2014 (rispettivamente -5.926 milioni e -2.113
milioni) per poi stabilizzarsi nel biennio successivo. Nel 2017 è prevista una
ripresa significativa )+4.895 milioni).
I trasferimenti correnti presentano
un andamento crescente in tutto il periodo considerato, anche se l’incremento è
più contenuto rispetto a quello del PIL (si passa dal 23,2 per cento del 2013
al 22,6 per cento del PIL). La stima sulla spesa per prestazioni sociali sconta
gli effetti contenitivi del decreto legge n. 201 del 2011 nonché quelli, di
segno opposto, derivanti dalla normativa diretta alla salvaguardia dei
lavoratori rispetto all’innalzamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
e all’introduzione di misure agevolative in materia di ricongiunzioni e di
totalizzazione di periodi pensionistici.
Il debito pubblico
In base ai dati recentemente pubblicati dalla Banca d’Italia
la consistenza del debito delle amministrazioni pubbliche a fine 2011 è stata
pari a 1.988.658 milioni con un incremento di 81.266 milioni di euro rispetto
allo stock registrato a fine 2011. La variazione del debito è ascrivibile, in
parte al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 65.713 milioni.
Hanno influito negativamente sullo stock di debito, inoltre, l’incremento delle
attività del Tesoro presso la Banca d’Italia per unvalore pari a 10.138 milioni
e gli scarti di emissione per un importo pari a 5.792 milioni. Solo
marginalmente ha compensato il controvalore in euro delle passività in valuta
per un valore pari a 377 milioni.
La Banca d’Italia precisa che le disponibilità del Tesoro sono
state accresciute da 24,3 a 34,4 miliardi, di contro, sono state cedute alla
Cassa depositi e prestiti le partecipazioni del Tesoro in SACE, Simest e
Fintecna (con un provento di quasi 8 miliardi) e sono diminuiti i depositi
bancari delle Amministrazioni pubbliche (di 9,1 miliardi, a 26,3)
principalmente per effetto dell’assoggettamento di molti enti pubblici a un più
stringente regime di tesoreria.
Con riguardo al debito delle amministrazioni pubbliche, il
documento in esame fornisce, nella Sezione I - Programma di stabilità, il
profilo del rapporto debito/PIL per il periodo 2011-2017. I dati sono,
rispettivamente, al netto ed al lordo degli effetti delle misure di sostegno
adottate nell’area euro ai fini della stabilizzazione finanziaria.
Negli anni 2011 e 2012, il valore del debito al lordo
delle misure di sostegno tiene conto della quota di pertinenza dell’Italia
dei prestiti EFSF diretti alla Grecia e del programma ESM, per un valore pari
rispettivamente a 13.118 e a 36.932 milioni di euro.
Tabella 4.7
Debito delle Amministrazioni pubbliche in
rapporto al PIL
(%
PIL)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Debito/PIL
netto misure sostegno
|
120,0
|
124,3
|
126,9
|
125,2
|
121,8
|
117,8
|
113,8
|
|
Impatto
misure sostegno
|
0,8
|
2,7
|
3,5
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,5
|
|
Debito/PIL
lordo misure sostegno
|
120,8
|
127,0
|
130,4
|
129,0
|
125,5
|
121,4
|
117,3
|
|
Variazione
|
1,5
|
6,2
|
3,4
|
-1,4
|
-3,5
|
-4,1
|
-4,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota:
le stime per gli anni 2013 -2017 includono i proventi da privatizzazioni per
un ammontare pari a circa 1 punto percentuale di PIL all’anno
|
|
|
Fonte: PdS-DEF
2013
In merito agli strumenti finanziari contratti, il debito
rappresentato da titoli negoziabili sia dell’Amministrazione centrale che degli
Enti locali rappresentava, a fine 2012, l’83,2 per cento del debito consolidato
complessivo, in calo rispetto all’84,2 per cento del 2011. Circa il 99 per
cento di queste obbligazioni è rappresentato da titoli di Stato. Il DEF precisa
che il 90,8 per cento del totale dei titoli negoziabili è stato emesso in forma
di obbligazioni a medio e lungo termine, in leggero calo rispetto al 91,8 per
cento del 2011, a causa di un moderato aumento delle emissioni sulle scadenze a
breve, dovuto alla necessità di fronteggiare un eccezionale volume di rimborsi
a medio-lungo termine in un contesto di mercato particolarmente difficile. Il debito
non negoziabile contratto nella forma di prestiti è pari all’8,7 per cento del
debito complessivo.
Nella tabella che segue è riportata la ripartizione del
debito al lordo e al netto dei sostegni finanziari all’area dell’euro
per sottosettori, con la precisazione che la quota relativa a tali sostegni è
posta interamente a carico delle Amministrazioni centrali.
Tabella 4.8
Debito delle Amministrazioni pubbliche
per sottosettori
(Milioni di euro- %PIL)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Debito netto sostegni UEM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.A.
|
1.894.275
|
1.945.993
|
1.995.916
|
2.032.816
|
2.043.870
|
2.040.114
|
2.032.295
|
|
%PIL
|
120,0
|
124,3
|
126,9
|
125,2
|
121,8
|
117,8
|
113,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amm.C.
|
1.785.363
|
1.838.855
|
1.887.547
|
1.923.468
|
1.933.793
|
1.929.606
|
1.921.854
|
|
%PIL
|
113,1
|
117,4
|
120,0
|
118,4
|
115,3
|
111,5
|
107,6
|
|
variazione
|
|
4,3
|
2,5
|
-1,5
|
-3,2
|
-3,8
|
-3,8
|
|
Amm.L.
|
135.159
|
131.810
|
133.039
|
134.018
|
134.747
|
135.177
|
135.469
|
|
%PIL
|
8,6
|
8,4
|
8,5
|
8,3
|
8,0
|
7,8
|
7,6
|
|
variazione
|
|
-0,1
|
0,0
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
|
Enti prev.
|
135
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Debito lordo sostegni UEM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.A.
|
1.907.392
|
1.988.658
|
2.051.352
|
2.094.275
|
2.105.502
|
2.101.937
|
2.094.348
|
|
%PIL
|
120,8
|
127,0
|
130,4
|
129,0
|
125,5
|
121,4
|
117,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amm.C.
|
1.798.480
|
1.881.520
|
1.942.983
|
1.984.927
|
1.995.425
|
1.991.429
|
1.983.908
|
|
%PIL
|
113,9
|
120,2
|
123,5
|
122,2
|
118,9
|
115,0
|
111,1
|
|
variazione
|
|
6,2
|
3,3
|
-1,3
|
-3,3
|
-3,9
|
-3,9
|
|
Amm.L.
|
135.159
|
131.810
|
133.039
|
134.018
|
134.747
|
135.177
|
135.469
|
|
%PIL
|
8,6
|
8,4
|
8,5
|
8,3
|
8,0
|
7,8
|
7,6
|
|
variazione
|
|
-0,1
|
0,0
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
|
Enti prev.
|
135
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota:
il debito delle amministrazioni centrali, locali e degli enti di previdenza è
da considerarsi al lordo degli interessi non consolidati
|
|
|
Fonte: PdS-DEF
2013
Il debito delle Amministrazioni centrali mostra un andamento
crescente fino al 2013 per poi invertire la tendenza a decorrere dal 2014, con
un contributo alla riduzione del debito in termini di PIL pari a 1,5 per cento,
tale tendenza appare accentuarsi anche per gli anni 2015 e 2016 con una
riduzione annua media pari al 3,5 per cento. Si può osservare inoltre che il
debito delle Amministrazioni locali presenta un andamento decrescente in
termini di PIL per tutto il periodo in esame, pari in media a circa 0,2 punti
percentuali.
Nel confronto con le previsioni contenute nel Programma di
stabilità 2012 e nella Nota di aggiornamento 2012, per il periodo temporale di
coincidenza delle stime, le nuove previsioni mostrano un profilo costantemente
superiore del rapporto debito/PIL, come riportato nella tabella che segue.
Tabella 4.9
Debito delle Amministrazioni pubbliche in
rapporto al PIL: confronto tra PdS-DEF 2012, Nota di Aggiornamento 2012 e Pds-DEF
2013 (% PIL)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PdS-DEF
2012 (aprile 2012)
|
120,1
|
123,4
|
121,5
|
118,2
|
114,4
|
|
|
|
Nota
agg. DEF 2012 (sett. 2012):
|
|
legislazione
vigente
|
120,7
|
126,4
|
127,1
|
125,1
|
122,9
|
|
|
|
quadro
programmatico
|
120,7
|
126,4
|
126,1
|
123,1
|
119,9
|
|
|
|
PdS-DEF
2013 (aprile 2013)
|
120,8
|
127,0
|
130,4
|
129,0
|
125,5
|
121,4
|
117,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N.B. il quadro programmatico indicato
nella Nota di aggiornamento al DEF 2012 sconta un ammontare di proventi pari
a circa 1 punto percentuale di PIL all’anno derivanti dalla valorizzazione e
successiva dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili sia
delle partecipazioni pubbliche. Tali effetti sono presi in considerazione
anche nel DEF 2013, per tutto il periodo 2013-2017.
|
|
|
Fonte: PdS-DEF 2013
Nel 2011, il rapporto è stato marginalmente rivisto al rialzo,
passando dal 120,7 per cento riportato nella Nota di Aggiornamento al DEF al
120,8 per cento. Nel 2012, invece, il rapporto aumenta di 0,5 punti percentuali
passando al 126,5 per cento nelle previsioni della Nota, ad un livello del 127
per cento. Il Documento in esame, precisa al riguardo che, mentre nel primo
caso si tratta di ordinarie revisioni statistiche relative sia allo stock
aggregato del debito pubblico (da parte della Banca d’Italia) sia al PIL (da
parte dell’ISTAT), a determinare l’incremento rispetto alle previsioni per l’anno
2012 è stato principalmente l’andamento del volume del debito, risultato
superiore di circa 12 miliardi di euro rispetto alle stime di settembre 2012.
Secondo il DEF questa evoluzione è stata in parte una dinamica del fabbisogno
del settore pubblico superiore alle attese e in parte un più accentuato ritmo
delle emissioni di titoli, che ha contribuito a consolidare la posizione di
cassa del Tesoro di fine anno.
Il Documento precisa che nei mesi maggiormente favorevoli del
2012, il Tesoro è riuscito a garantire il rifinanziamento dei titoli in
scadenza accelerando il ritmo delle emissioni su tutte le scadenze fino a 10
anni e in particolare sui BOT. Le migliori condizioni rispetto agli ultimi mesi
del 2011 hanno reso, inoltre, possibile il lancio, nel mese di marzo, del BTP
Italia, titolo quadriennale indicizzato all’indice di inflazione FOI (Indice
delle famiglie italiane di operai ed impiegati) indirizzato agli investitori retail
e quotato sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni). Inoltre, il
Documento afferma che, nelle fasi di maggiori turbolenza, si è fatto ricorso ad
una graduale rimodulazione delle emissioni sulle scadenze 2-10 anni
privilegiando la parte a 3 e a 10 anni, a fronte di una riduzione del carico
sulle scadenze a 15-30 anni, sulla componente a tasso variabile (CCTeu) o
indicizzata all’inflazione dell’area euro (BTP€i). Di converso in queste fasi è
stata intensificata l’offerta dei titoli non più in corso di emissione (titoli off-the-run)
mentre in un caso si è proceduto a svolgere un’operazione di concambio, con
l’obiettivo di fornire un supporto ai BTP indicizzati all’inflazione dell’area
euro, che in alcune fasi di mercato hanno presentato una performance molto
negativa anche in termini di liquidità del mercato secondario.
Per l’anno 2013 il rapporto debito/PIL è previsto ancora in
crescita di oltre 3 punti percentuali di PIL rispetto al 2012, arrivando al
130,4 per cento, un dato di circa 4,3 punti percentuali di PIL superiore alla
stima programmatica contenuta nella Nota di Aggiornamento del 2012. Il DEF
afferma che tale evoluzione è determinata, in parte, dall’effetto di
‘trascinamento’ dal 2012 (per circa 0,7 punti di PIL) e da un livello del PIL
stimato per l’anno lievemente inferiore (per circa 0,5 punti percentuali);
tuttavia, il fattore maggiormente significativo è da ricondurre a una sostanziale
revisione al rialzo del fabbisogno del settore pubblico (per quasi 3,3 punti di
PIL), anche per effetto del provvedimento di sblocco dei pagamenti dei debiti
commerciali delle Pubbliche Amministrazioni verso i propri fornitori (D.L. n.
35 del 2013).
Nel 2014 si assiste ad una riduzione del livello del
rapporto/PIL che dovrebbe portarsi al 129 per cento, poco meno di 6 punti
percentuali di PIL al di sopra della previsione dello scorso settembre. Sulla
base di quanto affermato nel Documento, questo risultato deriva da un livello
del fabbisogno del Settore pubblico ben più elevato di quello contenuto nelle
stime della Nota (per quasi due punti di PIL), anch’esso in larga parte dovuto
agli effetti del decreto legge sopra citato.
Dal 2015 in poi si assiste ad un percorso di riduzione del
rapporto piuttosto sostenuto, per circa 4 punti percentuali di PIL all’anno,
dovuto, secondo il DEF, al venir meno degli effetti finanziari del D.L. n. 35
del 2013, ad una dinamica del fabbisogno particolarmente virtuosa dal 2016 in
poi ed al mantenimento dell’ipotesi di entrate da dismissioni immobiliari
costanti, per importi pari circa a un punto percentuale di PIL all’anno per
tutto il periodo 2013-2017.
Al riguardo, tenuto conto che il Documento in esame
nell’effettuare le stime del rapporto debito/PIL estende a tutto il periodo di
previsione considerato (2013-2017) l’ipotesi di entrate da dismissioni
immobiliari costanti per importi pari a circa 1 punto di Pil all’anno,
determinando una riduzione del suddetto rapporto pari a fine periodo (2017) a
cinque punti percentuali, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori
elementi informativi in merito al programma di valorizzazione e dismissione del
patrimonio pubblico, indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2012.
Gli “altri fattori rilevanti”
La nuova regola per la riduzione del debito pubblico (v. approfondimento
7. La regola del debito) prevede che, anche nel caso in cui il rapporto
debito/PIL risulti più elevato del benchmark, si tengano comunque in
considerazione un certo insieme di “altri fattori rilevanti”. L’analisi di tali
fattori rappresenta, quindi, un passo importante nell'ambito delle procedure
europee.
Il sistema bancario
Con riferimento alla situazione del sistema bancario, il DEF
sottolinea che le imprese finanziarie, seguendo anche le indicazioni delle
autorità di vigilanza, hanno proceduto ad una riqualificazione delle attività
patrimoniali a favore di crediti meno rischiosi. Allo stesso tempo le
principali banche hanno provveduto ad effettuare una ricapitalizzazione dando
seguito alla raccomandazione dell’EBA del dicembre 2011. Il Documento rileva
che i valori della leva finanziaria che risultano dagli ultimi dati di
confronto con i principali sistemi bancari europei mostrano che l’Italia si
trova in una situazione più rassicurante di altri Paesi. Sulla base di quanto
affermato dal DEF, il sistema bancario italiano ha mostrato maggiori segni di
tenuta durante la crisi rispetto agli altri Paesi avanzati. Gli aiuti pubblici
alle banche in Italia sono stati pari allo 0,3 per cento del PIL, di entità
minore rispetto a quanto registrato in altri Paesi europei, quali la Germania
(1,8 per cento), la Spagna ( 2 per cento), il Belgio (4,3 per cento), i Paesi
Bassi (5,2 per cento) e l’Irlanda (40 per cento).
Con riferimento agli aiuti pubblici alle banche, si rileva che
il DL n. 95 del 2012, articoli da 23-sexies a 23-duodecies, ha previsto la
sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari emessi da Banca Monte
dei Paschi di Siena. Successivamente lo schema di decreto del presidente del
Consiglio, presentato alle Camere per il parere (Atto del Governo n. 525) e a
tutt’oggi non ancora definitivamente pubblicato, ha previsto l’emissione di
titoli di debito pubblico in misura pari a 2 miliardi ai fini del finanziamento
della suddetta sottoscrizione. La relazione tecnica allegata al provvedimento
precisava che la sottoscrizione, configurandosi come operazione di carattere
finanziario, non incide sul saldo di indebitamento netto, fatti salvi gli
effetti in termini di interessi, ma incide oltre che sul fabbisogno e sul
debito, anche “sulle spese finali del SNF”, senza tuttavia iscrivere effetti ai
fini di tale ultimo saldo.
Con riferimento alla diposizione richiamata, il DEF afferma
che, anche incorporando gli interventi già decisi per MPS , il sostegno
pubblico complessivo alle banche italiane rimane molto contenuto nel confronto
internazionale.
Il Documento sottolinea, pertanto, la solidità complessiva
del sistema bancario italiano, dovuta ad un’esposizione contenuta verso
attività rischiose e a un valore ridotto della leva finanziaria rispetto alla
media europea.
Al riguardo, la Banca d’Italia
rileva come la congiuntura sfavorevole si è ripercossa sulla redditività degli
intermediari italiani, ma il loro assetto patrimoniale è rimasto solido. La
raccolta al dettaglio delle banche italiane si conferma robusta; si sono
attenuate, ancorché non completamente riassorbite, le difficoltà per la
raccolta sui mercati internazionali. È proseguita, tuttavia, la flessione dei
prestiti bancari al settore privato non finanziario: nei tre mesi terminanti in
febbraio sono diminuiti dell’1,4 per cento (in ragione d’anno, al netto dei
fattori stagionali e dell’effetto contabile delle cartolarizzazioni). Si sono
contratti dell’1,8 per cento i prestiti alle imprese, dell’1,0 quelli alle
famiglie.
Secondo
quanto affermato dall’Istituto, l’elevata incertezza sulle prospettive
economiche continua a influenzare sia la domanda sia l’offerta di credito. Le
richieste di finanziamenti da parte di imprese e famiglie risentono in
particolare del calo degli investimenti e del pessimismo sulle prospettive del
mercato immobiliare. L’indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey)
relativa al quarto trimestre del 2012 indicava il permanere di tensioni dal
lato dell’offerta, seppur in lieve attenuazione rispetto al trimestre
precedente; le inchieste presso le imprese segnalano che nei primi mesi del
2013 le difficoltà di accesso al credito si sono mantenute elevate.
Il debito privato
Con riferimento all’indebitamento del settore privato, il
DEF afferma che livelli eccessivi di tale indicatore potrebbero dar luogo ad
instabilità macroeconomica nel caso in cui il settore si trovasse costretto a
ridurre rapidamente l’indebitamento. Tuttavia, l’Italia non presenta valori
critici; i flussi di credito sono ampiamente nella norma e il livello dell’indebitamento
del settore presenta dimensioni molto contenute rispetto alla media europea.
Il Documento precisa, inoltre, che il portafoglio delle famiglie
italiane presenta una struttura equilibrata in quanto caratterizzata da un
elevato livello di attività (rispetto al reddito disponibile) di cui quelle ad
alto rischio rappresentano una quota contenuta.
Il DEF precisa che le attività finanziarie delle famiglie sono
costituite per il 50 per cento da depositi e riserve assicurative e
previdenziali e per il 20 per cento da obbligazioni principalmente bancarie e
pubbliche. La quota restante è quasi interamente investita in azioni,
partecipazioni e fondi comuni.
Secondo i dati diffusi da Banca d’Italia,
nel quarto trimestre del 2012 il debito delle famiglie è rimasto pressoché
invariato; l’incidenza sul reddito disponibile è tuttavia cresciuta di 0,5
punti percentuali, al 65,7 per cento, a causa del calo di quest’ultimo. Gli
oneri sostenuti per il servizio del debito (pagamento di interessi e
restituzione del capitale) sono diminuiti di tre decimi di punto, al 9,8 per
cento del reddito disponibile. Nella media del trimestre è proseguita la
flessione, avviatasi nel marzo del 2012, dei tassi sui nuovi prestiti per
l’acquisto di abitazioni e di quelli sul credito al consumo; la riduzione si è
tuttavia arrestata a gennaio del 2013.
L’Istituto evidenzia, peraltro, che
a fronte del livello relativamente contenuto dell’indebitamento e del basso
costo del denaro, il principale rischio per le condizioni finanziarie delle
famiglie è tuttora rappresentato dalla debole dinamica del reddito, che
potrebbe rendere gravoso il servizio del debito, in particolare per le famiglie
vulnerabili. In prospettiva, tensioni potranno derivare da un aumento dei tassi
di mercato, qualora esso non fosse associato a una sostenuta ripresa
dell’attività economica.
Con riferimento alle imprese non finanziarie, il DEF
afferma che il livello di indebitamento risulta sostanzialmente in linea con la
media europea, tuttavia i prestiti contratti nei confronti delle banche
rappresentano una percentuale più alta rispetto al benchmark europeo.
L’accentuata esposizione crea in alcuni csi problemi di redditività e nella
fase attuale della congiuntura rende le imprese più vulnerabili verso
situazioni di restrizione del credito.
Peraltro la Banca d’Italia rileva una contrazione
dei prestiti bancari alle imprese non finanziarie, con particolare riferimento
a quelle di piccole dimensioni. L’Istituto indica che lo stock di debito
complessivo delle imprese è rimasto di poco sotto l’80 per cento del PIL, un
valore inferiore di circa 20 punti percentuali rispetto a quello medio
dell’area dell’euro.
Garanzie concesse dallo
Stato
Con particolare riferimento alle garanzie concesse dallo
Stato sia su attività finanziarie che non finanziarie (grandi opere,
imprenditoria, etc.), il DEF indica che, al 31
dicembre 2012, esse sono ammontate a circa 100 miliardi, pari al 6,4 per cento
del PIL, di cui quelle concesse ad istituti di credito in seguito alla recente
crisi finanziaria hanno raggiunto 85,7 miliardi, pari al 5,5 per cento del PIL.
|
Garanzie
pubbliche (in milioni di euro) - 2012
|
|
|
Livello
|
in
% di PIL
|
|
Stock
garanzie
|
100.025
|
6,4
|
|
di
cui: settore finanziario
|
85.679
|
5,5
|
|
Fonte: PdS 2013
|
All’ammontare complessivo hanno contribuito le seguenti
componenti:
- Fondo
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. E’ uno strumento di
politica industriale del Ministero dello Sviluppo Economico che opera
attraverso tre distinte modalità di intervento: garanzia diretta, concessa alle
banche e agli intermediari finanziari; controgaranzia su operazioni di garanzia
concesse da Confidi e altri fondi di garanzia; cogaranzia concessa direttamente
a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e altri fondi di
garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’UE o da essa
cofinanziati. Al 31 dicembre 2012, il debito residuo complessivo garantito
risulta pari a 8.318 milioni di euro.
-
TAV S.p.A.. Il Ministero del Tesoro garantisce l’adempimento
degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti della
TAV S.p.a., in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema
Alta Velocità. Si tratta di una garanzia fideiussoria di diritto finalizzata a
rendere possibile il reperimento sul mercato delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione della rete ad alta velocità. Al 31 dicembre 2012,
il debito residuo garantito risulta pari a circa 2.278 milioni.
- Aiuti
al salvataggio delle imprese. Tali aiuti comprendono le garanzie concesse
dallo Stato alle imprese a fronte di debiti contratti con istituzioni
creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione
e il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. Al 31
dicembre 2012, il debito residuo garantito risulta pari a circa 64,7 milioni
- Garanzie
assunte dalle amministrazioni locali. I dati relativi alle garanzie
prestate dagli Enti Locali sono forniti dalla Banca d’Italia, che li rileva
attraverso le informazioni trasmesse, per mezzo delle segnalazioni di
vigilanza, direttamente dagli istituti finanziari che ne beneficiano. Al 31
dicembre 2012, il debito residuo garantito risulta pari a 3.687 milioni.
-
Banche italiane. Tali garanzie sono concesse dallo Stato
sulle passività delle banche italiane relativamente ai titoli obbligazionari
emessi dagli istituti di credito. Al 31 dicembre 2012, il debito residuo
garantito risulta pari a 85.679 milioni.
5. Analisi speciali
Il Documento di economia e finanza 2013 fornisce un'analisi
di sensitività delle previsioni programmatiche dei principali indicatori di
finanza pubblica (scenario di base) rispetto ad ipotesi alternative circa la
dinamica futura della crescita economica e dei tassi di interesse considerate
come fattori determinati esogenamente rispetto al quadro di finanza pubblica.
Per analizzare la sensitività della finanza pubblica alla
crescita economica nel periodo 2013-2017
sono stati considerati due scenari macroeconomici alternativi, uno ottimistico
- di alta crescita - e l'altro pessimistico - di bassa crescita. In entrambi i
casi lo scostamento annuo del tasso di crescita del PIL reale rispetto a quello
dello scenario di base è di 0,5 punti percentuali.
Le
alternative ipotesi di crescita influenzano la dinamica del PIL potenziale e
dell'output gap. Conseguentemente ne risulta modificato l’avanzo
primario sia nella parte strutturale che nella componente ciclica. A sua volta
il diverso andamento degli avanzi primari si riflette sull'andamento del
debito, conseguentemente, della spesa per interessi. Nella derivazione del
rapporto debito/PIL, si assume che il tasso di interesse implicito e lo stockflow
adjustment negli scenari alternativi non cambino rispetto allo scenario
base.
La
tabella 5.1 riporta l'andamento del tasso di crescita reale nei tre scenari
(base, ottimistico e pessimistico). Le tabelle 5.2 e 5.4, invece, mostrano i
risultati delle simulazioni rispettivamente per l'indebitamento netto e per il
rapporto debito/PIL. Le tabelle 5.3 e 5.5, infine, mostrano le differenze dei
valori simulati rispetto a quelli dello scenario base.
Tabella 5.1
Ipotesi alternative di crescita del PIL
reale (in
% del PIL)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Scenario di maggiore crescita
|
-2,4
|
-0,8
|
1,8
|
2,0
|
1,8
|
1,9
|
|
Scenario di base
|
-2,4
|
-1,3
|
1,3
|
1,5
|
1,3
|
1,4
|
|
Scenario di minore crescita
|
-2,4
|
-1,8
|
0,8
|
1,0
|
0,8
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: DEF 2013.
Tabella 5.2
Sensitività dell'indebitamento netto alla
crescita. Anni 2012-2017 (in % del PIL)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Scenario di maggiore crescita
|
-3,0
|
-2,6
|
-1,3
|
-0,9
|
0,1
|
0,8
|
|
Scenario di base
|
-3,0
|
-2,9
|
-1,8
|
-1,5
|
-0,9
|
-0,4
|
|
Scenario di minore crescita
|
-3,0
|
-3,1
|
-2,2
|
-2,3
|
-1,7
|
-1,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: DEF 2013.
Tabella 5.3
Variazioni
dell'indebitamento netto tra gli scenari alternativi e quello di base (in
% del PIL)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Scenario di maggiore crescita
|
0,0
|
0,3
|
0,5
|
0,6
|
1,0
|
1,2
|
|
Scenario di minore crescita
|
0,0
|
-0,2
|
-0,4
|
-0,8
|
-0,8
|
-1,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: elaborazioni su DEF 2013.
Nello
scenario di minore crescita si avrebbe un aumento medio annuo di 0,7 punti
percentuali di PIL, mentre nello scenario di maggiore crescita la simulazione
mostra una riduzione media dell'indebitamento pari ancora a 0,7 punti
percentuali.
La
corrispondenza - in valore assoluto ma con segno opposto - della variazione
media dell'indebitamento netto nei due scenari alternativi rispetto a quello di
base è spiegabile con la simmetria della variazione del tasso di crescita del
PIL reale ipotizzata nei due scenari e con le caratteristiche di calcolo dei
valori simulati (invariato rispetto alle condizioni del ciclo economico). Un
meccanismo di simulazione più realistico, ma indubbiamente più complicato da
applicare, potrebbe utilmente differenziarsi in fasi di espansione
dell'economia rispetto alle fasi di contrazione.
La
differenza massima delle simulazioni rispetto allo scenario di base si avrebbe
in entrambi gli scenari nel 2017 allorché l'indebitamento netto migliorerebbe
di 1,2 punti percentuali di PIL nello scenario di crescita più favorevole
mentre peggiorerebbe di 1,1 punti in quello sfavorevole. Nello scenario di
maggiore crescita si raggiungerebbe un saldo positivo - accreditamento netto -
a partire dal 2016.
Tabella 5.4
Sensitività del rapporto debito/PIL alla
crescita. Anni 2012-2017 (in % del
PIL)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Scenario di maggiore crescita
|
127,0
|
129,5
|
126,9
|
122,1
|
116,5
|
110,5
|
|
Scenario di base
|
127,0
|
130,4
|
129,0
|
125,5
|
121,4
|
117,3
|
|
Scenario di minore crescita
|
127,0
|
131,3
|
131,0
|
129,0
|
126,5
|
124,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: DEF 2013.
Tabella 5.5
Variazioni del rapporto debito/PIL tra
gli scenari alternativi e quello di base (in % del PIL)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Scenario di maggiore crescita
|
0,0
|
-0,9
|
-2,1
|
-3,4
|
-4,9
|
-6,8
|
|
Scenario di minore crescita
|
0,0
|
0,9
|
2,0
|
3,5
|
5,1
|
6,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: elaborazioni su DEF 2013.
Per
quanto riguarda il rapporto debito/PIL, le tabelle 5.4 e 5.5 mostrano che la
differenza media delle simulazioni rispetto allo scenario base equivale nei due
scenari alternativi ed è pari a 3,6 punti percentuali in valore assoluto. In
particolare, nello scenario di maggiore crescita la diminuzione del rapporto va
da 0,9 punti percentuali nel 2009 a 6,8 punti nel 2017. La simulazione nel caso
di crescita ridotta mostra una dinamica quasi identica per le stesse
motivazioni rappresentate sopra in riferimento all'indebitamento netto.
E'
bene ricordare che tali esercizi di simulazione mostrano una serie di
limitazioni che inducono cautela nella valutazione dei risultati.
L'elemento più problematico, in particolare, riguarda l'ipotesi di invarianza
dei tassi di interesse impliciti che risulta poco realistica in presenza di
variazioni del tasso di crescita del PIL reale che può influenzare i tassi di
interesse attraverso una diversa percezione del rischio legato ai titoli del
debito pubblico da parte dei mercati finanziari.
Sarebbe,
inoltre, utile ottenere dal Governo una valutazione circa il rispetto delle
regole della spesa e del debito nei due scenari macroeconomici alternativi.
L'analisi di sensitività del debito pubblico all'andamento
dei tassi di interesse viene condotta nel DEF stimando l’impatto di potenziali
variazioni della curva dei rendimenti che influenzino il costo all’emissione
dei titoli del debito pubblico sul mercato primario.
I risultati si basano sull'attuale e futura composizione
dello stock dei titoli di Stato negoziabili che a fine dicembre 2012 si
componeva di titoli domestici, ossia emessi sul mercato interno, per il 96,32
per cento, e di titoli esteri, ossia emessi sui mercati esteri, sia in euro che
in valuta, per il 3,68 per cento.
L'analisi indica che a un aumento istantaneo e permanente di
un punto percentuale della curva dei rendimenti sui titoli di Stato comporta un
aumento dell'onere del debito di 0,15 punti percentuali di PIL nel primo anno,
0,33 nel secondo e 0,46 nel terzo. La trasmissione di questa variazione
dell'onere sul costo del debito avviene interamente dopo 5,51 anni. Tali valori
sono inferiori per i primi due anni rispetto a quelli stimati nel DEF del 2012
a causa di un minor ricorso all'emissione della componente del debito legata
alle fluttuazioni dei tassi (BOT e CCTeu) nonché di un minore attività di
indebitamento complessiva dovuta a minori scadenze e un ridotto fabbisogno del
Settore statale.
L’aggiornamento del Programma di stabilità 2013 reca
un’analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche
nel lungo periodo: essa tiene conto degli effetti sulla spesa e sulla dinamica
del debito del progressivo invecchiamento della popolazione, alla luce di
diverse ipotesi circa il quadro macroeconomico e di finanza pubblica di
riferimento.
Il PdS presenta, quindi, una proiezione della spesa pubblica
in Italia, per pensioni, sanità, assistenza agli anziani, istruzione e
indennità di disoccupazione, nonché il dettaglio delle ipotesi demografiche e macroeconomiche
di riferimento.
Da tali analisi emerge come, grazie alle riforme
implementate negli ultimi venti anni, le spese legate all’invecchiamento
risultino essere sotto controllo.
Sono poi presentate delle simulazioni sulla dinamica del
debito, basate su ipotesi alternative, rispetto allo scenario di riferimento,
riguardanti sia le principali variabili macroeconomiche, che il livello di
avanzo primario strutturale.
Con riguardo a tale saldo, i risultati delle simulazioni
evidenziano come la dinamica del debito si modifichi significativamente a
seguito della variazione dell’avanzo primario rispetto al valore programmatico
inglobato nello scenario di base (+5,7 nel 2017 in termini nominali).
Per un livello inferiore, pari al 3,7 per cento, il debito continua a diminuire
ma varca la soglia del 60 per cento del PIL solo nel 2035. Un avanzo primario
pari al 2,7 per cento nel 2017 non stabilizzerebbe il debito al 60 per cento
nel lungo periodo.
Le proiezioni della spesa pubblica contenute nella Tabella
V.1 del Programma di stabilità (PdS), recepiscono – secondo quanto specificato
dal documento - le ipotesi dello scenario baseline concordato in sede
europea, con alcune modifiche. Queste sono dirette ad
aggiornare i dati iniziali per tener conto dei risultati 2011-2012 e del quadro
normativo in vigore ad aprile 2013. Per il periodo
2013-2017 le previsioni recepiscono il quadro di finanza pubblica e le ipotesi
di crescita previste nel DEF.
Come evidenziato dalla Tabella V.1 del PdS, negli anni
successivi al 2010 le spese legate all’invecchiamento della popolazione in
rapporto al PIL si riducono, per poi aumentare nuovamente a partire dal 2035 fino
al 2050, riflettendo l’andamento della spesa previdenziale in corrispondenza
del pensionamento della generazione del c.d. baby boom. Alla fine
dell’orizzonte di previsione, la spesa age-related tende a ridursi e a
convergere (in termini di rapporto con il PIL) sui livelli del 2010 (28,2 per
cento).
Sulla base delle ipotesi relative all’evoluzione delle
variabili demografiche e macroeconomiche e delle proiezioni delle
spese legate all’invecchiamento, l’analisi di sostenibilità della finanza
pubblica è condotta nel documento attraverso la proiezione del rapporto
debito/PIL nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2060 ed attraverso il
calcolo di indicatori sintetici di sostenibilità (i sustainability gaps
indicati con S1 e S2 ed il required primary bilance indicato
con RPB).
La simulazione si basa, inoltre, sui seguenti parametri:
·
livelli del rapporto debito/PIL e dell’avanzo primario
strutturale corrispondenti a quelli indicati dal Governo per l’anno 2017 pari,
rispettivamente, al 117,3 ed al 6,1 per cento del PIL;
·
tasso di interesse reale costante per tutto il periodo di
riferimento e pari al 3 per cento. Ipotizzando che il deflatore PIL converga al
2 per cento nel triennio successivo al 2017, il tasso di interesse nominale si
colloca al 5 per cento dal 2020 ;
·
variazione dell’avanzo primario strutturale per effetto delle
(sole) variazioni delle spese correlate all’invecchiamento della popolazione e
dei redditi proprietari
I risultati della simulazione mostrano un andamento del
rapporto debito/PIL costantemente decrescente nel periodo di riferimento. Nonostante
un livello iniziale del rapporto debito/PIL più elevato rispetto alla
precedente simulazione, grazie ad un avanzo
primario strutturale consistente il rapporto si colloca sotto la soglia del 60
per cento del prodotto nel 2027, con (solo) due anni in ritardo rispetto al
risultato dell’analoga simulazione condotta nell’aggiornamento 2012 del
Programma di stabilità (v. grafico V.1, tratto dal PdS).
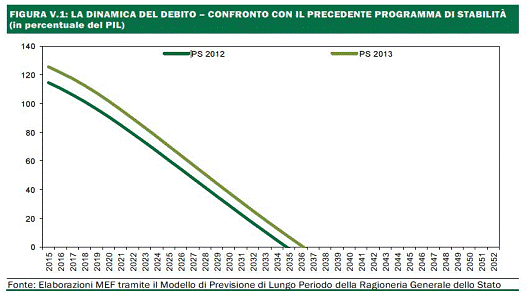
Come si è detto, una indicazione della dimensione degli
squilibri eventualmente presenti nei conti pubblici, è fornita dagli indicatori
S1 e S2, i quali misurano l'ampiezza dell'aggiustamento fiscale permanente,
in termini di saldo primario strutturale, necessario per raggiungere:
1.
l'obiettivo debito/PIL del 60 per cento nel 2030 (S1);
2.
l'obiettivo del vincolo intertemporale su un orizzonte infinito (S2).
La metodologia di calcolo dell’indicatore S1
è stata recentemente modificata dalla Commissione europea:
l’obiettivo del debito al 60 per cento del PIL è stato anticipato al 2030
(rispetto al precedente termine del 2060); dato il maggiore sforzo richiesto
per conseguire prima il raggiungimento di tale soglia, si prevede la
possibilità di non compiere l’intero aggiustamento fiscale immediatamente, ma
di procedere gradualmente (in modo lineare) tra il 2018 e il 2020, per poi
mantenere il livello di avanzo primario raggiunto nei successivi 10 anni.
E' possibile scomporre gli indicatori S1 ed S2
nelle loro rispettive componenti, al fine di valutare se i rischi alla
sostenibilità provengono dalla posizione fiscale corrente (saldo primario
strutturale e stock di debito) e/o anche dal progressivo invecchiamento
della popolazione.
La posizione fiscale iniziale (initial budget position)
misura la distanza tra l'avanzo primario strutturale alla fine del periodo
coperto dal Programma di stabilità (6,1 per cento del PIL) e quello in grado di
mantenere costante il rapporto debito/PIL al livello iniziale, coeteris
paribus. Esso indica, quindi, se
le finanze sono sostenibili, considerando esclusivamente la posizione fiscale
corrente.
Questa componente, per quanto riguarda S1, include il “costo” del ritardo dell’aggiustamento,
in quanto si ipotizza che l’avanzo primario aumenti in modo graduale fino al
2020, per poi stabilizzarsi al livello raggiunto.
La seconda componente, la condizione sul debito (debt
requirement) al 2030, è specifica dell'indicatore S1 ed
evidenzia l'aggiustamento necessario per portare il debito dal livello iniziale
al 60 per cento nel PIL entro tale anno.
La terza componente, l'impatto di lungo periodo sul saldo
primario (long-term changes in the primary balance), quantifica
l'impatto dell'invecchiamento della popolazione sul bilancio, prevedendo un
ulteriore aggiustamento per fare fronte all'aumento delle spese connesse con
tale fenomeno.
S1 e S2 sono dati dalla somma
algebrica delle rispettive componenti. Valori positivi di S1 e S2
indicano la necessità di uno sforzo di aggiustamento permanente per soddisfare
l’una o l'altra delle condizioni, tanto maggiore quanto maggiore è la grandezza
assunta dagli indicatori. Valori negativi indicano, invece, che la
sostenibilità di lungo periodo non richiede sforzi addizionali permanenti
(ulteriori, cioè, rispetto a quelli richiesti dal raggiungimento degli
obiettivi programmatici contenuti nel documento presentato dal Governo).
Un terzo indicatore utilizzato in tali analisi è l'avanzo
primario necessario (required primary balance, RPB), che indica
l'avanzo primario strutturale medio nei primi 5 anni del periodo di proiezione
coerente con l'aggiustamento suggerito da S2.
Come si evince dalla Tavola 1, tratta dall'aggiornamento
2013 del Programma di Stabilità, il consolidamento previsto è sufficiente ad
assicurare finanze pubbliche sostenibili nel lungo periodo, tenuto conto
dell'invecchiamento della popolazione. Gli indicatori sintetici S1
ed S2 assumono, infatti, valori negativi.
Tale conclusione è confermata osservando l'avanzo primario
necessario (RPB) che, con un valore pari a +2,3 per cento è sensibilmente
inferiore all'avanzo primario strutturale previsto alla fine del periodo
coperto dal Programma di stabilità (+6,1 per cento nel 2017).
Tabella
5.6
Indicatori di sostenibilità di
lungo periodo
|
|
S1
|
S2
|
RPB
|
|
Valore
|
-1,7
|
-4,5
|
2,3
|
|
di cui
|
|
|
|
|
Posizione fiscale iniziale
|
-4,9
|
-4,8
|
|
|
Condizione sul debito nel 2030
|
4,1
|
|
|
|
Impatto di lungo
periodo sul saldo primario
|
0,9
|
0,3
|
|
|
N.B. L’impatto di lungo periodo sul
saldo primario riflette il cost of ageing: esso entra nella formula
dell’indicatore S1 con segno negativo, mentre in S2 con
segno positivo
(Per la metodologia, v. Fiscal
Sustainibility Report 2012, European economy n. 8/2012)
Fonte:
Aggiornamento 2013 del Programma di stabilità
|
I risultati ottenuti dall’analisi di sostenibilità delle
finanze pubbliche in termini di dinamica di lungo periodo del rapporto
debito/PIL e di indicatori sintetici mostrano come la tenuta degli obiettivi
programmatici indicati a tutto il 2017 sia in grado di garantire
contestualmente, nello scenario macroeconomico ipotizzato, la copertura delle
spese connesse all’invecchiamento della popolazione ed il raggiungimento del
valore obiettivo del rapporto debito/PIL nel periodo di riferimento.
Nel documento in esame tali esiti sono sottoposti ad un test
di sensitività, che consiste nell’introdurre modifiche permanenti delle ipotesi
assunte nello scenario di base, riguardanti la variazione di parametri sia di
natura macroeconomica (dinamica dei flussi migratori e di altre variabili demografiche,
andamento della produttività del lavoro, dell’occupazione e del tasso attività
degli anziani e delle donne), sia di finanza pubblica (saldo primario).
Rispetto alle precedenti simulazioni, si verifica anche l’effetto sul baseline
di una diversa dinamica della spesa per sanità e assistenza agli anziani e ai
disabili a lungo termine (LTC).
Tali analisi hanno la finalità di verificare l’affidabilità
dei risultati dello scenario di riferimento a fronte dell’incertezza che
caratterizza proiezioni macroeconomiche e demografiche di lungo periodo e di
indicare in quale misura eventuali interventi di riforma, ovvero l’adozione di
misure strutturali di bilancio, possano agire sulla sostenibilità del debito.
Con riferimento al primo gruppo di variabili, si rileva in
premessa come l’Italia sia il paese europeo con il più elevato tasso di
invecchiamento della popolazione, e con un indice di dipendenza degli anziani
destinato a raddoppiare nel lungo periodo (da un valore del 33,3 per cento nel
2010 al 61,6 per cento nel 2060).
Si sono pertanto valutati gli effetti di una diminuzione del
10 per cento medio annuo dei flussi migratori (-31.000 unità rispetto al
flusso scontato nello scenario di base), mantenendo tuttavia la stessa
composizione per età e genere dello scenario di riferimento. Le conseguenze sul
debito di tali variazioni, così come quelle relative all’allungamento di 1 anno
nella speranza di vita alla nascita appaiono trascurabili. In tutti gli
scenari, il rapporto debito/PIL si riduce velocemente e scende sotto la soglia
del 60 per cento intorno al 2030.
Riguardo alla produttività del lavoro, la simulazione
prevede uno scenario alternativo nel quale, a partire dal 2025, tale variabile
sia permanentemente superiore (o inferiore), rispetto allo scenario di base, di
0,1 punti percentuali: anche in questo caso gli effetti sulla dinamica del
debito appaiono trascurabili sia nel medio che nel lungo periodo.
Un graduale aumento del tasso di occupazione della
popolazione 15-64 anni, fino a raggiungere 1 punto più elevato al 2060, ha
effetti marginali. Determina, invece, effetti più significativi sulle
proiezioni del rapporto debito/PIL, già a partire dal 2020, un aumento del tasso
di attività dei lavoratori anziani tale da raggiungere nel 2060 un
incremento di 5 punti rispetto allo scenario di base. Effetti solo nel medio-lungo
periodo derivano da un aumento della partecipazione femminile di 5 punti
rispetto all’ipotesi base.
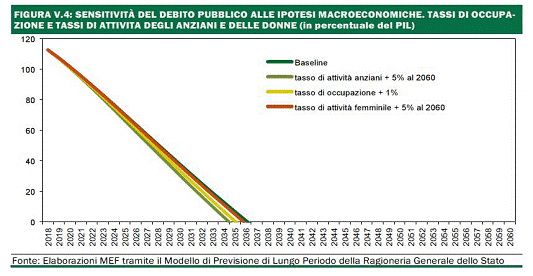
Tali risultati mostrano come l’adozione di riforme
strutturali suscettibili di determinare nel medio periodo aumenti del tasso di
partecipazione al mercato del lavoro di soggetti attualmente esclusi,
potrebbero migliorare, a parità di altre condizioni, la sostenibilità di lungo
periodo delle finanze pubbliche.
Il PdS 2013 introduce una nuova analisi di sensitività
relativa alle spese sanitarie legate all’invecchiamento della
popolazione, in cui si testano gli effetti sull’evoluzione del debito di una
dinamica della spesa sanitaria e per assistenza agli anziani e disabili di
lungo periodo (LTC), derivanti da ipotesi (relative a fattori non
demografici) più stringenti rispetto allo scenario di base. Anche in questo
caso gli scostamenti (che peggiorano l’evoluzione del rapporto debito/PIL)
hanno una rilevanza limitata: il rapporto scende al di sotto della soglia del
60 per cento nel 2027.
Per quanto riguarda le variabili di finanza pubblica, si
ipotizzano variazioni del livello dell’avanzo primario nominale in
termini di PIL rispetto al valore assunto nello scenario base nel 2017 e
mantenuto per tutto il periodo di previsione, coincidente con il 5,7 per cento
indicato dal Governo. I valori del saldo sono ridotti via via di 1 punto
percentuale scendendo fino ad un saldo pari +2,7 per cento.
I risultati mostrano (v. grafico V.6 tratto dal PdS)
che per un livello iniziale pari al 3,7 per cento il rapporto debito/PIL
decresce, ma raggiunge la soglia obiettivo solo nel 2035 (rispetto al 2027
dello scenario base). Per valori dell’avanzo primario pari al 2,7 per cento,
nel lungo periodo il debito si stabilizzerebbe al 60 per cento del PIL.
Il Documento reca, infine, una specifica analisi riguarda
l’impatto delle riforme pensionistiche sulla sostenibilità del debito.
Come evidenziato grafico V.7, tratto dal PdS, la serie di riforme
previdenziali che si sono susseguite dal 2004 ad oggi hanno reso compatibile la
dinamica di lungo periodo delle spese age-related con la sostenibilità
del debito pubblico italiano.
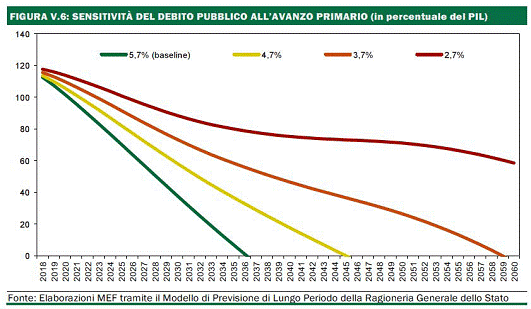
I risultati mostrano che nello scenario che sconta l’assenza
delle riforme adottate da 2004, il rapporto debito/PIL continuerebbe a ridursi,
ma si attesterebbe su livelli permanentemente più alti rispetto a quelli dello
scenario di riferimento, che invece incorpora gli effetti finanziari della
riforma adottata con la legge 214/2011.
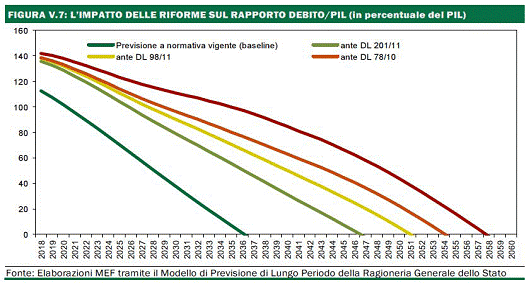
Approfondimento
4 Avanzo primario strutturale e ciclo economico:
l’analisi della fiscal stance
Il confronto tra l’andamento
dell’avanzo primario strutturale (cioè il saldo primario corretto per il ciclo
e al netto delle una tantum) e l’output gap, che evidenzia
la distanza tra il PIL effettivo ed il potenziale di crescita dell’economia,
consente un’analisi della fiscal stance: questa misura l’indirizzo
espansivo o restrittivo della politica fiscale a fronte dell’andamento
macroeconomico.
Le variabili utilizzate per l’analisi della finanza pubblica corretta
per il ciclo: alcuni elementi definitori
Il PIL
potenziale rappresenta il livello teorico massimo di produzione che un
paese può raggiungere senza causare tensioni inflazionistiche. Esso esprime,
pertanto, i fondamentali dell’economia e la componente strutturale della
crescita, cui si confronta l’andamento registrato in un determinato momento del
ciclo economico. Il PIL potenziale non è direttamente osservabile, ma risulta,
secondo la metodologia approvata dall’Ecofin e utilizzata dagli Stati membri
per il calcolo degli indicatori strutturali richiesti dal Programmi di
stabilità, dalla stima statistica prodotta utilizzando sia i valori
effettivamente registrati a consuntivo negli anni precedenti, sia il valore del
PIL atteso nel periodo di previsione. Da ciò derivano due conseguenze: i)
difficilmente il calcolo del PIL potenziale è in grado di cogliere appieno i
punti di inversione del ciclo e gli effetti di cambiamenti strutturali; ii) la
variazione del valore atteso del PIL per il periodo di previsione o le
modifiche riguardanti i dati di consuntivo (conseguenti anche a revisioni
contabili) determinano una revisione del PIL potenziale, e quindi dell’output
gap, anche negli anni in cui non si è verificata alcuna variazione nella
crescita effettiva (o attesa). A parità di parametro relativo alla sensibilità
del bilancio al ciclo e di valore nominale dell’indebitamento netto o del saldo
primario effettivo (o atteso), si verifica pertanto una variazione nel saldo
strutturale.
La deviazione del PIL
effettivo rispetto al valore potenziale è rappresentato dall’output
gap (pari alla differenza in livello tra PIL effettivo e PIL
potenziale, rapportata al PIL potenziale).
Il prodotto tra l’output
gap e la stima della sensibilità al ciclo delle entrate e delle spese
correnti costituisce la componente ciclica del saldo di bilancio. La
sensibilità del saldo di bilancio all’andamento del PIL è un parametro, il cui
valore, individuato sulla base degli andamenti registrati nell’arco di un
decennio, viene periodicamente aggiornato in sede europea; esso è attualmente
pari per l’Italia a 0,55, quale somma delle elasticità delle entrate e delle
spese.
Per ottenere il saldo
strutturale (l’indebitamento netto o il saldo primario), occorre in primo luogo
depurare il saldo nominale dalla sua componente ciclica: se negativa, tale
componente migliora il saldo in termini strutturali; viceversa in caso di
componente ciclica positiva.
Il saldo corretto per il ciclo
va poi depurato delle misure una tantum (cfr infra), sottraendo
sia le entrate che le spese identificate come straordinarie: in caso di prevalenza
delle prime sulle seconde il saldo strutturale risulterà peggiore del saldo
corretto per il solo ciclo, viceversa in caso di prevalenza delle spese sulle
entrate.
Le variabili utilizzate
nell’analisi grafica sono riportate nella Tavola 1.
Tabella 1
Output gap e avanzo primario programmatico,
corretto per il ciclo al netto delle una tantum
(% PIL)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Output
gap
|
-3,6
|
-4,8
|
-3,8
|
-2,6
|
-1,7
|
-0,8
|
|
variazioni
output gap
|
-1,8
|
-1,2
|
1,0
|
1,2
|
0,9
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avanzo
primario strutturale
|
4,4
|
5,3
|
6,0
|
5,8
|
6,0
|
6,1
|
|
Variazioni
avanzo primario strutturale
|
2,9
|
0,9
|
0,7
|
-0,2
|
0,2
|
0,1
|
|
N.B. La variabile relativa all’avanzo primario fa
riferimento al quadro programmatico
Fonte: PdS 2013, Tavola
III.8
|
Il Grafico 1 confronta la
variazione dell’avanzo primario strutturale con l’output gap nel periodo
2012-2017. Esso si compone di quattro quadranti. Quello in alto a sinistra
contiene i punti che rappresentano situazioni di restrizione fiscale e di ciclo
economico negativo. In basso a sinistra, si posizionano le combinazioni di
manovre espansive e ciclo economico negativo. I due quadranti a destra,
corrispondenti a situazioni economiche favorevoli, illustrano, quello in alto,
una politica fiscale restrittiva, quello in basso, una politica fiscale
espansiva.
Secondo la teoria economica,
la politica fiscale dovrebbe svolgere una funzione di stabilizzazione e avere
pertanto un carattere anticiclico, attraverso l’adozione di misure di
consolidamento fiscale nella fasi positive del ciclo e viceversa nelle fasi
recessive.
In base alle regole europee,
invece, solo gli Stati membri che abbiano già raggiunto l’obiettivo di medio
termine e che presentino pertanto un bilancio pubblico in pareggio strutturale possono
lasciare operare liberamente gli stabilizzatori automatici (in termini del
Grafico 1, ciò implica che tali Paesi si trovino sull’asse orizzontale che
rappresenta una stance neutrale), o eventualmente adottare misure
discrezionali per contenere le fluttuazioni cicliche, nei limiti del rispetto del
loro obiettivo di medio termine (OMT).
Ai Paesi che non abbiano
raggiunto il pareggio di bilancio sono richiesti, invece, aggiustamenti annui
in termini di aumento dell’avanzo primario strutturale pari o superiori allo
0,5 per cento. Essi dovrebbero pertanto trovarsi in punti situati nei due
quadranti superiori del Grafico, corrispondenti a politiche fiscali
restrittive.
Per l’Italia, l’obiettivo di
medio termine (OMT) è fissato nel pareggio di bilancio in termini strutturali,
da raggiungere entro il 2013.
Grafico 1
Fiscal stance e output gap, DEF- PdS 2013
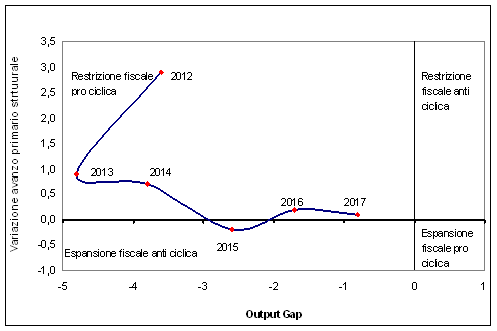
Il Grafico 1 evidenzia come,
nel 2012 e 2013, la politica fiscale abbia un’impronta restrittiva: in presenza
di un output gap che accentua la sua connotazione negativa, l’avanzo
primario aumenta, sia pure con ritmi annui diversi (rispettivamente, + 2,9
punti di PIL nel primo anno e +0,9 punti nel secondo), consentendo di
raggiungere il pareggio di bilancio in termini strutturali nell’esercizio in
corso. Dopo un’ulteriore variazione positiva (+0,7) nel 2014, l’avanzo tende a
stabilizzarsi nel triennio successivo intorno ad una valore del 6 per cento.
Un secondo metodo per
valutare la fiscal stance mette in relazione le variazioni dell'output
gap, con le variazioni dell'avanzo primario strutturale. Un simile
approccio permette di porre maggiore enfasi sulla dinamica del ciclo economico
e di cogliere in modo più puntuale i cambiamenti della politica fiscale.
Grafico 2
Fiscal stance e variazione
dell’output gap, DEF - PdS 2013
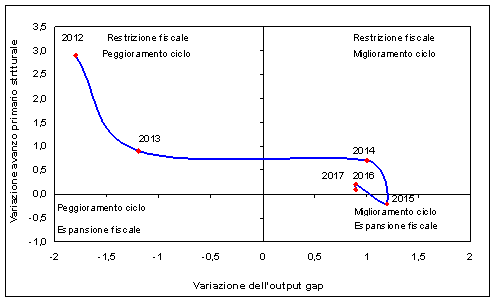
Nel Grafico 2 si nota come,
all’inizio del periodo in esame (2012 e 2013), la restrizione fiscale si
collochi in una fase di forte peggioramento del ciclo (l’output gap
aumenta il proprio valore negativo di 1,8 punti di PIL nel primo anno e di 1,2
punti nel secondo). Nel 2014 il consolidamento fiscale (indicato da variazioni
positive, anche se più contenute, dell’avanzo primario) prosegue in presenza di
un output gap ancora negativo ma che tende a chiudersi.
Nel triennio successivo, a fronte di un output gap che si riduce
ulteriormente e di un livello elevato di avanzo primario (intorno al 6 per
cento del PIL), la politica fiscale tende ad essere neutrale.
La Tavola 2 riporta gli
indicatori strutturali utilizzati ai fini della presente analisi contenuti nel
PdS - DEF 2013 confrontandoli con quelli contenuti nei precedenti Documenti
programmatici.
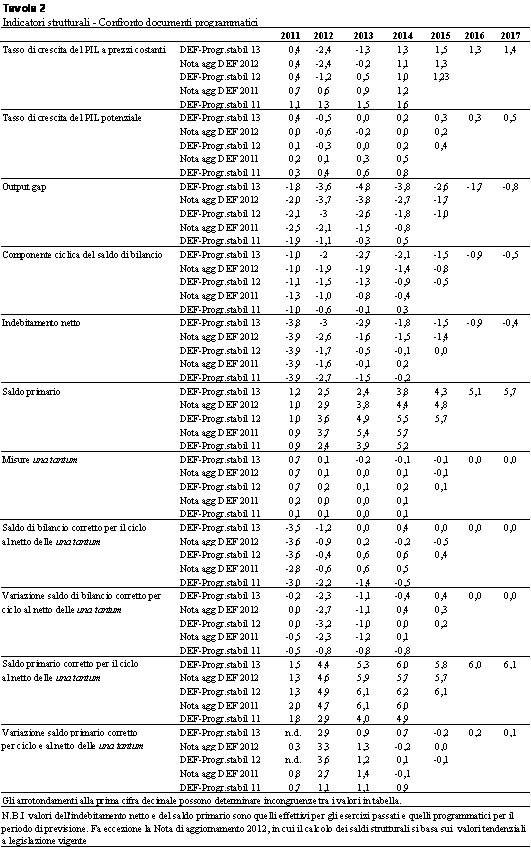
Approfondimento
5. Le misure una tantum
Il DEF riporta il quadro
delle misure una tantum che hanno inciso
sul saldo dell’indebitamento netto nel periodo 2010-2012 e formula le
corrispondenti previsioni per il periodo 2013-2017.
Rispetto all’analisi
contenuta nella Nota di aggiornamento al DEF 2012,
l’incidenza complessiva sul PIL di tali misure, prevista sia per il 2013
che per il 2014, risulta rivista al ribasso di due decimi di punto. In
particolare, nei due citati esercizi, il Documento prevede che le misure una
tantum concorrano a migliorare il saldo dell’indebitamento netto
strutturale (in misura pari a circa 2 decimi di punto di PIL per il 2013 e
a 1 decimo di punto per l’anno successivo). Ciò in quanto le misure di
carattere una tantum previste sul lato della spesa risultano superiori
rispetto a quelle considerate sul lato dell’entrata. Sulle prime incide in
particolare la revisione al rialzo delle spese per gli interventi a sostegno
delle aree colpite da calamità naturali; sulle seconde incide invece una
revisione al ribasso del gettito atteso dall’imposta sostitutiva per l’allineamento
dei valori di bilancio ai principi IAS.
Si segnala in via
preliminare che le misure una tantum non includono l’effetto derivante dal
DL n. 35/2013, riguardante il pagamento dei debiti della pubblica
amministrazione, i cui effetti, pari a circa 0,5 punti di PIL, peggiorano
pertanto l’indebitamento netto strutturale. Tale saldo non si discosta,
peraltro, dall’obiettivo del pareggio precedentemente fissato, in quanto il
predetto provvedimento sfrutta gli spazi resisi disponibili dall’ampliamento
della componente ciclica del bilancio, dovuta all’approfondimento della crisi
congiunturale rispetto alle precedenti previsioni di finanza pubblica.
Si segnala inoltre che, come di consueto, la tavola
ricognitiva delle misure una tantum riportata dal DEF 2013, di seguito
riprodotta, non è corredata di un’analisi illustrativa delle singole misure e
dei fattori alla base delle variazioni riscontrate a consuntivo o apportate
alle previsioni rispetto ai precedenti documenti di finanza pubblica. L’analisi
di seguito operata necessiterebbe pertanto di conferma da parte del Governo.
Tabella
Le misure una tantum nel
DEF 2013
(mln
di euro)
|
|
Consuntivo
|
Previsioni
|
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale One-Offs
|
3.129
|
10.698
|
1.512
|
-2.900
|
-960
|
-1.178
|
702
|
536
|
|
In % del Pil
|
0,2
|
0,7
|
0,1
|
-0,18
|
-0,1
|
-0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- a ) Entrate
|
4.103
|
6.755
|
2.122
|
430
|
375
|
120
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imposte sostitutive varie
|
1.271
|
1.595
|
770
|
360
|
255
|
110
|
0
|
0
|
|
Rientro dei capitali/scudo fiscale ter
|
656
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Allineamento bilancio ai principi IAS
|
2117
|
5115
|
643
|
70
|
100
|
0
|
0
|
0
|
|
Contributo U.E. per sisma Emilia
|
0
|
0
|
670
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- b) Spese
|
-2.207
|
2.801
|
-1.819
|
-4.830
|
-2.785
|
-2.748
|
-348
|
-364
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- IVA auto aziendali
|
-77
|
-37
|
0
|
-100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Interventi per calamità naturali
|
-1.953
|
-841
|
-1.584
|
-4.490
|
-2.715
|
-2.748
|
-348
|
-364
|
|
- Dividendi in uscita
|
-176
|
-149
|
-133
|
-140
|
-70
|
0
|
0
|
0
|
|
- Asta frequenze
|
0
|
3.827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Compensazioni emittenti
|
0
|
0
|
-103
|
-100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- c ) Dismissioni immobiliari
|
1.233
|
1.142
|
1.210
|
1.500
|
1.450
|
1.450
|
1.050
|
900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ripartizione per Sottosettori
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Amministrazioni Centrali
|
1.660
|
9.501
|
-425
|
-4.460
|
-2.280
|
-2.328
|
-198
|
-264
|
|
- Amministrazione Locali
|
1.316
|
1.023
|
1.565
|
450
|
450
|
450
|
300
|
300
|
|
- Enti di previdenza
|
153
|
174
|
372
|
1.110
|
870
|
700
|
600
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pil (x 1.000)
|
1.552
|
1.578
|
1.566
|
1.573
|
1.624
|
1.678
|
1.731
|
1.786
|
Fonte:
DEF 2013 - Sez. II - Tavola II.2.9
Si segnala in primo luogo
che la tavola sopra riportata sembra presentare alcune incongruenze:
-
la somma delle voci indicate
sul lato delle entrate non corrisponde al totale delle entrate stesse. Dal
confronto con le tavole contenute nei precedenti documenti di finanza pubblica,
sembrerebbe omessa un’unica riga: quella riguardante il condono
edilizio, che dovrebbe ancora presentare una coda nei versamenti. Peraltro,
aggiungendo i corrispondenti importi, si perviene ai
totali indicati nella tavola attualmente in esame per tutti gli esercizi salvo
il solo 2013, per il quale sembrerebbe invece iscritto un importo nullo a
titolo di condono edilizio a fronte della precedente previsione di 20 mln. Non
è chiaro a quali fattori vada ascritta la variazione relativa all’esercizio
2013;
-
inoltre, con riferimento agli
esercizi 2013-2017, sembrerebbero invertiti gli importi attribuiti ai due
comparti degli Enti previdenziali e delle Amministrazioni locali.
Analizzando le variazioni apportate
dal DEF 2013 rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF 2012, emerge che le
principali variazioni sul lato dell’entrata riguardano il gettito
delle imposte sostitutive[88],
tra cui in particolare l’imposta sui maggiori valori iscritti in bilancio nel
caso di riallineamento dei valori di bilancio ai principi IAS, il
cui gettito risulta separatamente evidenziato nel documento in esame. Da tali
dati emerge che i risultati di gettito conseguiti nel 2012 appaiono contenuti
rispetto alle attese; le previsioni di gettito per gli esercizi 2013 e 2014
(precedentemente prossime, rispettivamente, a 1 e a 2 mld) sono state conseguentemente
ridotte.
Le previsioni inerenti la
citata imposta sostitutiva erano state riviste al rialzo nel DEF 2012, a
seguito dei risultati migliori delle attese conseguiti nel 2011. Nel corso di
tale esercizio era stato previsto un ampliamento della base applicativa del
tributo, senza peraltro modificarne le date di scadenza (cfr. art, 23, commi da
15 a 17 del DL n. 98/2011). Si rinvia in proposito a quanto osservato nel
Dossier di verifica n. 17/XVI Leg., relativo al DEF 2012, in cui si evidenziava
che il tributo in questione avrebbe dovuto comunque esaurire la maggior parte
dei propri effetti nel corso dell’esercizio 2011, salvo marginali code dei
versamenti negli esercizi successivi. Pertanto si osservava che la citata
disposizione non appariva suscettibile di determinare effetti di gettito per un
importo complessivo di 4,5 mld circa sul triennio 2012-2014. Tali effetti
vengono ora ridotti a circa 800 mln nel medesimo arco temporale.
Si ricorda inoltre il principio di corrispondenza tra le
revisioni del gettito delle imposte sostitutive, rilevanti ai fini delle una
tantum, e il gettito ordinario delle imposte dirette, al fine di tenere conto
del gettito IRES e IRAP sugli ammortamenti e le plusvalenze tassabili inerenti
i beni oggetto di riallineamento. Nel caso specifico, una rettifica al rialzo
delle imposte ordinarie risulterebbe opportuna solo ove queste ultime fossero
state precedentemente riviste al ribasso in occasione dei precedenti incrementi
delle stime dell’imposta sostitutiva in esame.
Con riferimento alle altre imposte sostitutive, delle quali
non è fornito il dettaglio, si segnala che incide presumibilmente sul periodo
di previsione, in particolare per il 2013 e il 2014 il gettito derivante dalla riapertura
dei termini dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle
partecipazioni, disposta dalla legge di stabilità per il 2013,
cui la relazione tecnica ascriveva effetti di maggior gettito pari a 200 mln nel
2013 e 100 mln annui nel 2014 e nel 2015.
A fronte di tale
previsione di gettito, le stime in esame sono riviste al rialzo di 226 mln nel
2013 e di 135 mln nel 2014, mentre sono riviste al ribasso di 10 mln nel 2015.
Non è chiaro pertanto quale fattore compensativo del maggior gettito
dell’imposta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni incida in
particolare sull’esercizio 2015.
Più in generale, ai fini
di una migliore trasparenza e completezza delle informazioni fornite,
risulterebbe opportuno che il dato delle imposte sostitutive fosse corredato
dall’indicazione delle sottovoci che concorrono a determinare il risultato
complessivo.
In particolare un chiarimento risulterebbe opportuno con
riferimento ai risultati di gettito conseguiti nel 2012 dai diversi cespiti
tributari che concorrono a comporre le imposte sostitutive. Si segnala infatti
che per tale esercizio il gettito delle imposte sostitutive, comprensivo di
quello relativo al riallineamento dei valori di bilancio ai principi IAS, risulta
immutato rispetto alle precedenti previsioni, nonostante la revisione al
ribasso del citato tributo.
Incide inoltre sul lato
dell’entrata l’acquisizione del contributo U.E. per il sisma dell’Emilia,
pari a 670 mln per il 2013, considerato tra le una tantum -
analogamente a quanto operato per il contributo U.E. per il sisma in Abruzzo
acquisito nel 2009 (pari a 494 mln) - per ragioni di simmetria rispetto alle
spese erogate per la medesima finalità.
Sul lato della spesa risultano apportate significative modifiche alle
spese inerenti gli interventi per calamità naturali.
Si segnala preliminarmente
che il documento in esame, a differenza dei precedenti, non fornisce il dato
disaggregato delle spese inerenti i due sismi dell’Abruzzo e dell’Emilia. Al
fine di una puntuale ricognizione delle revisioni operate nelle stime,
risulterebbe pertanto opportuno acquisire tali dati.
Dai dati complessivi forniti,
risulta operata una revisione al rialzo delle spese per il periodo 2012-2015,
per complessivi 3,6 mld, di cui circa 2,4 nel 2013 (0,15 punti di PIL). Di
seguito si riporta la disaggregazione del dato complessivo delle spese per
calamità naturali in “interventi vari” e “mutui erogati”, fornita per le vie
brevi dalla Ragioneria generale dello Stato.
Tabella
(mln
di euro)
|
|
Consuntivo
|
Previsioni
|
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
|
Interventi per calamità naturali
|
-1.953
|
-841
|
-1.584
|
-4.490
|
-2.715
|
-2.748
|
-348
|
-364
|
|
di cui: - interventi vari
|
-1.458
|
-468
|
-458
|
-2.154
|
-1.400
|
-400
|
-348
|
-364
|
|
- mutui
erogati
|
-496
|
-372
|
-1.126
|
-2.337
|
-1.315
|
-2.348
|
0
|
0
|
Dal dato relativo ai mutui
erogati, nell’assunto che quelli erogati nel triennio 2010-2012 si riferiscano
all’Abruzzo e quelli da erogarsi nel triennio 2013-2015 si riferiscano
all’Emilia, emergerebbe che i primi ammontino a circa 2 mld (1994 mln), mentre
i secondi esattamente a 6 mln. Tali importi coinciderebbero sostanzialmente con
quelli autorizzati dalle corrispondenti leggi.
Non è invece chiaro invece
come si ripartiscano le spese per “interventi vari” tra le aree interessate e a
quali tipologie di intervento esse siano destinate. Andrebbe in particolare
chiarito se le spese per interessi a carico dello Stato (sia quelli inerenti i
mutui attivati per la ricostruzione, sia quelli inerenti il differimento dei
termini per il pagamento degli oneri fiscali e contributivi dei soggetti
colpiti dal sisma) siano o meno considerate una tantum.
Ulteriori variazioni, di
portata più contenuta, riguardano:
-
le spese per dividendi in
uscita, che risultano incrementate sia per l’esercizio di consuntivo (+ 33
mln) che per il 2013 e il 2014 (rispettivamente +140 e + 70);
-
le erogazioni per compensazioni
alle emittenti locali, rispetto alle quali risultano maggiori spese
rispetto alle previsioni per +72 mln nel 2012, parzialmente compensati da un
contenimento della spesa nell’esercizio successivo (-35 mln).
Al riguardo, andrebbero
acquisiti gli elementi informativi sottostanti le variazioni sopra indicate.
Il Documento in esame,
analogamente alla precedente Nota di aggiornamento al DEF 2012, non imputa
variazioni di importo alla voce riguardante gli incassi per l’assegnazione
di diritti d’uso di frequenze radioelettriche, presumibilmente nel
presupposto che le entrate derivanti dalla revoca del cd. “beauty contest”,
non incluse nelle previsioni, saranno comunque registrate tra le una tantum
nel momento in cui si verificheranno.
In merito alle dismissioni
immobiliari si segnala che il DEF evidenzia per il 2012 entrate da
dismissioni lievemente inferiori alle attese (-230 mln), mentre rivede
lievemente al rialzo le entrate previste per il triennio 2013-2015
(rispettivamente di 50, 150 e 150 mln). Non sembrano pertanto iscritti effetti
in relazione al piano pluriennale di valorizzazione del patrimonio pubblico,
dal quale sono attesi effetti di riduzione del debito, pari a 1 punto
percentuale di PIL all’anno, che si cumula nell’arco del triennio 2013-2017.
Andrebbe quindi chiarito se la mancata previsione a tale titolo di maggiori
entrate da dismissione immobiliari, incluse per loro natura tra le una tantum,
sconti l’ipotesi che il processo di valorizzazione riguardi esclusivamente
partite di carattere finanziario e non dia luogo, invece, a maggiori
dismissioni di cespiti immobiliari.
In merito ai criteri
di riparto delle misure una tantum tra i diversi livelli di governo,
ferma restando la necessità di un chiarimento in merito all’apparente refuso
sopra segnalato - riguardante la presumibile inversione degli importi tra i
comparti degli Enti previdenziali e delle Amministrazioni locali per gli
esercizi 2013-2017 - andrebbero acquisite informazioni sui fattori alla base
del riparto. Non è chiaro, in particolare, quali siano le componenti
positive che incidono sul comparto degli enti locali e degli enti di
previdenza: la somma di tali due comparti, entrambi di segno positivo, risulta
infatti superiore, per gli esercizi dal 2010 al 2013 rispetto al valore
complessivo delle dismissioni immobiliari. Tale eccedenza risulta
particolarmente significativa per l’esercizio 2012 (+727 mln) e non è chiaro a
quale fattore essa vada ascritta.
Approfondimento
6. La regola sulla spesa
I nuovi regolamenti europei,
il c.d. six pack[91],
introducono nell'ambito del braccio preventivo del Patto di Stabilità e
Crescita (PSC) un vincolo alla crescita della spesa (expenditure benchmark),
diretto a rafforzare il raggiungimento dell’obiettivo di medio termine,
parametrato al tasso di crescita di medio periodo del PIL potenziale.
Il Codice di condotta
stabilisce in proposito che questo è calcolato come media delle stime dei
precedenti 5 esercizi, della stima per l'esercizio corrente e delle proiezioni
per i 4 esercizi successivi. Ai fini del calcolo del benchmark, esso
viene aggiornato periodicamente e comunicato agli Stati membri: per quanto
riguarda l’Italia, il valore relativo al biennio 2012-2013 é pari +0,3 per
cento, mentre per il triennio 2014-2016 il valore è pari a zero.
L'aggregato di spesa pubblica
sottoposto a valutazione è individuato nel totale della spesa delle
Amministrazioni Pubbliche[93] diminuito della spesa per interessi, della spesa nei
programmi europei per la quota coperta da fondi comunitari e della componente
legata al ciclo delle spese non discrezionali per indennità di disoccupazione.
L'aggregato deve essere depurato dalla volatilità intrinseca della spesa per
investimenti, prevedendo che il valore iscritto in ciascun esercizio sia
sostituito da un valore medio calcolato sulla base della spesa per l'esercizio
in corso e quella relativa ai tre esercizi precedenti.
Al valore della spesa così
ottenuto devono essere sottratte le entrate derivanti da misure discrezionali,
considerando l’incremento rilevato (o atteso) nell’anno t rispetto
all’esercizio precedente (t-1). A queste si aggiungono (purché non
ricomprese nella precedente voce) le eventuali maggiori entrate derivanti da
innalzamenti automatici di imposte e/o tasse previsti dalla legislazione a
copertura di poste specifiche di spesa.
Poiché il PIL potenziale è
stimato in termini reali, la spesa così determinata è deflazionata con il
deflatore del PIL quale risulta dalle previsioni della Commissione[96]. Per l’Italia, per la valutazione del rispetto della
regola nel biennio 2012-2013, tali valori sono rispettivamente l’1,87 e 1,88
per cento. Per gli esercizi
successivi, il valore utilizzato nel PdS è quello indicato dal Governo nel
quadro macroeconomico (Tavola II.2b del DEF).
Il limite massimo per la
variazione della spesa è diverso a seconda della posizione di ciascuno Stato
rispetto all'OMT, in quanto è diretto a garantire la coerenza con il percorso
di convergenza concordato. Per gli Stati membri che hanno già raggiunto l'OMT,
la crescita della spesa pubblica non deve essere più elevata del parametro
medio relativo al PIL potenziale. Eventuali dinamiche di crescita superiori
possono essere consentite soltanto se compensate da misure discrezionali dal
lato delle entrate di pari ammontare. Per gli Stati che non hanno ancora
raggiunto l'OMT il tasso di crescita della spesa deve essere inferiore a quello
del PIL potenziale e coerente con un miglioramento del saldo strutturale di
almeno 0,5 punti in termini di PIL.
Per l’Italia, secondo le
stime della Commissione, il c.d. shortfall risulta pari a -1,1 punti:
a fronte di una crescita del potenziale pari +0,3 per cento, il benchmark
prevede infatti una variazione negativa dell’aggregato pari a -0,8 per cento sia
per il 2012 che per il 2013, esercizio in cui è previsto il raggiungimento
dell’OMT. Nel periodo successivo,
il benchmark é pari a zero, coincidendo con la nuova stima del PIL
potenziale.
Il rispetto del benchmark
viene valutato ex post nell’ambito del giudizio sull’avvicinamento o raggiungimento
dell’OMT. Uno scostamento nella dinamica della spesa dal valore di riferimento
non ha conseguenze se il Paese ha già raggiunto l’OMT e questo non sia
pregiudicato.
Per un Paese che non
abbia raggiunto l’OMT e che presenti una deviazione del saldo di bilancio
rispetto al percorso di avvicinamento pari o superiore allo 0,5 per cento del
PIL in un anno (o cumulativamente in due anni), lo scostamento viene
considerato significativo se la spesa al netto delle misure discrezionali sulle
entrate ha un impatto sul saldo pari ad almeno allo 0,5 per cento del PIL in un
anno (o cumulativamente in due anni).
Approfondimento
7. La regola del debito
Il nuovo quadro di riforma
della governance economica dell'UE, adottato nel novembre 2011(six pack)
e richiamato nel fiscal compact, rafforza il controllo della disciplina
di bilancio attraverso l'introduzione di una regola numerica che specifica il
ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60 per cento del PIL[101].
In particolare, il nuovo
articolo 2 del regolamento 1467/97 stabilisce che, per la quota del rapporto
debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60 per cento, il tasso di
riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti
esercizi[102].
Nel caso in cui il valore del
rapporto debito/PIL nell’esercizio di riferimento sia superiore al benchmark,
la Commissione deve verificare se il mancato rispetto della regola possa essere
attribuibile a effetti ciclici o se, sulla base delle previsioni a politiche
invariate, è prevista una correzione entro i due anni successivi al primo anno
di valutazione (t+2)[103].
Per quanto riguarda il primo
aspetto, occorre considerare che una regola sul debito che non tenga in
considerazione gli andamenti ciclici potrebbe portare a risultati incoerenti
con la fissazione di obiettivi di saldo in termini strutturali, depurato cioè dagli
effetti degli stabilizzatori automatici. Essa, inoltre, rischierebbe di essere
fortemente pro-ciclica, penalizzando un deterioramento delle finanze pubbliche
non imputabile a fattori strutturali. Per tale ragione la regola di benchmark
del debito é affiancata da un'altra formula che misura il debito aggiustato per
l'andamento ciclico[104]. In fasi negative del ciclo, il rapporto debito/PIL
aggiustato risulterà inferiore rispetto a quello effettivo, in quanto il debito
verrà depurato per l'effetto degli stabilizzatori automatici e il PIL nei tre
anni precedenti viene fatto variare al tasso di crescita del PIL potenziale. E'
da notare che tale formula non viene utilizzata dalla Commissione nelle fasi
positive del ciclo, nelle quali il debito aggiustato risulterebbe superiore
rispetto a quello effettivo (una componente ciclica positiva farebbe aumentare
il numeratore e quindi il valore del rapporto). In altre parole, ai paesi non é
chiesto, in relazione al debito, uno sforzo aggiuntivo nei "tempi
buoni".
In conclusione, la prima
formula fornisce il livello di debito in percentuale sul PIL da perseguire che,
qualora raggiunto, esime il paese da ulteriori sforzi; la seconda formula
serve, invece, a valutare - qualora l'applicazione del primo algoritmo
evidenziasse un mancato rispetto del benchmark - se la regola possa essere
considerata comunque effettivamente rispettata, tenuto conto della possibilità
di scontare gli andamenti ciclici.
Qualora il rapporto
debito/PIL fosse più alto del benchmark anche dopo l’aggiustamento per il ciclo
e rimanesse più elevato anche in prospettiva (nei due anni successivi all’anno
di riferimento), la Commissione sarà chiamata a redigere un rapporto ex art.
126(3) TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), nel quale al
benchmark numerico si aggiungono valutazioni “qualitative” relative a un certo
insieme di “altri fattori rilevanti”. L’analisi di tali fattori rappresenta,
quindi, un passo obbligato nelle valutazioni che inducono ad avviare una
procedura per disavanzi eccessivi a causa di una mancata riduzione del debito
ad un “ritmo adeguato”. Questi fattori sono :
- le operazioni di
aggiustamento stock-flow del debito;
- le riserve accantonate e le
altre voci dell’attivo del bilancio pubblico;
- le garanzie, specie quelle
legate al settore finanziario;le passività, sia esplicite che implicite,
connesse all’invecchiamento della popolazione;
- il livello del debito
privato, nella misura in cui rappresenti una passività implicita potenziale per
il settore pubblico.
Particolare attenzione
meritano, infine, gli interventi di sostegno tra Stati membri o nei confronti
dell’EFSF/MES nel contesto della salvaguardia della stabilità finanziaria:
qualora la regola non fosse rispettata, la Commissione dovrà valutare in quale
misura tali interventi incidano sul debito e verificare se, al netto di essi, la
regola risulti rispettata.
E’ da rilevare che, nel caso
di Stati membri correntemente sottoposti alla procedura di deficit eccessivo, è
previsto un periodo di transizione di tre anni per l’applicazione della regola.
In tale periodo, gli Stati devono prevedere un aggiustamento fiscale (cioè una
correzione del saldo di bilancio) strutturale minimo tale da garantire un
progresso continuo e realistico verso il benchmark del debito.
L’aggiustamento deve essere tale da rispettare le seguenti condizioni:
-
l’aggiustamento strutturale annuo
non deve scostarsi più dello 0,25 per cento del PIL dell’aggiustamento
richiesto per assicurare la regola del debito a fine periodo;
-
in qualsiasi momento del periodo
di transizione, il restante aggiustamento strutturale annuo non deve superare
lo 0,75 per cento del PIL.
Tale percorso di
aggiustamento è evidenziato dalle seguenti figure (tratte dalla Nota Ecofin/
C1-C4 (2011):
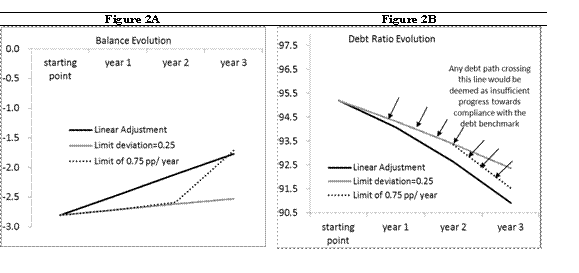
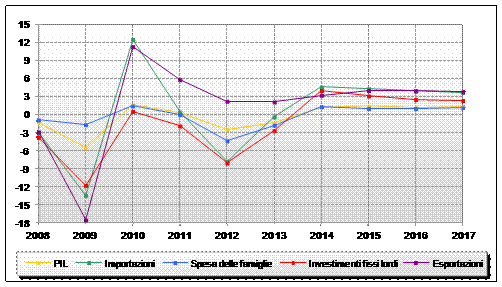
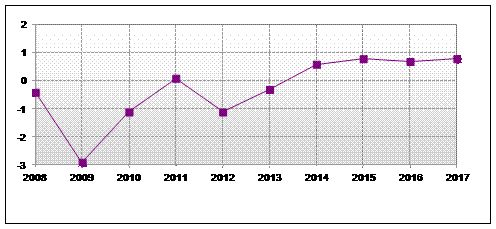
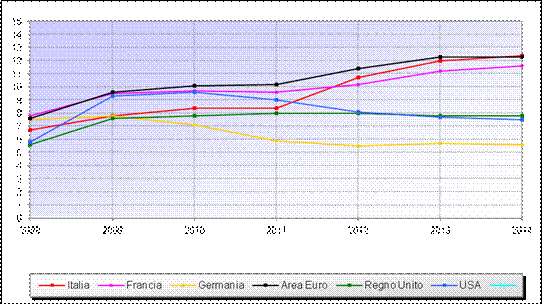 Fonte: Per
i consuntivi 2008-2012, per i paesi della UE, dati della Commissione Europea,
per USA, dati FMI. Per le previsioni 2013-2014, FMI, Word Economic Outlook (aprile
2013)
Fonte: Per
i consuntivi 2008-2012, per i paesi della UE, dati della Commissione Europea,
per USA, dati FMI. Per le previsioni 2013-2014, FMI, Word Economic Outlook (aprile
2013)