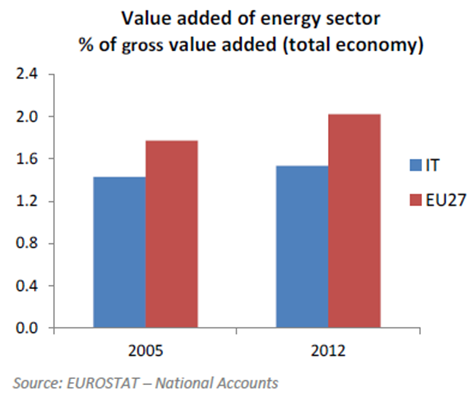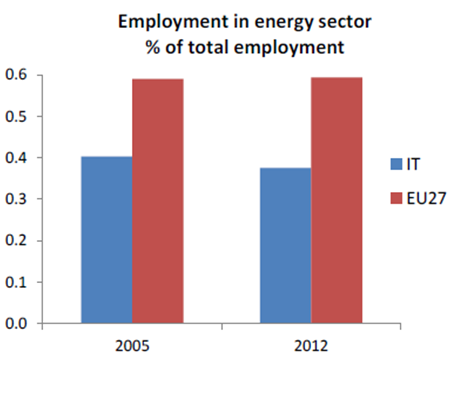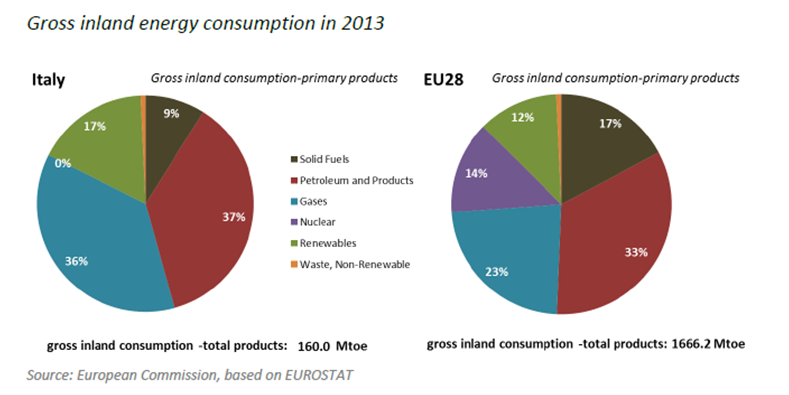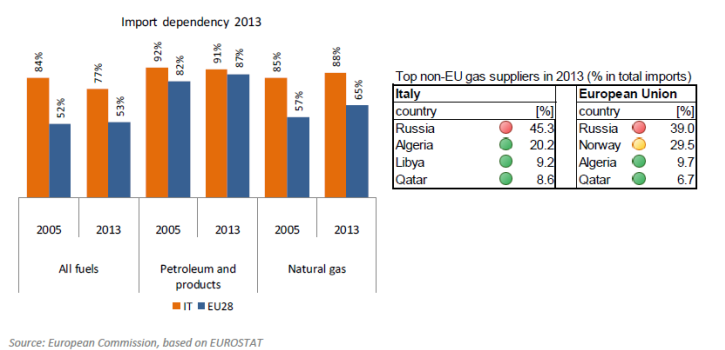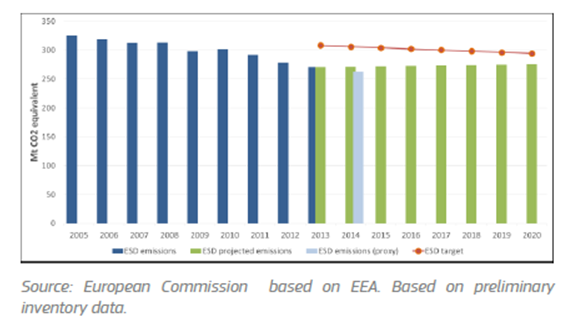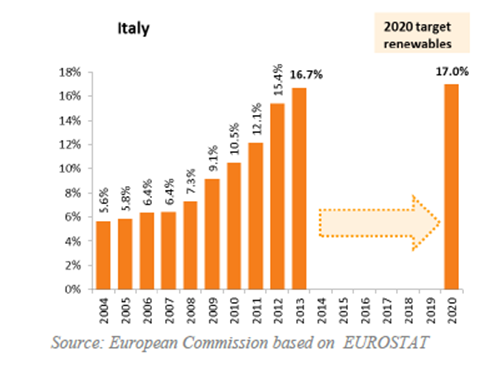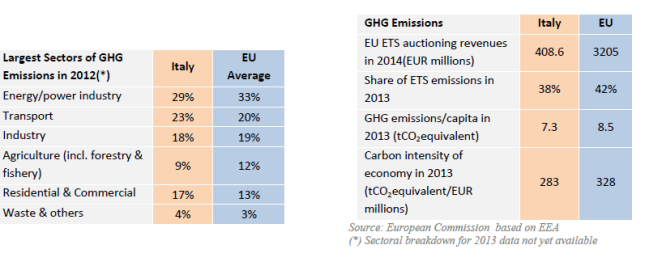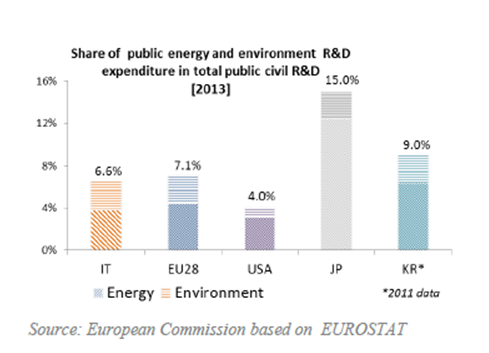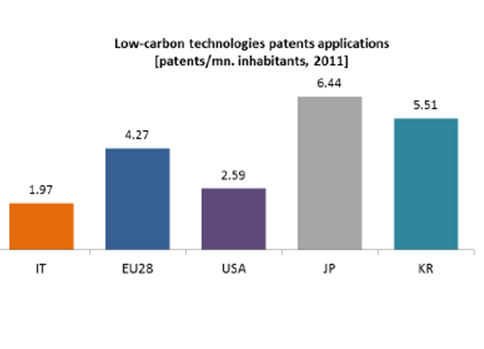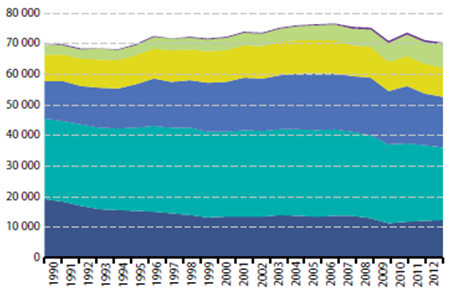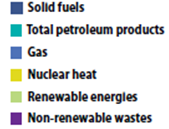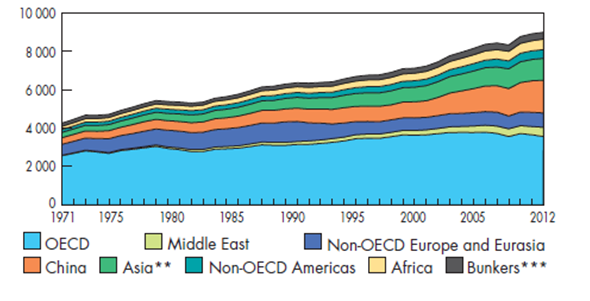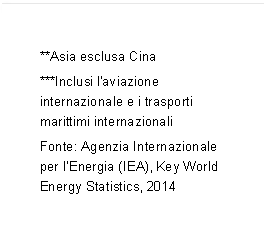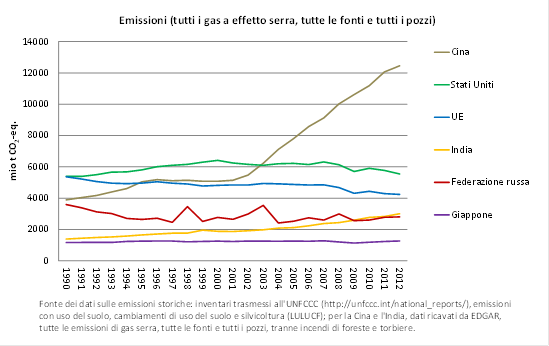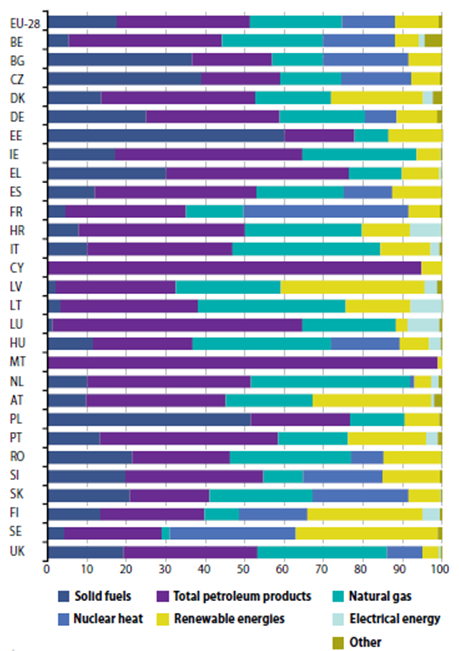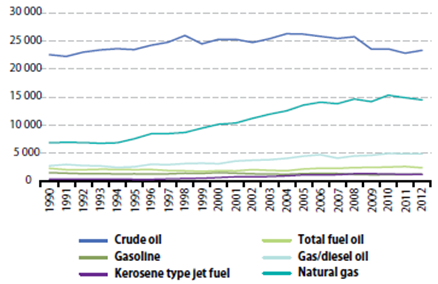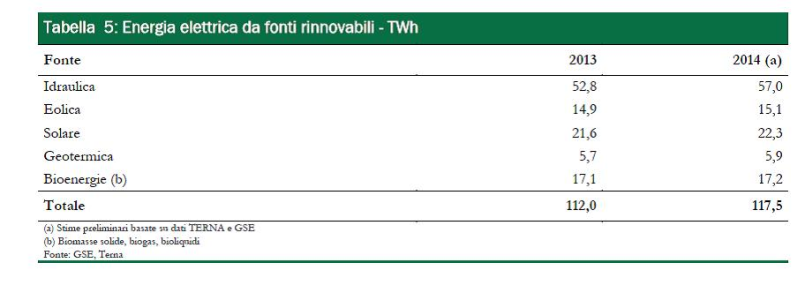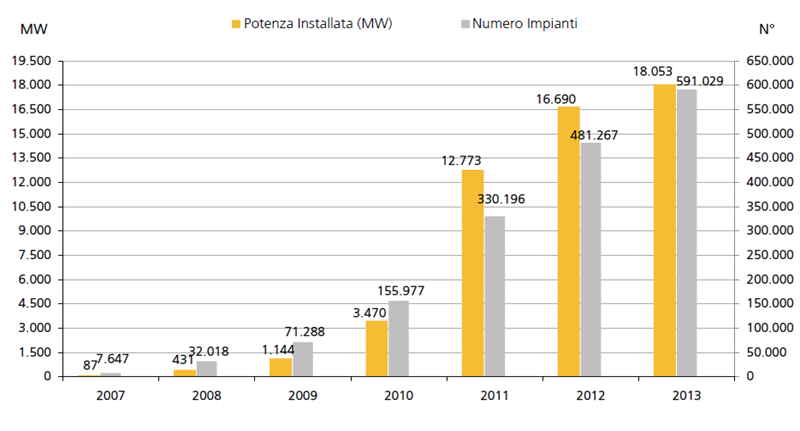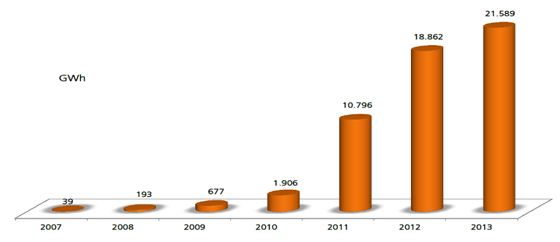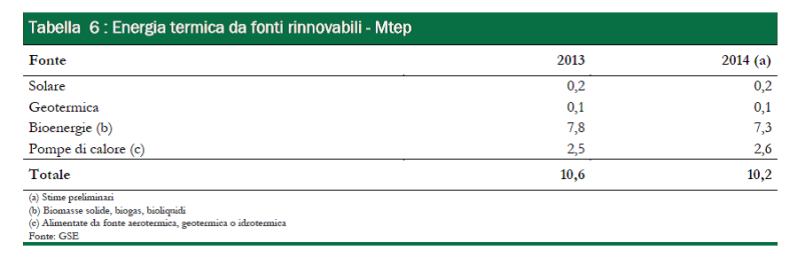La Comunicazione pubblicata lo scorso 18 novembre è
accompagnata da due allegati contenenti rispettivamente un aggiornamento
della tabella di marcia indicante il calendario per l'adozione di una
serie di misure e azioni riguardanti l'Unione dell'energia e gli orientamenti
per gli Stati membri ai fini dell'elaborazione dei piani
nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030. E' inoltre
corredata da 28 schede informative per gli Stati membri, tra cui quella
per l'Italia.
A ciò si aggiungono anche una serie di relazioni e documenti di lavoro dei
servizi della Commissione che analizzano nel dettaglio i progressi compiuti
nell'ambito dei vari obiettivi dell'Unione dell'Energia (azione per il clima,
efficienza energetica, sicurezza energetica), nell'attuazione di alcune
direttive UE (sulla sicurezza nucleare e sulle scorte petrolifere) nonché una
proposta legislativa sulle statistiche relative ai prezzi dell'elettricità e
del gas naturale, volta al miglioramento delle statistiche europee sui prezzi dell'energia. Si
segnala poi la seconda lista di Progetti di Interesse Comune (PIC): si
tratta di 195 progetti di infrastrutture indispensabili per conseguire gli
obiettivi di politica energetica.
Di seguito un'illustrazione dei contenuti della Comunicazione,
relativamente alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.
Questa dimensione riguarda la politica
climatica dell'Unione europea e il settore delle energie rinnovabili,
nel quale l'Unione aspira a diventare leader mondiale. Si premette che in
materia di politica climatica l'obiettivo dell'Ue è quello di limitare il
riscaldamento globale a 2° al di sopra delle temperature medie del periodo
pre-industriale. Al riguardo l'Ue si pone i seguenti obiettivi per il 2020, come
definiti dal Pacchetto clima-energia adottato nel 2008:
-
ridurre di almeno
il 20% le emissioni di gas effetto serra;
-
portare al 20% la
quota di rinnovabili nel consumo energetico.
Gli obiettivi dell'UE per il
2030 sono ancora più ambiziosi, come si evince dal Quadro 2030 per le
politiche dell'energia e del clima adottato nell'ottobre 2014, su cui
si basa la posizione europea alla Conferenza sul clima di Parigi avviata lo
scorso 30 novembre:
-
ridurre di almeno il
40% le emissioni di gas effetto serra rispetto al 1990 (obiettivo vincolante);
-
raggiungere la
quota del 27% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.
Per quanto concerne i progressi
compiuti in questa dimensione dell'Unione dell'energia, la Commissione
sottolinea che l'economia UE è la più efficace al mondo in termini di
emissioni di carbonio e che è riuscita con successo a dissociare la
crescita economica e le emissioni di gas a effetto serra. Tra il 1990 e il
2014 il PIL combinato dell'UE è aumentato del 46% mentre le emissioni di gas
a effetto serra sono diminuite del 23%. Secondo le proiezioni fornite dagli
Stati membri, l'UE per il 2020 dovrebbe essere in grado non solo di
conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas effetto serra, ma
di superarlo di quattro punti percentuali (24%). Le energie rinnovabili
soddisfano già il fabbisogno di 78 milioni di europei e l'Unione europea è sulla
buona strada per raggiungere l'obiettivo del 20% di consumo di energia finale
da tali fonti. Nel 2015 l'Ue, oltre che nell'ambito delle energie rinnovabili,
ha compiuto progressi in altri due settori chiave:
-
sistema di scambio
quote di emissione (ETS): la Commissione europea ha presentato, nel luglio
2015, una proposta di riforma che è attualmente al vaglio delle istituzioni, e
ha raggiunto un accordo per la riserva stabilizzatrice di mercato che entrerà
in vigore nel 2019 e che rafforzerà tale sistema;
-
investimenti nelle
tecnologie a basse emissioni di carbonio e nell'efficienza energetica: almeno
il 20% del bilancio UE è destinato a tematiche legate al clima, per un
ammontare di circa 180 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Di questi
circa 110 miliardi sono messi a disposizione attraverso i fondi strutturali e
di investimento europei (ESI). É stato inoltre attivato il Fondo europeo per
gli investimenti strategici (FEIS) per alcuni progetti in materia di energia
sostenibile.
Inoltre, nel settembre 2015
l'Unione ha approvato il mandato politico per la Conferenza sul clima di
Parigi
nella quale ha confermato di essere pronta a negoziare un ambizioso accordo
globale sul clima, vincolante e trasparente, presentando un obiettivo di
riduzione delle emissioni a livello domestico del 40% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990. La Commissione ha dato conto del fatto che al momento
dell'adozione della Comunicazione, 160 paesi, responsabili di oltre il 90%
delle emissioni, avevano presentato i loro contributi stabiliti a livello
nazionale (INDC).
Per quanto concerne le azioni
future, nel 2016 l'UE intende:
-
formulare proposte
sull'attuazione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni nei settori non
compresi nel sistema ETS (30% in meno rispetto al 2005), fissando obiettivi
nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e affrontando la
questione dell'uso del suolo;
-
pubblicare una
comunicazione sulla decarbonizzazione dei mezzi di trasporto;
-
concentrarsi sulle
emissioni prodotte dal trasporto stradale e sui sistemi di collaudo: è in
preparazione una proposta volta ad applicare la procedura di prova armonizzata
a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP). Inoltre, dal 2017 sarà
obbligatorio effettuare prove di emissioni in condizioni reali di guida al fine
di abbattere le emissioni di ossido di azoto (NOx). E' altresì previsto il
rafforzamento del sistema di sorveglianza del mercato;
-
presentare una
nuova direttiva sulle energie rinnovabili e sulla politica di sostenibilità
delle bioenergie ed eliminare gradualmente le sovvenzioni a favore dei
combustibili fossili.
Conclusioni politiche
Per quanto concerne le emissioni di gas serra
l’Unione europea nel 2020 avrà ridotto del 24%, quindi superato di quattro
punti percentuali l’obiettivo stabilito. 24 Stati membri raggiungeranno gli
obiettivi nei settori non-ETS. 4 Stati (Irlanda, Lussemburgo, Belgio e Austria)
dovranno fare ulteriori sforzi per raggiungere tali obiettivi. Per quanto
riguarda le fonti rinnovabili, l’Unione europea è sulla strada giusta per
raggiungere gli obiettivi prefissati. 3 Stati (Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno
Unito) non hanno raggiunto il loro obiettivo intermedio al 2013, mentre 19
Stati membri (tra cui l'Italia) supereranno abbondantemente il loro obiettivo nel
2020. Alcuni, tra i quali Regno Unito, Francia, Spagna, dovranno invece valutare
se occorrerà mettere in cantiere ulteriori misure. Per tutti saranno
necessari sforzi aggiuntivi per integrare le energie rinnovabili nel mercato
europeo. Si
richiedono inoltre iniziative regionali volte a promuovere la cooperazione degli Stati in
materia di energie rinnovabili. Al momento, gli unici Stati membri impegnati in
tal senso sono la Svezia e la Norvegia con il Piano di interconnessione del
mercato energetico del Baltico.
Si ricorda che l'Unione europea persegue l'obiettivo per
il 2020 di migliorare l'efficienza
energetica del 20%, come previsto dal pacchetto clima-energia. L'Obiettivo
per il 2030 è di migliorarla del 27%, come previsto dal
Quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia. Nel
2020, inoltre, vi sarà una revisione volta ad innalzare tale obiettivo al 30%. La
Commissione intende quindi incoraggiare gli Stati membri affinché diano
all'efficienza energetica un posto preminente nelle loro politiche. I settori
maggiormente interessati sono quelli dell'edilizia e dei trasporti.
Per conseguire l'obiettivo 2030 la Commissione europea nel
2015 ha presentato una proposta di revisione della Direttiva sull’etichettatura
energetica, ed entro l'anno prevede di presentare un programma di lavoro sull’ecodesign
nel contesto della nuova proposta sull’economia circolare. Nel 2015 sono
inoltre entrate in vigore numerose misure sull’ecodesign e sull’etichettatura
energetica che dovrebbero ridurre il consumo energetico a vantaggio dei
consumatori. Per quanto concerne i finanziamenti il Fondo Europeo per gli
Investimenti Strategici (FEIS) sta già sostenendo alcuni progetti in Europa,
Italia inclusa.
Come evidenziato dalla relazione sui progressi compiuti in
materia di efficienza energetica,
che accompagna la Comunicazione, nonostante i significativi progressi compiuti,
gli sforzi collettivi degli Stati membri hanno condotto a un risparmio di
energia primaria solo del 17,6% rispetto alle previsioni per il 2020. Tuttavia,
la Commissione ritiene che l'obiettivo per il 2020 sarà raggiunto, a
condizione che la legislazione in vigore dell'UE sia pienamente attuata, gli
sforzi si intensifichino, aumenti il livello di ambizione e migliorino le
condizioni di investimento.
Per quanto riguarda le iniziative future, la Commissione
europea nel 2016 intende presentare:
-
una proposta di revisione della Direttiva sull’efficienza
energetica nel contesto dell’obiettivo per il 2030;
-
una revisione della Direttiva sulla prestazione energetica
degli edifici, che contano per il 40% delle emissioni di CO2;
-
una nuova strategia per il riscaldamento e il raffreddamento, che
rappresenta il primo utilizzo dell’energia nell'UE (53,4%), puntando sugli
edifici residenziali, terziari e industriali.
Inoltre, al fine di migliorare i finanziamenti iniziali
nell'efficienza energetica, la Commissione europea elaborerà un piano per
aggregare i progetti di efficienza energetica di piccole dimensioni nell'ottica
di migliorare le opportunità di investimento e garantire maggior accesso ai
capitali necessari per programmi nazionali, regionali o locali.
Conclusioni politiche
Gran parte degli Stati Membri
deve migliorare la performance per raggiungere gli obiettivi di efficienza
energetica per il 2020. Molti Stati membri, tra cui l’Italia, hanno notificato
obiettivi più ambiziosi in tema di consumo di energia primario o finale. Al
tempo stesso alcuni hanno ridotto le loro aspettative in uno dei due obiettivi
(l’Italia, per esempio, ha ridotto il suo obiettivo per il consumo finale di
energia). Inoltre sempre per alcuni, tra cui l'Italia, gli obiettivi per il
2020 non sono sufficientemente ambiziosi per quanto concerne le previsioni di
crescita economica. Per quanto concerne l'intensità energetica esiste una
differenza notevole tra gli Stati membri dovuta in larga parte a differenze
strutturali. Gli Stati membri dovranno inoltre promuovere ulteriormente il
teleriscaldamento e il teleraffreddamento ad alto rendimento.
Questa dimensione dell'Unione dell'energia richiede un
miglioramento delle infrastrutture,
in particolare dei collegamenti transfrontalieri e delle interconnessioni. A
tal riguardo si ricorda che l'Unione europea si è posta un obiettivo specifico di interconnessione minima per
l'energia elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10%
della capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri. In altri
termini, il 10% dell'elettricità deve poter "attraversare le
frontiere". Per far sì che ciò accada la
Commissione europea ha previsto che occorrerà investire circa 200 miliardi
di euro l'anno per i prossimi dieci anni in grandi progetti infrastrutturali. Occorrerà poi
garantire la piena applicazione della normativa vigente, in particolare il terzo pacchetto sul mercato interno
dell'energia e rivolgere un'attenzione miratas ai
consumatori che in futuro dovrebbero poter godere di più ampie possibilità di
scelta, acquistando energia anche da società con sedi in altri Stati membri.
Su questa dimensione la Commissione europea afferma che dal
febbraio 2015 sono stati compiuti notevoli progressi, rappresentati, per
quanto concerne il settore elettrico, dall'inaugurazione delle interconnessioni
tra Francia e Spagna, Italia e Malta e dal completamento delle interconnessioni
Eastlink tra Finlandia ed Estonia, NordBalt tra Lituania e Svezia, che hanno
consentito agli Stati baltici di partecipare al mercato dell'energia elettrica
"NordPool". Per quanto concerne il settore del gas, la Commissione
richiama l'inaugurazione in Lituania del nuovo terminal di gas naturale
liquefatto (GNL), la realizzazione di un'interconnessione tra Ungheria e
Slovacchia e l'installazione all'interno dell'Ue e alle sue frontiere con
l'Ucraina di attrezzature di flusso inverso per agevolare gli scambi
bidirezionali. Nel 2015, la Commissione europea
ha lavorato con alcuni Stati membri per istituire gruppi di alto livello per lo
sviluppo di reti di interconnettività nella penisola iberica, nell'Europa
meridionale, centrale ed orientale (CESEC), nella regione del Mar Baltico (BEMIP)
e per eliminare gli attuali ostacoli normativi al commercio transfrontaliero di
energia elettrica e gas, con particolare riguardo ai problemi connessi alla
piena attuazione del terzo pacchetto dell'energia. Gli Stati membri a loro
volta hanno rafforzato la loro collaborazione a livello regionale. Nel 2015 è
stato istituito un Forum per le infrastrutture energetiche, inaugurato il 9-10
novembre scorso. Sul fronte dei consumatori, la Commissione europea rileva che
questi non riescono ancora a svolgere appieno il loro ruolo nel sistema
energetico.
I mercati del gas e dell'elettricità non funzionano ancora come dovrebbero,
come evidenziato nel documento di lavoro sulle tendenze nel consumo di energia
presentato congiuntamente alla Comunicazione.
Per quanto riguarda le
prospettive future la Commissione europea sottolinea che nel 2016 occorrerà
accelerare il lavoro sui progetti di infrastrutture energetiche, soprattutto
per quanto riguarda i Progetti di Interesse Comune (PCIs), sui quali si
registrano ritardi dovuti principalmente alle lungaggini delle procedure
amministrative di autorizzazione e/o a questioni di finanziamento. La
Commissione europea sottolinea inoltre la necessità per gli Stati membri di
attuare il regolamento TEN-E, soprattutto in merito alle disposizioni sulla
concessione di autorizzazioni. Contestualmente alla Comunicazione, la
Commissione europea ha pubblicato la seconda lista di PIC, illustrando i
progetti più urgenti per conseguire gli obiettivi di politica energetica e i
miglioramenti necessari per predisporre l'infrastruttura portante di un mercato
europeo integrato dell'energia.
Per il 2016 la Commissione
europea prevede inoltre di:
-
presentare una Comunicazione sulle
misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 15% di interconnessione entro
il 2030;
-
destinare il 50% degli
investimenti in PCI nel settore elettrico nella regione del Mare del Nord;
-
presentare proposte legislative
volte a migliorare i collegamenti tra mercati all’ingrosso e al dettaglio; a
migliorare la cooperazione regionale e il commercio internazionale; a
sviluppare il mercato di breve e lungo periodo al fine di inviare segnali di
prezzo adeguati per la modernizzazione delle tecnologie sia ai produttori che
ai consumatori di energia;
-
proseguire il monitoraggio del
sostegno pubblico agli investimenti nel settore energetico, per garantire che
la concessione di aiuti di Stato sia compatibile con le regole europee;
-
realizzare uno studio sui prezzi e
i costi dell’energia in Europa per avere un quadro del costo della tassazione e
dei sussidi nazionali, anche al fine di fornire una base per comparare i
diversi livelli di prezzo tra gli Stati membri e gli impatti sulla
competitività.
Conclusioni politiche
La Commissione europea sottolinea che molti Stati
membri hanno fatto notevoli passi avanti per garantire la concorrenza nel
mercato dell’energia. Tuttavia, persistono numerose differenze tra gli Stati
nell’attuazione delle regole sulla concorrenza. 22 Stati membri stanno per
raggiungere o hanno raggiunto l’obiettivo del 10% sull'interconnessione
elettrica. L’Italia invece deve fare ulteriori sforzi.
La regolamentazione dei
prezzi per il settore industriale deve essere limitata a circostanze
eccezionali
e dovrebbe essere ulteriormente ridotta. Il ruolo del consumatore deve
essere rafforzato migliorando il sistema di informazione sulle opzioni
riguardanti l'efficienza energetica. Lo sviluppo dei contatori intelligenti
volti anche alla responsabilizzazione dei consumatori è una realtà concreta
solo in pochi Stati membri (Finlandia e Svezia) Occorrono inoltre misure più
mirate per i consumatori vulnerabili. A metà del 2015, a livello regionale la
maggior parte dei mercati elettrici all’ingrosso risultavano accoppiati ad uno
o più mercati vicini, con segnali di convergenza dei prezzi. Più complicata la
situazione nel settore del gas. Nonostante una certa convergenza in alcuni
principali hub del gas, differenze di prezzo di mercato e scarsa integrazione
persistono, anche a causa di contratti a lungo termine e mancate
interconnessioni. I mercati al dettaglio sia per l’elettricità che per il
gas sono ancora nazionali e sono necessari maggiori sforzi da parte di tutti
gli Stati membri per progredire nell’integrazione del mercato.
Per quanto riguarda questa dimensione, l'obiettivo della Commissione europea,
illustrato nella Strategia quadro per l'Unione dell'energia, è quello di
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, riducendo la dipendenza
energetica attraverso la diversificazione delle fonti, dei fornitori e delle
rotte di approvvigionamento.
Il 2015 è stato dominato da alcuni eventi che
hanno fortemente inciso sul mercato dell’energia europeo:
-
il
conflitto tra Russia e Ucraina;
-
il
persistere di prezzi bassi del petrolio;
-
nuove
infrastrutture per il trasporto di gas naturale dalla Russia;
-
nuove
prospettive aperte dalla conclusione del negoziato sul nucleare iraniano;
-
la continua
diminuzione della produzione di combustibile fossile.
La Commissione europea ritiene che l’Ucraina
debba rimanere un Paese di transito nell’interesse di tutte le parti.
Nel corso del 2015, ha facilitato i negoziati tra
Ucraina e Russia per garantire gli approvvigionamenti di gas all’Ucraina
durante l’inverno. A tal riguardo nel settembre 2015 è stato siglato un
protocollo vincolante, la cui attuazione è iniziata nell'ottobre 2015. Anche la
capacità di flusso inverso dall'Ue, tra Ucraina e Slovacchia è
considerevolmente aumentata nel corso del 2015. La Commissione europea prende
atto di alcuni piani per la costruzione di altri gasdotti tra la Russia e la Germania
attraverso il Mar Baltico. I gasdotti dovranno però rispettare la normativa Ue
sul Terzo Pacchetto Energia.
La Commissione osserva che le recenti scoperte di
gas nel Mediterraneo orientale aumentano il potenziale contributo della regione
alla sicurezza energetica europea. Pertanto è stata intensificata la cooperazione
attraverso l'istituzione di tre piattaforme sul gas, sul mercato elettrico
regionale e sulla promozione delle energie rinnovabili. Inoltre è proseguito il
lavoro sul Corridoio sud e sono stati rilanciati i negoziati sul gasdotto
attraverso il Mar Caspio.
Per quanto riguarda le iniziative future, nel 2016
la Commissione intende presentare:
-
una
proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza degli
approvvigionamenti di gas, con l’obiettivo di migliorare la capacità europea di
reagire alle interruzioni dell'approvvigionamento;
-
una
strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) e per il suo stoccaggio;
-
la
revisione della Decisione sugli accordi intergovernativi nel settore
energetico, con l’obiettivo di aumentarne la trasparenza e fare in modo che
siano adeguati alla normativa UE di riferimento;
-
un nuovo
strumento giuridico sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia
elettrica volto a migliorare la trasparenza, assicurare un approccio comune e
predisporre soluzioni transfrontaliere più efficaci.
La Commissione europea sosterrà inoltre
l'importanza dell'energia nell'ambito dei negoziati in corso con gli Stati
Uniti sul Partenariato Transatlantico per il commercio e gli investimenti
(TTIP).
Conclusioni politiche
L’Unione europea sta realizzando progressi nella
diversificazione delle fonti, delle rotte e dei fornitori di energia. Tuttavia molti
Stati dell’Europa dell’Est e dell’Europa centrale dipendono esclusivamente da
un unico fornitore (Russia). E’ necessario migliorare i collegamenti tra
gli Stati baltici e la Finlandia e il mercato del gas dell'Europea centrale e
assicurare l’accesso al gas liquefatto da parte di tutti i paesi europei. Gli
stress test regionali eseguiti nel 2014 hanno evidenziato i benefici della
cooperazione regionale nel prevenire o mitigare le crisi energetiche. Gli
Stati membri devono rafforzare la loro cooperazione sulla sicurezza
dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e l'adeguatezza della
produzione.
Questa dimensione dell'Unione dell'energia è fondamentale
per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
Nel 2015 la Commissione europea ha presentato la Comunicazione "Verso un
piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) con la
quale intende dare un nuovo impulso all'impiego di tecnologie a basse emissioni
di carbonio.
Un ruolo fondamentale nel settore dell'innovazione è svolto
dai finanziamenti. Al momento sono attivi il Fondo strategico per gli
investimenti (FEIS) e il programma NER 300 - che offre un finanziamento di
circa 2.1 miliardi di Euro. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi, per
progetti connessi al clima e all'energia, dei fondi derivanti dalla vendita
all'asta delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS (nel 2014 tale
cifra è stata pari a 3,2 miliardi di euro). Nell'ambito della revisione del
sistema ETS, la Commissione europea ha proposto l'istituzione di un nuovo Fondo
per l'innovazione e del nuovo Fondo per la modernizzazione. Il primo estende il
Programma NER anche per i progetti per tecnologie a basso contenuto di
carbonio nei settori industriali e il secondo si rivolge agli Stati membri con
un PIL inferiore al 60% della media dell'Ue. Mediante il programma quadro
"Orizzonte 2020" sono stati destinati, nel biennio 2014-2015, circa 9
miliardi per programmi in materia di ricerca energetica, trasporti puliti,
azione per il clima e uso efficiente delle risorse.
Per quanto riguarda le prospettive future, nel 2016 la
Commissione europea intende presentare una nuova strategia integrata
dell'Unione dell'energia e concentrarsi su un coordinamento più efficace tra
Unione dell'energia, mercato unico digitale ed economia circolare.
Conclusioni politiche
Molti Stati membri hanno compiuto sforzi significativi per
promuovere l'innovazione e, nonostante la crisi, nel settore delle energie
rinnovabili è aumentata l'occupazione, con quasi mezzo milione di posti di
lavoro. Tuttavia, la Commissione europea ritiene che possano essere compiuti
ulteriori sforzi, ad esempio modificando il sistema fiscale in modo da
stimolare l'occupazione e la competitività contribuendo a realizzare gli
obiettivi dell'Unione dell'energia.
Si ricorda che la Strategia quadro per l'Unione
dell'energia, oltre alle cinque
dimensioni, prevede un sistema di governance integrata che garantisca
che tutte le azioni intraprese a livello nazionale, regionale e locale siano in
linea con gli obiettivi fissati. Il processo di governance sarà volto,
tra l'altro, a combinare le azioni in materia di clima ed energia a quelle in
altri settori strategici per garantire una maggiore coerenza programmatica a
lungo termine e dare così agli investitori maggiore certezza.
A seguito di un confronto politico e di un dialogo tecnico
con gli Stati membri, avviato nei mesi scorsi con le numerose visite del
Commissiario Šefčovič presso di
essi, la Commissione europea ha elaborato una serie di schede informative per
ciascun paese, la proposta di una metodologia basata
su alcuni indicatori chiave, e un documento di lavoro che offre un quadro
comparativo tra gli Stati Membri nell’implementazione delle cinque dimensioni
dell’Unione dell’Energia utilizzando questi primi indicatori chiave.
La Commissione
europea afferma che solo un terzo degli Stati membri dispone di strategie
globali in materia di clima ed energia per il periodo post-2020. Pertanto,
contestualmente alla Comunicazione, ha presentato una guida per facilitare gli Stati Membri nella
formulazione dei piani strategici nazionali per il periodo 2021-2030.
Questi dovranno essere presentati nel 2017, per essere completati, dopo
eventuali altre discussioni, nel 2018 e messi in atto prima del 2021.
Per quanto riguarda le azioni
future, nel 2016 la Commissione europea pubblicherà delle linee guida su come
migliorare e rafforzare la cooperazione regionale. Per seguire da vicino i
progressi sarà istituito un sistema trasparente di monitoraggio basato su
indicatori chiave, sulle relazioni biennali degli Stati membri in merito ai
rispettivi piani nazionali. Inoltre, la Commissione intende presentare una
proposta volta a razionalizzare la pianificazione e gli obblighi di
comunicazione per gli Stati membri, in modo da ridurre gli oneri amministrativi
superflui, in linea con l'agenda "Legiferare meglio".
Si segnala che lo scorso 26
novembre il Consiglio energia ha adottato delle Conclusioni
relative ad un nuovo sistema di
governance dell'Unione dell'energia che controllerà i progressi dell’UE
verso il raggiungimento degli obiettivi dell’UE in materia di energia e clima e
gli obiettivi strategici generali. Il sistema dovrebbe operare sulla base di
programmi esistenti e non dovrebbe comportare alcun onere amministrativo. Fra
gli elementi essenziali del sistema di governance rientrano:
•
un piano nazionale per
l’energia e il clima che deve essere adottato da ciascuno Stato membro per il
periodo dal 2021 al 2030;
•
relazioni sui
progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale;
•
dialoghi costruttivi
tra la Commissione e gli Stati membri;
•
il monitoraggio e la
valutazione basati su indicatori chiave.
Le relazioni sullo stato di attuazione dell’Unione per
l’energia, presentate il 18 novembre 2015, sono accompagnate da schede
informative sui singoli Stati membri. Per quanto riguarda l’Italia, la
Commissione segnala che:
· per percentuale sul valore aggiunto lordo
totale e percentuale sul totale degli occupati, il settore
energetico nazionale registra valori più bassi rispetto alla media europea;
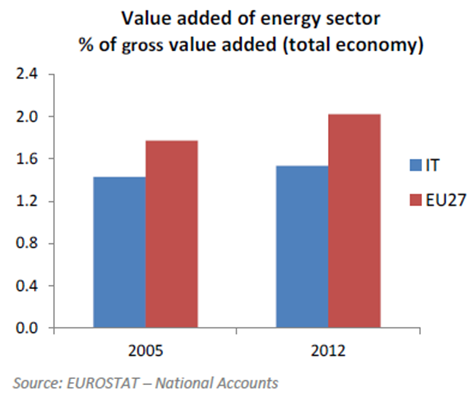
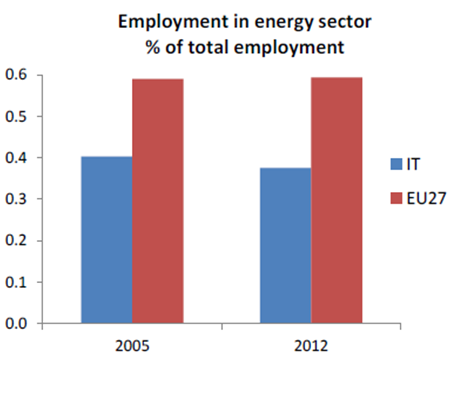
· il mix
energetico differisce da quello dell’UE a 28, con una più ampia percentuale
di gas e l’assenza del nucleare. Comparate ai dati del 1995, la percentuale di
petrolio e derivati è diminuita (passando dal 58% al 37% del consumo energetico
all’ingrosso) mentre la percentuale di combustibili solidi e energie
rinnovabili è aumentata rispettivamente di 2 e 8 punti percentuale. La
percentuale di gas è cresciuta considerevolmente, passando dal 28% al 36% del
mix energetico;
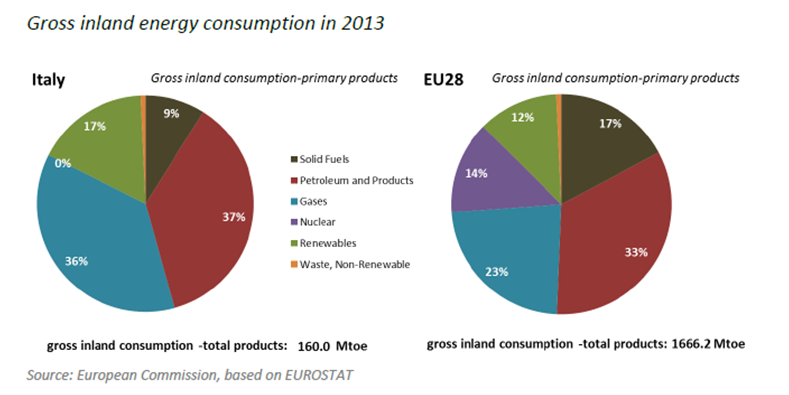
· la dipendenza
da combustibili solidi è superiore rispetto all’UE a 28. La
dipendenza dalle importazioni è particolarmente elevata per i prodotti del
petrolio e del gas. Un’alta percentuale di importazioni del gas proviene dalla
Russia, ma in ogni caso, le fonti di approvvigionamento sono relativamente ben
diversificate. Pertanto, l’indice di concentrazione dei paesi fornitori è
relativamente basso;
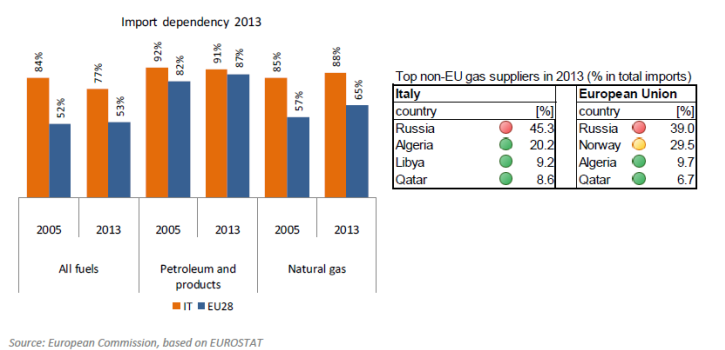
· la capacità
di interconnessione rappresenta il 7,4% della capacità istallata e
necessita di essere migliorata. L’Italia è interessata a 16 Progetti di
interesse comune (PIC); quelli nel settore elettrico sono concentrati
principalmente sulle interconnessioni con la Francia (Grande Ile-Piossasco), la
Svizzera (Verderio Inferiore-Thusis/Sils e Airolo-Baggio), l’Austria
(Lienz-Veneto e Wurmlach-Somplago), la Slovenia (Salgareda-Divaca/Bericevo) e
il Montenegro (Latsva-Villanova). L’attuazione di questi progetti entro il 2020
dovrebbe portare la capacità di interconnessione al 12%, mentre l’obiettivo del
15% entro il 2030 dovrebbe essere raggiunto con l’attuazione dei nuovi PIC. La
Commissione segnala inoltre la necessità di migliorare la rete interna per
eliminare i colli di bottiglia, aumentando i livelli di sicurezza e flessibilità
del sistema. Per quanto riguarda il gas, l’Italia gioca un ruolo importante
nella creazione di un hub mediterraneo: in tale ambito, uno dei progetti
PIC prevede la costruzione di un gasdotto che colleghi l’Algeria all’Italia,
via Sardegna (cosiddetto gasdotto Galsi). Nell’ambito del corridoio meridionale
per il gas – una delle priorità della politica energetica dell’UE -, la TAP (Trans
Adriatic Pipeline), che trasporterà il gas azero dal confine turco
all’Italia meridionale attraverso Grecia e Albania, dovrebbe partire nel 2016
nonostante la forte opposizione delle autorità locali.
· i prezzi
dell’energia elettrica al dettaglio per l’utenza domestica sono in generale
sopra la media UE; i costi per la rete, gli oneri di sistema e le tasse
pesano rispettivamente per il 17%, il 23% e il 13% del prezzo finale al
consumatore; i prezzi del gas per tutti i consumatori sono fra i più alti tra
gli Stati membri: costi della rete e tasse pesano rispettivamente per il 18% e
il 36% sul prezzo finale;
· i clienti
sono relativamente attivi nel cambio di fornitore. A dispetto dei numerosi
fornitori di energia elettrica presenti sul mercato nazionale (circa 140), la
Commissione segnala che l’offerta standard ("maggior tutela", rivolto
alle sole utenze domestiche) è dominato da una grande compagnia con l’85.4% del
mercato;
· l’obiettivo
dell’Italia in termini di efficienza energetica per il 2020 è 158 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) espressi in consumo di energia
primaria (124 Mtep espressi in consumo finale di energia). Considerato il
livello attuale di consumo di energia primaria (166 Mtep nel 2014), si rendono
necessari sforzi per mantenere il trend al ribasso anche in presenza
dell’atteso incremento del PIL durante i prossimi cinque anni;

· l’Italia
ha diminuito le sue emissioni del 22% tra il 2005 e il 2014 ed è sulla
strada per raggiungere il suo obiettivo 2020 di riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra; 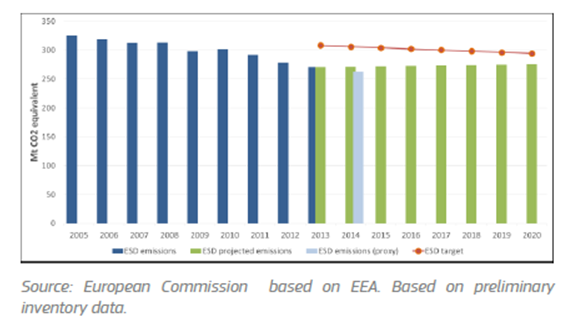
· con
una percentuale di 16.7% di energie da fonte rinnovabile nel 2013, l’Italia
ha pressoché raggiunto l’obiettivo del 17% per il 2020. Secondo quanto
dichiarato dal Gestore dei servizi energetici durante un’audizione al Senato,
il sostegno ai costi per l’energia rinnovabile ha raggiunto euro 307/MWh per il
fotovoltaico solare e euro 120/MWh per le altre rinnovabili. Ciò avrebbe
indotto il Governo a rivedere il sistema degli incentivi. Secondo la
Commissione, le attuali incertezze sul futuro degli incentivi alle rinnovabili
possono determinare nuove sfide per lo sviluppo di questo importante settore.
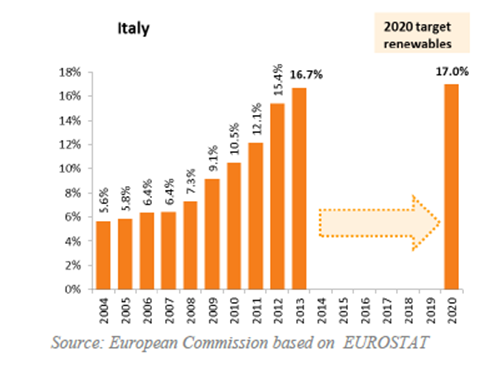
· in
Italia l’intensità di carbonio dell’economia nel 2013 è stata del 4% più bassa
rispetto alla media UE. Nel 2014 gli introiti dalle assegnazioni delle
quote ETS ammontano a 408.6 milioni di euro, il 50% dei quali destinato ad
obiettivi climatici ed energetici;
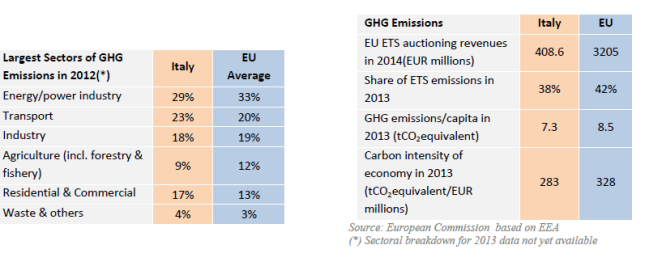
· l’Italia
è vicina alla media europea, sopra gli USA e sotto Giappone e Corea del Sud, in
termini di sostegno pubblico alla ricerca e innovazione nei settori
energetico e ambientale. Questi livelli sono più bassi di altre grandi
economie europee, quali Francia o Germania. In termini di brevetti per
tecnologie a bassa intensità di carbonio, l’Italia è invece molto indietro
rispetto alla media europea e ai principali partner internazionali;
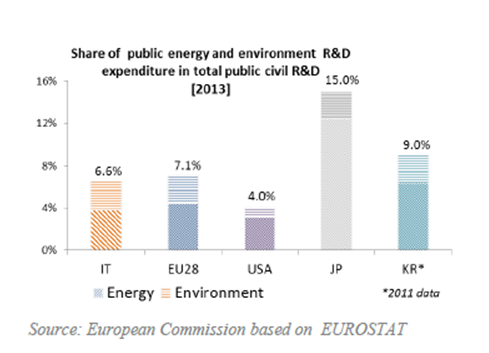
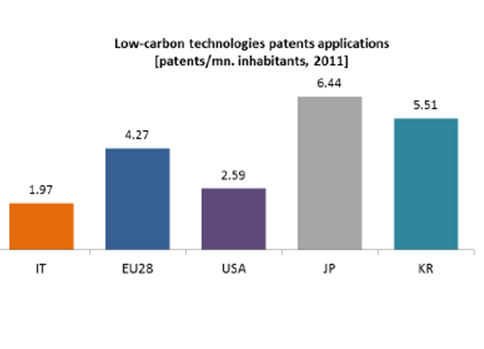
· il costo
reale unitario dell’energia è più alto in Italia che in UE e USA. Con
riguardo ai prezzi pagati dai consumatori industriali, l’Italia sperimenta uno
fra i prezzi più in Europa e fra i maggiori partner commerciali non UE. Si
registra naturalmente una grande discrepanza tra i prezzi minimi e massimi
pagati dall’industria, basati sui livello di consumo. Tasse e prelievi sui
prezzi dell’elettricità sono saliti in maniera significativa negli ultimi anni,
specialmente per l’industria. Mentre per una larga maggioranza degli Stati
membri il livello di tasse e prelievi è sotto il 10%, per l’Italia essi
eccedono il 20%. I prezzi per il gas sono molto più bassi per l’industria e si
sono abbassati recentemente.

· la politica
di coesione costituisce – in complemento con il cofinanziamento pubblico e
privato - un’importante opportunità di investimento per attuare gli obiettivi
della politica energetica in Italia.
- Mercato
interno dell’energia: nel perdiodo 2014-2020, la politica di coesione investirà
quasi 444 millioni di euro in reti intelligenti di distribuzione dell’energia
elettrica. Tali investimenti dovrebbero contribuire a connettere circa 304.000 nuovi
utenti alle reti intelligenti;
- efficienza
energetica: nel mededismo periodo la politica di coersione investirà 1.413 milioni
di euro in miglioramenti dell’efficienza energetica nell’ediliza pubblica e,
con estensione minore, negli edifici residenziali e industriali, così come in
cogenerazione ad alta efficienza e distretti di riscaldamento in Italia. Ulteriori
3.684 milioni di euro saranno investiti a supporto di trasporti efficienti e
decarbonizzati. Tali investimenti dovrebbero contribuire a circa 1.000 utenze
domestiche con una migliore classificazione in termini di consumo di energia e
una diminuzione di 367.598.000 kWh per anno del consumo di energia primaria
degli edifici pubblici, così come a circa 270 chilometri di reti ferroviarie
ricostruite e migliorate e 250 chilometri di nuove linee metro e tram;
- decarbonizzazione:
gli investimenti della politica di coesione contribuiranno una diminuzione
annuale di emissioni di gas ad effetto serra, per un totale di circa 5.149.000
tonnellate di CO2 equivalente. Tra il 2014 e il 2020, verrranno
inoltre investiti 200 milioni di euro in energie rinnovabili, aumentando la
capacità produttiva di quasi 405 MW;
- ricerca,
innovazione e competitività: nell’ambito della politica di coesione, si
invetirà in maniera significativa in competività delle piccole e medie imrpese
e in ricerca e innovazione, sulla base delle strategie energetiche nazionali e
regionali per la smart specialisation.
Senato della Repubblica
Il Pacchetto "Unione
dell'Energia" è stato esaminato
dalle Commissioni riunite 10a (industria, commercio turismo) e 13a (territorio,
ambiente, beni culturali) del Senato della Repubblica, che il 4 giugno 2015
hanno adottato una risoluzione (DOC XVIII, n. 92) nella quale si sono espresse in senso favorevole formulando alcuni
rilievi. In particolare, per quanto concerne l'impegno dell'Unione europea a
ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 hanno sottolineato come esso debba
essere commisurato agli obiettivi delle altre macroregioni del mondo. Circa gli
impegni Ue in materia di energie verdi ed efficienza energetica hanno precisato
che questi dovranno essere realizzati nel contesto di accordi che coinvolgano
tutte le principali economie del mondo (in riferimento alla COP21 e al TTIP).
Altre osservazioni hanno riguardato la proposta di revisione del sistema ETS,
l'importanza dell'approvvigionamento dai giacimenti del Mediterraneo orientale,
del Caspio, del Mediooriente e del Nord Africa, la necessità di regole di
accesso più semplici ai finanziamenti, soprattutto nel settore dei Progetti di
interesse comune (PIC), l'importanza di garantire un'efficace governance
dell'energia, mediante una semplificazione e riduzione degli oneri
amministrativi e un quadro normativo chiaro. Tra gli altri elementi emersi,
l'opportunità, per concerne il passaggio a sistemi energetici e di produzione a
bassa emissione di gas serra, di puntare su norme regolatrici dei mercati
piuttosto che su incentivi o disincentivi diretti.
Sempre presso in Senato, la
10a Commissione l'8 ottobre 2015 ha approvato una risoluzione sulla Proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica (DOC XVIII n. 97). La 13a Commissione il 30 luglio 2015, in occasione della
consultazione pubblica sull'economia circolare, ha adottato una risoluzione (Doc XXIV n. 51) a conclusione dell'esame assegnato in materia di rifiuti,
Atto n. 580. La risoluzione è stata adottata al termine di un breve ciclo di
audizioni informali di personalità provenienti dalla Commissione europea, dal
Governo italiano nonché di enti di ricerca sul tema dell'economia circolare.
Camera dei deputati
Il pacchetto Unione dell’energia è stata esaminato dalla
Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, che l’8 luglio
2015 hanno approvato un documento
finale in cui si esprime una valutazione positiva, con alcune
osservazioni. In particolare si pone l’attenzione sul tema delle
interconnessioni, chiedendo la realizzazione, nel più breve tempo
possibile, della piena interconnessione delle reti a livello continentale,
sulla base di un disegno strategico coerente che non sia rimesso alle
iniziative di singoli paesi o operatori, ma che risponda a una logica sistemica
e ad esigenze comuni. A tal fine, si richiede che in sede europea si
individuino e si stanzino le risorse necessarie allo scopo, ad integrazione di
quelle già disponibili che appaiono largamente insufficienti. Specifico
riferimento viene fatto alla realizzazione di un hub del gas nell'Europa
meridionale per il quale l'Italia può legittimamente candidarsi.
Nel documento finale, si richiede inoltre di promuovere
l'ampliamento della generazione distribuita, favorendo una maggiore capacità
da fonti di energia rinnovabile con gli opportuni e necessari interventi di
semplificazione amministrativa. In particolare, si ritiene opportuno un disegno
di riordino complessivo dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili
di energia per favorirne lo sviluppo su scala continentale con un sistema di
regole stabile e omogeneo tra i diversi paesi.
Tra le ulteriori indicazioni fornite dalle Commissioni, si
segnalano la promozione delle attività di ricerca e innovazione
nell'ambito della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili –
anche allo scopo di sostenere lo sviluppo dell'industria del settore; gli investimenti
per la realizzazione di reti elettriche intelligenti (smartgrids) e
di sistemi di gestione intelligente attraverso l'utilizzo della tecnologia
digitale; la definizione in sede europea di sistemi di tassazione che
attribuiscano un costo al carbonio – carbon tax – e di un sistema di
regole chiaro, coerente, uniforme e stabile nel tempo che dia il giusto segnale
alle imprese per indirizzare le proprie scelte di investimento verso tecnologie
e attività a bassissimo impatto di carbonio.
Nel quadro della cooperazione internazionale, si richiede la
promozione di partenariati con i paesi del Nord Africa, finalizzati non
soltanto a garantire all'Unione europea l'accesso alle fonti energetiche ma
anche a favorire lo sviluppo di tali paesi.
La Commissione attività produttive della Camera ha esaminato
anche le due comunicazioni “Un new deal
per i consumatori di energia” (COM (2015) 339) e “Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo
assetto del mercato dell’energia” (COM(2015)340) presentate il 15 luglio 2015, nell’ambito delle
iniziative previste dall’Unione dell’energia. Il 2 dicembre 2015 la
Commissione ha approvato un documento finale, in cui esprime una valutazione
positiva, con alcune osservazioni. Per quanto riguarda i consumatori, la
Commissione attività produttive chiede che venga garantita agli utenti la
conoscibilità ed accessibilità dei dati sul consumo in tempo reale, per
consentire scelte consapevoli nell’utilizzo dell’energia; che venga promossa la
digitalizzazione delle relazioni fornitore/cliente per semplificare e
accelerare l’espletamento delle richieste del cliente e che vengano ridotti
ulteriormente i tempi per l’attivazione delle forniture e per il cambiamento
del fornitore. Per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica, nel
documento finale si pone l’accento sulla necessità di destinare tutte le
risorse disponibili all’ammodernamento delle reti e alle loro interconnessioni,
con particolare riguardo all’Italia, al fine di consentire lo sviluppo della
produzione decentrata da energie rinnovabili. Si sollecita inoltre un approccio
più coordinato tra gli Stati membri per la revisione dei regimi di aiuto a
favore delle rinnovabili, l’accelerazione del processo di armonizzazione dei
mercati di bilanciamento nonché la promozione della cooperazione regionale in
tema di sicurezza dell’approvvigionamento e interconnessioni, dando priorità
alla zona del Mediterraneo.
Elementi di approfondimento
La politica energetica dell’Unione europea si articola su
tre linee di intervento:
·
sicurezza dell'approvvigionamento, per assicurare una
fornitura affidabile di energia quando e dove necessario;
·
competitività, per assicurare prezzi ragionevoli per
utenze domestiche e imprese;
·
sostenibilità del consumo energetico, attraverso
l’abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e la riduzione della
dipendenza da combustibili fossili.
L'energia nell'UE in cifre
·
6 Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno per la
totalità delle loro importazioni di gas
·
l'UE importa il 90% del petrolio greggio e il 66% del gas
naturale
·
il 75% delle abitazioni nell'UE è a bassa efficienza energetica
·
il 94% dei trasporti dipende da prodotti petroliferi, che sono
importati al 90%
·
i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono superiori del 30% e i
prezzi all'ingrosso del gas di oltre il 100% rispetto a quelli degli Stati
Uniti
Come risulta dalle cifre sopra indicate, tra le sfide cui è
sottoposta l’UE in campo energetico, la sua dipendenza dalle importazioni
è la questione più pressante: l’UE, la seconda economia mondiale, consuma un
quinto dell’energia prodotta nel mondo e possiede una percentuale molto ridotta
di riserve energetiche; attualmente importa oltre la metà della sua energia
per un costo di 400 miliardi per anno.
Altro importante tema è rappresentato dalla scarsa
differenziazione delle fonti, in particolare greggio e gas naturale, e dei
fornitori, che rende l’UE vulnerabile alle perturbazioni nelle forniture
energetiche e al conseguente aumento dei prezzi. Inoltre, il continuo ricorso
ai combustili fossili in Europa contribuisce al riscaldamento globale e
all’inquinamento.
Proprio in relazione a quest’ultimo problema, negli ultimi
anni la politica energetica dell’UE è stata strettamente legata alla
definizione di una politica europea per il cambiamento climatico e alla
conseguente definizione di una strategia per uno sviluppo sostenibile (sotto il
profilo ambientale) dell’economia europea. In tale ambito, l’UE si pone in
posizione di leader del processo in atto a livello internazionale nella lotta
ai cambiamenti climatici.
Per inserire le sue iniziative nell’ambito di una strategia
coerente di lungo termine, a partire dal 2007 l’UE si è data obiettivi
misurabili in materia di clima ed energia
per il 2020:
- ridurre
le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai
livelli del 1990 (nel 2012 erano stati ridotti del 18%);
- ottenere
il 20% dell’energia da fonti rinnovabili (la quota di energie
rinnovabili è passata dall'8,5% del 2005 al 14,1% del 2012);
- migliorare
l'efficienza energetica del 20% (si prevede un aumento dell'efficienza
energetica del 18–19% entro il 2020. Siamo appena al di sotto
dell’obiettivo del 20%, ma possiamo raggiungerlo se gli Stati membri
applicheranno tutte le normative dell’UE)
per il 2030:
- ridurre
del 40% i gas a effetto serra, rispetto al 1990
- ottenere
almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili
- aumentare
l'efficienza energetica del 27-30%
- portare
il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il
15% dell’energia elettrica prodotta nell’Unione può essere trasportato
verso altri paesi dell’UE)
per il 2050:
·
tagliare dell'80-95% i gas a effetto serra rispetto ai
livelli del 1990. La tabella
di marcia per l'energia 2050 illustra come ci si può riuscire.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati, il
25 febbraio 2015 la Commissione ha presentato una strategia
quadro per l'Unione dell'energia
che riunisce in un'unica strategia coerente una serie di settori di intervento,
concentrandosi su cinque elementi che si sostengono reciprocamente:
·
la sicurezza energetica, puntando alla diversificazione
delle fonti e dei fornitori, allo sviluppo ulteriore delle risorse interne e al
miglioramento delle infrastrutture di accesso a nuove fonti di
approvvigionamento;
·
il rafforzamento del mercato interno dell'energia per
garantire il coordinamento delle capacità a livello regionale, lo stoccaggio e
una risposta più flessibile alla domanda, consentendo una partecipazione più
attiva dei consumatori al mercato e scambi transfrontalieri di energia più
agevoli;
·
l'efficienza energetica, in quanto mezzo per moderare la
domanda di energia, promuovendo in particolare interventi per migliorare
l'efficienza energetica e la prestazione energetica nell'edilizia;
·
la decarbonizzazione dell’economia, puntando
all’efficiente integrazione nel mercato della produzione di energia da fonti
rinnovabili e accelerando la decarbonizzazione del settore dei trasporti, anche
attraverso la promozione dell'elettrificazione del settore e di investimenti
nella produzione di biocarburanti avanzati;
·
la ricerca, l'innovazione e la competitività, sostenendo
in particolare attività di tecnologie energetiche del futuro sicure, pulite ed
efficienti.
Il piano d’azione allegato alla strategia quadro
illustra le misure specifiche da preparare e attuare nel corso dei prossimi
anni. Alcune di esse sono già state presentate dalla Commissione il 15 luglio
2015. Si tratta in particolare:
-
della proposta
di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad
effetto serra, che l’UE ha istituito nel 2003 per affrontare i cambiamenti
climatici e indirizzare l'UE verso un'economia a basse emissioni di biossido di
carbonio.
-
della revisione
della direttiva sull'etichettatura energetica dei prodotti, a vent’anni
dalla sua introduzione;
-
di una consultazione
sul riassetto del mercato interno dell’energia elettrica;
-
di proposte
volte a tutelare i consumatori di energia, favorendo il risparmio di denaro
ed energia grazie a una migliore informazione e ad un più ampio margine di
scelta in materia di partecipazione ai mercati dell'energia.
L’energia nell’UE
Il consumo interno lordo di energia nell'UE-28
ha mostrato nel periodo 1990-2012 un andamento
tendenzialmente stabile: nel 2012 è stato inferiore dell'1%
rispetto al 2011 (circa 70,5 milioni di terajoule - TJ).
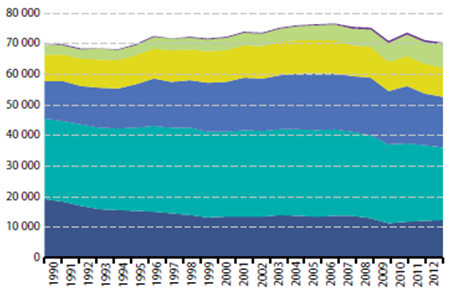 EU-28: consumo interno
lordo di energia, 1990-2012 (1.000 TJ)
EU-28: consumo interno
lordo di energia, 1990-2012 (1.000 TJ)
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment
indicators - 2014
A fronte di tale
andamento, si riscontra una crescita molto forte del consumo di energia
(e, conseguentemente, delle emissioni di CO2) da parte delle economie
più sviluppate.
Totale
consumo finale di energia – 1971-2012 (MTOE)
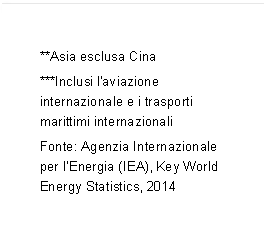
Le
emissioni di gas ad effetto serra da parte delle economie più
sviluppate hanno avuto il seguente andamento nel periodo 1990-2012:
L’UE
ha conseguito risultati generalmente valutati positivamente nella riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra, come si evince anche dal confronto
internazionale.
Emissioni
di gas serra (escluso LULUCF- tonnellate CO2 equivalenti – migliaia)
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
UE
28
|
4.646,7
|
4.756,1
|
4.607,7
|
4.548,3
|
|
Germania
|
912,6
|
946,3
|
928,6
|
939,0
|
|
Spagna
|
359,6
|
347,1
|
345,8
|
340,8
|
|
Francia
|
509,2
|
516,4
|
490,0
|
490,2
|
|
Italia
|
490,3
|
499,8
|
487,4
|
461,1
|
|
Regno
Unito
|
593,3
|
609,6
|
565,7
|
582,8
|
|
Fonte:
Agenzia europea per l’Ambiente, marzo 2015
|
Emissioni di gas serra (escluso
LULUCF- tonnellate CO2 equivalenti – migliaia) – 2011
|
|
|
Giappone
|
1.307,7
|
|
Russia
|
2.320,8
|
|
Stati
Uniti
|
6.665,7
|
|
Brasile
|
862,8
|
|
Cina
|
7.465,9
|
|
India
|
1.523,8
|
|
Fonte: Eurostat, The EU in the world 2014
|
La struttura del consumo
lordo per il 2012 mostra ancora un peso preponderante del consumo di
petrolio (34%), seguito dal gas (23%), dai combustibili solidi (17%).
Il nucleare ha raggiunto la quota del 14% e le fonti di rinnovabili
l’11%.
In questo quadro, è
interessante notare come il ricorso ai combustibili solidi si è ridotto,
tra il 1990 e il 2012, del 10% (dal 27% al 17%) mentre, nel medesimo
periodo, il consumo di energia da fonti rinnovabili è aumentato dal 4%
all’11%. La composizione dei consumi varia tra i vari Stati membri a
seconda del tipo e della quantità delle risorse naturali disponibili, della struttura
dell'economia e dei sistemi energetici.
EU-28: quote nazionali delle fonti di energia nel
consumo interno lordo, 2012
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment
indicators - 2014
Interessante è il notevole sviluppo delle energie
rinnovabili nel medesimo periodo 1990-2012.
EU-28:
produzione di energia da fonti rinnovabili (1990-2012)
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment
indicators - 2014
Il risparmio energetico è uno degli obiettivi
della Strategia Europa 2020 (in tale anno, il consumo di energia
primaria dovrà essere pari a 1.483 Mtoe).
EU-28: risparmio energetico 2005-2012 (%)
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment
indicators - 2014
Il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio energetico è funzionale anche alla necessità per
l’Unione europea di raggiungere un maggior grado di indipendenza energetica,
vista la relativa scarsità di risorse energetiche proprie.
La figura che segue illustra
l’andamento delle importazioni dei più importanti prodotti energetici
nel periodo 1990-2012.
UE-28,
importazioni di prodotti energetici, 1990-2012 (1.000 TJ)
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment
indicators – 2014
La principale fonte delle
importazioni europee è la Russia (per
tutti i tipi di prodotti: carburanti solidi, gas naturale e petrolio greggio),
anche se, nel tempo, il grado di dipendenza europeo da tale paese è andato
ridimensionandosi.
|
UE
-28, importazioni di prodotti energetici dalla Russia, 2002-2012 (% totale
importazioni extra UE)
|
|
|
2002
|
2005
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
Combustibili
solidi
|
13.1
|
23.7
|
30.0
|
26.9
|
26.2
|
25.9
|
|
|
Petrolio
greggio
|
29.5
|
22.9
|
33.5
|
34.7
|
34.8
|
33.7
|
|
|
Gas
naturale
|
45.2
|
40.7
|
33.0
|
29.5
|
31.6
|
32.0
|
|
|
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators -
2014
|
I
dati dimostrano che, sebbene sia stato fatto uno sforzo per diversificare il
grado di dipendenza dell’UE da un singolo paese esportatore, la dipendenza
energetica complessiva dell’UE è rimasta, nel periodo 2002-2012,
sostanzialmente stabile.
|
Dipendenza
energetica totale, 2009-2012 (%)
|
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
UE
28
|
53.7
|
52.7
|
53.9
|
53.4
|
|
UE
18
|
63.8
|
62.1
|
62.2
|
61.0
|
|
Germania
|
61.0
|
60.0
|
61.5
|
61.1
|
|
Spagna
|
79.1
|
76.8
|
76.4
|
73.3
|
|
Francia
|
51.0
|
49.1
|
48.7
|
48.1
|
|
Italia
|
83.3
|
84.3
|
81.8
|
80.8
|
|
Regno
Unito
|
26.3
|
28.3
|
36.2
|
42.2
|
|
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators -
2014
|
La
prima Comunicazione definisce innanzitutto gli
obiettivi dell'Unione dell'energia e illustra la Strategia quadro volta a
realizzarli. La Commissione europea mira a costruire un'Unione dell'energia
solida, articolata intorno ad un'ambiziosa politica per il clima in grado di
garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva
a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è superare la
frammentazione attuale trasformando i 28 mercati nazionali in un unico
mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse,
che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le
frontiere.
La
Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia intende mettere in primo piano
i cittadini, che devono poter usufruire di opzioni sufficienti nella
scelta dei loro fornitori, poter controllare in modo adeguato i loro costi e
vedere diminuiti i rischi di back out. Gli Stati membri, dal canto loro,
dovranno essere consapevoli di dipendere gli uni dagli altri nell'assicurare ai
loro cittadini un approvvigionamento energetico sicuro.
Inoltre,
l'Unione dell'energia dovrà attirare investimenti nel settore delle
infrastrutture energetiche che a loro volta dovranno adeguarsi alla transizione
verso la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La
Strategia quadro prevede una serie di misure ed iniziative volte a modificare
drasticamente il sistema energetico europeo attuale e si
basa su cinque dimensioni strettamente collegate e che si rafforzano a
vicenda: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del
mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda;
decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. Per
ciascuna di queste dimensioni la Commissione illustra una serie di azioni e
indica in una Tabella di marcia un calendario per la loro
adozione e attuazione.
Per
quanto concerne la prima dimensione della sicurezza energetica, solidarietà
e fiducia, obiettivo della Commissione europea è quello di garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti. Per fare ciò occorre innanzitutto ridurre la
dipendenza energetica attraverso la diversificazione delle fonti, dei
fornitori e delle rotte di approvvigionamento. A tale fine la Commissione
europea intende: intensificare i lavori del corridoio meridionale del trasporto
del gas per favorire le importazioni dall'Asia centrale; favorire l'accesso a
fornitori alternativi dal Mediterraneo e dall'Algeria; ridurre il consumo di
petrolio e investire sulle fonti rinnovabili. Inoltre, la Commissione mira a
sfruttare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) sul quale sarà
elaborata una strategia globale che considererà anche l'infrastruttura di
trasporto e lo stoccaccio. Presenterà poi una proposta di revisione del
regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti che farà
parte di un pacchetto di resilienza e diversificazione per il settore del gas.
Poiché la sicurezza degli approvvigionamenti dipende anche dalla capacità
degli Stati membri di collaborare tra loro e dalla possibilità di contare
sui propri vicini, soprattutto nei casi di perturbazione degli
approvvigionamenti, la Commissione intende proporre dei piani di prevenzione e
di emergenza a livello regionale e dell'Ue volti ad istituire una gestione
comune delle crisi. Inoltre, valuterà la possibilità di adottare dei meccanismi
di aggregazione volontaria della domanda per acquisti collettivi di gas in caso
di crisi o dipendenza da un unico fornitore. Perseguirà poi il fine della
sicurezza degli approvvigionamenti anche nell'ambito della politica
commerciale, inserendo delle clausole sull'energia negli accordi commerciali,
istituendo partenariati strategici sull'energia con paesi quali
l'Algeria, la Turchia, l'Azerbaijan, il Medio oriente e l'Africa e consolidando
quelli esistenti con la Norvegia e l'Ucraina. Inoltre valuterà il riassetto
delle relazioni con la Russia nel settore dell'energia. Infine, si adopererà
per garantire maggiore trasparenza nell'approvvigionamento di gas,
assicurando la conformità al diritto dell'Ue degli accordi stipulati con i
paesi terzi per l'acquisto di gas. Attualmente tale verifica viene fatta ex
post, con tutte le problematiche derivanti dall'eventuale necessità di
rinegoziare accordi già conclusi. La Commissione, pertanto, intende riesaminare
la normativa sugli accordi intergovernativi al fine di garantire una migliore
valutazione della compatibilità al diritto dell'Unione ex ante.
Circa
la seconda dimensione relativa alla piena integrazione del mercato interno
dell'energia, la Commissione sottolinea come sia necessario migliorare le
infrastrutture, in particolare i collegamenti transfrontalieri e le
interconnessioni. A tale riguardo il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha
posto un obiettivo specifico di interconnessione minima per l'energia
elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10% della capacità di
produzione elettrica installata degli Stati membri. In altri termini, il 10%
dell'elettricità deve poter "attraversare le frontiere". Le misure
previste a tale scopo sono illustrate nella terza Comunicazione facente parte
del Pacchetto "Unione dell'energia", di cui si veda infra. La
Commissione europea periodicamente farà il punto sull'avanzamento dei grandi
progetti infrastrutturali e presenterà una relazione annuale sui progressi
compiuti per raggiunger l'obiettivo di interconnessione del 10%. Sempre per
garantire la realizzazione del mercato interno dell'energia occorrerà
investire circa 200 miliardi di euro l'anno per i prossimi dieci
anni in grandi progetti infrastrutturali, quali le reti energetiche,
attraverso i mezzi disponibili, ovvero il Meccanismo per collegare l'Europa, i
fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS), e attraverso altresì investimenti privati. Al
fine poi di garantire l'accesso ai finanziamenti, sarà allestito, nell'ambito
del Fondo europeo per gli investimenti strategici, un "Portale degli
investimenti", il cui scopo è migliorare la trasparenza dell'iter
dei progetti e rendere le informazioni accessibili ai potenziali investitori.
Per far sì che il mercato interno dell'energia sia pienamente integrato occorrerà
inoltre garantire la piena applicazione e il rispetto della normativa
vigente, in particolare le disposizioni in materia di concorrenza nonché
quelle contenute nel 3° pacchetto sul mercato interno dell'energia.
Riguardo a quest'ultimo, la Commissione intende dare piena realizzazione alle
misure ivi contenute, provvedendo, in alcuni casi, a rafforzarle. Ad esempio,
intende incrementare i poteri dell'ACER, l'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia, conferendole funzioni di regolamentazione a
livello europeo e di monitoraggio dello sviluppo del mercato interno, per poter
affrontare tutte le questioni transfrontaliere derivanti dall'integrazione
dello stesso. La Commissione elaborerà poi una proposta legislativa per
riconfigurare il mercato dell'energia integrando il commercio all'ingrosso e al
dettaglio. Essa sarà volta ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e
a garantire un aumento del numero dei produttori, in particolare di quelli che
utilizzano fonti energetiche rinnovabili. La Commissione intende poi
intervenire nell'ambito dei meccanismi di regolazione di capacità e a tal
proposito ha già pubblicato degli orientamenti e delle norme per limitare gli
effetti dannosi di alcune forme di intervento pubblico. La Commissione mira a
garantire che i meccanismi di regolazione della capacità e il sostegno
all'elettricità da fonti rinnovabili non falsino il mercato dell'energia.
Particolare attenzione sarà poi rivolta ai consumatori che in futuro
dovrebbero poter godere di più ampie possibilità di scelta, acquistando energia
anche da società con sedi in altri Stati membri. I consumatori dovranno inoltre
poter usufruire di tecnologie in grado di consentire loro di monitorare il
proprio consumo energetico e avere facile accesso alle informazioni relative ai
costi. A tal riguardo la Commissione intende promuovere la standardizzazione
dei contatori intelligenti a livello nazionale e premiare altresì l'uso
flessibile dell'energia. Inoltre, si impegnerà per la graduale eliminazione
delle tariffe regolamentate sottocosto che di fatto scoraggiano il libero
mercato e alla lunga risultano dannose per i consumatori stessi. Gli Stati
membri saranno pertanto incoraggiati ad eliminare progressivamente queste
tariffe e ad istituire un meccanismo di tutela dei consumatori vulnerabili
nell'ambito del sistema generale di previdenza sociale.
Circa
la terza dimensione dell'efficienza energetica come mezzo per moderare la
domanda di energia, la Commissione ricorda che obiettivo dell'Unione,
fissato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, è quello di migliorare del 27%
l'efficienza energetica entro il 2030. Nel 2020 vi sarà una revisione in vista
di un obiettivo del 30%. La Commissione intende quindi incoraggiare gli Stati
membri affinché diano all'efficienza energetica un posto preminente nelle loro
politiche. I settore maggiormente interessati sono quelli dell'edilizia
e dei trasporti. Nel settore edilizio, la Commissione si concentrerà sul
potenziale offerto dal teleriscaldamento e dal teleraffreddamento, che saranno oggetto
di una strategia apposita. Inoltre si adopererà per attrarre il maggior numero
di investimenti possibile nella progettazione di edifici ad alta efficienza
energetica e nella riqualificazione di quelli esistenti. Per quanto attiene il
settore dei trasporti, che rappresentano più del 30% del consumo finale di
energia in Europa, la Commissione si adopererà per rendere più severe le norme
sul consumo di CO2 per le autovetture e i furgoni e per ridurne il consumo da
parte dei veicoli pesanti e degli autobus. Promuoverà l'utilizzo di sistemi di
tariffazione stradale basati sui principi "chi usa paga" e "chi
inquina paga". Inoltre, investirà nei settori che producono basse
emissioni di gas effetto serra, quali il trasporto ferroviario, il trasporto
marittimo e le vie navigabili interne. Si concentrerà poi sulla
decarbonizzazione del settore dei trasporti, che dipende ancora dal petrolio,
incoraggiando la diffusione di carburanti alternativi, l'elettrificazione del
parco automobilistico e di altri mezzi di trasporto.
La
quarta dimensione, quella della decarbonizzazione dell'economia,
riguarda la politica climatica dell'Unione europea e il settore delle energie
rinnovabili, nel quale l'Unione aspira a diventare leader mondiale. Sul
clima l'Unione persegue una politica ambiziosa, con un obiettivo di ridurre
di almeno il 40% delle emissioni di gas effetto serra rispetto al 1990 entro il
2030. Questo rappresenta il contributo che l'Unione fornirà nell'ambito dei
negoziati mondiali sul clima che si svolgeranno a Parigi nel 2015, di cui si
veda infra. Per quanto concerne le energie rinnovabili obiettivo
dell'Unione è quello di raggiungere la quota del 27% di energia da fonti
rinnovabili entro il 2030. A tale scopo proporrà un nuovo pacchetto sulle
energie rinnovabili che comprenderà una politica per la biomassa e i
biocomustibili sostenibili, e altre norme per garantire l'obiettivo sia
raggiunto con efficacia dei costi.
Infine,
per quanto concerne la quinta dimensione, relativa alla ricerca,
all'innovazione e alla competitività, la Commissione annuncia che metterà a
punto una strategia R&I per l'energia che perseguirà i seguenti obiettivi:
garantire all'Unione europea la leadership mondiale nello sviluppo della
prossima generazione delle energie rinnovabili; agevolare la partecipazione dei
consumatori alla transizione energetica mediante reti intelligenti e città
intelligenti; disporre di tecnologia in grado di rendere il parco immobiliare
neutro dal punto di vista energetico; dotare l'Unione di sistemi di trasporto più
sostenibili. La strategia R&I perseguirà anche altre priorità, quali quella
di definire un approccio lungimirante alla cattura e allo stoccaggio del
carbonio e alla cattura e al consumo del carbonio, mantenere la leadership
tecnologia nel settore del nucleare, continuando a garantire che gli Stati
membri utilizzino i migliori standard in materia di sicurezza, gestione dei
rifiuti e non proliferazione
Oltre
che su queste cinque dimensioni, la Commissione europea pone l'accento sulla
necessità che l'Unione dell'energia sia dotata di una governance integrata
che garantisca che tutte le azioni intraprese a livello nazione, regionale e
locale siano in linea con gli obiettivi fissati. Il processo di governance sarà
volto, tra l'altro, a combinare le azioni in materia di clima ed energia a
quelle in altri settori strategici per garantire una maggiore coerenza
programmatica a lungo termine e dare così agli investitori maggiore certezza.
La seconda Comunicazione è incentrata sul tema dei
cambiamenti climatici e sul dibattito politico in atto a livello mondiale per
la negoziazione di un nuovo accordo sul clima, che coinvolga tutte le
principali economie del mondo e sostituisca l'attuale impianto del Protocollo
di Kyoto, basato sulla responsabilizzazione dei paesi industrializzati.
Questo accordo dovrebbe essere raggiunto durante la ventunesima Conferenza
delle Parti attualmente in corso a Parigi (COP21) e dovrebbe entrare in vigore
dopo il 2020. Obiettivo generale, perseguito
anche dall'Unione europea, è quello di limitare il riscaldamento globale a 2°
al di sopra delle temperature medie del periodo pre-industriale. Come già
ricordato, nell'ottobre 2014 il Consiglio europeo ha adottato le Conclusioni
sul Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, sulle quali cui si
baserà la posizione europea in occasione della COP21. Esse stabiliscono che
entro il 2030 l'Unione dovrà ridurre le proprie emissioni del 40% rispetto ai
livelli del 1990.
La presente Comunicazione
illustra la visione dell'UE per nuovo accordo trasparente, dinamico e giuridicamente
vincolante sui cambiamenti climatici. In particolare, essa:
-
traduce la
decisione presa dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014 nell’obiettivo per le
emissioni proposto dall’UE, ossia il suo contributo previsto stabilito a
livello nazionale (di seguito "INDC" - Intended Nationally Determined
Contribution), che deve essere presentato entro la fine del primo trimestre del
2015;
-
propone che
tutte le Parti dell’UNFCCC presentino i loro INDC con ampio anticipo rispetto
alla Conferenza di Parigi;
-
traccia le
linee di un accordo trasparente, dinamico e giuridicamente vincolante che
contenga impegni equi e ambiziosi di tutte le Parti stabiliti in base a una
situazione geopolitica ed economica mondiale in costante evoluzione;
-
propone che
l’accordo del 2015 sia un protocollo dell’UNFCCC, al quale le grandi economie,
in particolare l’UE, la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero aderire il più presto
possibile.
Il "Protocollo di
Parigi", dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi :
-
garantire
riduzioni ambiziose di emissioni, precisando che l'obiettivo a lungo termine è
ridurre le emissioni mondiali di almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai
livelli del 2010 e definire impegni chiari che consentano di raggiungere
l'obiettivo dei 2°. La riduzione delle emissioni dovrebbe riguardare tutti i
settori, compresi quello dell'agricoltura, della silvicoltura, dei trasporti
aerei e marittimi;
-
garantire
un dinamismo degli impegni attraverso un riesame completo da effettuarsi ogni
cinque anni;
-
rafforzare
la trasparenza e l’assunzione di responsabilità, mediante un insieme comune di
norme e procedure da applicare alla rendicontazione annuale, alla verifica
periodica e all’esame degli inventari delle emissioni a cura di esperti
internazionali;
-
incoraggiare
uno sviluppo sostenibile resiliente ai cambiamenti climatici promuovendo la
cooperazione internazionale;
-
promuovere
un’attuazione e una cooperazione efficienti ed efficaci, incoraggiando
investimenti pubblici e privati, in programmi e politiche a basse emissioni,
resilienti ai cambiamenti climatici.
La Comunicazione illustra
inoltre la strategia diplomatica dell'Unione in vista della COP21, che prevede
le seguenti azioni:
-
porre i
cambiamenti climatici al centro dei dialoghi politici, in particolare in
occasione delle riunioni del G7 e del G20, nonché all’Assemblea generale delle
Nazioni Unite;
-
sostenere
uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici e alle
catastrofi attraverso la cooperazione allo sviluppo dell’UE;
-
collegare
il cambiamento climatico alle sue potenziali conseguenze a lungo termine, ivi
compresi i problemi di sicurezza.
Queste azioni si sommeranno ad
altre politiche dell'Unione che possono contribuire agli obiettivi della stessa
nel negoziato internazionale e nell’applicazione del protocollo nei paesi
partner. Si tratta in particolare delle politiche in materia di cooperazione
economica e allo sviluppo, di ricerca scientifica, nonché della politica
commerciale, della politica ambientale e della politica in materia gestione
delle catastrofi.
Infine, la Comunicazione
illustra gli impegni futuri dell'Unione europea, che dovrà innanzitutto
presentare il proprio INDC entro la fine del primo trimestre del 2015. A tal
proposito si segnala che nel corso della riunione del Consiglio
"Ambiente" svoltasi il 6 marzo 2015, sono stati adottati gli INDC
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, che si sono impegnati a conseguire
entro il 2030 un obiettivo vincolante, da realizzarsi congiuntamente, di una
riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra di almeno il 40%
rispetto ai livelli del 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio
europeo di ottobre 2014. Lo stesso giorno gli INDC sono stati trasmessi al
Segretariato dell'UNFCCC. L'Unione europea, inoltre, si adopererà per
dimostrare e garantire la stabilità e la prevedibilità del sostegno finanziario
che l’UE fornisce collettivamente ai propri partner internazionali per
stimolare uno sviluppo a basse emissioni e resiliente al clima e in ultimo
premerà affinché si giunga alla rapida liberalizzazione (entro la fine del
2015) degli scambi di beni e servizi ambientali.
La
Comunicazione è corredata da un Allegato che
contiene informazioni generali e curve di emissione dei maggiori produttori
mondiali di emissioni.
La terza Comunicazione illustra la strategia della Commissione europea in materia di interconnessioni, volta al
raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione elettrica del 10% fissato dal
Consiglio europeo dell'ottobre 2014. Nonostante negli ultimi dieci anni gli
Stati membri abbiano potenziato le proprie capacità di interconnessione, ben dodici
Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno raggiunto l'obiettivo del 10% e
rimangono isolati nel mercato interno dell'energia elettrica. Le
infrastrutture energetiche rappresentano pertanto una priorità della politica
energetica europea. In tale contesto particolare attenzione è rivolta alle strutture
interconnesse che consentono di rafforzare la sicurezza degli
approvvigionamenti, garantiscono prezzi più accessibili nel mercato interno e
favoriscono il conseguimento degli obiettivi in materia di decarbonizzazione
del mix energetico e di politica climatica grazie alla riduzione delle
emissioni di CO2. Inoltre, incrementare l'interconnessione della rete
consentirà all'Unione europea di realizzare la sua ambizione di divenire leader
mondiale nel settore delle energie rinnovabili.
Come già accennato al
paragrafo n. 1 della presente Scheda, l'Unione europea si è dotata di una serie
di strumenti di intervento per favorire gli investimenti nelle infrastrutture
di rete. Nell'ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR),
elaborato a seguito della crisi economica, sono stati individuati alcuni
progetti di interconnessione e spesi circa 650 milioni di euro per le
interconnessioni elettriche. Altri strumenti sono il Regolamento TEN-E,
adottato nel 2013
e il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE),
che consentono di individuare progetti lungo 12 corridoi, aree prioritarie e
di assicurarne la realizzazione. Progetti di comune interesse ( PIC) sono 248 e
sono stati individuati in un primo elenco nel 2013, di questi ben 52
riguardano le interconnessioni elettriche. Entro il 2020 la Commissione prevede
il completamento di circa il 75% dei progetti. Il secondo elenco dei PIC
dovrebbe essere adottato dalla Commissione europea nell'autunno 2015. In questo
contesto sarà conferita particolare importanza ai progetti che potenzieranno la
capacità di interconnessione in quei paesi che sono al di sotto dell'obiettivo
del 10%. Per quanto riguarda l'Italia i progetti previsti (che riguardano le
interconnessioni con Francia, Svizzera e Austria) potrebbero portare, una volta
completati, la capacità di interconnessione al 12% entro il 2020. La
Commissione prevede che entro tale data occorrerà investire circa 200 miliardi
di euro nelle infrastrutture necessarie a garantire un'adeguata
interconnessione. In particolare, per i progetti legati all'energia elettrica
saranno necessari 105 miliardi di euro, di cui 35 miliardi per le
interconnessioni. Nell'ambito del MCE nel bilancio 2014-2020, sono stati
stanziati 5.35 miliardi di euro, e nell'ambito Fondo europeo e di sviluppo
regionale (FESR) ne saranno stanziati circa 2 miliardi. Con il Fondo europeo
per investimenti strategici (FEIS), presentato dalla Commissione nel gennaio
2015, potranno essere finanziati molti PIC e altri progetti di
interconnessione. Inoltre con il futuro Polo europeo di consulenza sugli
investimenti (EIAH) potranno essere individuati, ed attuati progetti di
investimento.
La Comunicazione si sofferma
poi sull'esigenza di garantire una maggiore cooperazione a livello regionale e
indica quattro regioni che dovranno compiere ulteriori sforzi in tale senso: la
regione baltica, la penisola iberica, i paesi del mar del Nord, l'Europa
centrale e sudorientale. Questi gruppi regionali definiranno, con la
collaborazione della Commissione, dei piani d'azione corredati da tappe precise
per la realizzazione dell'obiettivo 10%. La Commissione seguirà da vicino
l'attuazione dei piani d'azione e promuoverà l'armonizzazione dei metodi di
lavoro dei vari gruppi regionali.
Infine la Comunicazione
illustra le prospettive future che riguardano l'innalzamento al 15% entro il
2030 dell'obiettivo di interconnessione. Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014
ha invitato la Commissione europea a riferire periodicamente sui progressi
realizzati in tal senso.
La Comunicazione è
accompagnata da due Allegati
relativi rispettivamente ai progetti cofinanziati dal Programma energetico
europeo per la ripresa e ai PIC.
(a cura del
Servizio Studi della Camera)
La Strategia energetica nazionale (SEN) contiene le linee
direttrici della politica energetica italiana dei prossimi decenni. Essa indica
quattro obiettivi principali:
- l'allineamento dei costi
energetici a quelli europei, con una previsione di circa 9 miliardi di
euro l'anno di risparmi sulla bolletta elettrica e gas a livello nazionale
(sui 70 miliardi di spesa totale attuale);
- il superamento di tutti gli
obiettivi ambientali europei (riduzione delle emissioni di CO2,
penetrazione delle rinnovabili, riduzione del consumo di energia). Questi
includono la riduzione delle emissioni di gas serra del 21% rispetto al
2005 (obiettivo europeo: 18%), riduzione del 24% dei consumi primari
rispetto all'andamento inerziale (obiettivo europeo: 20%) e raggiungimento
del 19-20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi
(obiettivo europeo: 17%). In particolare, ci si attende che le rinnovabili
diventino la prima fonte nel settore elettrico al pari del gas con
un'incidenza del 35-38%;
- il rafforzamento della nostra
sicurezza ed indipendenza di approvvigionamento, con una riduzione di
circa 14 miliardi l'anno di acquisti energetici dall'estero (rispetto ai
62 miliardi attuali, e -19 rispetto alle importazioni tendenziali 2020),
con la riduzione dall'84 al 67% della dipendenza dall'estero. Ciò equivale
a circa 1% di PIL addizionale e, ai valori attuali, sufficiente a
riportare in attivo la bilancia dei pagamenti, dopo molti anni di passivo;
- la spinta alla crescita
economica guidata dal settore energetico, con una previsione di circa 180
miliardi di euro di investimenti di qui al 2020, sia nella green e white
economy (rinnovabili e efficienza energetica), sia nei settori
tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo
idrocarburi). Si tratta di investimenti privati, solo in parte supportati
da incentivi, e con notevole impatto in termini di competitività e
sostenibilità del sistema.
Per ottenere questi obiettivi, la SEN individua 7 priorità
d'azione, ciascuna dettagliata in misure concrete da prendere:
- Efficienza energetica
- Mercato competitivo del gas e
hub sud-europeo
- Sviluppo sostenibile delle
energie rinnovabili
- Sviluppo delle infrastrutture
e del mercato elettrico
- Ristrutturazione della
raffinazione e della rete di distribuzione carburanti
- Produzione sostenibile di
idrocarburi nazionali
- Modernizzazione del sistema di
governance
Il Rapporto "La situazione energetica nazionale nel
2014
A luglio 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha
presentato il Rapporto "La situazione energetica nazionale nel 2014".
Nel Rapporto si mette in evidenza che il fabbisogno energetico lordo
dell'Italia nel 2014 è stato di 166,43 Milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio (Mtep), con un decremento del 3,8 % rispetto al 2013, a fronte di una
riduzione del PIL in termini reali dello 0,4. La diminuzione della domanda di
energia primaria conferma il trend di riduzione registratosi negli ultimi anni,
rappresentando il valore, in termini assoluti, più basso da 18 anni. In termini
di composizione percentuale delle fonti energetiche impiegate per la copertura
della domanda nel 2014, rispetto al 2013, è stabile il petrolio (dal 33,7% del
2013 al 34,4%) e i combustibili solidi (dall' 8,2% all' 8,1%) e diminuisce gas,
dal 33,2% al 30,5%. Aumenta di poco l'importazione netta di energia elettrica
dal 5,4% al 5,7%, mentre continuano a crescere della quota delle fonti
rinnovabili che passa dal 19,5% al 21,2%. Nel 2014, la produzione nazionale di
fonti energetiche è cresciuta complessivamente del 2,8%, passando da 43,8 a
45,4 Mtep. La quota delle importazioni nette di energia rispetto al fabbisogno
energetico nazionale si riduce, da 74,7% del 2013 al 73,6% nel 2014. L'Italia,
nel confronto con la media dei 28 paesi dell'Unione Europea, si caratterizza
per un maggior ricorso al gas naturale, all'import strutturale di elettricità,
al ridotto contributo dei combustibili solidi e al mancato ricorso alla fonte
nucleare.
Energie rinnovabili
Nell'ambito della Strategia energetica nazionale il concetto
chiave in materia di fonti rinnovabili è quello di un loro "sviluppo
sostenibile". L'Italia intende superare gli obiettivi di produzione
rinnovabile europei (‘20-20-20'), contribuendo in modo significativo alla
riduzione di emissioni e all'obiettivo di sicurezza energetica, ma
contemporaneamente vuole realizzare lo scopo di contribuire alla ripresa
economica. Oltre a valorizzare le energie rinnovabili nell’ambito della green
economy[35],
si impone il vincolo di contenere la spesa in bolletta che grava su
imprese e famiglie, allineando il livello degli incentivi ai valori europei e
spingendo lo sviluppo dell'energia rinnovabile termica, che ha un buon
potenziale di crescita e costi specifici inferiori a quella elettrica. L'Italia
ha prezzi dell'energia mediamente superiori ai suoi concorrenti europei e ad
altri paesi come gli Stati Uniti. Questa situazione rappresenta un fattore di
grave appesantimento per la competitività del sistema economico italiano, ed
una delle cause è dovuta al peso sui costi energetici degli incentivi alla
produzione rinnovabile elettrica in Italia. Tali incentivi, che derivano dai
molteplici meccanismi di sostegno che convivono in Italia, sono storicamente i
più elevati d'Europa (ad esempio, quelli alla produzione fotovoltaica sono
circa il doppio di quelli tedeschi), con un forte impatto sul costo
dell'energia: circa il 20% circa della bolletta elettrica italiana (escluse
imposte) è destinato al sostegno della produzione di elettricità tramite fonti
rinnovabili.
Per quanto riguarda il settore elettrico, l'obiettivo
italiano è quello di sviluppare le rinnovabili fino al 35-38% dei consumi
finali al 2020. Con tale contributo, la produzione rinnovabile diventerà la
prima componente del mix di generazione elettrica in Italia, al pari del gas.
Si consideri che la produzione di energia rinnovabile elettrica negli ultimi
anni ha avuto uno sviluppo fortissimo, guidato dagli incentivi di cui si
diceva. Nel settore elettrico, l'obiettivo 20-20-20 è stato raggiunto, con
quasi 8 anni di anticipo: nel 2013 sono stati prodotti 112 TWh di energia
elettrica, mentre nel 2014 la stima preliminare si attesta sui 118
TWh.
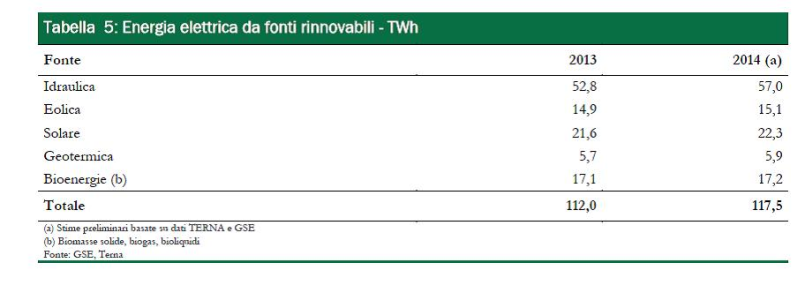
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili rappresentano
circa il 37% della potenza complessiva istallata in Italia e il 31% della
produzione lorda totale Questo è dovuto ad una forte crescita delle
installazioni negli ultimi anni, in particolare degli impianti fotovoltaici:
che hanno raggiunto i 21,6 TWh (siamo secondi solo alla Germania). Il grafico
che segue illustra l’evoluzione della potenza e della numerosità degli impianti
fotovoltaici installati in Italia.
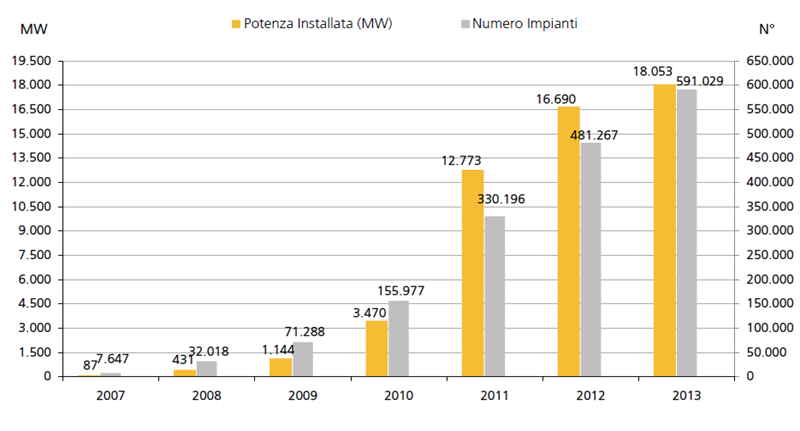
Il sistema incentivante italiano non ha tenuto in debito
conto della rapida diminuzione dei costi legati alle tecnologie (la tecnologia
fotovoltaica ha abbattuto i suoi costi di circa il 70% dal 2008 al 2012). Da
alcuni anni, come si diceva, per contenere i costi in bolletta il sostegno alle
fonti rinnovabili – ed al fotovoltaico in particolare – ha subito una brusca
sterzata. Dalla metà del 2013 sono esauriti i fondi del Quinto Conto Energia
per l'incentivazione del fotovoltaico, in quanto è stata raggiunta la soglia
dei 6,7 miliardi di euro. In seguito, sono stati emanati alcuni provvedimenti,
cosiddetti “spalma-incentivi”[36],
mirati a ridurre il costo annuo dell’incentivazione.
Produzione degli impianti fotovoltaici in Italia
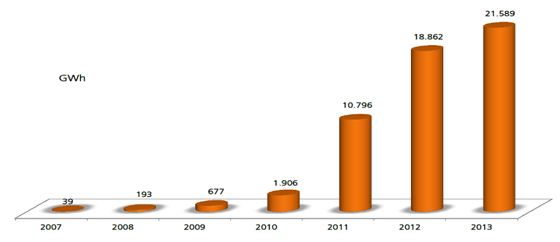
La crescente produzione da fonti intermittenti e non
programmabili rappresenta inoltre sempre più una sfida per l'infrastruttura
di rete e per il mercato, per i problemi di dispacciamento che essa comporta.
La produzione rinnovabile discontinua è ad esempio concentrata (e probabilmente
destinata a concentrarsi ancor più) al Sud, Centro-Sud e nelle isole, con una
potenza attesa già al 2016 superiore alla domanda di punta di quest'area
(25.000 MW contro i 21.000 MW), mentre la domanda è maggiore in Nord Italia.
Sono necessari, quindi, interventi di rafforzamento della rete sulle principali
sezioni critiche tra zone di mercato. Inoltre, per quanto riguarda gli oneri da
sbilanciamento, sarà importante adottare un approccio che stimoli i produttori
da fonti rinnovabili a programmare la propria produzione tenendo conto delle,
possibilità effettive di previsione delle diverse tecnologie, e che favorisca
una gestione aggregata degli impianti e dei carichi. Molto importanti saranno
gli sviluppi circa la riduzione dei costi ed il miglioramento delle prestazioni
della capacità di accumulo elettrico per garantire lo sviluppo in
sicurezza delle energie rinnovabili elettriche.
Il contributo fornito dalle fonti rinnovabili nel settore
Termico è un fenomeno che è stato approfondito dal punto di vista
statistico solo negli anni più recenti, grazie principalmente alle attività di
rilevazione sviluppate dal GSE ai fini del monitoraggio degli obiettivi europei
sugli impieghi di FER e alla realizzazione di importanti rilevazioni sul tema.
Nel 2013 risultano consumati circa 10,6 Mtep di fonti rinnovabili per
riscaldamento, pari al 18% dei consumi termici complessivi del Paese; in
particolare, 9,8 Mtep sono stati consumati in modo diretto (attraverso stufe,
camini, pannelli solari, pompe di calore, impianti di sfruttamento del calore
geotermico), mentre 0,8 Mtep sono relativi ai consumi di calore prodotto da
attività di trasformazione, principalmente impianti di cogenerazione e sistemi
di teleriscaldamento alimentati da biomasse (calore derivato). I dati
preliminari relativi al 2014 indicano una leggera flessione della produzione
complessiva rispetto all'anno precedente, stimabile in circa 0,4 Mtep,
associata principalmente alle più favorevoli condizioni climatiche. La fonte
rinnovabile di gran lunga più importante per la produzione di energia termica è
costituita dalla biomassa solida (7,8 Mtep nel 2013 e 7,3 Mtep secondo le stime
preliminari del 2014), utilizzata soprattutto nel settore domestico in forma di
legna da ardere e pellet; è ancora piuttosto limitato, invece, lo sfruttamento
della risorsa geotermica e di quella solare (complessivamente 0,3 Mtep - 0,4
Mtep). È da sottolineare, infine, il contributo rilevante fornito delle pompe
di calore (oltre 2,5 Mtep sia nel 2013 che nel 2014). I dati suesposti e la
Tabella che segue sono tratti dal Rapporto MISE sulla "Situazione
energetica nazionale nel 2014".
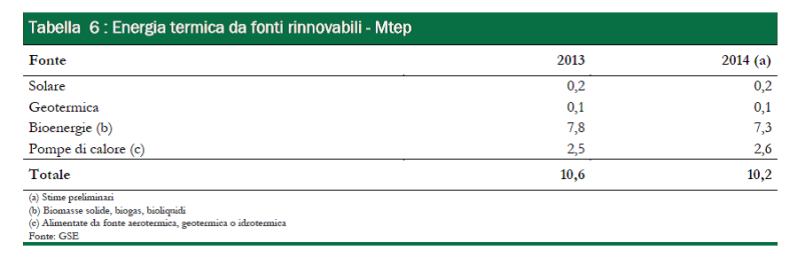
L'obiettivo nazionale per il settore termico è quello
di sviluppare la produzione di rinnovabili fino al 20% dei consumi finali al
2020 (dal 17% dell'obiettivo 20-20-20), pari a circa 11 Mtep/anno. Il
raggiungimento dell'obiettivo è legato alla sostituzione di una parte degli
impianti esistenti alimentati a combustibili convenzionali, alle nuove
installazioni, all'evoluzione degli obblighi di integrazione delle rinnovabili
nell'edilizia. Le dimensioni proposte implicano anche lo sviluppo o
l'ampliamento, ove economicamente conveniente, di infrastrutture di rete per la
diffusione del calore rinnovabile, attraverso l'attivazione di un Fondo di
garanzia, e la costituzione di un sistema statistico, con la diffusione di
sistemi di misura e contabilizzazione del calore. Nei prossimi anni, le azioni
saranno dunque volte ad un'ampia crescita di tecnologie quali caldaie a
biomassa, pompe di calore, solare termico, ecc. Per razionalizzare e garantire
continuità dei meccanismi di supporto, è stato introdotto un Conto Termico per
l'incentivazione degli interventi di più piccole dimensioni, con a disposizione
fino a circa 900 milioni di euro l'anno. Saranno inoltre attivati i previsti
strumenti a sostegno delle reti di teleriscaldamento.
Le fonti rinnovabili termiche rappresentano un elemento
fondamentale della strategia italiana di raggiungimento degli obiettivi
'20-20-20', grazie alla loro efficienza di costo e alla facilità di
installazione diffusa. Fino ad oggi, queste tecnologie sono state piuttosto
trascurate dalle politiche energetiche del Paese e dalla regolazione;
nonostante ciò, hanno visto uno sviluppo spontaneo importante. I consumi
termici rappresentano la quota più importante dei nostri consumi energetici,
sia nei settori civili che industriali (circa il 45% dei consumi finali
complessivi). Rispetto alle rinnovabili elettriche, quelle termiche risultano
in generale più efficienti e meno costose per il raggiungimento degli
obiettivi europei (in termini di costo per tonnellata di CO2 evitata o di costo
per KWh di energia finale prodotta), e comportano benefici significativi di
risparmio combustibile per il consumatore finale (ad esempio attraverso il
riscaldamento a biomassa), e per il Paese nel suo complesso (riduzione import
di combustibili fossili). Lo sviluppo delle rinnovabili termiche negli ultimi 5
anni è avvenuto in assenza di un quadro di incentivazione stabile e dedicato,
in grado di orientare il consumatore verso le tecnologie più
"virtuose". Prevalentemente, le misure a supporto sono state
sovrapponibili a quelle per l'efficienza energetica – detrazioni fiscali e
certificati bianchi – in assenza di iniziative dedicate. Il Paese è ben
posizionato nel segmento industriale delle rinnovabili termiche, in particolare
nell'ambito delle biomasse, in cui circa il 65% della tecnologia è di
produzione italiana.
Per lo stimolo delle rinnovabili termiche di piccola taglia
(destinato prevalentemente al settore civile), è stato varato un decreto
ministeriale che incentiva direttamente l'installazione di impianti dedicati,
il cosiddetto "Conto Termico" (DM 28 dicembre 2012). Tale
meccanismo:
- garantisce l'accesso al regime
incentivante alle tecnologie più virtuose, con criteri minimi stabiliti
per ciascuna tipologia di intervento e requisiti che integrano, ove
possibile, l'efficienza energetica.
- assegna incentivi a copertura
di una quota dei costi di investimento iniziale, variabili in base alla
taglia e alla zona climatica, corrisposti in 2 anni (per piccoli
interventi domestici) o 5 anni (per gli altri) e con premialità
addizionali per le tecnologie più efficienti. Dalle interazioni avute con
le associazioni di consumatori e produttori, si ritiene che questa formula
possa avere un elevato tasso di gradimento e dunque di adesione, con tutta
probabilità superiore allo strumento delle detrazioni fiscali.
Al 2020, il Conto Termico da solo consentirà di raggiungere
il target PAN per le rinnovabili termiche, pari al 17% dei consumi finali
lordi, ovvero ~10 Mtep.
Con il D.L. 133/2014 (cd. Sblocca-Italia) si è
cercato di dare nuovo impulso a tale tipologia di incentivazione, cercando di
facilitare l'accesso ad imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per
gli interventi:
- di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili;
- di incremento dell'efficienza
energetica di piccole dimensioni,realizzati in data successiva al 31
dicembre 2011.
Si prevede a tal fine che l'aggiornamento del sistema di
incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) venga effettuato
entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti
per favorire l'accesso alle risorse stanziate. L'applicazione di tale nuovo
sistema prevede un monitoraggio entro il 31 dicembre 2015. Sulla base del
monitoraggio è prevista l'adozione di un decreto modificativo della disciplina
vigente. L'incentivo viene inoltre reso accessibile da parte dei soggetti di
edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi
della Pubblica Amministrazione. Il Ministero ha aperto una consultazione
pubblica fino al 28 febbraio 2015 sulle nuove misure per la semplificazione e
il potenziamento del meccanismo di del "Conto Termico", ha
predisposto l'aggiornamento del decreto ad aprile 2015, e successivamente è
stata avviata la fase di concertazione con i Ministeri interessati (Ambiente e
politiche agricole), ma il decreto non è stato ancora adottato, in
quanto attualmente all'esame presso la Conferenza Unificata.
Per quanto riguarda il settore Trasporti,
l'impiego delle fonti rinnovabili è costituito dall'immissione in consumo di
biocarburanti, per un contenuto energetico complessivo che nel 2013 è stato
pari a circa 1,25 Mtep, mentre i dati preliminari relativi al 2014
indicherebbero una flessione di circa 0,2 Mtep. In entrambi gli anni la quota
principale di biocarburanti immessi in consumo in Italia (90-95%) è costituita
da biodiesel.
I dati suesposti e la tabella che segue sono tratti dal
Rapporto del MISE "La situazione energetica nazionale nel 2014".

La strategia energetica nazionale conferma l'obiettivo
europeo al 2020 di un contributo da biocarburanti pari a circa il 10% dei
consumi, ovvero circa 2,5 Mtep/anno. Ci si propone di spingere quanto possibile
l'adozione di biocarburanti di seconda generazione, preservando tuttavia gli
investimenti già effettuati sulla produzione di biocarburanti di prima
generazione. In termini di costi per il sistema, dato il differenziale di
prezzo per la quota di biocarburanti, l'impatto al 2020 potrebbe ammontare a
circa 1 miliardo di euro l'anno.
La riduzione delle bollette elettriche
Una delle cause degli alti costi dell'energia in Italia
rispetto agli altri paesi è da ricercarsi nel peso degli incentivi alla
produzione rinnovabile elettrica. Tali incentivi sono storicamente i più
elevati d'Europa (ad esempio, gli incentivi unitari alla produzione
fotovoltaica sono circa il doppio di quelli tedeschi), con un forte impatto sul
costo dell'energia: circa il 20% circa della bolletta elettrica italiana
(escluse imposte) è destinato a incentivi alla produzione tramite fonti
rinnovabili (componente A3 della bolletta).
I provvedimenti emanati nella XVII legislatura
Con il D.L. 145/2013, c.d. Destinazione Italia (convertito
in legge 9/2014) sono state previste numerose disposizione che vanno nella
direzione di ridurre le bollette energetiche. In particolare, con il cosiddetto
"spalma-incentivi volontario" (articolo 1, commi 3-6) si propone ai
produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che
beneficiano di incentivi un'alternativa tra continuare a godere del regime
incentivante spettante per il periodo di diritto residuo oppure optare per la
fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga del periodo di
incentivazione. In tal modo si cerca di ridurre il peso della componente A3
sulle bollette dei prossimi anni, senza effetti retroattivi sui contratti già
stipulati.
Con il D.L. 91/2014, l'obiettivo della riduzione delle
bollette elettriche si concentra sulle piccole e medie imprese, alle quali sono
destinati i risparmi sulle componenti tariffarie effettuati col decreto.
Anzitutto, con il cosiddetto "spalma-incentivi obbligatorio" (articolo
26), vengono introdotte nuove modalità di erogazione degli incentivi a
carico delle tariffe elettriche riconosciute all'energia prodotta dai grossi
impianti fotovoltaici. In particolare, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
(G.S.E. S.p.A.) – a decorrere dal secondo semestre 2014 – eroga le tariffe
incentivanti con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della
producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio,
riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla
produzione effettiva. Ai produttori viene lasciata la scelta tra tre opzioni:
a.
l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di
una rimodulazione del valore unitario dell'incentivo di entità dipendente dalla
durata del periodo incentivante residuo;
b.
il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una
riduzione dell'incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento
dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal MiSE;
c.
il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una
riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia
degli impianti (tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da
parte dell'operatore).
La medesima norma prevede la possibilità per i beneficiari
di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, di cedere una quota fino all'80% degli incentivi per le
fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali attraverso un'asta
organizzata dall'Autorità per l'energia. Alle quote di incentivi cedute agli
acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le
rimodulazioni precedenti. Tale possibilità di cessione è però subordinata alla
verifica da parte del ministero dell'Economia della compatibilità degli effetti
delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica.
Altri risparmi sulle componenti della bolletta arrivano
dalla rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello
Stato, dalla riduzione dei costi per le isole minori non interconnesse,
dall'esclusione degli sconti ai dipendenti delle aziende elettriche dagli oneri
generali di sistema, dalle norme sulle reti interne di utenza e i sistemi
efficienti di utenza. Lo stesso decreto contiene norme di semplificazione
amministrativa e di regolazione per interventi di efficienza energetica. Le
semplificazioni, che sono operate attraverso apposite integrazioni alla
disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 28/2011, riguardano tra l'altro la procedure
per l'autorizzazione realizzazione di interventi di efficienza energetica,
piccoli impianti a fonti rinnovabili, e di impianti di produzione di biometano.
Per quanto riguarda i decreti di attuazione di queste norme
che mirano alla riduzione degli oneri di incentivazione dell'energia elettrica
da fotovoltaico e da altre fonti rinnovabili, si ricordano:
·
lo spalma-incentivi volontario (previsto dall'articolo 1, commi
3-6 del DL 145/2013), che stabilisce le modalità di ridefinizione volontaria
degli incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Il decreto interessa in particolare ai produttori da fonti rinnovabili
interessati a operazioni di rifacimento o ripotenziamento del sito, e porta ad
un prolungamento di sette anni del periodo di diritto agli incentivi, con una
conseguente riduzione dell'erogazione annua (DM 6 novembre 2014);
·
lo spalma-incentivi obbligatorio per i grandi impianti
fotovoltaici (previsto dall'articolo 26, comma 3, del DL 91/2014), che
regolamenta la rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di
potenza superiore a 200 kW nell'arco dei venti anni (DM 17 ottobre 2014).
·
il DM 16 ottobre 2014, sulle modalità di erogazione degli
incentivi al fotovoltaico da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE
Spa, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 91/2014. Sulla
base del provvedimento, ai produttori sarà riconosciuto, ogni anno, un acconto
pari al 90%, calcolato sulla base della produzione effettiva dell'anno
precedente, con saldo entro 60 giorni dall'invio delle misure sulla produzione
effettiva e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il Ministero stima di poter ottenere tramite queste misure
una tra 500 e 700 milioni di euro l'anno, a partire dal 2015.
Efficienza energetica
In termini di efficienza energetica, l'Italia parte già da
un buon livello medio. E' uno dei primi paesi per intensità energetica in
Europa, con un livello inferiore alla media di circa il 14%, nonostante una
struttura economica in cui l'industria manifatturiera ha un peso superiore alla
media europea (anche se, negli ultimi due decenni, altri Paesi europei hanno
mediamente migliorato tale indicatore in maniera più forte rispetto a quanto
fatto dall'Italia). L'Italia vanta inoltre una consolidata tradizione
industriale in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica
(caldaie, motori, inverter, smart grid, edilizia, …).
Rimane tuttavia un potenziale di miglioramento importante. Da quanto risulta
dall'ultimo Rapporto dell'ENEA (giugno 2015) relativo all'anno 2013, grazie
alle politiche nazionali per l'efficienza energetica l'Italia ha risparmiato
7,55 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all'anno, pari a
oltre 2 miliardi di euro di minori importazioni di gas naturale e petrolio,
evitando la produzione di 18 milioni di tonnellate di CO2. Inoltre, grazie al
solo meccanismo delle detrazioni fiscali, i cosiddetti ‘ecobonus', oltre 2
milioni di famiglie hanno investito 22 miliardi di euro per riqualificare
energeticamente le proprie abitazioni dal 2007 al 2013, con un indotto di 40
mila occupati in media l'anno. Il Rapporto evidenzia che nel 2013 è stato
raggiunto oltre il 20% dell'obiettivo di efficienza previsto per il 2020; tra i
settori che hanno maggiormente contribuito a questo risultato il residenziale e
l'industria.
Relativamente all'anno 2014, il Rapporto del MISE sulla
situazione energetica italiana, evidenzia che il fabbisogno energetico lordo
del Paese nel 2014 si è ridotto del 3,8% rispetto al 2013 (nel 2014 è stato di
166,43 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), che rappresenta il
valore, in termini assoluti, più basso da 18 anni) e che il decremento del
fabbisogno energetico del 2014 è stato determinato dall'azione
congiunta della recessione economica, della ricomposizione settoriale della
produzione e della maggiore efficienza energetica.
Coerentemente con la strada tracciata nel 2013 dalla Strategia
Energetica Nazionale, nell'attuale legislatura, è stato adottato il provvedimento
di recepimento della Direttiva sull'Efficienza Energetica, D.Lgs. n.
102/2014, sia il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEEE,
con D.M. 17 luglio 2014), nonchè sono state adottate misure sull'efficienza
energetica nel patrimonio edilizio, attraverso la leva delle detrazioni per la
riqualificazione energetica degli edifici (i cd. ecobonus) e sulla
certificazione energetica.
Il Decreto Legislativo 102/2014
Il D.Lgs. n. 102/2014 ha recepito in Italia la Direttiva
2012/27/UE10 stabilendo un quadro di misure per la promozione e il
miglioramento dell'efficienza tese al raggiungimento degli obiettivi nazionali
di risparmio energetico definiti al 2020, pari alla riduzione dei consumi di
energia primaria di 20 Mtep/anno, equivalenti a 15,5 Mtep/anno di energia
finale. Per quanto riguarda il settore industriale, entro il 5 dicembre 2015 (e
successivamente ogni quattro anni) le grandi aziende e le imprese ad alta
intensità energetica saranno tenute ad eseguire diagnosi energetiche
periodiche, utili per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i
consumi di energia. Per incentivare la realizzazione dei progetti di efficienza
energetica definiti sulla base delle diagnosi realizzate, il Decreto prevede un
ulteriore potenziamento del meccanismo dei Certificati Bianchi, nonché
l'istituzione di schemi di certificazione e accreditamento per la conformità
alle norme tecniche in materia di Società di Servizi Energetici, esperti in
gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia e diagnosi energetiche.
Per il settore edilizio, l'ENEA viene incaricata di elaborare una proposta di
interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili, sia pubblici che privati, anche per aumentare il
numero di Edifici a Energia Quasi Zero. Per il settore pubblico è previsto un
programma annuale di interventi di riqualificazione energetica negli edifici
della Pubblica Amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici,
relativi ad almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata, da
realizzare ricorrendo al finanziamento tramite terzi e ai contratti di
rendimento energetico. Inoltre, nell'ambito delle forniture di prodotti e
servizi della Pubblica Amministrazione centrale, il provvedimento rafforza il
vincolo di acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica. Il
provvedimento istituisce, inoltre, il Fondo nazionale per l'efficienza
energetica, un importante strumento finanziario di supporto alla
riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione ed
agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori
dell'industria e dei servizi. Il decreto prevede, inoltre una cabina di regia
per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, composta
dallo Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si potrà avvalere della
collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici).Le
modalità di funzionamento sono stabilite dal decreto 9 gennaio 2015
Si ricorda che sul relativo schema di decreto legislativo (Atto n. 90) le Commissioni parlamentari competenti hanno reso
il parere nella seduta del 18 giugno 2014. La X Commissione della Camera dei
Deputati ha richiesto (si veda la seduta del 18 giugno) un approfondimento sulla riforma del
mercato elettrico, clausole di salvaguardia per il superamento della
progressività delle tariffe elettriche, la garanzia dell'Iva al 10% per i
contratti di prestazione energetica stipulati con la pubblica amministrazione
indipendentemente dai combustibili utilizzati e che la nozione di contratto di
servizio energia sia interpretata nel senso di fornitura di servizi e non di
fornitura di combustibile al cliente. La Commissione Industria del Senato, nel
proprio parere, ha posto come condizioni, tra le altre, di rendere
permanente l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici, di riformulare le condizioni sul teleriscaldamento e di ampliare la
platea degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno
in modo da ricomprendere anche gli immobili di proprietà delle Regioni e degli
altri Enti territoriali. Si segnala infine, che la X Commissione attività
produttive della Camera ha recentemente reso (il 22 ottobre 2015) parere
favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni integrative al D.Lgs. n. 102/2014, finalizzato a dare
risposta ai rilievi della Commissione europea di incompleto recepimento
nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza
energetica.
Per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli
edifici il decreto-legge 63/2013 ha recepito la direttiva
2010/31/UE in materia di certificazione energetica degli edifici,
sostituendo l'attestato di certificazione energetica con il nuovo attestato
di prestazione energetica (APE). Tale decreto ha anche potenziato il regime
di detrazioni fiscali. Tali misure nel corso degli anni sono state
ulteriormente prorogate.
Il disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444),
attualmente all'esame in seconda lettura presso la Camera, dispone la ulteriore
proroga per l'anno 2016 degli ecobonus relativi agli interventi di
riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli
edifici condominiali, e di quelli concernenti gli interventi antisismici
(articolo 1, comma 41-43).
In uno studio
realizzato ad ottobre 2015 dal Servizio Studi della Camera in collaborazione
con l'istituto di ricerca CRESME su "Il recupero e la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di
incentivazione" si evidenzia che gli incentivi fiscali in esame hanno
interessato dal 1998 al 2015 oltre 12,5 milioni di interventi. Nello
stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti
pari a 207 miliardi di euro (una media di 11 miliardi di euro all'anno a valori
correnti), di cui 178 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e poco
meno di 30 miliardi la riqualificazione energetica. Il dato a consuntivo per il
2014 indica un volume di investimenti pari a 28,5 miliardi di euro, di cui 24,5
miliardi di euro sono relativi al recupero e 3,9 alla riqualificazione
energetica.
Il 1° ottobre 2015 è la data di entrata in vigore dei
decreti del MiSE 26 giugno 2015:
- sull'applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- sulle modalità di riferimento
per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici.
- sull'adeguamento delle linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, che aggiorna
le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli
edifici.


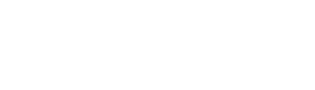
![]() @SR_Studi
@SR_Studi