|
Senato della Repubblica
|
Camera dei deputati
|
Documentazione per le Commissioni
Dossier europei
Audizione del Commissario europeo Miguel Arias Cañete sui temi del clima e dell'energia
Roma, 25 giugno 2015
|
Senato della Repubblica n. 1 |
Camera dei deputati n. 19 |
24 giugno 2015
XVII LEGISLATURA
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea della Camera dei deputati (' 06 6760.2145 - * cdrue@camera.it) e dal Servizio Studi del Senato della Repubblica (' 06 6706.2891 - * affeuropei@senato.it).
________________________________________________________________
I dossier dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati declinano ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
INDICE
La politica energetica dell’UE Pag. 1
Il recente dibattito sull'Unione dell'Energia 5
Il Pacchetto "Unione dell'energia" 10
Scheda di lettura
Il 25 giugno 2015 avrà luogo l'audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, presso la Sala del Mappamondo della Camera dei deputati.
L'audizione è stata organizzata dalle Commissioni congiunte VIII (Ambiente), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 10ª (Industria, commercio turismo), 13ª (Territorio, ambiente e beni culturali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica.
In vista di tale evento, la presente nota fornisce elementi sulla politica energetica dell'UE; una breve panoramica sui recenti sviluppi del dibattito sul pacchetto "Unione dell'energia", presentato dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015; un richiamo agli esiti dell'esame svolto presso il Senato della Repubblica; un'illustrazione dettagliata delle misure previste nel pacchetto.
1) La politica energetica dell’UE
Il consumo interno lordo di energia nell'UE-28 ha mostrato nel periodo 1990-2012 un andamento tendenzialmente stabile: nel 2012 è stato inferiore dell'1% rispetto al 2011 (circa 70,5 milioni di terajoule - TJ).
EU-28: consumo interno lordo di energia, 1990-2012 (1.000 TJ)

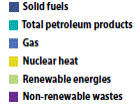 |
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
A fronte di tale andamento, si riscontra una crescita molto forte del consumo di energia (e, conseguentemente, delle emissioni di CO2) da parte delle economie più sviluppate.
Totale consumo finale di energia – 1971-2012 (MTOE)

 |
Le emissioni di gas ad effetto serra da parte delle economie più sviluppate hanno avuto il seguente andamento nel periodo 1990-2012:
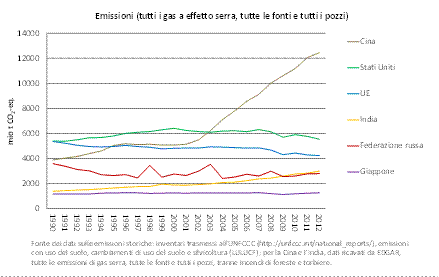 |
L’UE ha conseguito risultati generalmente valutati positivamente nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, come si evince anche dal confronto internazionale.
Emissioni di gas serra (escluso LULUCF- tonnellate CO2 equivalenti – migliaia)
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
UE 28 |
4.646,7 |
4.756,1 |
4.607,7 |
4.548,3 |
|
Germania |
912,6 |
946,3 |
928,6 |
939,0 |
|
Spagna |
359,6 |
347,1 |
345,8 |
340,8 |
|
Francia |
509,2 |
516,4 |
490,0 |
490,2 |
|
Italia |
490,3 |
499,8 |
487,4 |
461,1 |
|
Regno Unito |
593,3 |
609,6 |
565,7 |
582,8 |
|
Fonte: Agenzia europea per l’Ambiente, marzo 2015 |
||||
Emissioni di gas serra (escluso LULUCF- tonnellate CO2 equivalenti – migliaia) – 2011
|
tonnellate CO2 equiv – migl. – 2011 |
|
|
Giappone |
1.307,7 |
|
Russia |
2.320,8 |
|
Stati Uniti |
6.665,7 |
|
Brasile |
862,8 |
|
Cina |
7.465,9 |
|
India |
1.523,8 |
|
Fonte: Eurostat, The EU in the world 2014 |
|
La struttura del consumo lordo per il 2012 mostra ancora un peso preponderante del consumo di petrolio (34%), seguito dal gas (23%), dai combustibili fossili (17%). Il nucleare ha raggiunto la quota del 14% e le fonti di rinnovabili l’11%.
In questo quadro, è interessante notare come il ricorso ai combustibili fossili si è ridotto, tra il 1990 e il 2012, del 10% (dal 27% al 17%) mentre, nel medesimo periodo, il consumo di energia da fonti rinnovabili è aumentato dal 4% all’11%. La composizione dei consumi varia tra i vari Stati membri a seconda del tipo e della quantità delle risorse naturali disponibili, della struttura dell'economia e dei sistemi energetici.
EU-28: quote nazionali delle fonti di energia nel consumo interno lordo, 2012
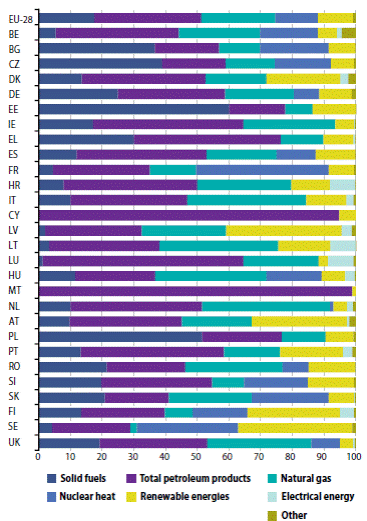 |
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
Interessante è il notevole sviluppo delle energie rinnovabili nel medesimo periodo 1990-2012.
EU-28: produzione di energia da fonti rinnovabili (1990-2012)
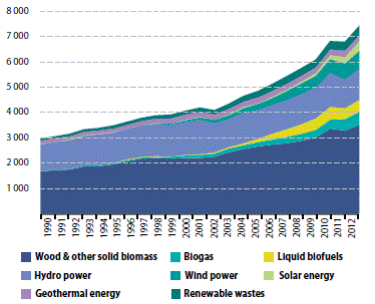 |
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
Il risparmio energetico è uno degli obiettivi della Strategia Europa 2020 (in tale anno, il consumo di energia primaria dovrà essere pari a 1.483 Mtoe).
EU-28: risparmio energetico 2005-2012 (%)
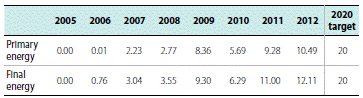
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014
Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico è funzionale anche alla necessità per l’Unione europea di raggiungere un maggior grado di indipendenza energetica, vista la relativa scarsità di risorse energetiche proprie.
La figura che segue illustra l’andamento delle importazioni dei più importanti prodotti energetici nel periodo 1990-2012.
UE-28, importazioni di prodotti energetici, 1990-2012 (1.000 TJ)
 |
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators – 2014
La principale fonte delle importazioni europee è la Russia (per tutti i tipi di prodotti: carburanti solidi, gas naturale e petrolio greggio), anche se, nel tempo, il grado di dipendenza europeo da tale paese è andato ridimensionandosi.
|
UE -28, importazioni di prodotti energetici dalla Russia, 2002-2012 (% totale importazioni extra UE) |
||||||
|
|
2002 |
2005 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Combustibili solidi |
13.1 |
23.7 |
30.0 |
26.9 |
26.2 |
25.9 |
|
Petrolio greggio |
29.5 |
22.9 |
33.5 |
34.7 |
34.8 |
33.7 |
|
Gas naturale |
45.2 |
40.7 |
33.0 |
29.5 |
31.6 |
32.0 |
|
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014 |
||||||
I dati dimostrano che, sebbene sia stato fatto uno sforzo per diversificare il grado di dipendenza dell’UE da un singolo paese esportatore, la dipendenza energetica complessiva dell’UE è rimasta, nel periodo 2002-2012, sostanzialmente stabile.
|
Dipendenza energetica totale, 2009-2012 (%) |
||||
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
UE 28 |
53.7 |
52.7 |
53.9 |
53.4 |
|
UE 18 |
63.8 |
62.1 |
62.2 |
61.0 |
|
Germania |
61.0 |
60.0 |
61.5 |
61.1 |
|
Spagna |
79.1 |
76.8 |
76.4 |
73.3 |
|
Francia |
51.0 |
49.1 |
48.7 |
48.1 |
|
Italia |
83.3 |
84.3 |
81.8 |
80.8 |
|
Regno Unito |
26.3 |
28.3 |
36.2 |
42.2 |
|
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014 |
||||
2) Il recente dibattito sull'Unione dell'Energia
Lo scorso 8 giugno il Consiglio "Telecomunicazione, Trasporti, Energia", ha adottato le Conclusioni sull'attuazione dell'"Unione dell'energia", il pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015.
Il pacchetto "Unione dell'energia", che si compone di tre comunicazioni - una Strategia quadro, una comunicazione in materia di clima, e una in materia di interconnessioni, illustrate più dettagliatamente al paragrafo 2 - contiene una serie di misure e di iniziative relative a vari settori di intervento, volte a garantire energia sicura, sostenibile, competitiva a prezzi accettabili, attraverso la piena integrazione del mercato. In particolare, l'Unione dell'energia si basa su cinque dimensioni strettamente collegate, che si rafforzano a vicenda: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività.
Le conclusioni, pur sottolineando l'importanza delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, si focalizzano su due temi orizzontali, ovvero i consumatori e gli investimenti.
In particolare, per quanto concerne i consumatori, il Consiglio riconosce che l'obiettivo di costruire un'Unione dell'energia è quello di fornire alle famiglie e alle imprese energia sicura, competitiva, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili. Pertanto, al fine di promuovere l'attuazione dell'Unione dell'energia orientata al consumatore, ribadisce l'importanza di un mercato interno dell'energia flessibile e dinamico in grado di garantire stabilità dei prezzi. Insiste, inoltre, sull'importanza della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, affermando la necessità di ridurre la dipendenza dell'Ue, mediante la diversificazione delle rotte, delle fonti e dei fornitori dell'energia. In questo contesto, rispondendo ad una specifica richiesta avanzata dal Governo italiano, il Consiglio richiama la necessità di sviluppare anche le interconnessioni con i paesi terzi. Ribadisce poi, ai fini della creazione di un mercato interno dell'energia, l'importanza di applicare appieno le norme dell'UE, tra cui il terzo pacchetto sull'energia[1], nonché la necessità di affrontare la mancanza di interconnessioni energetiche, spesso causa dell'aumento dei prezzi, di combattere la povertà energetica, con attenzione alle specificità nazionali, di aiutare i consumatori in situazioni di vulnerabilità, mediante una combinazione adeguata di politiche sociali, energetiche e dei consumatori. Sempre ai fini della realizzazione del mercato dell'energia, sottolinea l'esigenza di informare adeguatamente i consumatori dando loro la possibilità di partecipare attivamente al mercato e di rispondere ai segnali di prezzo, stimolando così la concorrenza e aumentando la flessibilità. Inoltre, il Consiglio ribadisce la necessità di mettere i consumatori in condizione di controllare il proprio consumo energetico, mediante, ad esempio, l'utilizzo di reti e contatori intelligenti. Riconoscendo poi gli aspetti positivi dell'efficienza energetica nel ridurre i costi dell'energia per i consumatori, sottolinea l'esigenza di assicurare agli stessi l'accesso a informazioni trasparenti e a incentivi adeguati per risparmiare energia, nonché a strumenti e a regimi di finanziamento mirati. Ribadisce poi l'importanza di un approvvigionamento energetico a basse emissioni di Co2 per i consumatori e prende atto della necessità di integrare nel mercato risorse autoconone sicure e sostenibili, con particolare riferimento a quelle rinnovabili. In questo contesto sottolinea l'importanza di una strategia di ricerca e innovazione lungimirante in grado in promuovere lo sviluppo di reti e sistemi energetici intelligenti ("smart grids"), lo stoccaggio di energia per l'uso di elettricità, la nuova generazione di energie rinnovabili e altre fonti di energia anche per i sistemi di riscaldamento, raffreddamento e per i trasporti.
Per quanto concerne gli investimenti nel settore energetico, il Consiglio afferma innanzitutto l'esigenza di migliorare il clima di investimento mediante un quadro giuridico stabile e trasparente e una politica lungimirante su clima ed energia. Sostiene l'importanza di una cooperazione regionale rafforzata nel settore in termini di investimenti, e ribadisce la necessità di concentrare gli stessi nelle infrastrutture energetiche, nell'efficienza energetica e nella generazione a basse emissioni di CO2. A tale scopo, sostiene l'utilizzo di tutte le possibili fonti di finanziamento, ivi comprese quelle dell'Ue, con particolare riferimento a quelle che stimolano la cooperazione regionale, per facilitare l'accesso ai finanziamenti di progetti, in particolare i progetti di interesse comune (PIC) di carattere non commerciale. Al fine di ridurre la dipendenza energetica, sottolinea la necessità di accelerare i lavori sui progetti infrastrutturali, in particolare le interconnessioni con le regioni periferiche, e a tal riguardo, pone l'accento sui progetti di interesse comune nel settore del gas, quali il corridoio nord-sud, nonché sui progetti volti alla creazione di un nuovo hub gasiero nell'Europa meridionale, e al potenziamento della sicurezza energetica della Finlandia e degli Stati baltici. Inoltre, in vista della realizzazione del mercato interno dell'energia occorrerà mobilitare tutti gli sforzi affinché gli Stati membri che non hanno ancora conseguito il livello minimo di interconnessione riescano a realizzare con urgenza tale obiettivo (il 10%) entro il 2020. Si tratta in particolare degli Stati baltici, del Portogallo e della Spagna. Il Consiglio ribadisce poi l'importanza di integrare la rete dell'energia elettrica degli Stati baltici nella rete continentale europea e di rivolgere particolare attenzione alle zone meno ben collegate come Malta, Cipro e Grecia. Chiede poi sostegno politico e finanziario al fine di migliorare l'efficienza energetica, in particolare nei settori del riscaldamento e del raffreddamento urbani, nell'edilizia e nei trasporti. Incoraggia gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili nonché le iniziative volte a promuovere la leadership dell'Unione europea nella tecnologia e nell'innovazione nei settori dell'energia e del clima.
Infine, sempre nelle Conclusioni, il Consiglio indica le prossime tappe per la costruzione dell'Unione dell'energia, invitando le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a proseguire in questa direzione. Il Consiglio riferirà su questo aspetto al Consiglio europeo del dicembre 2015. La Commissione europea dovrà inoltre presentare iniziative sul tema della governance dell'Unione dell'energia, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2015 e dell'ottobre 2014[2], al fine di riferirne sempre al Consiglio europeo di dicembre. All'Esecutivo europeo è inoltre chiesto di garantire maggiore trasparenza nella composizione dei costi e dei prezzi dell'energia e di valutare la portata di tutti gli attuali strumenti di finanziamento e dei regimi di investimento dell'UE nel settore dell'energia, evitando le distorsioni e le frammentazioni del mercato.
Sul tema della governance, è intervenuto il Commissario Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione europea e responsabile del pacchetto Unione dell'Energia, che ha fornito una breve illustrazione degli elementi che la Commissione intende sviluppare in vista della presentazione della relazione sull'Unione dell'energia nel prossimo autunno: un sistema di governance più integrato che tenga in considerazione diverse dimensioni (in particolare quella economica, ambientale, del clima e dei trasporti); una base fattuale, con un sistema di raccolta dati migliorato; obblighi di rendicontazione semplificati e più uniformi; lo sviluppo d piani nazionali del clima e dell'energia; stretta cooperazione tra Stati membri, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo.
Si ricorda, inoltre, che il Consiglio ha proceduto ad un dibattito orientativo sui progressi compiuti nell'attuazione della Strategia europea di sicurezza energetica[3], al quale ha preso parte il Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, che, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, ha informato i ministri circa i recenti contatti con altri fornitori quali l'Algeria, il Marocco, la Norvegia, e ha sottolineato la necessità di accelerare negli impegni con i paesi del Mediterraneo e dell'Asia centrale. Ha quindi annunciato che la Commissione europea intende presentare una proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti del gas entro la fine dell'anno nonché una strategia sul gas naturale liquefatto (GNL).
Il Pacchetto "Unione dell'Energia" è stato esaminato dal Consiglio europeo tenutosi il 19 e 20 marzo scorsi. Nelle Conclusioni, i Capi di Stato e di Governo hanno affermato l'impegno a costruire un'Unione dell'energia con politiche lungimiranti in materia di clima sulla base della Strategia quadro presentata dalla Commissione. Inoltre, hanno ribadito il proprio sostegno a favore di un'azione coordinata in vista della ventunesima Conferenza delle Parti che si svolgerà a Parigi nel dicembre 2015 (COP21)[4]. Hanno poi sottolineato l'importanza di intensificare il lavoro per conseguire soluzioni in materia di finanziamento, trasferimento di tecnologie e sviluppo di capacità, che rappresentano questioni chiave in vista del nuovo accordo mondiale sul clima accordo che dovrebbe raggiungersi a Parigi.
Il pacchetto "Unione dell'Energia" è stato esaminato dalle Commissioni riunite 10a (industria, commercio turismo) e 13a (territorio, ambiente, beni culturali) del Senato della Repubblica, che il 4 giugno scorso hanno adottato una risoluzione (DOC XVIII, n. 92), nella quale si sono espresse in senso favorevole, formulando alcuni rilievi. In particolare, per quanto concerne l'obiettivo e l'impegno dell'Unione europea a ridurre le emissioni del 40% entro il 2030[5] hanno sottolineato come esso debba essere commisurato agli obiettivi delle altre macroregioni del mondo e debba essere valutato in relazione alle scelte che queste ultime intendono fare in questa direzione. In materia di energie verdi e di efficienza energetica, la risoluzione sottolinea come gli obiettivi che l'Unione europea si prefigge di raggiungere per il 2030, tra cui il miglioramento dell'efficienza energetica del 27%, debbano essere realizzati nel contesto di accordi che coinvolgano tutte le principali economie del mondo, con riferimento alla prossima Conferenza sul clima che si terrà a Parigi (COP21) nel dicembre 2015 e ai negoziati sul Parternariato Transatlantico (TTIP) con gli Stati Uniti. Circa la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) proposta dalla Commissione europea e attualmente al vaglio delle istituzioni UE[6], si chiede se essa non rischi di introdurre nuove forme di sussidio nel quadro di un sistema di prezzi amministrati, nel qual caso dovrebbe essere valutata l'ipotesi alternativa di introdurre forme di carbon tax[7] sia sulle merci prodotte nell'Ue che su quelle di importazione. In materia di riduzione delle emissioni e di sicurezza degli approvvigionamenti, la risoluzione sottolinea l'importanza degli interventi volti a promuovere il risparmio energetico e l'uso di risorse interne. Per quanto concerne i rischi di carbon leakage[8] sostiene l'importanza di promuovere un sistema di compensazione non a livello nazionale ma a livello europeo, per evitare che i paesi con economie più forti possano effettuare compensazioni a favore delle proprie imprese nazionali, e che tale possibilità sia preclusa a Paesi con economie più deboli. In materia di sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, la risoluzione sostiene l'importanza di promuovere l'approvvigionamento dai giacimenti del Mediterraneo orientale, del Caspio, del Mediooriente e del Nord Africa. Circa poi gli obblighi di stoccaggio strategico dei gas introdotti da alcuni Stati membri, la Commissione europea è invitata a provvedere ad una gestione congiunta a livello europeo della quantità da conservare nel tempo, mentre per quanto concerne gli acquisti collettivi di gas in caso di crisi, la risoluzione sottolinea che la partecipazione a tali gruppi debba avere carattere volontario. La risoluzione chiede inoltre regole di accesso più semplici ai finanziamenti, soprattutto nel settore dei Progetti di interesse comune (PIC), con la possibilità di estendere ai finanziamenti anche i progetti che riguardano le interconnessioni con i paesi terzi, citando, nel caso dell'Italia, il progetto con la Tunisia. Più in generale chiede il superamento del vincolo che qualifica un "progetto di interesse comune" quello che interessa almeno due Stati membri dell'Unione. Tra gli altri rilievi formulati dalla risoluzione, si ricorda l'importanza di garantire un'efficace governance dell'energia, mediante una semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi e un quadro normativo chiaro. Quanto agli obiettivi che ciascuno Stato realizzi il 10% di interconnessioni elettriche entro il 2020 e il 15% entro il 2030, previsti dal pacchetto Unione dell'energia, la risoluzione sottolinea che essi debbano essere condizionati ad adeguate analisi dei costi-benefici, al fine di evitare investimenti non efficienti. Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, e in particolare delle fasce più vulnerabili, la risoluzione auspica un sistema dei prezzi basato sui consumi, mentre in materia di concorrenza, ritiene utile favorire la pluralità delle offerte e degli acquisti, anche sottoforma di acquisti consortili, da parte di soggetti pubblici o privati. In materia di politiche industriali volte a favorire l'innovazione tecnologica, chiede che nel settore dei trasporti vengano stabilite delle misure per migliorare l'efficienza dei carburanti e la riduzione delle emissioni, sopratutto dei mezzi pesanti e degli autobus, e che vengano introdotte iniziative volte ad incentivare la mobilità sostenibile tramite veicoli ibridi o elettrici. Per quanto concerne il passaggio a sistemi energetici e di produzione a bassa emissione di gas serra la risoluzione sottolinea che piuttosto che introdurre incentivi o disincentivi diretti, che nel tempo potrebbero influenzare negativamente i mercati e produrre inefficienza, è più opportuno puntare su norme regolatrici dei mercati. Circa gli obiettivi di riduzione di gas a effetto serra e sempre nel rispetto degli stessi, la risoluzione afferma l'opportunità di lasciare agli Stati membri la scelta di determinare il proprio mix energetico, alla luce delle diversità esistenti in ciascuno di essi in termini di clima, struttura produttiva, tecnologia utilizzata per la costruzione degli edifici.
Attualmente il pacchetto "Unione dell'Energia" è all’esame delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati.
Nell’ambito dell’esame sono state effettuate alcune audizioni che hanno coinvolto rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nonché rappresentanti di Enel, Terna, GDF Suez e dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU).
3) Il Pacchetto "Unione dell'energia"
Il 25 febbraio 2015 la Commissione europea ha presentato il pacchetto "Unione dell'Energia" nel quale illustra una serie di misure e di settori di intervento volti a modificare l'attuale quadro energetico europeo caratterizzato da una frammentazione delle politiche nazionali, da una eccessiva dipendenza da un numero limitato di fonti di approvvigionamento, in primo luogo di gas naturale, dall'assenza di posizioni comuni nei confronti di paesi terzi, da zone geografiche isolate dal punto di vista energetico, dalla scarsità di investimenti nel settore, da barriere di mercato, dalla necessità di garantire una competitività dei prezzi alle famiglie e alle imprese. Si ricorda, per inciso, che già nel 2014 con l’accordo sul Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima e sulla Strategia europea di sicurezza energetica è stato avviato un processo per pervenire a una visione comune delle modalità con cui portare avanti queste politiche nel futuro, tuttavia si richiedono ora ulteriori azioni in questa direzione[9].
Il Pacchetto "Unione dell'energia" si compone di tre comunicazioni e dei rispettivi allegati.
3.1) "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"
La prima Comunicazione[10] definisce innanzitutto gli obiettivi dell'Unione dell'energia e illustra la Strategia quadro volta a realizzarli. La Commissione europea mira a costruire un'Unione dell'energia solida, articolata intorno ad un'ambiziosa politica per il clima in grado di garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è superare la frammentazione attuale trasformando i 28 mercati nazionali in un unico mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse, che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere[11].
La Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia intende mettere in primo piano i cittadini, che devono poter usufruire di opzioni sufficienti nella scelta dei loro fornitori, poter controllare in modo adeguato i loro costi e vedere diminuiti i rischi di back out. Gli Stati membri, dal canto loro, dovranno essere consapevoli di dipendere gli uni dagli altri nell'assicurare ai loro cittadini un approvvigionamento energetico sicuro.
Inoltre, l'Unione dell'energia dovrà attirare investimenti nel settore delle infrastrutture energetiche che a loro volta dovranno adeguarsi alla transizione verso la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La Strategia quadro prevede una serie di misure ed iniziative volte a modificare drasticamente il sistema energetico europeo attuale[12] e si basa su cinque dimensioni strettamente collegate e che si rafforzano a vicenda: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. Per ciascuna di queste dimensioni la Commissione illustra una serie di azioni e indica in una Tabella di marcia un calendario per la loro adozione e attuazione.
Per quanto concerne la prima dimensione della sicurezza energetica, solidarietà e fiducia, obiettivo della Commissione europea è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per fare ciò occorre innanzitutto ridurre la dipendenza energetica attraverso la diversificazione delle fonti, dei fornitori e delle rotte di approvvigionamento. A tale fine la Commissione europea intende: intensificare i lavori del corridoio meridionale del trasporto del gas per favorire le importazioni dall'Asia centrale; favorire l'accesso a fornitori alternativi dal Mediterraneo e dall'Algeria; ridurre il consumo di petrolio e investire sulle fonti rinnovabili. Inoltre, la Commissione mira a sfruttare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) sul quale sarà elaborata una strategia globale che considererà anche l'infrastruttura di trasporto e lo stoccaccio. Presenterà poi una proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti[13] che farà parte di un pacchetto di resilienza e diversificazione per il settore del gas. Poiché la sicurezza degli approvvigionamenti dipende anche dalla capacità degli Stati membri di collaborare tra loro e dalla possibilità di contare sui propri vicini, soprattutto nei casi di perturbazione degli approvvigionamenti, la Commissione intende proporre dei piani di prevenzione e di emergenza a livello regionale e dell'Ue volti ad istituire una gestione comune delle crisi. Inoltre, valuterà la possibilità di adottare dei meccanismi di aggregazione volontaria della domanda per acquisti collettivi di gas in caso di crisi o dipendenza da un unico fornitore. Perseguirà poi il fine della sicurezza degli approvvigionamenti anche nell'ambito della politica commerciale, inserendo delle clausole sull'energia negli accordi commerciali, istituendo partenariati strategici sull'energia con paesi quali l'Algeria, la Turchia, l'Azerbaijan, il Medio oriente e l'Africa e consolidando quelli esistenti con la Norvegia e l'Ucraina. Inoltre, valuterà il riassetto delle relazioni con la Russia nel settore dell'energia. Infine, si adopererà per garantire maggiore trasparenza nell'approvvigionamento di gas, assicurando la conformità al diritto dell'Ue degli accordi stipulati con i paesi terzi per l'acquisto di gas. Attualmente tale verifica viene fatta ex post, con tutte le problematiche derivanti dall'eventuale necessità di rinegoziare accordi già conclusi. La Commissione, pertanto, intende riesaminare la normativa sugli accordi intergovernativi al fine di garantire una migliore valutazione della compatibilità al diritto dell'Unione ex ante.
Circa la seconda dimensione relativa alla piena integrazione del mercato interno dell'energia, la Commissione sottolinea come sia necessario migliorare le infrastrutture, in particolare i collegamenti transfrontalieri e le interconnessioni. A tale riguardo il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha posto un obiettivo specifico di interconnessione minima per l'energia elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10% della capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri. In altri termini, il 10% dell'elettricità deve poter "attraversare le frontiere". Le misure previste a tale scopo sono illustrate nella terza Comunicazione facente parte del Pacchetto "Unione dell'energia", di cui si veda infra. La Commissione europea periodicamente farà il punto sull'avanzamento dei grandi progetti infrastrutturali e presenterà una relazione annuale sui progressi compiuti per raggiunger l'obiettivo di interconnessione del 10%. Sempre per garantire la realizzazione del mercato interno dell'energia occorrerà investire circa 200 miliardi di euro l'anno per i prossimi dieci anni in grandi progetti infrastrutturali, quali le reti energetiche, attraverso i mezzi disponibili, ovvero il Meccanismo per collegare l'Europa, i fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e attraverso altresì investimenti privati. Al fine poi di garantire l'accesso ai finanziamenti, sarà allestito, nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, un "Portale degli investimenti", il cui scopo è migliorare la trasparenza dell'iter dei progetti e rendere le informazioni accessibili ai potenziali investitori. Per far sì che il mercato interno dell'energia sia pienamente integrato occorrerà inoltre garantire la piena applicazione e il rispetto della normativa vigente, in particolare le disposizioni in materia di concorrenza nonché quelle contenute nel terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia. Riguardo a quest'ultimo, la Commissione intende dare piena realizzazione alle misure ivi contenute, provvedendo, in alcuni casi, a rafforzarle. Ad esempio, intende incrementare i poteri dell'ACER, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, conferendole funzioni di regolamentazione a livello europeo e di monitoraggio dello sviluppo del mercato interno, per poter affrontare tutte le questioni transfrontaliere derivanti dall'integrazione dello stesso. La Commissione elaborerà poi una proposta legislativa per riconfigurare il mercato dell'energia integrando il commercio all'ingrosso e al dettaglio. Essa sarà volta ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e a garantire un aumento del numero dei produttori, in particolare di quelli che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. La Commissione intende poi intervenire nell'ambito dei meccanismi di regolazione di capacità e a tal proposito ha già pubblicato degli orientamenti e delle norme per limitare gli effetti dannosi di alcune forme di intervento pubblico. Particolare attenzione sarà poi rivolta ai consumatori che in futuro dovrebbero poter godere di più ampie possibilità di scelta, acquistando energia anche da società con sedi in altri Stati membri. I consumatori dovranno inoltre poter usufruire di tecnologie in grado di consentire loro di monitorare il proprio consumo energetico e avere facile accesso alle informazioni relative ai costi. A tal riguardo la Commissione intende promuovere la standardizzazione dei contatori intelligenti a livello nazionale e premiare altresì l'uso flessibile dell'energia. Inoltre, si impegnerà per la graduale eliminazione delle tariffe regolamentate sottocosto che di fatto scoraggiano il libero mercato e alla lunga risultano dannose per i consumatori stessi. Gli Stati membri saranno pertanto incoraggiati ad eliminare progressivamente queste tariffe e ad istituire un meccanismo di tutela dei consumatori vulnerabili nell'ambito del sistema generale di previdenza sociale.
Circa la terza dimensione dell'efficienza energetica come mezzo per moderare la domanda di energia, la Commissione ricorda che obiettivo dell'Unione, fissato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, è quello di migliorare del 27% l'efficienza energetica entro il 2030. Nel 2020 vi sarà una revisione in vista di un obiettivo del 30%. La Commissione intende quindi incoraggiare gli Stati membri affinché diano all'efficienza energetica un posto preminente nelle loro politiche. I settore maggiormente interessati sono quelli dell'edilizia e dei trasporti. Nel settore edilizio, la Commissione si concentrerà sul potenziale offerto dal teleriscaldamento e dal teleraffreddamento, che saranno oggetto di una strategia apposita. Inoltre si adopererà per attrarre il maggior numero di investimenti possibile nella progettazione di edifici ad alta efficienza energetica e nella riqualificazione di quelli esistenti. Per quanto attiene il settore dei trasporti, che rappresentano più del 30% del consumo finale di energia in Europa, la Commissione si adopererà per rendere più severe le norme sul consumo di CO2 per le autovetture e i furgoni e per ridurne il consumo da parte dei veicoli pesanti e degli autobus. Promuoverà l'utilizzo di sistemi di tariffazione stradale basati sui principi "chi usa paga" e "chi inquina paga". Inoltre, investirà nei settori che producono basse emissioni di gas effetto serra, quali il trasporto ferroviario, il trasporto marittimo e le vie navigabili interne. Si concentrerà poi sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti, che dipende ancora dal petrolio, incoraggiando la diffusione di carburanti alternativi, l'elettrificazione del parco automobilistico e di altri mezzi di trasporto.
La quarta dimensione, quella della decarbonizzazione dell'economia, riguarda la politica climatica dell'Unione europea e il settore delle energie rinnovabili, nel quale l'Unione aspira a diventare leader mondiale. Sul clima l'Unione persegue una politica ambiziosa, con un obiettivo di ridurre di almeno il 40% delle emissioni di gas effetto serra rispetto al 1990 entro il 2030. Questo rappresenta il contributo che l'Unione fornirà nell'ambito dei negoziati mondiali sul clima che si svolgeranno a Parigi nel 2015, di cui si veda infra. Per quanto concerne le energie rinnovabili obiettivo dell'Unione è quello di raggiungere la quota del 27% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. A tale scopo proporrà un nuovo pacchetto sulle energie rinnovabili che comprenderà una politica per la biomassa e i biocomustibili sostenibili, e altre norme per garantire l'obiettivo sia raggiunto con efficacia dei costi.
Infine, per quanto concerne la quinta dimensione, relativa alla ricerca, all'innovazione e alla competitività, la Commissione annuncia che metterà a punto una strategia R&I per l'energia che perseguirà i seguenti obiettivi: garantire all'Unione europea la leadership mondiale nello sviluppo della prossima generazione delle energie rinnovabili; agevolare la partecipazione dei consumatori alla transizione energetica mediante reti intelligenti e città intelligenti; disporre di tecnologia in grado di rendere il parco immobiliare neutro dal punto di vista energetico; dotare l'Unione di sistemi di trasporto più sostenibili. La strategia R&I perseguirà anche altre priorità, quali quella di definire un approccio lungimirante alla cattura e allo stoccaggio del carbonio e alla cattura e al consumo del carbonio, mantenere la leadership tecnologia nel settore del nucleare, continuando a garantire che gli Stati membri utilizzino i migliori standard in materia di sicurezza, gestione dei rifiuti e non proliferazione
Oltre che su queste cinque dimensioni, la Commissione europea pone l'accento sulla necessità che l'Unione dell'energia sia dotata di una governance integrata che garantisca che tutte le azioni intraprese a livello nazione, regionale e locale siano in linea con gli obiettivi fissati. Il processo di governance sarà volto, tra l'altro, a combinare le azioni in materia di clima ed energia a quelle in altri settori strategici per garantire una maggiore coerenza programmatica a lungo termine e dare così agli investitori maggiore certezza.
3.2) "Il Protocollo di Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020"
La seconda Comunicazione[14] è incentrata sul tema dei cambiamenti climatici e sul dibattito politico in atto a livello mondiale per la negoziazione di un nuovo accordo sul clima, che coinvolga tutte le principali economie del mondo e sostituisca l'attuale impianto del Protocollo di Kyoto, basato sulla responsabilizzazione dei paesi industrializzati. Questo accordo dovrebbe essere raggiunto durante la ventunesima Conferenza delle Parti di Parigi nel dicembre 2015 (COP21) e dovrebbe entrare in vigore dopo il 2020. Obiettivo generale, perseguito anche dall'Unione europea, è quello di limitare il riscaldamento globale a 2° al di sopra delle temperature medie del periodo pre-industriale. Nell'ottobre 2014 il Consiglio europeo ha adottato le Conclusioni sul "Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima", sulle quali cui si baserà la posizione europea in occasione della COP21. Esse stabiliscono che entro il 2030 l'Unione dovrà ridurre le proprie emissioni del 40% rispetto ai livelli del 1990.
Il Quadro 2030, fortemente sostenuto dalla Presidenza italiana dell'Unione europea, pone un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nazionali di gas ad effetto serra almeno del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Inoltre, prevede la riforma del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) fissando dall'1,74% al 2,2% il fattore di riduzione del tetto massimo di emissioni a partire dal 2021. E' inoltre fissato un obiettivo vincolante a livello di Unione europea per la quota di fonti energetiche rinnovabili almeno al 27% entro il 2030. L'obiettivo sarà realizzato mediante i contributi degli Stati membri, lasciando ad essi la flessibilità di definire obiettivi nazionali più ambiziosi. Per quanto riguarda l'efficienza energetica è stabilito un obiettivo indicativo del 27% a livello dell'Unione europea nel 2030. Il Quadro 2030 punta inoltre sulla realizzazione di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e connesso, su misure volte a ridurre la dipendenza energetica dell'UE e su azioni miranti a garantire la sicurezza energetica per quanto concerne sia l'energia elettrica che il gas. E' previsto poi lo sviluppo di un sistema di governance affidabile, trasparente e privo di oneri amministrativi superflui per garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di politica energetica.
La presente Comunicazione illustra la visione dell'UE per nuovo accordo trasparente, dinamico e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici. In particolare, essa:
- traduce la decisione presa dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014 nell’obiettivo per le emissioni proposto dall’UE, ossia il suo contributo previsto stabilito a livello nazionale (di seguito "INDC" - Intended Nationally Determined Contribution), che deve essere presentato entro la fine del primo trimestre del 2015;
- propone che tutte le Parti dell’UNFCCC presentino i loro INDC con ampio anticipo rispetto alla Conferenza di Parigi;
- traccia le linee di un accordo trasparente, dinamico e giuridicamente vincolante che contenga impegni equi e ambiziosi di tutte le Parti stabiliti in base a una situazione geopolitica ed economica mondiale in costante evoluzione;
- propone che l’accordo del 2015 sia un protocollo dell’UNFCCC, al quale le grandi economie, in particolare l’UE, la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero aderire il più presto possibile.
Il "Protocollo di Parigi", dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi:
- garantire riduzioni ambiziose di emissioni, precisando che l'obiettivo a lungo termine è ridurre le emissioni mondiali di almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai livelli del 2010 e definire impegni chiari che consentano di raggiungere l'obiettivo dei 2°. La riduzione delle emissioni dovrebbe riguardare tutti i settori, compresi quello dell'agricoltura, della silvicoltura, dei trasporti aerei e marittimi;
- garantire un dinamismo degli impegni attraverso un riesame completo da effettuarsi ogni cinque anni;
- rafforzare la trasparenza e l’assunzione di responsabilità, mediante un insieme comune di norme e procedure da applicare alla rendicontazione annuale, alla verifica periodica e all’esame degli inventari delle emissioni a cura di esperti internazionali;
- incoraggiare uno sviluppo sostenibile resiliente ai cambiamenti climatici promuovendo la cooperazione internazionale;
- promuovere un’attuazione e una cooperazione efficienti ed efficaci, incoraggiando investimenti pubblici e privati, in programmi e politiche a basse emissioni, resilienti ai cambiamenti climatici.
La Comunicazione illustra inoltre la strategia diplomatica dell'Unione in vista della COP21, che prevede le seguenti azioni:
- porre i cambiamenti climatici al centro dei dialoghi politici, in particolare in occasione delle riunioni del G7 e del G20, nonché all’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- sostenere uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici e alle catastrofi attraverso la cooperazione allo sviluppo dell’UE;
- collegare il cambiamento climatico alle sue potenziali conseguenze a lungo termine, ivi compresi i problemi di sicurezza.
Queste azioni si sommeranno ad altre politiche dell'Unione che possono contribuire agli obiettivi della stessa nel negoziato internazionale e nell’applicazione del protocollo nei paesi partner. Si tratta in particolare delle politiche in materia di cooperazione economica e allo sviluppo, di ricerca scientifica, nonché della politica commerciale, della politica ambientale e della politica in materia gestione delle catastrofi.
Infine, la Comunicazione illustra gli impegni futuri dell'Unione europea, che dovrà innanzitutto presentare il proprio INDC entro la fine del primo trimestre del 2015. A tal proposito si segnala che nel corso della riunione del Consiglio "Ambiente" svoltasi lo scorso 6 marzo[15], sono stati adottati gli INDC dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, che si sono impegnati a conseguire entro il 2030 un obiettivo vincolante, da realizzarsi congiuntamente, di una riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2014. Lo stesso giorno gli INDC sono stati trasmessi al Segretariato dell'UNFCCC. L'Unione europea, inoltre, si adopererà per dimostrare e garantire la stabilità e la prevedibilità del sostegno finanziario che l’UE fornisce collettivamente ai propri partner internazionali per stimolare uno sviluppo a basse emissioni e resiliente al clima e in ultimo premerà affinché si giunga alla rapida liberalizzazione (entro la fine del 2015) degli scambi di beni e servizi ambientali.
La Comunicazione è corredata da un Allegato che contiene informazioni generali e curve di emissione dei maggiori produttori mondiali di emissioni.
3.3) "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica europea pronta per il 2020"
La terza Comunicazione[16] illustra la strategia della Commissione europea in materia di interconnessioni, volta al raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione elettrica del 10% fissato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014. Nonostante negli ultimi dieci anni gli Stati membri abbiano potenziato le proprie capacità di interconnessione, ben dodici Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno raggiunto l'obiettivo del 10% e rimangono isolati nel mercato interno dell'energia elettrica[17]. Le infrastrutture energetiche rappresentano pertanto una priorità della politica energetica europea. In tale contesto particolare attenzione è rivolta alle strutture interconnesse che consentono di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, garantiscono prezzi più accessibili nel mercato interno e favoriscono il conseguimento degli obiettivi in materia di decarbonizzazione del mix energetico e di politica climatica grazie alla riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, incrementare l'interconnessione della rete consentirà all'Unione europea di realizzare la sua ambizione di divenire leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili.
Come già accennato, l'Unione europea si è dotata di una serie di strumenti di intervento per favorire gli investimenti nelle infrastrutture di rete. Nell'ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), elaborato a seguito della crisi economica, sono stati individuati alcuni progetti di interconnessione e spesi circa 650 milioni di euro per le interconnessioni elettriche. Altri strumenti sono il Regolamento TEN-E, adottato nel 2013[18] e il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)[19], che consentono di individuare progetti lungo 12 corridoi, aree prioritarie e di assicurarne la realizzazione. Progetti di comune interesse (PIC) sono 248 e sono stati individuati in un primo elenco nel 2013, di questi ben 52 riguardano le interconnessioni elettriche. Entro il 2020 la Commissione prevede il completamento di circa il 75% dei progetti. Il secondo elenco dei PIC dovrebbe essere adottato dalla Commissione europea nell'autunno 2015. In questo contesto sarà conferita particolare importanza ai progetti che potenzieranno la capacità di interconnessione in quei paesi che sono al di sotto dell'obiettivo del 10%. Per quanto riguarda l'Italia i progetti previsti (che riguardano le interconnessioni con Francia, Svizzera e Austria) potrebbero portare, una volta completati, la capacità di interconnessione al 12% entro il 2020. La Commissione prevede che entro tale data occorrerà investire circa 200 miliardi di euro nelle infrastrutture necessarie a garantire un'adeguata interconnessione. In particolare, per i progetti legati all'energia elettrica saranno necessari 105 miliardi di euro, di cui 35 miliardi per le interconnessioni. Nell'ambito del MCE nel bilancio 2014-2020, sono stati stanziati 5.35 miliardi di euro, e nell'ambito Fondo europeo e di sviluppo regionale (FESR) ne saranno stanziati circa 2 miliardi. Con il Fondo europeo per investimenti strategici (FEIS), presentato dalla Commissione nel gennaio 2015, potranno essere finanziati molti PIC e altri progetti di interconnessione. Inoltre con il futuro Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) potranno essere individuati, ed attuati progetti di investimento.
La Comunicazione si sofferma poi sull'esigenza di garantire una maggiore cooperazione a livello regionale e indica quattro regioni che dovranno compiere ulteriori sforzi in tale senso: la regione baltica, la penisola iberica, i paesi del mar del Nord, l'Europa centrale e sudorientale. Questi gruppi regionali definiranno, con la collaborazione della Commissione, dei piani d'azione corredati da tappe precise per la realizzazione dell'obiettivo 10%. La Commissione seguirà da vicino l'attuazione dei piani d'azione e promuoverà l'armonizzazione dei metodi di lavoro dei vari gruppi regionali.
Infine, la Comunicazione illustra le prospettive future che riguardano l'innalzamento al 15% entro il 2030 dell'obiettivo di interconnessione. Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha invitato la Commissione europea a riferire periodicamente sui progressi realizzati in tal senso.
La Comunicazione è accompagnata da due Allegati relativi rispettivamente ai progetti cofinanziati dal Programma energetico europeo per la ripresa e ai PIC.