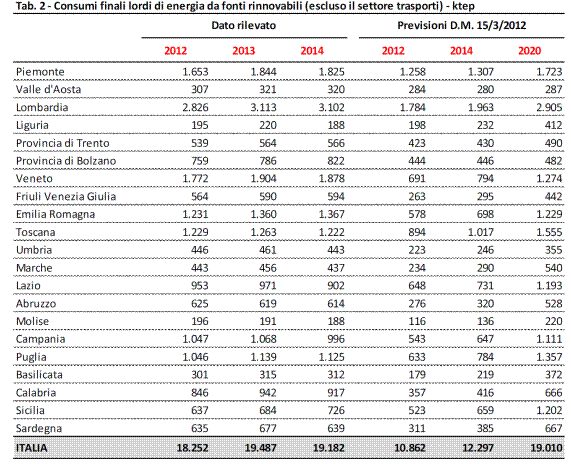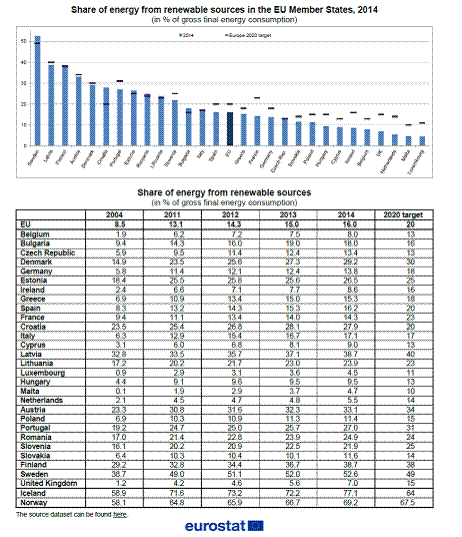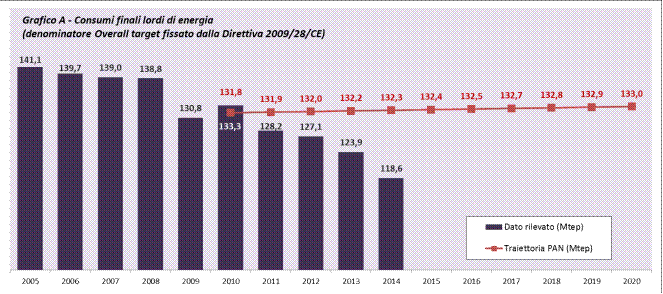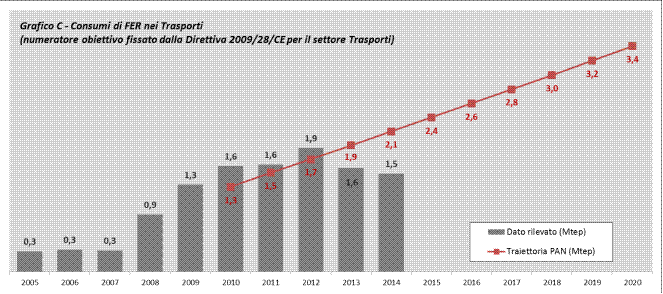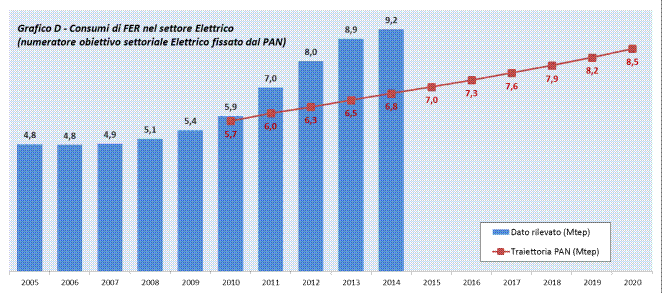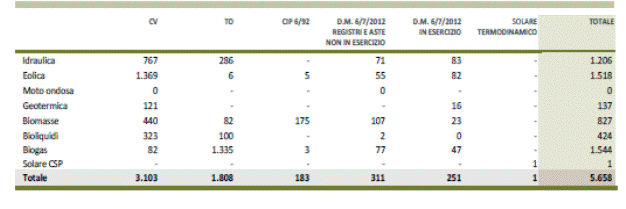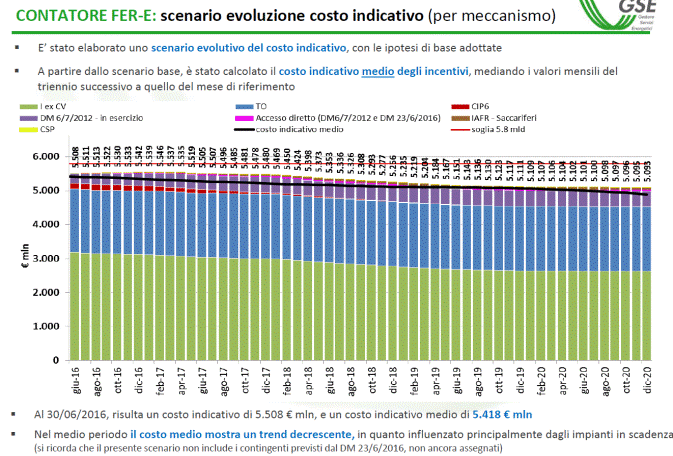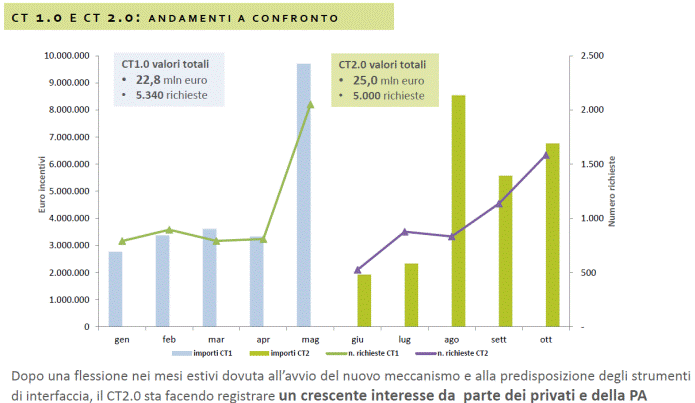La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, fissa per l’Italia per il 2020:
a) un obiettivo complessivo (Overall target) che consiste nel soddisfare con energia da FER il 17% dei
consumi finali lordi di energia;
b) un obiettivo settoriale che consiste nel
soddisfare con energia da FER il 10% dei
consumi complessivi per i trasporti. La stessa Direttiva, per il calcolo
degli obiettivi, introduce alcune definizioni e alcuni criteri di calcolo non
previsti dalle statistiche ordinarie.
Ai sensi del D.Lgs.
28/2011, il grado di raggiungimento di
tale obiettivo è monitorato
annualmente dal GSE, secondo la metodologia approvata dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 14 gennaio 2012.
Il Piano d’Azione Nazionale per le energie
rinnovabili (PAN), elaborato nel
2010, recepisce gli obiettivi definiti dalla direttiva 2009/28/CE (17% e 10%
dei consumi finali lordi di energia coperti da fonti rinnovabili
rispettivamente sui consumi energetici complessivi e sui consumi del settore
Trasporti) e ne individua due ulteriori
settoriali, per il settore Elettrico e per il settore Termico
(rispettivamente 26,4% e 17,1% dei consumi coperti da FER).
Nel PAN sono inoltre indicate le traiettorie previste per il
raggiungimento degli obiettivi e le principali politiche da attuare a tale fine.
Nell’ambito della
ridefinizione delle priorità strategiche per l’intero sistema energetico
nazionale, nel corso del 2012, l’Italia ha spontaneamente elaborato una Strategia Energetica Nazionale (SEN) – approvata con D.M 8 marzo 2013. In tale ambito, per quanto riguarda le
energie rinnovabili, si è ritenuto di prevedere che al 2020 la quota di consumi finali coperti mediante le
rinnovabili possa arrivare al valore
del 19%-20%, fermo restando l’impegno vincolante del 17% assegnato in
ambito europeo.
Il
Governo ha annunciato che è in corso un processo
di revisione della SEN in ragione
della necessità di dotarsi di uno strumento programmatorio con un orizzonte
temporale coerente con quello europeo, individuando obiettivi realisticamente
perseguibili al 2030 e, come tendenza, al 2050, Vi sarà un primo documento
pronto per la consultazione pubblica, in concomitanza con il G7 energia
previsto nei primi giorni di aprile 2017. La consultazione sarà svolta mediante
pubblicazione del documento sul sito del MISE (si veda la risposta del Governo all’interrogazione
a risposta Immediata in Commissione n. 5-10250 di Giovedì
12 gennaio 2017).
A cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea
In
linea con il suo impegno a presentare una Relazione
annuale sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione europea ha
pubblicato, il 1° febbraio 2017, la
sua seconda relazione (COM(2017)53)
con cui illustra i progressi compiuti successivamente alla pubblicazione della
prima relazione sullo stato dell'Unione dell'energia nel novembre 2015
(COM(2015)572).
Entrambe le relazioni
sono elementi centrali per il monitoraggio dei progressi compiuti a livello di
Unione e di singoli Stati membri e per tracciare le azioni future, elaborando
anche gli orientamenti destinati agli Stati membri per quanto concerne i piani
nazionali per l’energia e il clima.
L'UE nel suo insieme
ha continuato a compiere buoni progressi verso la realizzazione degli obiettivi
dell'Unione dell'energia, in particolare quelli in materia di clima ed energia
per il 2020. L'UE, infatti, ha già raggiunto l'obiettivo fissato al 2020 per
quanto riguarda il consumo di energia finale. Lo stesso vale per le emissioni
di gas a effetto serra: nel 2015, erano del 22% inferiori ai livelli del 1990.
L'UE è sulla buona strada anche nel settore delle energie rinnovabili, dove, in
base ai dati del 2014, la quota di energie rinnovabili ha raggiunto il 16% del
consumo unionale lordo di energia finale.
Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha
certificato il raggiungimento nel 2014
dell’obiettivo – previsto da
raggiungere entro il 2020 - del
17% di energia da fonti rinnovabili; nel 2014, infatti, l’Italia ha
raggiunto una quota di energia da fonti rinnovabili del 17,1%. La Commissione
europea ha richiamato anche i risultati
positivi conseguiti dall’Italia per quanto concerne l'efficienza energetica
e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In particolare, sotto il
profilo dell’efficienza energetica,
la Commissione ha rilevato che, considerato il livello di consumo di energia
primaria, si rendono necessari sforzi per mantenere il trend al ribasso. Sulla base dei dati Eurostat, infatti, l’Italia ha registrato una domanda di
energia primaria nel 2014 pari a 143,8 Mtep, mentre i consumi finali di energia
sono stati pari a 113,4 Mtep (esclusi gli usi non energetici). Circa la riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, l’Italia, sempre in base ai dati
Eurostat, mostra un trend positivo
dal 2005 al 2014.
Tuttavia, nonostante i
suddetti progressi, l'Italia, a
giudizio della Commissione, dovrà
impegnarsi ancora al fine di migliorare la capacità di interconnessione (l’Italia,
infatti, è ancora insufficientemente collegata con il mercato dell'energia
elettrica dell'UE e non ha ancora raggiunto l'obiettivo di interconnessione di
energia elettrica 2020 del 10%) e di
ridurre i prezzi dell'energia elettrica che, in generale, sono sopra la
media UE.
Il 30 novembre 2016 la Commissione europea
ha presentato il pacchetto legislativo
"Energia pulita per tutti gli europei" , a completamento delle
iniziative legislative previste nell'ambito della Strategia dell''Unione dell'energia”. Le proposte legislative del
pacchetto riguardano l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'assetto
del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento
elettrico e le norme sulla governance
per l'Unione dell'energia e intendono fornire un quadro di riferimento più
appropriato per conseguire gli obiettivi europei al 2030 che il Consiglio
europeo ha fissato nell'ottobre 2014 :
• ridurre
le emissioni di gas a effetto serra del 40% (rispetto ai livelli del 1990);
• raggiungere
la quota del 27% di energia da fonti rinnovabili (dei consumi finali
complessivi);
• aumentare
l'efficienza energetica del 27% rispetto alle proiezioni di consumo basate
sui criteri vigenti.
Al riguardo, la proposta di direttiva COM(2016)761
propone di modificare la direttiva 2012/27/UE al fine di introdurre un
obiettivo unionale vincolante di miglioramento
dell'efficienza energetica del 30% per il 2030.
Gli Stati membri
presteranno ciascuno il proprio contributo (obiettivi nazionali specifici) nei
piani nazionali per l’energia e il clima. Per quanto concerne l’Italia, il
Ministro Calenda ha recentemente annunciato che nel corso del 2017 l’Italia
provvederà ad aggiornare la Strategia
energetica nazionale (SEN) risalente al 2013.
Inoltre, nell'ambito
del suddetto pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", la
Commissione ha presentato una proposta
di regolamento (COM(2016)759) sulla governance
dell'energia, la quale stabilisce che, entro il 1° gennaio 2019, gli Stati membri dovranno presentare un piano energetico e climatico integrato per
il periodo 2021-2030 e per i decenni successivi, sulla base di un modello
predisposto dalla Commissione europea.
Nei piani energetici,
gli Stati membri dovranno indicare le misure
nazionali relative alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e una
valutazione degli impatti di tali misure per il primo decennio, almeno fino al
2030.
La situazione nazionale
Come risulta dal Bilancio
energetico nazionale (BEN), le Fonti energetiche rinnovabili (FER), hanno
consolidato negli ultimi anni un ruolo
di primo piano nell’ambito del sistema energetico italiano, trainate da meccanismi
di sostegno pubblico.
Applicando ai dati
sulla produzione effettiva di energia i criteri di contabilizzazione previsti
dalla Direttiva 2009/28/CE ai fini del monitoraggio degli obiettivi di consumo di FER al 2020 (si tratta di criteri differenti rispetto alle contabilizzazioni del
BEN), i consumi
complessivi di energia da fonti
rinnovabili sono risultati pari nel 2013 a 20,7 Mtep, con un’incidenza sui consumi finali lordi
di energia pari al 16,7%, di poco
inferiore al target del 17% fissato
per l’Italia al 2020.
Mentre, per il 2014, i
consumi complessivi di energia da FER si attestano intorno ai 20,2 Mtep, con
un’incidenza sui consumi finali lordi di
energia pari al 17,07%.
In termini assoluti,
la flessione nel 2014 di circa 0,5
Mtep rispetto al 2013 (-2,4%) ha interessato il settore Termico (principalmente
per il clima più caldo registrato nel 2014 che ha fatto diminuire
l’utilizzo della biomassa) e il settore
Trasporti (principalmente come conseguenza del trend di contrazione dei
consumi di carburanti).
In termini percentuali
(consumi complessivi di energia da FER su consumi finali lordi di energia), nel 2014 è stato raggiunto in anticipo e superato dall’Italia il target del 17% fissato in sede europea per il 2020 (cfr. Tabelle).
Si osservi comunque
che l’obiettivo del 17% è un criterio
dinamico che dipende dai consumi
finali lordi di energia. Tale target
è stato raggiunto nell’anno 2014 in una situazione di riduzione dei consumi
complessivi di energia, dovuta dunque non solo agli interventi di maggiore
efficientamento energetico avutisi negli ultimi anni, ma anche ed in modo sensibile
alla crisi economica, che ha determinato una riduzione dei consumi energetici.
Pertanto,
come rileva il GSE la possibilità di
mantenere la quota dei consumi finali coperta da rinnovabili su questi livelli
dipenderà, oltre che dal trend di diffusione delle FER stesse nei prossimi anni
(e dagli interventi di efficienza energetica), anche dall’andamento dei consumi energetici complessivi del Paese nella
fase post-crisi.

Fonte: MISE-GSE “Terza relazione
dell’Italia sui progressi compiuti nell’attuazione della Direttiva 2009/28/CE”
(cd. Progress Report) di dicembre
2015, inviato alle Istituzioni europee.
Il raggiungimento in anticipo ed il
superamento da parte dell’Italia degli obiettivi
2020 nell’anno 2014 è stato
attestato - oltre che a novembre scorso dalla Commissione Europea - da Eurostat nel comunicato stampa del 10 febbraio 2016.
L’Istituto statistico
europeo osserva che, tra i 28 Stati membri, un terzo di essi ha già raggiunto i propri obiettivi nazionali 2020: Bulgaria, Repubblica Ceca,
Estonia, Croazia, Italia, Lituania,
Romania, Finlandia e Svezia. Inoltre,
Danimarca ed Austria sono sotto di un punto percentuale rispetto al loro target
2020. All’opposto, la Francia (sotto
di 8,7 punti percentuali dal raggiungimento del suo obiettivo 2020), i Paesi Bassi (sotto di 8,5 punti), il Regno unito (sotto di 8,0 punti) e
l’Irlanda (sotto di 7,4 punti) sono i
più lontani dai loro obiettivi.
Infine, appare
opportuno menzionare il “Monitoraggio statistico degli obiettivi
nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia”, pubblicato a
dicembre 2016 dal GSE ai sensi del
D.M. 11 maggio 2015 (art. 7).
Con riferimento all’obiettivo
complessivo (overall target, che
prevede una quota FER sui consumi totali pari al 17%) fissato dalla Direttiva
2009/28, il Decreto 15 marzo 2012
del Ministero dello Sviluppo Economico (c.d. decreto burden sharing) fissa il contributo
che le diverse regioni e province autonome italiane sono tenute a fornire ai
fini del raggiungimento del target
nazionale, attribuendo a ciascuna di esse specifici obiettivi regionali di
impiego di FER al 2020. In questo contesto normativo, il Decreto 11 maggio 2015
del Ministero dello Sviluppo Economico, che approva la metodologia da applicare
per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, prevede – all’articolo 7 – la
pubblicazione annuale di “[…] un rapporto
statistico relativo al monitoraggio del grado di raggiungimento dell’obiettivo
nazionale e degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali
lordi di energia da fonti rinnovabili, a livello complessivo e con riferimento
ai settori elettrico, termico e dei trasporti”. A dicembre 2016, il GSE ha
pubblicato il primo rapporto del DM, presentando i dati di monitoraggio degli
obiettivi nazionali e regionali sulle FER aggiornati all’anno 2014.
Nel Rapporto è esposta una Tabella
riepilogativa dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili
attribuibili a ciascuna regione.
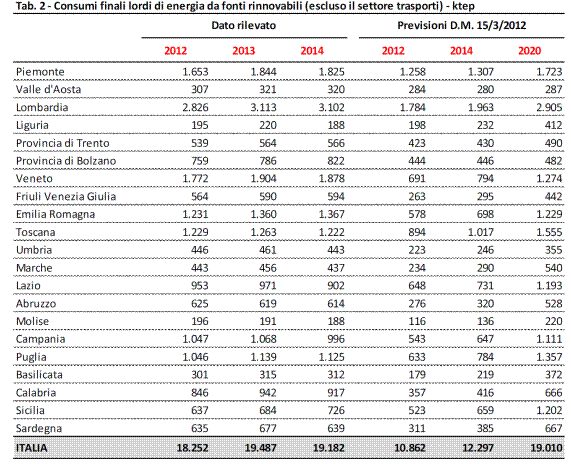
Sulla base di quanto
risulta dalla Tabella, quasi tutte le regioni
e le province autonome registrano, sia nel 2012 che nel 2014, una quota di consumi finali lordi di energia coperta da fonti
rinnovabili superiore alle previsioni del D.M. burden sharing.
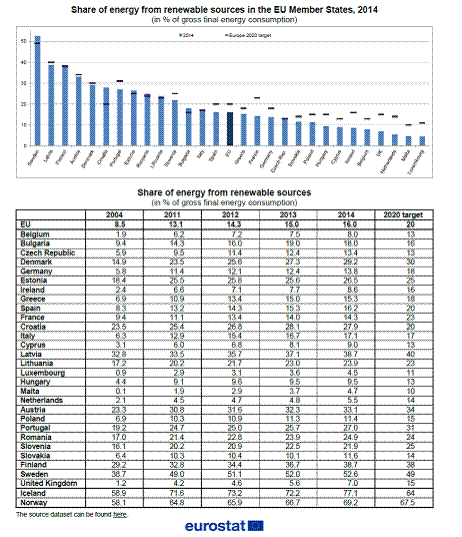
Per quanto riguarda l’anno 2015, i dati preliminari diffusi dal GSE il 29 febbraio 2016
evidenziano consumi di energia da FER nel 2015 pari a 21,1 Mtep, con un’incidenza sui consumi finali lordi intorno al 17,3%, dunque un valore - sia in termini assoluti che in termini percentuali - superiore rispetto agli impieghi del 2014. L’incremento degli impieghi di FER (circa
900 ktep) è per oltre il 70% imputabile all’utilizzo delle biomasse nel settore
termico.
Conclusioni
Secondo la contabilizzazione Eurostat, nel 2014, i consumi finali lordi (CFL) di
energia in Italia si sono attestati intorno a 118,6 Mtep, valore più basso degli ultimi 10 anni e inferiore di
oltre 5 Mtep rispetto all’anno precedente (-4,3%). La quota di tali consumi coperta da fonti
rinnovabili (FER)è stata pari al 17,07 %, un
valore superiore al target
assegnato all’Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (17%) e non distante dall’obiettivo individuato
dalla Strategia Energetica Nazionale (19-20%).
Nel 2015, i consumi finali lordi (CFL) di
energia in Italia si sono attestati (stime GSE) intorno a 122,2 Mtep, registrando dunque una ripresa rispetto al 2014 (+ 3,0
%).
La quota di tali
consumi coperta da FER sarebbe stata pari a 21,1 Mtep, con un’incidenza sui consumi finali lordi intorno al 17,3%, un valore dunque - sia in termini assoluti che in termini percentuali - superiore rispetto agli impieghi del 2014.
Rimane, anche in
questo caso, l’osservazione del GSE secondo la quale la possibilità di mantenere la quota dei consumi finali coperta da
rinnovabili su questi livelli dovrà essere testata anche sulla base del futuro andamento dei consumi energetici
complessivi del Paese nella fase post-crisi.
La tabella seguente,
tratta dalla pubblicazione del GSE “Energia
da fonti rinnovabili in Italia – Dati preliminari 2015” del 29 febbraio
2016, fornisce il quadro completo delle grandezze considerate per il
monitoraggio dell’obiettivo 2020: esse comprendono gli impieghi di FER in
Italia nei settori elettrico, termico e trasporti, nonché le macro-voci che
compongono i Consumi Finali Lordi di energia del Paese. I dati sono stati
richiamati dal MISE nella “Relazione sulla situazione energetica nazionale
2015” di giugno 2016.

Dalla Tabella
precedente, si evince che le FER trovano impiego diffuso, in primis, per la produzione di calore: nel 2015 il settore Termico, concentra infatti circa il
50,1% dei consumi complessivi di energia da FER (dopo la lieve flessione
registrata nel 2014 principalmente per il clima più caldo che aveva fatto
diminuire l’utilizzo della biomassa); nonché, per la produzione di energia
elettrica: il settore Elettrico assorbe
nel 2015 il 44,3% dei consumi da
FER; infine come biocarburanti per l’autotrazione: il settore Trasporti assorbe il 5,6%, in lieve aumento rispetto al
2014 (anno in cui si è registrato un valore di consumi inferiore ascrivibile al
trend di contrazione dei consumi di
carburanti).
Confronto tra consumi energetici
rilevati nel 2014 e traiettorie PAN
Osservando in
dettaglio i grafici relativi ai tre
settori, elaborati dal GSE nell’ultimo Rapporto statistico (dicembre 2015) si nota che:
§ nel 2014 il dato relativo ai consumi di FER nel settore Trasporti
(Grafico C) risulta inferiore sia
alle previsioni del PAN (circa 600 ktep in meno) sia al dato relativo al 2013,
principalmente come conseguenza della contrazione generale dei consumi di
carburanti in Italia;
§ il
dato di consumo nel settore Elettrico
(grafico D) risulta superiore, nel 2014, non solo al dato previsto dal PAN
per lo stesso anno, ma anche al valore
previsto per il 2020;
§ i
consumi rilevati di FER nel settore
Termico (grafico E) risultano sempre
ampiamente superiori rispetto alle previsioni PAN.
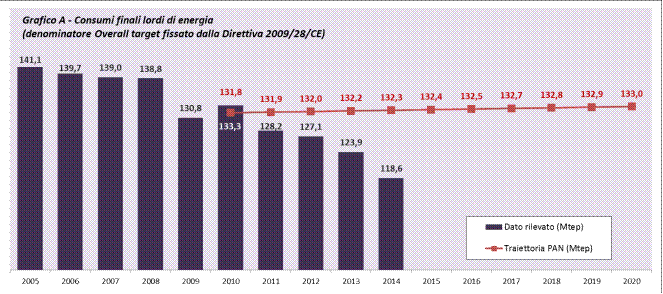

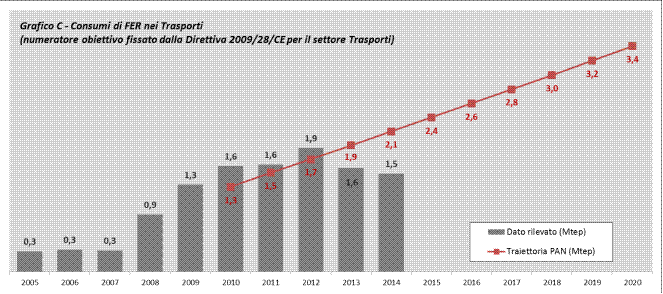
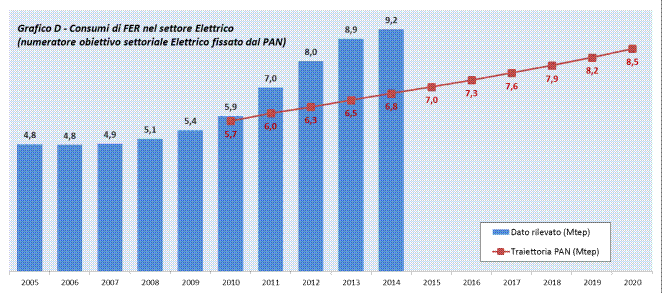

Approfondimento: i consumi e la
produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia nel 2014 e 2015 suddivisi
per settore
Come già detto, applicando
i criteri di contabilizzazione previsti dalla Direttiva 2009/28/CE, nel 2014 i consumi complessivi di energia
da FER in Italia risultano pari a 20,2
Mtep. La flessione di circa 0,5 Mtep
rispetto al 2013 (-2,4%) ha interessato
il settore Termico (principalmente
per il clima più caldo registrato
nel 2014 che ha fatto diminuire l’utilizzo della biomassa) e il settore Trasporti (principalmente a
causa del trend di contrazione dei consumi di carburanti).
Per quanto riguarda l’anno 2015, i le stime
diffuse dal GSE evidenziano consumi di energia da FER pari a 21,1 Mtep, circa il 17,3% dei consumi finali di energia,
dunque un valore - sia in termini
assoluti che in termini percentuali
- superiore rispetto agli impieghi del 2014. L’incremento
degli impieghi di FER è per oltre il 70% imputabile all’utilizzo delle biomasse
nel settore termico.
Per quanto riguarda la produzione in Italia di
elettricità da FER, i circa 656.000 impianti alimentati da fonti rinnovabili
installati sul territorio nazionale (per una potenza complessiva di 50.594 MW)
hanno prodotto, nel 2014, circa 120,7
TWh di energia elettrica (+7,8% rispetto al 2013), che si riducono a 107,6
TWh applicando le regole di calcolo previste dalla Direttiva 2009/28/CE ai fini
del monitoraggio degli obiettivi.
La fonte rinnovabile che ha
fornito il contributo più importante nel settore Elettrico è, nel 2014 quella idraulica (48% della produzione
elettrica da FER), seguita dalla fonte
solare (19%), dalle bioenergie
(15%), dalla fonte eolica (13%) e da
quella geotermica (5%). Nell’anno 2015, la produzione di energia
elettrica da FER si è ridotta, passando da circa 120,7 TWh a circa 106,8 TWh, ma rimane sostanzialmente
invariato, in termini percentuali, il contributo delle fonti predette.
Per quanto riguarda invece
il settore Termico, nel 2014 sono stati prodotti circa 9,9 Mtep di energia termica da fonti
rinnovabili (416.000 TJ), di cui poco meno di 9 Mtep in modo diretto
(attraverso stufe, camini, pannelli solari, pompe di calore, impianti di
sfruttamento del calore geotermico) e circa 1 Mtep come consumi di calore
derivato (principalmente attraverso sistemi di teleriscaldamento alimentati da
biomasse). La fonte di gran lunga più importante è la biomassa solida (6,7
Mtep), utilizzata soprattutto nel settore domestico. Assumono grande rilievo
anche le pompe di calore (2,6 Mtep), mentre sono ancora limitati i contributi
della fonte geotermica e di quella solare. Nel 2015, sono stati prodotti 10,6
Mtep di energia termica da FER, in
aumento rispetto all’anno 2014.
Per quanto riguarda infine
il settore Trasporti, nel 2014 sono
stati immessi in consumo circa 1,06 Mtep di biocarburanti (oltre 1,2 milioni di
tonnellate), e nel 2015 sono stati immessi in consumo 1,15 Mtep, in larghissima
parte costituiti da biodiesel.
Gli incentivi alla produzione rinnovabile
elettrica in Italia sono storicamente i più elevati d’Europa, con un forte impatto sul costo dell’energia:
circa il 20% circa della bolletta
elettrica italiana è destinato a incentivi alla produzione tramite fonti
rinnovabili (componente A3 della
bolletta. Si veda infra
il box Andamento del fabbisogno
economico e del gettito della componente A3 della bolletta elettrica).
Negli ultimi anni, comunque,
in coerenza con la Strategia energetica nazionale, sono stati approvati alcuni
provvedimenti mirati a ridurre i costi dell’energia, e in particolare le
cosiddette norme “spalma-incentivi”, che puntano a diminuire l’onere annuo dell’incentivazione delle fonti rinnovabili
che si scarica sulla componente A3. Dapprima, con il D.L. 145/2013 (articolo 1, commi 3-6), c.d. Destinazione
Italia è stato previsto il cosiddetto "spalma-incentivi volontario"
con il quale si è proposto ai produttori di energia elettrica da fonti
rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di Certificati Verdi, Tariffe
Onnicomprensive e tariffe premio, un’alternativa tra continuare a godere
del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo oppure
optare per la fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga del
periodo di incentivazione.
Successivamente, con
il D.L. 91/2014, articolo 26,
è stato introdotto il cosiddetto "spalma-incentivi obbligatorio",
che introduce nuove modalità di erogazione degli incentivi a carico delle
tariffe elettriche già riconosciuti all’energia prodotta dai grossi impianti fotovoltaici (di potenza incentivata superiore a 200KW),
lasciando ai produttori la scelta tra tre opzioni.
Con riferimento al cd.
spalma incentivi obbligatorio, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 16
del 7 dicembre 2016- 24 gennaio 2017 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno2014, n. 91 (disciplina
del cd. spalma incentivi obbligatorio).
Secondo la Corte
Costituzionale, l’intervento del legislatore del 2014 ha operato in un contesto
congiunturale nel quale - a fronte della remuneratività delle tariffe
incentivanti per l'energia solare prodotta da fonte fotovoltaica, rivelatasi
progressivamente più accentuata, sia rispetto anche ai costi di produzione (in
ragione del repentino sviluppo tecnologico del settore), sia rispetto al quadro
complessivo europeo - era venuto specularmente in rilievo il crescente peso
economico di tali incentivi sui consumatori finali di energia elettrica (in
particolare sulle piccole e medie imprese costituenti il tessuto produttivo
nazionale). Il legislatore è pertanto intervenuto, con logica perequativa, al
dichiarato fine di «favorire una
migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili»
(art. 26 D.L. n. 91 del 2014) e di «pervenire ad una più equa distribuzione
degli oneri tariffari frale diverse categorie di consumatori elettrici», prevedendo a tal proposito che i minori
oneri per l'utenza derivanti dalla rimodulazione degli incentivi per gli
impianti fotovoltaici siano «destinati alla riduzione delle tariffe elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione
[...]» (art. 23 D.L. 91/2014).
E', dunque,
quello contenuto nel D.L. n. 91/2014 un intervento che risponde ad un interesse
pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco,
volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte
rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli
utenti finali dell'energia elettrica.
Come già detto, il cd. “spalma incentivi obbligatorio” interviene
sulle tariffe incentivanti già godute, in quanto, dalla metà dell’anno
2013, si sono esauriti i fondi del Quinto Conto Energia per l’incentivazione
del fotovoltaico, essendo stata
raggiunta la soglia dei 6,7 miliardi di euro .
Per ciò che attiene
agli effetti del cd. “spalma incentivi
obbligatorio” il GSE, nell’ultimo Rapporto disponibile sull’attività svolta
nel corso del 2015, pubblicato a marzo 2016, evidenzia che, nel corso dell’anno 2015, l’erogazione
degli incentivi a favore di oltre 550.000 impianti (circa 17.700 MW) ammessi ai
diversi Conti energia ha comportato un costo di 6,3 miliardi di euro, in calo rispetto al costo sostenuto nel 2014
(6,6 miliardi) per effetto della rimodulazione obbligatoria di cui al D.L. n.
91/2014.
Per ciò che attiene
invece al cd. “spalma incentivi
volontario”, il GSE rileva che gli impianti (non fotovoltaici) che
risultano aver aderito alla rimodulazione sono 237 (di cui 174 a Certificati Verdi
e 63 a Tariffa Onnicomprensiva), per una potenza complessiva di 942 MW (di cui
922 a CV e 20 a TO); si osserva una netta prevalenza della fonte idraulica.
Complessivamente, la riduzione del costo
indicativo annuo risulta pari, per il primo anno, a circa 51 milioni di euro, di cui quasi 39
milioni ascrivibili all’idroelettrico.
Alcuni più recenti
interventi, contenuti nella legge di
stabilità 2016, sono invece suscettibili
di determinare un aumento degli oneri della componente A3. La legge di
stabilità infatti riconosce alla
produzione di energia elettrica di
impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno
cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare
di incentivi sull’energia prodotta - in alternativa all’integrazione dei ricavi
prevista dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in
assenza di incentivi (norma questa mai attuata) - un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo
all’energia prodotta. L’incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal
D.M 6 luglio
2012 agli impianti di
nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità
fissate dallo stesso D.M..
L’erogazione dell’incentivo è comunque subordinata alla decisione
favorevole della Commissione europea
in esito alla notifica del regime di aiuto (articolo 1, commi 149-151).
Andamento
del fabbisogno economico e del gettito della componente A3 della bolletta
elettrica
Il GSE rileva, nell’ultimo
rapporto pubblicato, che il fabbisogno economico A3 è cresciuto rapidamente dai
circa 3 miliardi di euro nel 2009 a oltre 13 miliardi di euro nel 2014.
Per l’anno 2014 i costi sostenuti dal GSE nella gestione dei
meccanismi dedicati alle fonti rinnovabili e assimilate sono ammontati
complessivamente a un valore di 15,8 miliardi di euro.
I costi sostenuti dal GSE
sono stati in parte compensati dai ricavi provenienti dalla vendita sul mercato
dell’energia elettrica ritirata. Nel 2014 i ricavi, al lordo dei corrispettivi
di borsa e della valorizzazione degli sbilanciamenti, sono stati pari a circa
2.420 milioni di euro.
La differenza tra costi
(15,8 miliardi di euro) e ricavi (2,4 miliardi di euro) ha determinato un onere
e, dunque, un fabbisogno economico
della componente A3, pari a 13,4
miliardi di euro.
Il gettito A3 raccolto da parte dei distributori connessi alla rete di
trasmissione nazionale per l’anno 2014
è stato, invece, pari a circa 12,6
miliardi di euro.
Ne consegue un disavanzo
economico di circa 770 milioni di euro che dovrà essere comunque coperto con
successivi prelievi sulla componente A3.
Per il 2015, dati GSE, la
differenza tra costi nella gestione dei meccanismi dedicati alle fonti
rinnovabili - circa 15 miliardi di euro - e ricavi (poco più di 2 miliardi di
euro) ha determinato un onere e, dunque, un fabbisogno economico della componente A3, pari a 12,9 miliardi di euro.
La diminuzione del fabbisogno economico della componente A3 nel 2015
rispetto al 2014 è dovuta – secondo il GSE - al contemporaneo verificarsi di
fattori di segno opposto: la discesa di oltre 1 miliardo di euro del costo
relativo al Cip 6/92 –
gravato nel 2014 dal peso delle estinzioni anticipate – e secondariamente la
diminuzione del costo associato al Ritiro dedicato (RID) e al
Conto Energia, hanno più che bilanciato i maggiori oneri per l’acquisto dei
certificati verdi (CV) e i minori ricavi derivanti dalla vendita dell’energia
sul mercato.
Un ulteriore incremento è
previsto dal GSE nel 2016, per cui
si stimano preliminarmente circa 14,4
miliardi di euro di oneri, principalmente per la sovrapposizione tra il
ritiro dei CV invenduti e l’erogazione delle tariffe incentivanti che, proprio
a partire dal 2016, sostituiscono i CV stessi.
Dal 2017 il GSE prevede,
invece, una riduzione del fabbisogno A3, sia perché cesserà il ritiro dei CV
sia per la conclusione del periodo di incentivazione per diversi impianti.
Fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico
Il D.M. 23 giugno 2016 stabilisce le modalità di incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, inclusi i
solari termodinamici, aventi potenza superiore
a 1 kW nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento
di potenziamento o di rifacimento purché entrati in esercizio dal 1°gennaio
2013.
Sono fissate modalità
transitorie di applicazione, a specifiche condizioni, del precedente regime
incentivante delineato nel D.M. 6 luglio
2012.
Si
ricorda in proposito che il D.M. 6 luglio 2012 ha disciplinato anche le
modalità con cui gli impianti già in esercizio passano, a partire dal 2016, dal
meccanismo dei certificati verdi a nuovi meccanismi di incentivazione.
In continuità con il precedente
D.M. 6 luglio 2012, viene incentivata la produzione di energia elettrica
netta immessa in rete dall'impianto (calcolata come minor valore tra
la produzione netta e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete). Sono
previsti due differenti meccanismi incentivanti:
a) una tariffa
incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza fino a
0,500 MW, calcolata sommando alla tariffa
incentivante base (Tb)
gli eventuali premi a cui l'impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato
comprende anche la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE;
b) un incentivo (I)
per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW, calcolato come differenza
tra la tariffa incentivante base (Tb) - a cui vanno sommati eventuali premi a
cui l'impianto ha diritto - e il prezzo zonale orario dell’energia. L’energia
prodotta resta nella disponibilità del produttore.
Gli impianti di
potenza fino a 0,500 MW possono optare per l’una o l’altra tipologia, con
la facoltà di passare da un sistema all’altro non più di due volte nel corso
dell'intero periodo di incentivazione.
Gli impianti di
potenza superiore a 0,500 MW possono richiedere solo l’incentivo (I).
Gli incentivi vengono
erogati, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un
periodo pari alla vita media utile
convenzionale della specifica tipologia di impianto. Il
periodo di incentivazione avrà nella gran parte dei casi durata di vent’anni (venticinque per il solare termodinamico).
Gli incentivi verranno assegnati attraverso diverse
modalità a secondo della potenza
dell’impianto. E’ in particolare previsto:
§ l’accesso
diretto, a seguito dell’entrata in esercizio: nel caso di impianti nuovi,
oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento
o rifacimento, con potenza inferiore a
specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte;
§ l’iscrizione a
registri e successiva richiesta di accesso agli incentivi per gli impianti
ammessi in posizione utile: nel caso di impianti
nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione,
potenziamento, con potenza ricompresa in specifici valori di soglia,
differenziati per tipologia di fonte, ovvero nel caso di impianti oggetto di rifacimento, con potenza ricompresa in
specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte;
§ l’aggiudicazione delle procedure competitive di asta al ribasso: nel caso di impianti
nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione,
potenziamento, con potenza superiore al
valore di soglia di 5.000 KW (5 MW),
stabilito per specifiche tipologie di fonte rinnovabile.
Sul sito istituzionale
del GSE è riportato il seguente schema
delle modalità di accesso agli incentivi distinto per tipologie di impianti
e di fonte.
Modalità di accesso agli incentivi per impianti
nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni (**) e potenziamenti (***)
|
TIPOLOGIA DI FONTE
|
ACCESSO DIRETTO (kW)
|
REGISTRO (kW)
|
ASTA(kW)
|
|
Eolico on shore
|
1 < P ≤ 60(*)
|
1 < P ≤ 5000
|
P>5000
|
|
Eolico off-shore
|
1 < P ≤ 60(*)
|
|
P>5000
|
|
Idroelettrico
(di cui all'art. 4.3.b punti i, ii, iii,
iv)
|
1 < P ≤ 250
|
1 < P ≤ 5000
|
|
|
Idroelettrico
(diversi dall’art. 4.3.b punti i, ii,
iii, iv)
|
|
1 < P ≤ 5000
|
|
|
Oceanica
|
1 < P ≤ 60(*)
|
1 < P ≤ 5000
|
|
|
Geotermoelettrico
|
|
1 < P ≤ 5000
|
P>5000
|
|
Biomasse (art 8.4.a-b)
|
1 < P ≤ 200
|
1 < P ≤ 5000
|
|
|
Biomasse (art 8.4.c-d rifiuti)
|
|
1 < P ≤ 5000 (****)
|
P>5000(*****)
|
|
Biogas
|
1 < P ≤ 100
|
1 < P ≤ 5000 (****)
|
|
|
Solare Termodinamico
|
1 < P ≤ 100
|
1 < P ≤ 5000
|
P>5000
|
(*) Per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da PP.AA.,
anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, ad eccezione dei
potenziamenti, le potenze massime per l'accesso diretto sono raddoppiate.
(**) L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per
gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica, gas residuati
dei processi di depurazione e idroelettrici installati negli acquedotti.
(***) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza
sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine
dell'intervento.
(****) Per impianti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) e
gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili
(*****) Per impianti di
cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d).
Modalità di accesso agi incentivi per impianti
oggetto di rifacimento (*)
|
TIPOLOGIA DI FONTE
|
ACCESSO DIRETTO (kW)
|
REGISTRO (kW)
|
|
Eolico on shore
|
1 < P ≤ 60
|
P > 1
|
|
Eolico off-shore
|
1 < P ≤ 60
|
|
|
Idroelettrico
(di cui all'art. 4.3.b punti i, ii, iii,
iv)
|
1 < P ≤ 250
|
P > 1
|
|
Idroelettrico
(diversi dall’art. 4.3.b punti i, ii,
iii, iv)
|
|
P > 1
|
|
Oceanica
|
1 < P ≤ 60
|
|
|
Geotermoelettrico
|
|
P > 1
|
|
Biomasse (art 8.4.a-b)
|
1 < P ≤ 200
|
|
|
Biogas
|
1 < P ≤ 100
|
|
(*) Per gli interventi di
rifacimento gli intervalli di potenza sono riferiti alla potenza dell'impianto
al termine dell'intervento
Fonte: GSE
Quanto alle risorse messe a disposizione, il D.M.
23 giugno 2016 stabilisce per le diverse fonti rinnovabili nuovi contingenti di
potenza incentivabile (art. 9, 12 e 17). Il MISE ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale una tabella riepilogativa, per ciascuna fonte,
del contingente di potenza incentivabile e la spesa annua prevista, che, complessivamente ammonta a 435 milioni di euro.
|
Tecnologia
|
Spesa prevista
(mln euro)
|
Potenza
incentivabile (MW)
|
|
Eolico on-shore
|
85
|
860(*)
|
|
Eolico off-shore
|
10
|
30(*)
|
|
Idroelettrico
|
61
|
80(*)
|
|
Geotermico
|
37
|
50(*)
|
|
Biomasse
|
105
|
90(*)
|
|
Rifiuti
|
10
|
50(*)
|
|
Solare
termodinamico
|
98
|
120(*)
|
|
Rifacimenti
|
29
|
90(**)
|
|
Totale
|
435
|
1.370
|
(*) Art.9 (contingenti di potenza per
incentivazione con iscrizione a registro) + Art. 12 (contingenti di potenza per
incentivazione con procedure d’asta)
(**) Art. 12 (contingenti di potenza per
interventi di rifacimento totale o parziale)
I nuovi incentivi
verranno comunque erogati nell’ambito del tetto
complessivo di 5,8 miliardi di euro annui previsto per le energie
rinnovabili, diverse dal fotovoltaico, oggi in bolletta. Infatti, il D.M. 23 giugno 2016 (come il precedente
D.M. 23 luglio 2016) stabilisce infatti che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli
impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro
annui (articolo 3, commi 2 e 3 e art. 27, comma 3).
Infine, per ciò che
attiene al cumulo con altre fonti incentivanti, il D.M. 23 giugno 2016 prevede meccanismi di incentivazione non sono
cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art.
26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di cumulo. In particolare, nell’allegato I.3 sono
stabilite le modalità per la rideterminazione della tariffa per gli impianti ai
quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale ai sensi
del citato articolo 26.
La tariffa per la
produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in allegato 1 non
è cumulabile con ulteriori incentivi all’efficienza energetica e alla
produzione di energia termica, inclusi quelli di cui all’art. 30, comma 11,
della legge n. 99 del 2009.
Costo indicativo annuo
dell’incentivazione da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
Come sopra già
accennato, il D.M. 23 giugno 2016 (come
il precedente D.M. 23 luglio 2016) stabilisce infatti che il costo indicativo
cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile,
con esclusione di quelli fotovoltaici, non
può superare i 5,8 miliardi di euro annui (articolo 3, commi 2 e 3 e art.
27, comma 3).
A tal fine, il GSE
aggiorna periodicamente e pubblica aggiornamenti mensili del costo indicativo
cumulato annuo degli incentivi. Il D.M. incide anche sulle modalità di calcolo
del costo indicativo annuo.
Qualora poi il costo correlato comportasse il superamento del limite, tutti
i contingenti dovranno essere ridotti dal GSE nella medesima misura
percentuale, pari al rapporto fra il costo effettivamente disponibile (valore
dato dalla differenza tra il costo massimo dei 5.8 MLD € ed il costo indicativo
annuo) e quello relativo ai contingenti messi a disposizione (articolo 27).
Secondo i dati GSE, il costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti
alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici (contatore
FER-E) si è attestato a fine 2015
sul valore di circa 5.658 milioni di
euro, ripartiti come segue tra i diversi meccanismi di incentivazione
Costo
indicativo annuo di incentivazione della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili (escluso il fotovoltaico) per meccanismo
(al 31/12/2015)
(mln
euro)
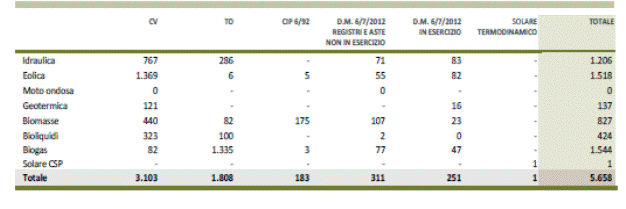 Fonte: GSE, Rapporto
attività 2015, pubblicato a marzo 2016.
Fonte: GSE, Rapporto
attività 2015, pubblicato a marzo 2016.
Secondo gli ultimi
dati messi a disposizione dal GSE, al 30
giugno 2016, risulta un costo indicativo annuo cumulato di 5.508 € mln, e un costo indicativo medio di 5.418 € mln.
Le proiezioni del GSE
indicano uno scenario evolutivo in diminuzione, ed in particolare una ulteriore discesa del costo annuo
dovuta prevalentemente al decadimento del diritto di accesso all’incentivo per
impianti non realizzati entro i termini previsti dal DM 6 luglio 2012.
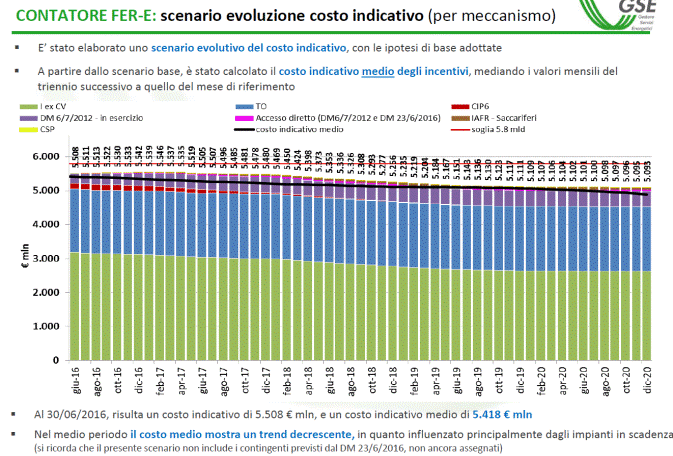
Settore termico
Per
quanto riguarda il settore
termico, l’obiettivo delineato nella SEN è quello di sviluppare
la produzione di rinnovabili fino al 20% dei consumi finali al 2020 (dal 17%
dell’obiettivo 20-20-20), pari a circa 11 Mtep/anno.
Il raggiungimento
dell’obiettivo è legato alla sostituzione di una parte degli impianti esistenti
alimentati a combustibili convenzionali, alle nuove installazioni,
all’evoluzione degli obblighi di integrazione delle rinnovabili nell’edilizia.
Per lo stimolo delle rinnovabili termiche di piccola taglia (destinato
prevalentemente al settore civile), è stato varato un decreto ministeriale che
incentiva direttamente l’installazione di impianti dedicati, il cosiddetto “Conto
Termico” (D.M. 28 dicembre 2012).
Con il D.L. 133/2014 (cd. Sblocca-Italia) si è
poi cercato di dare nuovo impulso a tale tipologia di incentivazione, cercando
di facilitare l'accesso ad imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi
per gli interventi:
§ di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
§ di
incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data
successiva al 31 dicembre 2011.
Il D.L. n. 133/2014 (articolo
22) ha previsto, a tal fine, l'aggiornamento,
entro il 31 dicembre 2014, del sistema di incentivi definiti dal c.d. conto
termico con il D.M. 28 dicembre 2012, al fine di semplificare le procedure ed
utilizzare gli strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate (cd.
nuovo conto termico).
Il “Nuovo conto termico” (Decreto interministeriale
del 16 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 marzo
2016), aggiorna dunque la disciplina per l’incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, perseguendo i principi di
semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica indicati
dal D.L. n. 133/2014, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione
energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
Il D.M. prevede un “tetto di spesa” pari a 200 milioni di euro per incentivi
riconosciuti ad interventi di pubbliche
amministrazioni e a 700 milioni di
euro ad interventi realizzati da privati.
Le richieste possono essere presentate (entro
60 giorni dalla fine dei lavori) attraverso la modalità dell’accesso diretto. Per
le PA è anche consentito, con l’accesso a prenotazione, riservare gli
incentivi prima dell’avvio lavori.
In accesso diretto l’incentivo
è erogato in un’unica soluzione, per i soggetti privati fino a 5.000
euro, per le PA a prescindere dall’importo.
In caso di prenotazione, le PA ricevono una
rata di acconto ad avvio lavori e il saldo al termine degli stessi.
Il responsabile della gestione del meccanismo
e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE.
In particolare, come sopra accennato, soggetti
che possono richiedere gli incentivi
del nuovo Conto termico sono i soggetti privati e le pubbliche
Amministrazioni (di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),
incluse gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte
all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro
consorzi, costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le
società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali
iscritte nei rispettivi albi regionali.
L’accesso ai meccanismi di incentivazione può
essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di ESCO:
per le Pubbliche Amministrazioni attraverso la sottoscrizione di un contratto di
prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante un contratto di
servizio energia previsti dal D.lgs. 115/2008.
Dal 19 luglio 2016 (a 24 mesi dall’entrata in
vigore del d.lgs. 102/2014), possono presentare richiesta di incentivazione al
GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo
la norma UNI CEI 11352.
Quanto agli interventi incentivabili, essi sono
stati schematizzati dal GSE (Cfr. Vademecum
del Conto termico 2.0) nel
seguente modo:

Fonte: GSE.
Rispetto al precedente
Conto termico, il nuovo Conto prevede, come evidenzia il GSE, percentuali di
incentivazione più alte, ed in particolare:
§ fino
al 65% della spesa sostenuta per gli nZEB
§ fino
al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la
sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari,
l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione
§ fino
al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e
§ fino
al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate,
se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare
termico, ecc.)
§ anche
fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi
a pompe di calore e impianti solari termici
§ il
100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione
Energetica (APE) per la PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50 % per
i soggetti privati, con le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali.
Le incentivazioni di
cui al Nuovo Conto Termico non sono cumulabili
con altri incentivi di natura statale, ad eccezione dei fondi di rotazione, di
garanzia e i contributi in conto interesse). Per le pubbliche amministrazioni (in riferimento agli edifici di proprietà
e in loro uso, e ad eccezione delle cooperative sociali e di abitanti) è
prevista la cumulabilità con altri
incentivi in conto capitale, sia di natura statale che non statale, nel limite
del 100% della spesa effettuata.
Per i soggetti privati
è prevista la cumulabilità con altri incentivi non statali nel limite del 100%
della spesa effettuata. Per le imprese,
l’ammontare complessivo dell’incentivo concesso (contributo del conto termico
più altri di natura non statale) deve essere nei limiti di spesa prevista dalla normativa europea sugli aiuti di stato in materia di energia e
ambiente.
Alle ESCO si applicano
i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.
Le domande di accesso agli incentivi presentate prima del 31 maggio
2016 sono disciplinate a norma del D.M. 28 dicembre 2012 (precedente conto
termico).
Le domande presentate dal 31 maggio 2016 sono invece soggette alla
disciplina prevista dal “Nuovo conto termico” D.M. 16 febbraio 2016.
Ad ottobre 2016, il GSE ha provveduto ad una prima analisi dell’andamento delle
domande, nell’anno 2016, avanzate ai sensi del precedente Conto termico e
del Nuovo conto termico.
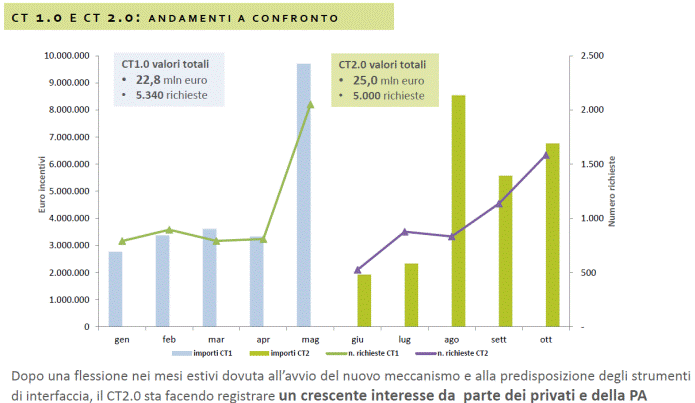
Fonte: GSE
La Tabella che segue è stata
tratta dalla “Terza Relazione dell’Italia in merito ai progressi ai
sensi della direttiva 2009/28/CE” (cd. Progress Report)” di dicembre 2015.
La tabella è stata
aggiornata agli interventi contenuti nella legge
di bilancio 2017 relativamente alle detrazioni
fiscali per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche e alla
disciplina del cd. nuovo “conto termico” di cui al D.M. 16 febbraio 2016.
Le misure di promozione delle fonti rinnovabili sono
qualificate per:
§
tipologie: come interventi finanziari (incentivazioni
di varia natura, anche fiscale), ovvero come misure normative (costituenti
talvolta obblighi di fare a carico dei soggetti destinatari);
§
per destinatari;
§
per risultato atteso;
§
per contenuto specifico della misura;
§
per data di inizio e conclusione della misura.