| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
| Titolo: | L'attuazione in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di durata dei processi e di espulsione degli stranieri - Schede di lettura | ||||
| Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 142 | ||||
| Data: | 20/10/2014 | ||||
| Descrittori: |
| ||||
| Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia | ||||
L'attuazione in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di durata dei processi e di espulsione degli stranieri
20 ottobre 2014
|
Indice |
| L'eccessiva durata dei processi|Gli indennizzi della Legge Pinto: procedimento e difficoltà di pagamento|L'espulsione degli stranieri| |
E' in preparazione l'VIII Rapporto della Commissione diritti umani del Consiglio d'Europa sull'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nei Paesi membri
Tra i dieci Paesi oggetto del rapporto, figura anche l'Italia rispetto principalmente a due questioni:
Si tratta delle medesime questioni emerse nell'ultimo rapporto pubblicato, il settimo, del 20 dicembre 2010. Sulla base di tale rapporto l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato nel 2011 la risoluzione n. 1787 e la raccomandazione n. 1955.
La Commissione diritti umani ha proceduto successivamente ad una serie di incontri con le delegazioni parlamentari dei Paesi interessati. Il 24 aprile 2012, la Commissione ha incontrato la delegazione italiana presieduta dall'on. Luigi Vitali, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Analogamente, il relatore del prossimo rapporto, l'olandese Klaas de Vries, procederà ad un nuovo giro di consultazioni. La visita in Italia è fissata per il 22 e 23 ottobre 2014.
In vista della redazione del nuovo rapporto, il relatore ha pubblicatonel 2013 un documento generale sulle principali questioni in discussione. In allegato al documento, una disamina della situazione per ciascuno degli otto Paesi interessati.
L'eccessiva durata dei processi |
Le censure mosse all'ItaliaIl Consiglio d'Europa, nel documento elaborato in preparazione dell'VIII rapporto sull'attuazione delle decisioni della CEDU, individua nell'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari, dalla quale deriva un numero imponente di procedimenti pendenti, e nell'assenza di conseguenti rimedi efficaci, due dei principali problemi dell'Italia per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. Della portata di tali emergenze è sintomatico il numero di ricorsi presentati contro il nostro Paese dinanzi alla Corte dei diritti. Infatti, nel giugno del 2012 l'Italia figurava tra i sette paesi del Consiglio d'Europa con il più alto numero di cause ripetitive pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti: oltre 8.000 ricorsi pendenti per eccessiva durata del processo in Italia8.000 ricorsi per eccessiva durata dei processi e per l'attuazione delle decisioni assunte in base alla c.d. Legge Pinto, la legge n. 89 del 2001 che disciplina la procedura per ottenere un equo indennizzo a seguito di violazione del termine di ragionevole durata del processo. Molte cause (circa 4.000), infatti, concernono i ritardi nei pagamenti dell'indennizzo riconosciuto in base alla Legge Pinto, ritardo stimato dalla CEDU tra i 9 ed i 49 mesi dall'emanazione della decisione (in oltre il 65% dei casi, il ritardo medio è di 19 mesi). Per questa ragione, nel dicembre 2012, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha nuovamente richiamato l'Italia per i ritardi eccessivi nell'amministrazione della giustizia, che si traducono «in una violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione», sottolineando l'urgenza di arrestare «il flusso di ulteriori ricorsi alla Corte europea e l'urgenza di trovare una soluzione sostenibile» per questo problema strutturale. L'eccessivo numero di ricorsi riguardanti la lunghezza del processo in Italia, infatti, minaccerebbe il futuro del sistema di protezione dei diritti umani in Europa. Di seguito si dà sommariamente conto delle iniziative intraprese dal legislatore italiano per risolvere i problemi evidenziati dal Consiglio d'Europa. Si riportano sinteticamente i provvedimenti approvati in XVI legislatura (2008-2013), che ancora devono compiutamente dispiegare i propri effetti, e quelli già introdotti nell'attuale XVII legislatura, con particolare riferimento anche al decreto-legge n. 132 del 2014, in corso di esame parlamentare. Si riportano poi approfondimenti specifici sull'istituto della mediazione e sulla digitalizzazione del processo, e approfondimenti statistici. |
Le misure per la riduzione dei tempi del processo e lo smaltimento dell'arretrato nella XVI legislatura (2008-2013)Se l'attuale legislatura si è caratterizzata per lo sforzo di Governo e Parlamento per ridurre la popolazione carceraria, in attuazione di numerose sentenze CEDU e richiami del Consiglio d'Europa, la scorsa legislatura (2008-2013) è stata invece segnata dall'impegno per la riduzione dei tempi dei giudizi (essenzialmente civili e amministrativi). In merito, lo stesso documento di preparazione dell'VIII rapporto, predisposto nel mese di maggio dello scorso anno, evidenzia i passi in avanti nello smaltimento dell'arretrato civile realizzati dall'Italia negli anni più recenti, soprattutto grazie alla semplificazione dei riti civili e alla digitalizzazione del processo; lo stesso documento afferma che ulteriori speranze sono riposte sulla disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali. Si tratta di iniziative che hanno tutte preso le La legge 69 del 2009 come fulcro di tutti gli interventi della XVI legislatura per la riduzione dei tempi del processo civilemosse dalla legge 69/2009, approvata a pochi mesi dall'inizio della legislatura, che oltre a prevedere una parziale riforma del codice di procedura civile, ha delegato il Governo a operare la semplificazione e riduzione dei riti di cognizione ed a disciplinare appunto la mediazione delle controversie civili. Le principali linee di intervento cui si è ispirata la riforma del processo civile sono le seguenti:
Le statistiche 2012 su nuove iscrizioni a ruolo, procedimenti definiti e pendentiAnche in esito a tali interventi, nel 2012 - ultimo dato disponibile - in quasi tutti gli uffici giudiziari i procedimenti civili definiti sono stati più numerosi dei procedimenti civili iscritti a ruolo, con i primi positivi effetti sullo smaltimento dell'arretrato. Come dimostra il confronto tra le statistiche del 2010 e quelle, appunto, del 2012, il dato più rilevante è quello della riduzione delle iscrizioni a ruolo; un dato forse collegato - oltre che all'introduzione dell'istituto della mediazione (v. infra) - anche alla consapevolezza della lunghezza e della conseguente onerosità del processo civile.
 Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione generale di statistica Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione generale di statisticaAlla Ma la durata del processo resta altariduzione dei procedimenti pendenti non ha sinora corrisposto una velocizzazione dei tempi del processo, come è dimostrato dal confronto, per i medesimi anni 2010 e 2012, tra le statistiche sulla durata media dei procedimenti civili dinanzi a ciascuna tipologia di ufficio giudiziario. In particolare, maggior sofferenza è espressa dai giudizi di impugnazione, dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte di Cassazione.
 Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione generale di statistica Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione generale di statistica |
I provvedimenti approvati nella XVII legislatura (da maggio 2013)Anche per rispondere alla crisi dei giudizi di impugnazione evidenziata dalle statistiche del 2012, nell'attuale XVII legislatura un consistente intervento per la riduzione dei tempi del processo civile è stato previsto dagli articoli da 62 a 84-bis del decreto-legge 69/2013. Il provvedimento d'urgenza, a seguito della conversione in legge operata dal Parlamento, ha in particolare dettato Le misure organizzativemisure organizzative e di ampliamento dell'organico, proprio riguardanti le Corti d'appello e la Corte di cassazione. In particolare,
Il decreto-legge ha anche introdotto ulteriori Le misure processualimisure processuali, per deflazionare il processo e accelerarne i tempi:
Successivamente, il decreto-legge 145 del 2013 ha Un foro per le società con sede all'esteroprevisto - tra le misure finalizzate a favorire l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane - la concentrazione in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e corti d'appello di una serie di controversie civili che coinvolgono società con sede all'estero. Il decreto-legge 90 del 2014 ha dettato disposizioni per il recupero di efficienza del processo amministrativo, in particolare contrastando l'abuso del processo. Nel settore civile, il provvedimento d'urgenza ha invece costituito il c.d. Ufficio del processoufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello. Presso tali strutture potranno svolgere il proprio stage i laureati in giurisprudenza (v. sopra). Da ultimo, il decreto-legge 132 del 2014, tuttora in corso di conversione (A.S. 1612):
|
Approfondimento: gli effetti deflattivi della mediazione obbligatoriaUna riduzione del numero dei procedimenti iscritti a ruolo nonché una fuoriuscita dal processo civile è l'obiettivo perseguito dal legislatore che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della mediazione, prevedendone l'obbligatorietà in relazione a particolari materie. Come detto, infatti, nella scorsa legislatura la legge 69/2009 – nell'ambito di articolati interventi sul processo civile - ha delegato il Governo a disciplinare la conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione del decreto legislativo 28/2010, prevedendo in particolare che per talune controversie il tentativo di mediazione fosse obbligatorio, ovvero rappresentasse una condizione di procedibilità dell'azione. Procedimenti di mediazione avviati dal 2011 al dicembre 2012 - Rilevazione statistica con proiezione nazionale (Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. (Direzione generale di statistica), Statistiche al 31 dicembre 2012)
I dati evidenziano una crescente spinta verso la mediazione, dovuta alla previsione della sua obbligatorietà per alcune materie.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, che ha dichiarato questo aspetto della disciplina incostituzionale per eccesso di delega, in quanto la legge 69/2009 non aveva introdotto alcun principio o criterio direttivo sul punto dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione. Tale intervento demolitorio della Consulta – che aveva depotenziato notevolmente il ruolo deflattivo assegnato dal Governo alla mediazione (come evidenziano chiaramente i dati sui procedimenti iscritti negli ultimi due mesi del 2012) – è stato superato, nell'attuale legislatura, dal decreto-legge 69/2013 che ha reintrodotto le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione pur affermandone il carattere transitorio e sperimentale (per 4 anni). Il provvedimento – a seguito della conversione in legge - ha inoltre:
Ad oggi, dunque, la disciplina della mediazione è contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla conversione del decreto-legge n. 69 del 2013. L'attività di mediazione è affidata ad appositi organismi di mediazione, iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia (disciplinato dal D.M. 180/2010); essa non preclude l'azione ordinaria. L'oggetto della mediazione viene circoscritto alle controversie civili e commerciali che abbiano ad oggetto diritti disponibili delle parti (articolo 2). La mediazione può essere obbligatoria o facoltativa. Inoltre, se originariamente, nel 2010, il procedimento di mediazione era pensato esclusivamente per la fase antecedente l'instaurazione della controversia civile, con la finalità di evitare il ricorso al giudice, a seguito della riforma del 2013 il procedimento di mediazione può svolgersi anche rispetto a una controversia già avviata, e proprio dietro impulso del giudice. Controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilitàPer quanto riguarda la fase antecedente l'instaurazione della controversia civile, a seguito della conversione del decreto-legge n. 69/2013, il tentativo di mediazione riveste – in relazione a specifiche controversie e per i quattro anni successivi alla conversione del decreto-legge, ovvero fino a 21 agosto 2017 - carattere obbligatorio, ed è quindi condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Questa previsione ha carattere sperimentale, dovendo il Ministero della giustizia, a partire dal 21 agosto 2015, attivare un monitoraggio sugli esiti dell'esperienza svolta. La mediazione è dunque oggi obbligatoria in relazione alle seguenti controversie (articolo 5, comma 1-bis):
Per tutte le restanti possibili controversie civili e commerciali la mediazione ha carattere facoltativo. Per quanto riguarda la fase successiva all'instaurazione della controversia civile, a seguito della conversione del decreto-legge n. 69/2013, il tentativo di mediazione può svolgersi anche rispetto a controversie già instaurate o addirittura già in appello. L'articolo 5, comma 2, stabilisce che laddove il giudice ritenga, per la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, che sia esperibile una mediazione, potrà disporre che le parti vi procedano; in tal caso, il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità dell'azione (tanto in primo grado quanto in appello). Al di fuori di queste ipotesi, anche rispetto a controversie già instaurate, l'esperimento di un tentativo di conciliazione avrà carattere facoltativo. Le Controversie per le quali la mediazione non è mai obbligatoriadisposizioni sulla mediazione obbligatoria (tanto rispetto al primo grado quanto all'appello) non si applicano:
Al fine di facilitare il ricorso alla mediazione, si prevede a carico dell'avvocato uno speciale obbligo di informazione nei confronti del cliente, già all'atto del conferimento dell'incarico, relativo alla possibilità, ovvero all'obbligo, di avvalersi del procedimento di mediazione (articolo 4), nonché delle agevolazioni fiscali previste per la procedura. In caso di violazione dell'obbligo di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. I dati resi disponibili dal Ministero della Giustizia (Dipartimento della organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica) relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 e poi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2014, evidenziano come nel 2013 siano stati iscritti 41.604 procedimenti di mediazione e solo nel primo trimestre del 2014 ben 58.389. Iscrizioni mediazioni: confronto 2012 - 2013 - I trim. 2014
I dati evidenziano come nel 2013 il numero dei tentativi di mediazione proposti abbia scontato gli effetti della sentenza della Corte costituzionale che a partire dall'ottobre 2012 ha soppresso la mediazione obbligatoria. Non è un caso se nel quarto trimestre del 2013, quando la mediazione obbligatoria è reintrodotta, si registrano circa 8.700 iscrizioni al mese (nei trimestri precedenti del 2013 le iscrizioni mensili erano circa 1.700). Oggi il Ministero quantifica in circa 20.000 al mese le iscrizioni di nuovi tentativi di conciliazione. Degli oltre 41.000 procedimenti di mediazione avviati nel 2013, il 54,7% sono relativi a controversie a mediazione obbligatoria, con procedimenti instaurati dunque dopo il DL 69/2013. Il 41,9% dei procedimenti iscritti sono riconducibili a mediazione volontaria, l'1,4% a mediazione obbligatoria in forza di una clausola contrattuale e l'1,9% a mediazione demandata dal giudice. Di seguito le statistiche del primo trimestre 2014 sulle materie della controversia per la quale è promossa la mediazione.
|
Approfondimento: gli effetti acceleratori del processo telematicoUlteriori speranze di accelerazione del processo civile, oltre che di riduzione dei suoi connessi costi economici e amministrativi, sono riposte dal legislatore nella piena attuazione del c.d. processo telematico. L'avvio del processo civile telematico è segnato da una serie di interventi normativi, il primo dei quali risale al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), in attuazione di una disposizione della cd. Legge Bassanini volta a riconoscere in via generale valore legale agli atti e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici (art. 15, comma 2, L. 59/97).
Le disposizioni contenute nel Regolamento erano volte a dare vita a un sistema informatizzato dell'attività giudiziaria alternativo a quello cartaceo.
Successivamente, una serie di decreti ministeriali ha previsto regole procedurali, tecnico-operative e modelli informatici per l'avvio del processo civile telematico.
Il quadro normativo sviluppatosi a partire dal 2001 è stato complessivamente rivisto nel corso della I provvedimenti approvati nella scorsa legislaturaXVI legislatura dal decreto-legge n. 193/2009. In particolare, l'art. 4 del provvedimento ha disposto che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale – (d.lgs. 82/2005) e del regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005). Per la prima volta, dunque, la disciplina del processo telematico è stata estesa anche al settore penale. Il provvedimento ha inoltre stabilito che negli uffici giudiziari indicati nei singoli decreti ministeriali attuativi, le seguenti notificazioni e comunicazioni devono essere effettuate per via telematica ad un indirizzo di posta elettronica certificata:
Il decreto-legge 138 del 2011 ha previsto poi che, nel processo civile, in ogni citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto, il difensore debba indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax e che con le indicate modalità debbono essere effettuate tutte le comunicazioni alle parti. La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) è tornata a novellare numerose disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione, per dare piena operatività all'utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare, articolo 25 della legge, entrato in vigore il 31 gennaio 2012, ha previsto:
Si segnala poi il decreto-legge 179/2012 che ha disposto come nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procederà, nel processo penale, per le notificazioni a persona diversa dall'imputato. Per favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, queste debbono comunicare al Ministero della giustizia l'indirizzo di PEC presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi dei posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli UNEP (uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) del Ministero della giustizia. Lo stesso provvedimento ma modificato inoltre in molteplici punti la legge fallimentare e le disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, per estendere l'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle diverse fasi delle procedure concorsuali. Da ultimo, nella scorsa legislatura, la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha stabilito che:
Da ultimo, nell'La digitalizzazione in XVII legislaturaattuale legislatura, il Parlamento è ulteriormente intervenuto sulla c.d. digitalizzazione della giustizia con la conversione del decreto-legge n. 90 del 2014. In particolare, il decreto:
Ulteriori disposizioni, relative alla comunicazione della sentenza e alle comunicazioni telematiche, sono dettate dal decreto-legge a seguito della conversione; in particolare, nel processo esecutivo, il decreto-legge interviene in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore prevedendo che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate con modalità telematiche con alcune eccezioni. In esito a tale complesso di disposizioni, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati - Area Civile, ha reso noti i seguenti dati: 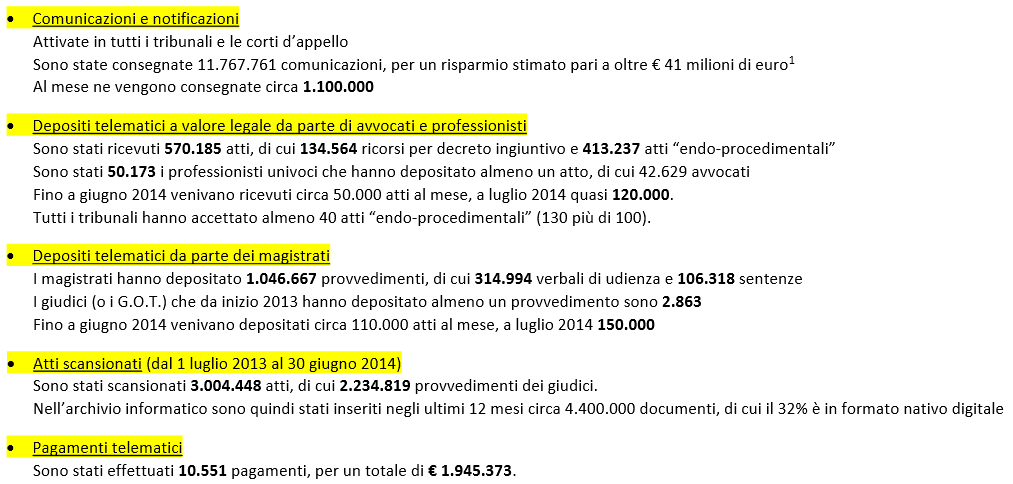 1. Calcolo effettuato sul costo medio stimato di € 7,00 a comunicazione tradizionale tramite ufficiale giudiziario, prudenzialmente moltiplicato per la metà delle comunicazioni elettroniche effettivamente consegnate (totale =11.767.761: 2 =5.883.880x €. 7,00 = €. 41.187.163,50) 1. Calcolo effettuato sul costo medio stimato di € 7,00 a comunicazione tradizionale tramite ufficiale giudiziario, prudenzialmente moltiplicato per la metà delle comunicazioni elettroniche effettivamente consegnate (totale =11.767.761: 2 =5.883.880x €. 7,00 = €. 41.187.163,50) |
Gli indennizzi della Legge Pinto: procedimento e difficoltà di pagamentoIl Consiglio d'Europa esprime preoccupazione, oltre che per la lunghezza dei processi in Italia, anche per «l'evidente cattivo funzionamento delle vie di ricorso previste nella normativa interna in materia di durata eccessiva dei procedimenti, e fa appello alle autorità italiane affinchè siano liquidati d'urgenza i danni riconosciuti dai tribunali italiani. Sollecita, inoltre, le autorità a rivedere l'istituto del rimedio risarcitorio e ad integrarlo con un rimedio maggiormente preventivo, ad effetto acceleratore, onde evitare la presentazione di ulteriori istanze di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo» (cfr. Rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012). Per migliorare l'efficienza nel pagamento degli indennizzi dovuti dallo Stato per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il legislatore ha recentemente novellato le disposizioni della c.d. Legge Pinto (legge n. 89 del 2001), il cui articolo 2 prevede il diritto all'equa riparazione per chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione. In particolare, il decreto-legge n. 83 del 2012 (art. 55) ha modificato la disciplina dei Nuovo procedimento, più veloceprocedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale, specificando inoltre, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole. I giudizi sul diritto all'equa riparazione che devono decidere sul fondatezza del ricorso e sulla liquidazione degli importi si svolgono davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile e con svolgimento attraverso una pluralità di udienze. Poiché tali procedimenti, proprio per la loro eccessiva durata, sono stati essi stessi fonte di domande di risarcimento, il decreto-legge ha delineato un nuovo, più snello, modello procedimentale (basato su quello del decreto ingiuntivo previsto dal codice di rito civile) che permette di arrivare ad una rapida decisione sia sulla domanda (dagli attuali quattro mesi si passa a trenta giorni) che sull'eventuale impugnazione.
Per limitare gli esborsi dello Stato per violazione del termine di ragionevole durata, il provvedimento ha previsto poi:
Con la novella in esame, inoltre, sono fissati nella stessa legge Pinto i Predeterminazione dei termini di ragionevole duratatermini di ragionevole durata nei diversi gradi di giudizio sulla base di parametri acquisiti dalla giurisprudenza (sei anni complessivi: tre per il primo grado, due per l'appello ed uno per il giudizio di cassazione).
La riforma della disciplina per l'indennizzo da irragionevole durata del processo ha comportato anche la previsione dell'obbligo in capo al Ministero dell'economia e delle finanze di procedere comunque ai pagamenti degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, anche in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio.
Sul tema degli indennizzi della Legge Pinto è da ultimo intervenuto anche il decreto-legge n. 35 del 2013 (art. 6) che ha affermato l'Impignorabilità delle sommeimpignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo, al fine di garantire un'ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate dallo Stato. Nel settembre 2013, il Fondi insufficenti per pagare gli indennizziMinistero della Giustizia (Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani), ha diramato una nota esplicativa, nella quale vengono palesate tutte le difficoltà di pagamento degli indennizzi da parte dello Stato. La nota affermava che al pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della c.d. Legge Pinto, nei quali il Ministero della giustizia è convenuto in giudizio e condannato, provvede il medesimo Ministero con il capitolo 1264 (Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo), gestito dal Dipartimento degli Affari della Giustizia. Tale capitolo è stato fino al 2012 incrementato mediante prelievo dal capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ("Fondo da ripartire per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi di equa riparazione"- spese obbligatorie). Stante la disposizione contenuta nella stessa legge 89/2001, secondo cui «L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili», il relativo stanziamento a favore della Giustizia è stato effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze una volta all'anno e con notevole ritardo (solitamente tra aprile e luglio) e in entità mai sufficiente né alla liquidazione dei decreti emessi nell'anno in corso né all'azzeramento del debito arretrato (nel 2011 e nel 2012 lo stanziamento è stato pari a circa il 10% del debito accumulato). Con l'anno 2013, per la prima volta, la Legge di bilancio ha stabilito a favore della Giustizia una assegnazione di fondi sul capitolo 1264, assegnazione definita dal Ministero «ancora del tutto insufficiente (50 milioni di euro) rispetto all'entità del debito (oltre 340 milioni di euro)». Il rendiconto 2013 registra previsioni definitive di competenza per 50 mln di euro ma i pagamenti effettuati per equa riparazione risultano, tuttavia, pari a 69,5 mln di euro (sono stati, allo scopo, utilizzati quasi integralmente i 19,8 mln di residui dell'esercizio finanziario 2012). Nel bilancio di previsione 2014 sul capitolo 1264 sono stati appostati 55 milioni di euro; lo stanziamento è stato confermato anche in sede di assestamento del bilancio. Quanto alle modalità di pagamento degli indennizzi, considerato l'elevato numero di condanne riportate dalla Giustizia nei contenziosi ex lege 89/2001, il Dipartimento degli Affari della Giustizia sin dall'aprile 2005 ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di Appello, "in un'ottica di decentramento e decongestione", con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264. Spetta pertanto alla Corte di appello che emesso il decreto di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi. Resta invece a carico dell'Amministrazione centrale, con facoltà di delega, il pagamento degli indennizzi stabiliti in sentenze emesse dalla Corte di cassazione. Per quanto riguarda l'attuazione data alle L'attuazione giurisprudenziale delle sentenze CEDUsentenze CEDU dalla giurisprudenza nazionale, si ricorda che recentemente le sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 6312 del 2014) hanno affermato che «In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo [...] l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all'art. 133, secondo comma, c.p.c.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva che, tuttavia, può essere fatta valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all'art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni esecutive». |
L'espulsione degli stranieri |
Le censure mosse all'ItaliaL'attenzione del Il Consiglio d'Europa e l'immigrazione in ItaliaConsiglio d'Europa nei confronti dell'Italia in materia d'immigrazione è diventata piuttosto significativa da quando il nostro paese si è dotato di strumenti giuridici e operativi per respingere l'immigrazione illegale e ha concluso accordi ad hoc con i paesi della sponda sud del Mediterraneo e in particolare con la Libia. Grande attenzione hanno destato i respingimenti in mare, il trattenimento degli immigrati nei Centri di permanenza temporanea (ora Centri di identificazione ed espulsione) e la politica in materia di asilo (per approfondimenti si veda Il Consiglio d'Europa e l'immigrazione a cura dell'Osservatorio di politica internazionale, del giugno 2010).
LaGiurisprudenza CEDU giurisprudenza della CEDU ha in diverse occasioni sollevato la questione della violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo nell'esecuzione dell'espulsione di cittadini stranieri. Le violazioni richiamate dalla Corte e che saranno oggetto del prossimo rapporto della Commissione riguardano fondamentalmente due profili. In primo luogo, viene richiamato l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che proibisce la tortura e la sottoposizione a pene o a trattamenti inumani o degradanti. In diverse sentenze la Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 3 da parte dell'Italia in caso di cittadini stranieri espulsi verso Paesi dove esisteva un rischio concreto che questi fossero sottoposti a tortura. In secondo luogo, viene richiamato l'articolo 34 che disciplina le procedure di ricorso individuale presso la Corte e impegna i Paesi membri a non ostacolare in alcun modo l'esercizio effettivo. La Corte ha considerato quali violazioni del diritto di accesso al ricorso le espulsioni effettuate dalle autorità italiane prima della pronuncia della Corte.
In particolare, per quanto riguarda le espulsioni in violazione dell'art. 3 della Convenzione, si ricorda la Sent. Saadisentenza Saadi (sent. 28 febbraio 2008, causa n. 37201/06) seguita da diverse casi simili. Saadi, di nazionalità tunisina, aveva ricevuto un ordine di espulsione dopo aver scontato la pena in Italia. Saadi era stato condannato a diversi anni di reclusione da un tribunale militare tunisino. La Corte di Strasburgo ha affermato che egli avrebbe corso un serio rischio di essere sottoposto in Tunisia ad un trattamento inumano o degradante contrario all'art. 3 della Cedu e che quindi non poteva essere deportato in quel paese, nonostante le accuse di terrorismo internazionale e le assicurazioni, da parte delle autorità diplomatiche tunisine, che egli non avrebbe subito alcun trattamento in violazione dei diritti umani. Con un'altra sentenza importante (BenSent. Khemais Khemais c. Italia, Ricorso n. 246/07, deciso il 24 febbraio 2009) la Corte ha affermato che l'espulsione del ricorrente verso la Tunisia, mentre era in corso il procedimento dinanzi alla Corte, ostacolava l'effettività del ricorso, in contrasto con l'art. 34 della CEDU. |
Gli interventi in materia di espulsioneIl Il principio di non-refoulementprincipio di non-refoulement, ossia il divieto di espulsione di uno straniero verso un Paese dove la sua vita o la sua libertà potrebbero essere messe in pericolo, è accolto nel nostro ordinamento ed è contenuto nel testo unico in materia di immigrazione del 1998. Infatti, non possono essere espulsi, né respinti in nessun caso gli stranieri che possono essere oggetto di persecuzione nel Paese di destinazione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/1998). Per i rifugiati, una disposizione analoga è recata dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (art. 33) recepita nel nostro ordinamento con la legge 722/1954.
In materia di espulsione, si ricorda che nel 2011 l'Italia ha recepito laLa direttiva rimpatri direttiva 2008/115/CE, riguardante il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari (la c.d. direttiva rimpatri) con l'adozione del decreto legge 89/2011 che ha apportato diverse modifiche ed integrazioni al testo unico in materia d'immigrazione. Con l'adozione del decreto-legge è stato introdotto il principio del rimpatrio volontario quale modalità ordinaria di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino straniero, mentre l'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera può essere disposto esclusivamente in una serie tassativa di casi determinati, quali ad esempio il rischio di fuga, e, in ogni caso, previo esame individuale della situazione personale dello straniero.
Tra le altre misure introdotte:
Con il decreto del ministro dell'interno 27 ottobre 2011, sono state adottate le Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, come previsto dal D.L. 89/2011.
In materia è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 6 dicembre 2012, C-430/11 (Sentenza Sagorcaso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE come recepita dal decreto-legge 89/2011. La Corte ha individuato nella procedura penale connessa alla punizione del Reato di immigrazione clandestinareato di immigrazione clandestina (introdotto con il pacchetto sicurezza del 2009) alcune misure che compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva privando quest'ultima del suo effetto utile.
La prima misura oggetto della censura della Corte risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae ad esso si applica l'obbligo di permanenza domiciliare al massimo di 45 giorni (art. 55, D.Lgs. 274/2000). Secondo la Corte la previsione dell'obbligo della permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità. Infatti, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni). E' vero che il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 16, comma 1 TU). Ma in questo caso l'espulsione è immediata; infatti l'art. 16, comma 2, TU fa rinvio per le modalità di espulsione all'art. 13, comma 4, TU, relativo espulsione con accompagnamento alla frontiera, e "immediata", come definita dal successivo comma 5.
E qui interviene la seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che "qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato" e quindi non può applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina.
L'adeguamento dell'ordinamento interno alla sentenza della Corte è previsto dall'articolo 2 del Il d.d.l. europea 2013-bisdisegno di legge europea 2013-bis in corso di esame da parte Parlamento (A.C. 1864) che apporta alcune modifiche al testo unico immigrazione, finalizzate appunto al pieno recepimento della direttiva rimpatri.
Il Parlamento italiano ha comunque deciso l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Infatti, il 2 aprile 2014 è stata approvata definitivamente la legge in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (L. n. 67 del 2014); essa reca all'articolo 2 una delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi è anche l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, trasformato in illecito amministrativo.
Il citato disegno di legge europea 2013-bis, in corso di esame, oltre all'adeguamento alla direttiva rimpatri, prevede ulteriori misure in materia, tra cui la riduzione (introdotta dalle Camere) a 90 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei CIE (attualmente di 18 mesi).
Si prevede inoltre che lo straniero, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, sia espulso solo se si trattenga oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schenghen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo 60 giorni nel caso lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in questura).
Si dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schenghen.
Altri interventi adeguano il diritto interno alle norme comunitarie anche alla luce della loro interpretazione recata da altre sentenze della Corte di giustizia europea.
Si prevede l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita (sentenza CGUE del 30 novembre 2009, C-357-09).
Viene poi rimodulata la durata del divieto di reingresso a seguito di condanna per il reato immigrazione irregolare, attualmente di non meno 5 anni, equiparandola a quella del divieto di reingresso per anni (sentenza CGUE 6 dicembre 2011, C-430/11).
Anche il Il decreto-legge 146/2013decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, introduce, tra l'altro, alcune disposizioni in materia di espulsione e trattenimento degli immigrati. In primo luogo, viene modificata la disciplina dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, ampliando il campo di possibile applicazione della misura e delineando i diversi ruoli di direttore del carcere, questore e magistratura di sorveglianza, prevedendo una velocizzazione delle procedure di identificazione. Inoltre, tra le funzioni attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito dal medesimo decreto-legge 146, sono previste anche la verifica del rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20 (trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione), 21 (modalità del trattamento), 22 (funzionamento dei centri) e 23 (attività di prima assistenza e soccorso) del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, con accesso senza restrizione alcuna in qualunque locale dei CIE.
Da segnalare anche l'iniziativa delle Camere, sia legislativa, sia di indirizzo e controllo.
Sul versante legislativo, si segnala che la Camera sta esaminando il testo unificato di tre proposte finalizzate alla istituzione di una Commissione d'inchiesta CIECommissione monocamerale di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri destinati all'accoglienza e al trattenimento di immigrati (Doc. XXII, n. 18, Doc. XXII, n. 19, Doc. XXII, n. 21). Il testo si riferisce ai Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ai Centri di accoglienza (CDA) ed ai Centri di accoglienza per Richiedenti asilo (CARA).
Relativamente all'attività di indirizzo si ricorda che la Camera tra il 2 e il 9 dicembre 2013 ha discusso alcune mozioni e una risoluzione riguardanti la disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alla problematica dei centri di identificazione ed espulsione. Tra gli atti approvati, qui rileva la Mozione Zampamozione Zampa ed altri n. 1-00156 che impegna il Governo a ripensare gli attuali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare che risultano inefficaci (per quanto attiene all'effettività dei provvedimenti di espulsione) e costosi e ad abbattere i tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione. In particolare, il Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi.
I provvedimenti sopra richiamati si inquadrano in una più ampia serie di interventi volti a rafforzare la tutela dei diritti degli stranieri e la loro effettiva integrazione nella società. Tra questi si ricordano la riforma della legge sulla cittadinanza (A.C. 9 ed abb.) e la modifica della disciplina del diritto di asilo (A.C. 327 ed abb.) entrambe all'esame della Camera. Per quanto riguarda il diritto di asilo, la legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013 ha conferito una delega al Governo per la emanazione di un testo unico che raccolga e riordini tutte le disposizioni in materia.
|