FRANCIA
DOSSIER SCHEDE - PAESE

XVI legislatura
| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Rapporti Internazionali | ||
| Titolo: | FRANCIA - Incontro del Presidente della Commissione Affari Esteri, on. Stefano Stefani, con l'Ambasciatore della Repubblica francese, S.E. Jean-Marc De La Sabliere - Roma, 12 giugno 2008 | ||
| Serie: | Schede Paese Numero: 22 | ||
| Data: | 11/06/2008 | ||
| Descrittori: |
| ||
FRANCIA

Francia
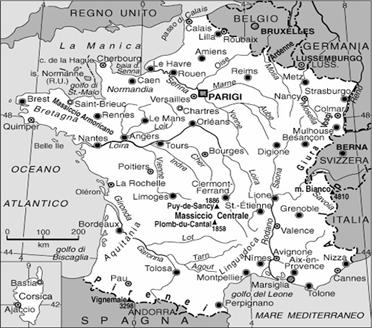 |
Abitata dal sec. VII a.C. da Celti, Liguri e Iberi, conquistata da Cesare tra il 58 e il 50 a.C., la Gallia fece parte per quattro secoli dell’Impero romano. Alla metà del sec. IV fu invasa da tribù germaniche tra le quali prevalsero i Franchi, che sotto i Merovingi riunificarono la regione. Con Pipino il Breve subentrarono (751) i Carolingi, il cui massimo esponente fu Carlo Magno, fondatore del Sacro Romano Impero. Alla sua morte l’impero si frazionò e alla metà del sec. IX l’autorità dei signori feudali si affermava a scapito di quella regia. Questa tornò a prevalere con i Capetingi, che raggiunsero la massima potenza nel sec. XIII con Filippo Augusto. Filippo il Bello (1268-1314), entrato in conflitto con il papato per motivi giurisdizionali, riuscì vincitore e alla morte di Bonifacio VIII fece trasferire la sede pontificia ad Avignone (1309), dove essa rimase fino alla metà del sec. XIV.
Con la guerra dei Cent’anni contro gli inglesi (1328-1453), la dinastia dei Valois riuscì a conseguire l’unità nazionale. Dal 1494 al 1555 i sovrani Carlo VIII, Luigi XII, Francesco I ed Enrico II intervennero più volte per contrastare la presenza spagnola in Italia, finchè la contesa per la supremazia nella Penisola non venne conclusa con il Trattato di Chateau-Cambresis (1559). Seguirono le guerre di religione (1560-98) tra cattolici e protestanti (ugonotti), cui pose fine Enrico IV, capostipite dei Borbone, con l’editto di Nantes (1598) che fissava lo stato giuridico delle minoranze protestanti (ma che fu revocato nel 1685).
Nel periodo successivo, con Luigi XIII e Luigi XIV e i Ministri Richelieu, Mazarino, Colbert, la monarchia francese si consolidò. In quegli anni la Francia ridimensionò con la guerra dei Trent’anni (1618-48) la preponderanza asburgica e ottenne l’Alsazia con la pace di Vestfalia (1648), mentre iniziava la colonizzazione in America (Québec, Louisiana e Antille) e in Africa. Con la pace di Utrecht (1713) l’egemonia francese in Europa fu a sua volta ridimensionata e col regno di Luigi XV iniziò una profonda crisi economica e politica.
Il diffondersi dell’illuminismo e l’insofferenza dei ceti borghesi per il potere della nobiltà minarono lo stato assoluto e portarono, durante il regno di Luigi XVI, allo scoppio della Rivoluzione (1789), che abolì i privilegi della nobiltà e del clero e proclamò la Repubblica (1792). Dopo la fase della dittatura giacobina (1793-94) e quella del direttorio, nel 1799 il potere fu assunto da Napoleone. Imperatore nel 1804, questi riuscì a estendere il dominio francese all’Italia, alla Spagna, a parte della Germania, alla Dalmazia e all’Olanda, finché, sconfitto nel 1813 a Lipsia e nel 1815 a Waterloo, fu esiliato.
Venne così restaurata la monarchia borbonica con Luigi XVIII, il cui successore Carlo X fu spodestato con la rivoluzione del luglio 1830 da Luigi Filippo d’Orleans, re dei francesi fino alla rivoluzione del 1848, che proclamò la Repubblica. Nel 1852 il Presidente Luigi Napoleone Bonaparte si proclamò Imperatore, con il titolo di Napoleone III. Con lui la Francia entrò in guerra prima contro la Russia (guerra di Crimea, 1854-56) poi contro l’Austria a fianco del Piemonte (1859) - da cui ottenne Nizza e la Savoia - infine contro la Prussia, da cui fu sconfitta a Sedan nel 1870. Ne seguì il crollo del II Impero e la nascita della III Repubblica, che riuscì a superare il trauma della Comune di Parigi (1871) e la perdita dell’Alsazia e della Lorena e si consolidò all’interno, democratizzando le proprie istituzioni, e all’esterno, proseguendo l’espansione coloniale, specialmente in Africa.
Alleatasi con la Russia (1893) e con l’Inghilterra (1904) la Francia prese parte dal 2 agosto 1914 alla prima guerra mondiale; con la capitolazione tedesca e il Trattato di Versailles ottenne la restituzione dell’Alsazia e della Lorena e parte delle colonie tedesche. L’avvento del nazismo in Germania e il disagio sociale susseguente alla crisi mondiale del ’29 favorirono la costituzione del Fronte popolare tra socialisti, radicali e comunisti, che nel 1936 assunse il potere col governo Blum, iniziando una politica di riforme sociali. L’esperimento venne però interrotto nel 1938, quando divenne Presidente del Consiglio Daladier, appoggiato dal centro e dalla destra.
In seguito all’invasione tedesca della Polonia (settembre 1939), la Francia dichiarò guerra alla Germania insieme all’Inghilterra. Sconfitta dai tedeschi nella primavera del 1940, fu da questi occupata nella parte settentrionale (con Parigi), mentre la parte meridionale (Vichy) venne affidata al regime filo-tedesco di Pétain. Da parte sua, l’Italia entrò nel conflitto contro la Francia nel maggio del 1940.
I fautori della resistenza, capeggiati dal colonnello De Gaulle riparato in Inghilterra, fondarono il comitato Francia libera.
Nel 1942 forze anglo-americane sbarcarono nell’Africa settentrionale francese, che passò al governo provvisorio di De Gaulle. Il 6 giugno1944 lo sbarco alleato in Normandia avviò la liberazione.
Finita la guerra, un’Assemblea Costituente elaborò una nuova Costituzione e proclamò la IV Repubblica. Questa fu caratterizzata da una forte instabilità politica, aggravata dal problema della decolonizzazione: l’Indocina fu abbandonata soltanto nel 1954, in seguito alla sconfitta di Dien Bien Phu; nello stesso anno iniziò, con la rivolta algerina, una lunga guerra, che divise l’opinione pubblica francese e fu conclusa nel 1962 dal Generale De Gaulle, tornato al potere nel 1958.
Con De Gaulle si passò alla V Repubblica, di tipo presidenziale, e a una politica nazionalistica, che portò nel 1966 all’uscita della Francia dall’organizzazione militare della NATO (anche se non dall’alleanza politica) e alla formazione di una propria force de frappe. De Gaulle fronteggiò con successo la crisi interna del maggio ’68, ma nel ’69 si dimise in seguito alla sconfitta in un referendum. Suoi successori furono G. Pompidou e, nel 1974, V. Giscard d’Estaing.
Nel 1981 venne eletto alla Presidenza della Repubblica il socialista François Mitterand. Le elezioni del 1986 decretarono tuttavia il successo dell’opposizione, guidata dal gollista Jacques Chirac. Nel 1988 Mitterand venne confermato alla Presidenza, ma una rapida successione di governi e una serie di scandali indebolirono il PS. Le elezioni del 1993 videro una nuova netta affermazione del centro-destra, che portava al Governo E. Balladur, tendenza confermata dall’elezione a Presidente della Repubblica di J. Chirac (1995).
Nelle elezioni legislative del 1997 la vittoria andava invece alla coalizione di sinistra, guidata dal socialista Jospin.
Le elezioni presidenziali del 2002 riconfermavano Chirac, anche se in un contesto del tutto particolare che aveva visto al primo turno la netta affermazione del candidato della destra xenofoba J. M. Le Pen su Jospin.
Alle legislative dello stesso anno la vittoria era andata alla nuova coalizione di centro-destra, guidata dal partito “Unione per un Movimento Popolare” (UMP); Primo Ministro veniva nominato J. P. Raffarin, il cui Governo, dopo tre successivi rimpasti, veniva sostituito il 31 maggio 2005 - a seguito della crisi apertasi dopo la vittoria del “no” nel referendum sul Trattato costituzionale europeo – dall’Esecutivo guidato da Dominique de Villepin.
Dopo un buon inizio, specie in materia di lotta alla disoccupazione (portata sotto il 10%), il Governo De Villepin registrava una forte perdita di velocità ed alcune gravi crisi ne segnavano il cammino: la rivolta nelle banlieues (novembre 2005), la vicenda del nuovo contratto di prima assunzione/CPE (ritirato doppo massicce manifestazioni di piazza nel marzo 2006), lo scandalo “Clearstream” e l’operazione di fusione Gaz de France-Suez (con la fronda di alcuni deputati della maggioranza).
|
DATI GENERALI* |
|
Superficie |
643,427 Kmq |
|
Capitale |
Parigi |
|
Abitanti |
64,057 milioni |
|
Tasso crescita popolazione |
0,574% |
|
Speranza di vita |
80,87 anni |
|
Tasso di emigrazione |
1,48 (su mille abitanti) |
|
Gruppi religiosi |
cattolici (83-88%); protestanti (2%) ebrei (1%); musulmani (5-10%) |
|
Lingue nazionali |
francese |
|
*Fonte: CIA Factbook 2008 |
|
|
Principali cariche dello stato
|
|
Presidente della Repubblica
|
Nicolas Sarkozy, dal 16 maggio 2007, eletto con il 53,06% dei voti (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) |
Presidente dell’Assemblea nazionale |
Bernard Accoyer, nominato il 18 maggio 2007,(Union pour un Mouvement Populaire – UMP) |
Presidente del Senato |
Christian Poncelet (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) |
Primo Ministro |
François Fillon (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) |
Ministro degli affari Esteri ed europei |
Bernard Kouchner (Socialista) |
Ministro della Difesa |
Hervè Morin |
Ministro degli interni |
Michèle Alliot-Marie (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) |
Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’occupazione |
Christine Lagarde (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) |
Scadenze elettorali
|
|
|
Presidente della Repubblica |
Si sono svolte il 22 aprile e il 6 maggio 2007 (prossime elezioni primavera 2012) |
|
Assemblea Nazionale |
Si sono svolte il 10 e 17 giugno 2007 (prossime elezioni giugno 2012) |
|
Senato |
Si sono svolte il 26 settembre 2004 (prossime elezioni settembre 2008) |
Quadro politico
|
Subito dopo il suo insediamento all’Eliseo, il neo eletto Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, ha conferito l’incarico di Governo a Francois Fillon, senatore della formazione neogollista UMP e suo uomo di fiducia che ha diretto la campagna elettorale presidenziale. Fillon, due giorni dopo aver ricevuto l’incarico, ha dato vita ad un esecutivo snello, formato da 15 ministri, sette dei quali donne, e caratterizzato dalla nomina agli Esteri del socialista Bernard Kouchner. Al ministero della Difesa è stato nominato Herve Morin, un ex luogotenente del leader centrista Francois Bayrou. Tutti gli altri ministeri sono stati assegnati a membri del partito UMP. Spicca la nomina al ministero della Giustizia di Rachida Dati, 41 anni, con madre algerina e padre marocchino, portavoce di Sarkozy durante la campagna elettorale. È la prima volta in Francia che un importante ministero viene affidato a un cittadino di origini maghrebine. Altra novità è la creazione di un ministero dell’Immigrazione e dell’Identità nazionale, concetto forgiato dal presidente durante la campagna elettorale.
Quadro istituzionale
|
Sistema politico
La Costituzione della V Repubblica (4 ottobre 1958) attribuisce una posizione di particolare preminenza al Presidente della Repubblica cheè stata ulteriormente rinforzata con il referendum del 28 ottobre 1962 che ha introdotto il principio dell’elezione diretta del Capo dello Stato. Viene eletto il candidato che al primo turno ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si effettua un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più preferenze.
La durata del mandato del Presidente della Repubblica è stata ridotta, dopo la riforma costituzionale intervenuta nel settembre 2000, da sette a cinque anni. Oltre che Capo dello Stato, egli è anche capo del potere esecutivo, nomina il Primo Ministro e, su proposta di questi, i Ministri. Secondo una consolidata prassi istituzionale, instauratasi già sotto la presidenza de Gaulle, il potere di nomina e di revoca del Primo Ministro si è configurato come una prerogativa spettante al Capo dello Stato: tuttavia, con la cohabitation tra un Presidente ed un Primo Ministro appartenenti a coalizioni politiche di segno opposto, - verificatasi per la prima volta dopo le elezioni politiche del marzo 1986 (Presidenza Mitterrand) e successivamente nel maggio 1993 e, da ultimo, a partire dal giugno 1997 fino ad oggi (Presidenza Chirac) - tale prerogativa è stata fortemente limitata, conferendo maggiore autonomia al ruolo del Primo Ministro.
Parlamento
L’iniziativa legislativa spetta al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento. Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento (bicamerale): Assemblea Nazionale (577 membri, eletti per 5 anni a suffragio universale diretto) e dal Senato (331 membri, eletti per 9 anni dai consiglieri comunali e dipartimentali, rinnovabili per 1/3 ogni 3 anni).
Il sistema parlamentare francese è caratterizzato da un bicameralismo diseguale. Il voto contrario del Senato su un disegno di legge è infatti superato da una seconda votazione positiva dell'Assemblea Nazionale. Il voto di sfiducia è sostituito con un voto di censura, che non obbliga il Governo alle dimissioni.
Le modifiche costituzionali sono approvate dai due rami del Parlamento e sottoposte a referendum popolare. Non si procede a referendum qualora il Presidente della Repubblica sottoponga le modifiche al Congresso, le due Camere riunite in seduta comune, e questo le approvi a maggioranza dei 3/5 dei voti.
Il sistema elettorale dell'Assemblea nazionale, incentrato su collegi uninominali, è maggioritario a doppio turno (scrutin d'arrondissement): un candidato è eletto al primo turno qualora ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi, purché questa maggioranza equivalga ad un quarto del numero degli elettori iscritti a votare nel collegio. In caso contrario, per poter accedere al secondo turno, un candidato deve ottenere un numero di suffragi pari al 12,5% del totale degli iscritti al voto. Se soltanto un candidato è riuscito ad ottenere questo risultato, il ballottaggio si effettuerà tra i primi due candidati. Nel secondo turno è sufficiente, per essere eletti, ottenere la maggioranza semplice dei voti.
L’attuale composizione dell’Assemblea Nazionale, dopo le elezioni del 10 e 17 giugno 2007, è la seguente[1]:
|
Gruppi |
Seggi |
|
Union pour un Mouvement Populaire |
313 (+ 8 affiliati)[2] |
|
Socialiste, Radical, Citoyen Et Divers Gauche
|
186 (+ 18 affiliati) |
|
La Gauche Démocrate et Républicaine
|
24 |
|
Nouveau Centre
|
20 (+ 1 affiliato) |
|
Deputati che non appartengono ad alcun gruppo
|
7 membri |
|
|
|
|
TOTALE |
577 |
Il Senato è eletto con un sistema misto di voto (proporzionale e maggioritario), da collegi formati, su base dipartimentale, dai deputati locali, dai consiglieri regionali, dai consiglieri generali (del dipartimento), dai delegati dei consigli municipali (che formano circa il 95% degli elettori).
Attualmente il Senato è così composto:
|
Gruppi[3]
|
Seggi |
|
Union pour un Mouvement Populaire
|
159 |
|
Socialiste
|
96 |
|
Union centriste (UDF)
|
30 |
|
Groupe Communiste Républicain et Citoyen
|
23 |
|
Rassemblement Démocratique et Social Européen
|
16 |
|
Senatori che non appartengono a nessun gruppo
|
6 |
|
TOTALE
|
330* |
* Un seggio è attualmente vacante a seguito della scomparsa del senatore Jacques Pelletier. Si provvederà al suo rimpiazzamento in occasione delle prossime elezioni parziali del Senato, previste per il mese di settembre 2008.
|
Quadro politico (in collaborazione con il MAE)
|
L’elezione di Nicolas Sarkozy a Presidente della Repubblica
Al termine di una campagna elettorale molto combattuta, polarizzata intorno alle figure dei candidati principali - Sarkozy per il centrodestra e la Royal per i socialisti e, nell’ultima fase, il centrista Bayrou - il voto per le presidenziali vedeva nel primo turno un elevatissimo tasso di partecipazione, pari all’85%. Al ballottaggio, svoltosi il 6 maggio, giungevano come previsto Royal e Nicolas Sarkozy, vincitore infine con il 53,06% dei consensi e quindi eletto sesto Presidente della Quinta Repubblica.
Fra i pochi uomini politici francesi non usciti dall’ENA, Sarkozy ha costruito la sua carriera sempre all’interno del partito di ispirazione gollista. Consigliere comunale a 21 anni, si avvicina a Chirac, che sarà il suo riferimento per 20 anni e dal quale si separa nel 1995 in favore di Balladur; sconfitto quest’ultimo, anche Sarkozy e’ messo ai margini. Risale la china a fatica, finchè nel 2002 viene “riabilitato”.
Nell’affrontare la sua rivale Segolene Royal durante il seguitissimo dibattito televisivo del 2 maggio, Sarkozy si era espresso con toni concilianti, gli stessi cui è ricorso dopo la vittoria: dopo la proclamazione dei risultati, si è rivolto infatti non tanto al suo elettorato, quanto alla Francia intera, nell’intento di avvicinare destra e sinistra, esprimendo inoltre rispetto e stima per la Royal.
Quest’ultima, pur nell’ammettere la sconfitta, si era espressa con toni decisi per puntare alle elezioni legislative, puntando a controbilanciare Sarkozy in ambito parlamentare. La sconfitta alle presidenziali riapriva tuttavia le tradizionali divisioni interne al partito socialiste, a stento sopite dopo che la Royal, aveva ottenuto un forte sostegno a livello della base contro l’opposizione degli “elefanti” del partito, vincendo le “primarie”con il 60% dei voti.
Il Governo Fillon
Il Governo istituito dopo la vittoria di Sarkozy si è insediato il 18 maggio, guidato da Francois Fillon; un Esecutivo snello, “rosa” e aperto ad altre forze politiche; esso è restato in carica fino alle elezioni legislative di giugno per poi essere sostanzialmente confermato.
Il nuovo Esecutivo è dimezzato nel numero dei dicasteri, quindici in tutto, di cui sette affidati a donne. A un popolare uomo di sinistra e ad un centrista sono stati attribuiti due dicasteri chiave, gli Esteri e la Difesa: l'ex Ministro della Sanità socialista, Bernard Kouchner, che fu tra i fondatori dell'associazione premio Nobel “Medici senza Frontiere”, è infatti il nuovo Ministro degli Esteri; il centrista Hervé Morin è stato invece nominato Ministro della Difesa.
Del secondo Governo Fillon non fa più parte Alain Juppè, in quanto non rieletto. Al suo posto, Jean-Louis Borloo, quale Ministro dell’Ecologia e dello Sviluppo sostenibile, con il rango di Ministro di Stato.
Da sottolineare anche le nomine di Christine Legarde a Ministro dell’Economia e di Michel Barnier a Ministro dell’Agricoltura e della Pesca.
In “rosa” anche altri due Ministeri chiave: gli Interni sono stati affidati a Michèle Alliot-Marie (già Ministro della Difesa), e la Giustizia a Rachida Dati, un giudice figlia di immigrati maghrebini ed ex-portavoce di Sarkozy. Tra gli altri Ministeri, a Eric Woerth il bilancio e la funzione pubblica.
Con un discorso di insediamento dai toni sobri e senza sorprese, privo di visioni strategiche, il Primo Ministro Fillon ha illustrato il 4 luglio 2007 le linee di fondo dell’l'azione dell'esecutivo. Il Primo Ministro ha posto al centro del suo discorso le misure di carattere economico e sociale ed in particolare la lotta alla disoccupazione, con l'obiettivo di giungere al pieno impiego nell'arco di cinque anni. La politica economica sarà incentrata sulla valorizzazione del lavoro, sull'equilibrio di bilancio, sulla progressiva riduzione del debito pubblico e sulla compressione delle spese dello Stato. Il Primo Ministro ha anche posto l'accento sull'educazione e sulla ricerca, promettendo un aumento dei fondi alle università ed ha ribadito l'attenzione a favore delle fasce sociali più deboli, proponendo un vasto programma di costruzione di alloggi popolari. Ampio spazio e' stato inoltre riservato a temi quali l'ordine pubblico, la tutela dell'ambiente, l'immigrazione, la riforma della giustizia, la modernizzazione dello stato sociale.
La parte più interessante del discorso ha riguardato le riforme istituzionali, per le quali ha proposto la costituzione di una commissione di "personalità incontestabili", sulla base delle indicazioni di massima del Presidente (bilanciare il ruolo del Capo dello Stato con un rafforzamento dei poteri di garanzia e di controllo riservati al Parlamento; modifica dei regolamenti parlamentari, con poteri più incisivi attribuiti all'opposizione; divieto per il Presidente della Repubblica di essere rieletto dopo il secondo mandato; statuto per l'opposizione; introduzione di una quota di proporzionale nel sistema elettorale).
Come indicato, una volta ultimata la fase istituzionale, ha preso il via un’intensa attività normativa.
- Il 26 luglio il Parlamento ha approvato il progetto di legge sulla recidiva e sulla delinquenza minorile che, attraverso un inasprimento delle pene, si propone di rafforzare “l’effetto dissuasivo della legge penale”. Fortemente criticata non solo dall’opposizione di sinistra, ma anche da ampi settori del mondo giudiziario, la legge limita, di fatto, la discrezionalità dei magistrati, introducendo delle pene minime che devono essere comminate in caso di reati commessi da recidivi (alla terza infrazione il giudice potrà derogare all’applicazione della pena minima solo qualora l’autore dei reati fornisca “garanzie eccezionali di reinserimento”).
Vengono previste pene minime anche per i recidivi che hanno compiuto sedici anni, che saranno pertanto trattati come i maggiorenni.
Circa una anno fa (giugno 2007) è stato varato il primo importante progetto di riforma economica del quinquennio, il “pacchetto fiscale”, una riforma in favore del lavoro, dell’occupazione e del potere d’acquisto.
Si tratta di una manovra imponente, una vera rivoluzione fiscale:
L’Assemblea Nazionale ha approvato il testo il 2 agosto scorso, realizzando uno dei pilastri del programma presidenziale. Obiettivo principale della riforma fiscale è favorire il potere d’acquisto per rilanciare i consumi privati.
Attualità di politica estera In collaborazione con il MAE
|
Quadro generale
Il rifiuto referendario del Trattato costituzionale europeo nel maggio 2005 aveva aperto una fase di oggettivo disorientamento nella politica estera francese; Chirac aveva quindi privilegiato in quella fase il rilancio dell’immagine della Francia sulle tematiche di governance globale, puntando sui problemi dello sviluppo per accreditarsi presso i PVS e rafforzando le relazioni privilegiate con le nuove potenze emergenti.
La Francia del resto legge le dinamiche globali in chiave di progressiva emersione di un modello multipolare, nel cui contesto affermare progressivamente il ruolo di una “Europa-potenza”. Quest’Europa polo mondiale, però, continua ad essere tacitamente vista come una sorta di proiezione ampliata della nazione francese. L’incapacità di fare i conti con i limiti del concetto di sovranità nazionale nel nuovo mondo globalizzato così come nel contesto dell’Europa polo di potenza mondiale che si aspira a costruire, costituisce l’intima contraddizione di una visione politica per il resto caratterizzata da indubbia coerenza. Classe dirigente, intellettuali e opinione pubblica stentano a prendere atto che l’Europa più integrata e coesa non sarà una semplice proiezione globale dei valori e degli interessi francesi, ma la risultante della sensibilità e delle modulazioni che ciascun partner vi apporterà.
Si ricorda che il 1° luglio 2008 inizierà il semestre di presidenza francese dell’Unione europea.
Il Parlamento francese ha completato la procedura di ratifica parlamentare del Trattato il 7 febbraio 2008 (Assemblea nazionale - 336 voti a favore, 52 contrari e 22 astensioni; Senato - 265 voti a favore, 42 contrari e 13 astensioni), successivamente all’approvazione di un progetto di revisione della Costituzione.
Sin dal suo insediamento il Presidente Sarkozy ha dato un rinnovato impulso alla politica estera, con innovazioni anzitutto di forma e, nella sostanza, un misto di continuità e cambiamento nei vari dossiers.
Il “manifesto” della sua politica estera è stato il discorso alla conferenza degli Ambasciatori francesi il 27 agosto scorso, nel quale ha tracciato le proprio valutazioni rispetto alle 3 grandi sfide contemporanee individuate come segue:
Il Presidente si e’ del resto mosso con notevole dinamismo sin dal suo insediamento in vari dossiers: particolare rilievo ha avuto il suo ruolo lo scorso luglio (unitamente a quello della ex-moglie Cecilia) nella liberazione delle infermiere bulgare, da 6 anni in arresto in Libia; dopo il rimpatrio delle 6 infermiere lo stesso Sarkozy si e’ recato in visita a Tripoli dove ha siglato varie intese ed in particolare una in materia di collaborazione nel nucleare civile (decisione fortemente contestata dall’opposizione socialista e guardato con perplessità in varie cancellerie).
Relazioni transatlantiche
A partire dal secondo mandato di Bush si era avviato un certo disgelo franco-americano dopo lo scontro sul dossier iracheno. Punto di partenza concreto era stata poi la constatazione della convergenza di interessi sul dossier libanese.
Diffidente della scala smisurata sulla quale l’America di Bush proietta le proprie visioni geostrategiche, Parigi si era sforzata di definire con Washington convergenze pragmatiche e ben delimitate, su singole questioni. Permanevano divergenze (embargo alla Cina, vocazione strategica e ruolo politico della NATO); varie ambiguità o rimozioni (multipolarismo, modelli di democratizzazione del Grande Medio Oriente, tempistica del processo di pace). Ma, nel complesso, si erano registrate ripetute convergenze: il Libano, anzitutto, ma anche l’antiterrorismo, nonchè il nucleare iraniano e nord coreano.
Il nuovo Presidente Sarkozy si è presentato come un amico degli Stati Uniti, dove ha trascorso le vacanze estive, incontrando il Pres.Bush; ha più volte dichiarato che intende rilanciare i rapporti a tutto campo, pur confermando la contrarietà alla guerra in Iraq e la necessità che Washington si ponga alla testa, e non osteggi, il movimento di lotta contro i cambiamenti climatici.
Dialogo di culture. Lotta al terrorismo
La Francia non è stata risparmiata dal post-11 settembre (assassinio di cittadini francesi a Karachi, attentato alla petroliera Limburg, attentato a danno di turisti a Bali), ed ha perciò adottato una legislazione più severa in materia di sicurezza. Anche la vicenda dei giornalisti sequestrati in Iraq e rilasciati solo dopo vari mesi, conferma che la tradizionale vicinanza al mondo arabo e islamico e l’opposizione alla guerra in Iraq non la mettono al riparo dal terrorismo. La risposta alle nuove minacce è perciò una priorità dell’azione diplomatica della Francia. Essa è inquadrata in un’ottica che privilegia approcci multilaterali e su più fronti. Parigi costituisce d’altra parte un partner privilegiato degli Stati Uniti in materia di intelligence ed investigazioni sulle reti terroristiche particolarmente maghrebine, tanto che ha sede a Parigi una cellula antiterrorismo coperta (“Alleanza-Base”) cui collaborano anche Australia, Canada, Germania e Regno Unito, per lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto ad Al Qaeda.
Sul piano generale, il Presidente Sarkozy ha individuato nel rapporto tra Occidente ed Islam una delle tre grandi sfide della nostra epoca; in tale contesto sostiene l’Islam moderato in Paesi quali Marocco, Algeria, Tunisia, Giordania ed Indonesia.
FOCUS il progetto dell’unione del mediterraneo ed il vertice di parigi del 13 luglio 2008 (in collaborazione con il MAE)
|
Il rilancio
della cooperazione euro-mediterranea è al centro dell’iniziativa, lanciata dal
Presidente Sarkozy, per la creazione di una Unione per il Mediterraneo. Il
progetto aveva ricevuto con
L’Unione per il Mediterraneo mira a divenire un valore aggiunto rispetto all'esistente quadro euro-mediterraneo sotto quattro profili: il primo è quello della “co-ownership”, ovvero di un maggiore coinvolgimento dei Paesi della sponda sud nel processo decisionale; il secondo riguarda il livello degli incontri che, riunendo i Capi di Stato e di Governo con cadenza biennale, dovrebbe imprimere un rafforzato impulso politico alla cooperazione euro-mediterranea; il terzo riguarda i contenuti che, attraverso il lancio di grandi progetti in settori d'interesse comune (sviluppo, infrastrutture, ambiente, energia, sicurezza, cultura), dovrebbe consentire un effettivo salto di qualità del Partenariato; il quarto comporta una maggiore attrazione di attori e capitali privati.
Il progetto di Unione per il Mediterraneo (UpM) sarà complementare alle relazioni bilaterali dell’UE con i Paesi Partner e pertanto non inciderà sul processo di adesione all’UE della Turchia e della Croazia.
In vista delle decisioni che saranno prese dal CAGRE
(16 giugno) e dal Consiglio Europeo (19-20 giugno),
Gli aspetti istituzionali e i contenuti progettuali saranno al centro dei negoziati che precederanno il Vertice di Parigi.
L’Italia continua a ritenere il rilancio della cooperazione nel Mediterraneo un obiettivo strategico prioritario e considera il successo del prossimo Vertice di Parigi una tappa decisiva in questa direzione. La visione italiana condivide il motivo di fondo che ha originato l’iniziativa francese ovvero l’ambizione di rimettere il Mediterraneo al centro della strategia europea. L’Unione per il Mediterraneo dovrà in primo luogo privilegiare la concretezza dei contenuti progettuali rispetto all’approccio troppo declaratorio, che ha spesso caratterizzato l’esperienza del Processo di Barcellona. In relazione ai progetti si considerano prioritari i temi finora proposti in ambito comunitario quali l’energia, l’ambiente ed i trasporti marittimi. L’Italia annette inoltre uguale importanza alla sicurezza condivisa nel Mediterraneo (mirata ad aspetti quali sicurezza marittima, trasporti energetici, disastri naturali, protezione civile, pesca illegale, lotta alla criminalità) sulla quale presenteremo un progetto, al rafforzamento del tessuto delle piccole e medie imprese (progetto italo-spagnolo di Agenzia Mediterranea per le PMI ed il microcredito) ed alla collaborazione culturale e universitaria attraverso lo sviluppo dell’acquis di Catania e Cairo per la creazione di una zona euro-mediterranea nell’istruzione superiore e nella ricerca
|
Principali indicatori economici |
|||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cc Crescita PIL (%) |
1.9 |
1.6 |
1,4 |
|
Inflazione (%) |
1.6 |
3 |
2 |
|
Saldo bilancio P.A./PIL (%) |
-2.7 |
-2.8 |
-2.6 |
|
Debito/PIL (%) |
64.2 |
64.4 |
65.1 |
|
Tasso di disoccupazione (%) |
8.3 |
8 |
8.1 |
|
PIL (in dollari USA)** |
2.067 miliardi di dollari |
||
|
PIL pro capite (in dollari USA)** |
33,800 |
||
|
Composizione per settore |
agricoltura (2%); industria (20.7%); servizi (77.3%) |
||
* Fonti: Commissione europea. Previsioni economiche. Primavera 2008.** Fonti: The Cia Worldfactbook 2008. |
|||
[1] Fonte: sito dell’Assemblea Nazionale francese
[2] A norma dell’articolo 19, comma 4, del Regolamento dell’Assemblea Nazionale francese, i deputati che non appartengono ad alcun gruppo politico possono affiliarsi ad un gruppo di propria scelta, dopo aver ottenuto il parere positivo del bureau del gruppo stesso. Sono computati per il calcolo dei seggi assegnati ai Gruppi nelle Commissioni.
[3] Fonte: sito del Senato francese.