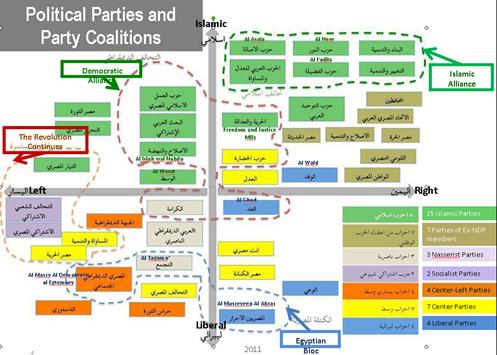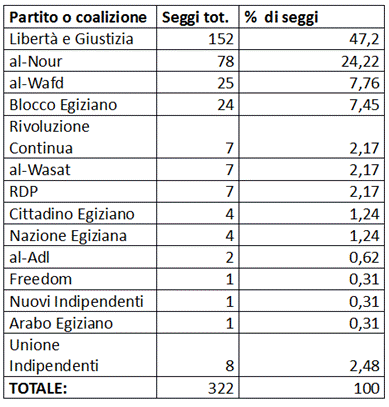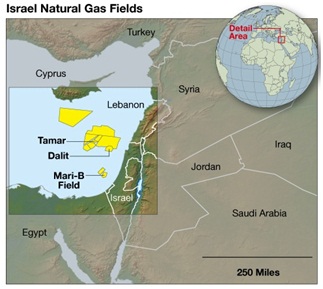Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
|
|---|
| Autore: |
Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
|
| Titolo: |
Missione in Egitto
|
| Serie: |
Documentazione e ricerche
Numero:
327
|
| Data: |
06/03/2012
|
| Descrittori: |
|
| Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
|
| Nota: |
Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale.
La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati
(ad es. presso la Biblioteca)
|
|
|
|
Camera dei deputati
|
|
XVI LEGISLATURA
|
|
|
|
|
|
|
|
Documentazione e ricerche
|
|
Missione in Egitto
|
|
(6-8 marzo 2012)
|
|
|
|
|
|
n. 327
|
|
|
|
|
|
|
|
6 marzo 2012
|
|
Servizio responsabile:
|
|
Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri
( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it
|
|
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi ed Uffici:
|
|
Servizio Rapporti Internazionali
( 066760-3948 – *
1
Ufficio Rapporti con l’Unione europea
( 066760-2145 – * cdrue@camera.it
|
|
|
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei
deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
|
|
File: Es1063.doc
|
INDICE
Programma
Documentazione
tematica
Scheda
politico-istituzionale 9
La vicenda egiziana
postrivoluzionaria, tra nuove convulsioni e tentativi di assestamento 20
Scheda-paese a cura del Ministero degli Affari esteri 29
STRUTTURA ISTITUZIONALE E POPOLAZIONE 31
POLITICA INTERNA 34
SITUAZIONE
ECONOMICA 41
§
Andamento congiunturale 41
§
Politiche Economiche 43
§
Privatizzazioni e
rinazionalizzazioni 44
§
Settore energetico 45
§
Infrastrutture 46
§
Relazioni
economiche e commerciali con i Paesi esteri 46
§
Investimenti diretti esteri (IDE) 47
§
Principali
indicatori macroeconomici 48
POLITICA ESTERA 49
§
Relazioni
con l’Unione Europea 49
§
Relazioni
con gli Stati Uniti 51
§
Rapporti
con organismi multilaterali 52
RAPPORTI
BILATERALI 53
§
RELAZIONI
POLITICHE 53
§
RELAZIONI
ECONOMICHE, FINANZIARIE E COMMERCIALI 56
§
CONTENZIOSI COMMERCIALI 61
DATI STATISTICI BILATERALI 64
§
Relazioni
culturali, scientifiche e tecnologiche 66
§
Cooperazione
Italiana 67
I partiti politici in Egitto (a cura del Ministero degli affari esteri) 73
Relazioni parlamentari Italia-Egitto (a
cura del Servizio Rapporti Internazionali) 76
Rapporti tra l’Unione
europea e l’Egitto (a cura dell’Ufficio
Rapporti con l’Unione europea) 85
§
Il contesto delle
relazioni tra Unione europea ed Egitto 85
§
Le recenti evoluzioni
delle relazioni 87
§
Assistenza finanziaria 89
Profili biografici (a cura del Servizio Rapporti Internazionali)
Mohamed KAMEL AMR Ministro degli Affari esteri della
Repubblica araba d’Egitto 93
Mohamed Saad TAWFIK EL-KATATNY Presidente dell’Assemblea del Popolo d’Egitto 94
SCHEOUDA III Capo della
chiesa ortodossa copta e Patriarca di Alessandria 95
Ahmed FAHMI Presidente
della Shura 97
Nabil El Arabi Segretario Generale della Lega Araba 98
El-Sayyid EL-BADAWI Presidente del Partito Nuovo Wafd 100
Mohammed BADI' Guida
generale dei Fratelli musulmani 101
Pubblicistica
§
ISPI ‘Egitto
un anno dopo: rivoluzione continua - background’, gennaio 2012 105
§
C. De
Martino ‘Hamas, i Fratelli Musulmani, e
il dilemma israeliano’, in: Aspenia, dal sito http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online,
9 gennaio 2012 111
§
E.
Dacrema ‘Egitto: Per i progressisti la
nuova era inizia in salita’, in: Equilibri, dal sito http://www.equilibri.net/nuovo, 18 gennaio 2012 115
§
A.
Meringolo ‘Il quadro politico egiziano:
un momento della verità per l’Islam politico’, in: Aspenia, dal sito http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online, 18 gennaio 2012 121
§
A.
Meringolo ‘Gattopardo o rivoluzione?
L’Egitto un anno dopo’, in: Limes, 25 gennaio 2012 125
§
G.
Mafodda ‘Il futuro economico dell’Egitto:
più populismo e meno crescita’, in: Limes, 27 gennaio 2012 128
§
A.
Meringolo ‘L’Egitto e gli aiuti
internazionali: dove la politica incontra l’economia‘, in: Aspenia, dal
sito http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online,
23 febbraio 2012 131
§
C.
Proietti Silvestri ‘Egitto e Israele alla
battaglia del gas’ dal sito http://www.affarinternazionali.it,
29 febbraio 2012 135
§
L.
Galeotti ‘Egitto: una panoramica sul
prima e dopo Mubarak’, in: Equilibri, dal sito http://www.equilibri.net/nuovo,
13 febbraio 2012 139
§
E.
Ardemagni ‘Marocco - Tunisia – Egitto: la
transizione amara di chi ha fatto le rivolte’, in: Equilibri, dal sito http://www.equilibri.net/nuovo, 27 febbraio 2012 147
Visita al Cairo dell'On.
Stefano Stefani
Presidente Commissione Affari
Esteri
(6-8
marzo 2012)
PROGRAMMA
Martedì 6 marzo
Ore
17.50 Arrivo
all’Aeroporto Internazionale del Cairo.
A seguire Trasferimento
all'Hotel Four Seasons (Nile Plaza, Garden City).
Ore 19.00 Incontro
con l'Ambasciatore d'Italia Claudio Pacifico e i funzionari dell'Ambasciata.
Al termine Pranzo
offerto dal Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata, Consigliere
Massimiliano Iacchini. Incontro con alcuni imprenditori italiani (Ristorante Le Pacha).
Mercoledì
7 marzo
Ore
09.45 Trasferimento
presso la sede dell'Assemblea del Popolo.
Ore
10.00 Colloquio
con il Vice Presidente della Commissione Affari Esteri, Dr. Gamal Heshmat
(Partito Giustizia e Liberta'/Fratelli Musulmani) e con membri della
Commissione: Emad Gad, (Social Democratic Party), Mohamed Emad (Partito
Giustizia e Liberta'), Hazem Foruk (Segretario della Commissione, Partito
Giustizia e Liberta'),
A
seguire Colloquio
con il Vice Presidente dell'Assemblea del Popolo, Mohamed Abdel Alim Daouad
(Partito laico El Wafd).
A
seguire Colloquio
con il Presidente del Consiglio della Shura (Secondo ramo del Parlamento),
Ahmed Fahmy (da confermare).
Ore
13.00 Colazione
offerta dall'Ambasciatore Claudio Pacifico.
Ore
15.30 A
seguire Incontro con esponenti del
Patriarcato Copto (Shubra El Kaina).
Al
termine Visita
del Museo Egizio.
Ore
19.00 Colloquio
con George Ishak, fondatore del movimento di opposizione Kefaya (Hotel Four Seasons).
Ore
20.30 Pranzo
di lavoro offerto dal Ministro Consigliere dell'Ambasciata, Andrea Orizio (Ristorante tipico El Kebabgy).
Giovedì 8 marzo
Ore
09.15 Trasferimento
alla sede della Lega Araba
Ore
09.30 Incontro
con il Segretario Generale della Lega Araba, Nabil Elaraby.
Ore
10.45 Trasferimento
al Ministero degli Affari Esteri.
Ore
11.00 Colloqui
con il Ministro degli Esteri, Mohamed Kamel Amr.
Ore
12.00 Trasferimento
ad Al Azhar (Dar El Ifta).
Ore
12.30 Incontro
con il Gran Mufti d'Egitto, Ali Gomaa.
Al
termine Breve
colazione.
Ore
15.00 Trasferimento
all'Aeroporto internazionale del Cairo.
Ore
17.15 Partenza
alla volta di Roma con volo Alitalia.
Il
quadro istituzionale
A seguito delle dimissioni del presidente
Mubarak, il Consiglio supremo delle forze armate ha assunto la guida del paese,
sospeso la Costituzione, sciolto il Parlamento ed avviato un processo di
transizione costituzionale. Nell’ambito di tale processo, il Consiglio ha affidato
ad una Commissione presieduta dal giudice del Consiglio di Stato in pensione
Tareq El Besri, il compito di redarre alcuni emendamenti alla costituzione egiziana. La Commissione ha concluso
i suoi lavori il 26 febbraio 2011 presentando gli emendamenti proposti alla
Costituzione, che sono stati approvati con referendum il 19 marzo.
Tra il novembre 2011 e il gennaio 2012 si
sono svolte le elezioni parlamentari delle due camere del Parlamento egiziano, l’Assemblea
del popolo e il Consiglio della Shura. In base agli emendamenti approvati alla
Costituzione (cfr. infra box), le due
Assemblee dovrebbero eleggere in una sessione congiunta i componenti di una
Commissione incaricata di formulare una nuova Costituzione (una dichiarazione
del Consiglio supremo delle forze armate dello scorso novembre prevedeva che le
Camere eleggessero solo 25 dei 100 componenti della Commissione mentre lo
stesso Consiglio avrebbe designato i rimanenti 75). Per il mese di maggio sono
previste le elezioni presidenziali.
Di seguito verranno fornite informazioni di
sintesi sul quadro istituzionale egiziano precedente alle dimissioni di
Mubarak, mentre le modifiche alla Costituzione e alla legge elettorale verranno
illustrate in un apposito box.
Nell’assetto costituzionale al momento ancora vigente, ancorché la costituzione
sia stata sospesa dal Consiglio supremo delle forze armate il 13 febbraio, il
Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto ed è
rieleggibile per un numero indefinito di mandati: fino al 2005 gli elettori
erano chiamati a confermare con referendum il candidato designato
dall’Assemblea del Popolo, mentre dal 2005 è stata introdotta la competizione
tra più candidati nelle elezioni presidenziali. In base alla riforme del 2005 e
del 2007, le candidature alla carica di presidente dovevano però essere
approvate da un partito autorizzato che avesse almeno il 3 per cento dei seggi
in entrambe le Camere, ovvero sostenute da 250 parlamentari o componenti degli
organi elettivi locali; inoltre, in via transitoria per dieci anni potevano
presentare candidati anche i partiti che avessero almeno un eletto in una delle
due Camere (sulla regolazione, e le restrizioni, della vita dei partiti in
Egitto cfr. infra in questo
paragrafo). Il presidente nomina e revoca il primo ministro e i ministri. I
singoli ministri, e, a seguito di una riforma costituzionale del 2007, anche il
primo ministro possono essere sfiduciati dall’Assemblea del popolo. Il
parlamento è bicamerale. A seguito della riforma del 2009, l’Assemblea del
Popolo, risultava composta da 518 deputati; 10 componenti sono nominati dal
presidente; i rimanenti deputati sono eletti a suffragio universale diretto
ogni 5 anni, con la riforma del 2009 il numero dei deputati è stato elevato
(dai precedenti 454) per consentire l’elezione di almeno 64 donne in speciali
collegi. Il sistema elettorale risultava complesso e fondato su collegi in cui
vengono eletti due deputati, con sistema maggioritario a doppio turno (per
essere eletti al primo turno è necessario che due candidati ottengano la
maggioranza assoluta dei voti) e con un eventuale terzo turno nel caso tra i
due candidati che hanno ottenuto più voti non vi sia un “lavoratore o un
contadino” (retaggio del panarabismo socialista nasseriano). L’altra Camera, il
consiglio della Shura, che ha funzioni consultive, risultava composta di 176
membri, 88 nominati dal presidente ed i rimanenti eletti con un sistema
uninominale maggioritario a doppio turno; i componenti rimangono in carica sei
anni, la componente elettiva è rinnovata per metà ogni tre anni. L’assetto
istituzionale egiziano è stato inoltre fin qui pesantemente condizionato dalla
costante proroga (l’ultima nel giugno 2010) dello stato di emergenza proclamato
al momento dell’omicidio del predecessore di Mubarak, Sadat nel 1981.
Lo stato di emergenza è stato
revocato il 24 gennaio 2012 dal Consiglio supremo delle forze armate
Le modifiche alla Costituzione e la nuova legge elettorale
La Commissione composta da Tareq El Besri ha proposto emendamenti a
diversi articoli della Costituzione:
Art. 75: tra i requisiti di eleggibilità del presidente viene inserito quello di
non avere doppia cittadinanza e di non avere un coniuge non egiziano. La
modifica ha suscitato perplessità in alcuni osservatori in quanto escluderebbe
dalla partecipazione alle elezioni presidenziali personalità significative come
Ahmed Zewail, premio nobel per la chimica naturalizzato statunitense e
rientrato dagli USA per partecipare alle proteste anti-Mubarak, e forse anche
Mohamed El Baradei, la cui moglie avrebbe una cittadinanza non egiziana
Art. 76: si propone che per presentare la candidatura alle elezioni presidenziali
risultino necessari o il sostegno da parte di trenta parlamentari o la
sottoscrizione da parte di trentamila elettori (in almeno 15 province, ed in
ciascuna provincia devono essere raccolte almeno 1.000 firme) o, infine, la
designazione da parte di un partito che abbia almeno un parlamentare (per i
requisiti attuali cfr. supra).
Art. 77: si propone di ridurre il mandato presidenziale da sei anni a quattro
anni e di porre un limite di due mandati consecutivi
Art. 88: si propone di affidare ad un comitato indipendente composto da
magistrati e non più ad un’autorità “indipendente” (che in realtà risultava
però controllata dal partito NPD di Mubarak) definita per legge la supervisione
delle elezioni e dei referendum
Art. 93: viene affidata alla Corte costituzionale e non più al Parlamento il
compito di verificare i titoli di ammissione e le cause di ineleggibilità e
incompatibilità dei membri del Parlamento
Art. 139: si propone l’introduzione obbligatoria della figura del vice-presidente,
che dovrebbe essere nominato dal presidente entro 60 giorni dalla sua elezione
Art. 148: si propone che la dichiarazione di stato di emergenza debba essere
sottoposta al Parlamento entro una settimana e non possa essere prorogata oltre
i sei mesi, salvo il caso in cui la proroga sia approvata da un referendum
popolare
Art. 179: sopprime la previsione, introdotta nel 2007, che consentiva deroghe alle
disposizioni in materia di protezione dei diritti umani in funzione
anti-terrorismo
Art. 189: si propone che la richiesta di una nuova Costituzione possa essere
presentata dal presidente con l’appoggio del governo ovvero dalla maggioranza
dei membri di entrambe le Camere. In tal caso le Camere procederanno
all’elezione di un’Assemblea costituente di 100 membri, con il compito di
redigere una nuova costituzione entro sei mesi e di sottoporla ad un referendum
popolare.
Merita rilevare come, se le
modifiche costituzionali proposte incidono significativamente sui limiti di
durata del mandato presidenziale e sulla disciplina dello stato di emergenza,
non viene soppresso il divieto di costituzione di partiti su base religiosa di
cui all’articolo 5 della costituzione.
Con riferimento alla legge
elettorale, il consiglio supremo delle forze armate ha approvato alcuni
emendamenti alle leggi elettorali vigenti volti a:
- individua il numero dei componenti elettivi dell’Assemblea del popolo in 498 e
del Consiglio della Shura in 327
- prevede per entrambe le Camere un sistema elettorale per due terzi proporzionale sulla base di
liste di partito e per un terzo maggioritario
a doppio turno (si svolge il secondo turno se nessun candidato ottiene più del
50 per cento dei voti) in collegi ”binominali” (in ciascun collegio sono eletti
due candidati, uno dei quali deve essere un lavoratore o un contadino, retaggio
dell’impostazione socialista nasseriana, pena lo svolgimento di un “terzo
turno”)
Con riferimento alle condizioni di esercizio
delle libertà politiche e civili, “Freedom House” classifica l’Egitto come
“Stato non libero”, mentre il Democracy
Index 2011 dell’Economist Intelligence Unit lo definisce come “regime
ibrido” (nel Democracy Index 2010 era
indicato come “regime autoritario” cfr. infra
“Indicatori internazionali sul paese”). Secondo Human Rights Watch (World Report 2012), nel corso del 2011
non si è registrato un significativo miglioramento nel grado di rispetto dei
diritti umani in Egitto: in particolare, anche dopo le dimissioni di Mubarak,
sono proseguiti le detenzioni ed i processi di fronte alle corti militare sulla
base della legge di emergenza, nonché la repressione di manifestazioni. La
stampa ha potuto godere di margini di libertà assai maggiori, tuttavia non sono
mancati procedimenti penali a carico di giornalisti per denigrazione delle
forze armate (come testimoniato dall’arresto lo scorso ottobre del blogger Alaa
Abdel Fattah). Le procedure per la registrazione di partiti politici sono state
semplificate e “liberalizzate” dal Consiglio supremo delle forze armate agli
inizi di marzo, mentre permangono forti ingerenze governative in materia di
costituzione di associazioni. Si sono inoltre ripetuti, nel corso del 2011,
episodi di intimidazione nei confronti della minoranza copta.
Nel corso della transizione, molto dibattuta
risulta la questione dei rapporti tra religione
e politica. Al riguardo, merita segnalare il manifesto dell’università
islamica di Al Azhar, centro principale per la definizione della giurisprudenza
islamica dell’Islam sunnita reso noto lo scorso 19 giugno. Nel manifesto si
sostiene “l’istituzione di uno Stato costituzionale democratico” e “l’adozione
di un sistema democratico basato sul suffragio universale diretto, che
rappresenta la formula moderna per realizzare il principio islamico della
consultazione (shura) islamica e garantisce il pluralismo, l’alternanza
pacifica al governo”. Al tempo stesso si pone come condizione alla libera
gestione da parte del popolo della società il fatto che “i principi generali
della sharia rimangano la fonte essenziale della legislazione e che i seguaci
delle altre religioni monoteiste possano ricorrere alle loro leggi religiose
per quanto concerne le questioni legate allo statuto personale”. Insieme però si
ribadisce il “ruolo guida di Al Azhar nella definizione di un retto pensiero
islamico mediano […] la sua importanza […] per illuminare la natura del
rapporto tra lo Stato e la religione e
chiarire le basi di una corretta politica ispirata ai principi della Sharia che
sia radicata […] sulla dimensione giurisprudenziale […] secondo i principi
della comunità che coniuga ragione e tradizione”. Dall’università di Al Azhar è
giunta inoltre la richiesta del ritorno all’elezione interna della guida, lo Sheick di Al Azhar, la cui nomina è in
questo momento invece affidata al governo.
La
situazione politica interna
A seguito delle dimissioni, l’11 febbraio
2011, del Presidente della Repubblica Hosni
Mubarak (n. 1928), la direzione del paese è stata affidata al Consiglio
supremo delle forze armate. In questo contesto, il consiglio supremo delle
forze armate ha deciso, il 13 febbraio, di affidare i compiti di rappresentanza
esterna del paese e quindi le funzioni di Capo dello Stato, al suo Presidente,
il ministro della difesa Mohamed Hussein
Tantawi (n. 1935).
Primo ministro dal novembre 2011 è Kamal al Ganzouri, già primo ministro
nel corso degli anni Novanta.
Nella tabella sottostante sono riportati i
risultati delle recenti elezioni legislative egiziane. Nel box è invece
riportata una descrizione sintetica delle posizioni dei diversi movimenti
politici egiziani.
Per il prossimo 23 maggio sono invece
previste le elezioni presidenziali. Tra i candidati al momento dovrebbero
figurare:
- Amr
Mussa, ex-segretario generale della Lega araba ed
ex-ministro degli esteri di Mubarak;
- Abd al Fatuh esponente riformatore
della Fratellanza musulmana in dissenso con la direzione conservatrice del
movimento;
- Ahmed Shafiq primo ministro tra il
gennaio e il marzo 2011
- Selim Al-Awwa islamista moderato
- Hazem Abu Ismail, esponente salafita
- Bothaina Kamel, conduttrice televisiva
ed attivista dei diritti umani.
La Fratellanza musulmana ha dichiarato che
annuncerà quale candidato sosterrà solo al termine del processo di
registrazione degli stessi, agli inizi di aprile
Il 25
gennaio 2012 ha invece annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale Mohamed El Baradei¸ insoddisfatto per
la gestione della transizione da parte delle forze armate egiziane.
Risultati elezioni Assemblea del
popolo
|
§
Partiti
|
Seggi
|
|
§ Alleanza democratica di cui
|
225
|
|
§ Partito libertà e
giustizia
|
216
|
|
§ Al-Karama
|
6
|
|
§ Al-Hadara
|
2
|
|
§ Partito del lavoro
|
1
|
|
§ Alleanza islamista di cui
|
125
|
|
§ Al Nour
|
109
|
|
§ Partito Costruzione e
sviluppo
|
§
13
|
|
§ Al Asala
|
§
3
|
|
§ Al Wafd
|
§
41
|
|
§ Blocco egiziano di cui
|
§
34
|
|
§ Al Tagammu
|
§
3
|
|
§ Partito socialdemocratico
egiziano
|
§
16
|
|
§ Partito dei liberi
egiziani
|
§
15
|
|
§ Partito Riforma e sviluppo
|
§
10
|
|
§ Partito al - Wasat
|
§
9
|
|
§ Alleanza per la prosecuzione della rivoluzione
|
§
8
|
|
§ Partito nazionale egiziano
|
§
5
|
|
§ Partito cittadini egiziani
|
§
4
|
|
§ Partito dell’Unione
|
§
3
|
|
§ Partito Libertà
|
§
3
|
|
§ Partito al - Adl
|
§
2
|
|
§ Partito Pace democratica
|
§
2
|
|
§ Partito Unione araba egiziana
|
§
1
|
|
§ Partito Nasserite
|
§
1
|
|
§ Indipendenti
|
§
25
|
|
§ TOTALE
|
§
498
|
Incarichi
all’interno dell’Assemblea del popolo
|
Incarichi
|
Nome
|
Partito
|
|
Presidente
|
Mohamed
Saad Tawfik Al Katatni
|
Libertà e giustizia
|
|
Vicepresidente
|
Ashraf
Thabit Saad Eddin Al-Sayed
|
al-Nour
|
|
Secondo
Vicepresidente
|
Mohamed
Abdel Aleem Dawoud
|
al-Wafd
|
|
Presidente
Commissione Affari esteri
|
Essam al-Din Mohamed
al-Erian
|
Libertà
e giustizia
|
|
Presidente
Commissione parlamentare legislativa
|
Mahmoud Reda Abdel Aziz
al-Khudairi
|
Indipendenti
|
|
Presidente
Comitato sicurezza nazionale
|
Abbas
Mohamed Mohamed Mukhaimar
|
Libertà
e giustizia
|
|
Presidente
Commissione sanità
|
Akram
Al-Mendoh Awad Al-Shaer
|
Libertà
e giustizia
|
|
Presidente
Commissione ricerca educativa e scientifica
|
Shaaban
Ahmed Abdel-Alim
|
al –
Nour
|
|
Presidente
Commissione diritti umani
|
Mohamed
Anwar Esmat Al-Sadat
|
Riforma e sviluppo
|
|
Presidente
Commissione affari economici
|
Tarek Hassan al-Desouki,
|
al-Nour
|
|
Presidente
Commissione lavoro
|
Saber Abu al-Fotouh
Badawi al-Sayed
|
Libertà
e giustizia
|
|
Presidente
Commissione giovani
|
Osama
Yassin Abdel Wahab Mohamed
|
Libertà e giustizia
|
|
Presidente
affari arabi
|
Mohamed
Saeed Ibrahim Idris
|
al-Karama
|
|
Presidente
Commissione Comunicazione e cultura
|
Mohamed
Abdel-Moneim Mahmoud Al-Sawy,
|
al-Hadara
|
Risultati elezioni Consiglio della Shura
|
Partito
|
Totale
Seggi
|
|
Libertà e giustizia
|
105
|
|
Al - Nour
|
45
|
|
Al - Wafd
|
14
|
|
Blocco egiziano
|
8
|
|
Libertà
|
2
|
|
Pace democratica
|
2
|
|
Indipendenti
|
4
|
Indicatori internazionali sul paese 1:
Libertà politiche e civili: Stato “non libero”,
(Freedom House); regime autoritario 2010, 138 su 167; 2011: regime
“ibrido” 115 su 167 (Economist)
Indice della libertà di stampa 2010: 127 su 178,
2011-12: 166 su 178
Libertà di Internet : assenza di evidenza di
“filtraggio”
Libertà religiosa: limitazioni alla libertà religiosa
ed episodi di violenza (ACS); Islam religione di stato e limitazioni alle
libertà delle altre religioni da parte
del governo (USA)
Libertà economica: 100 su 179 (Heritage Foundation)
Corruzione percepita 2010: 98 su 178, 2011: 112 su 178
Variazione PIL 2010: + 5,1 per cento, 2011: 1,2 per
cento
Fonti: The Statesman’s Yearbook 2011,
Unione interparlamentare, Freedom House,
Human Rights Watch, Arab Reform Bulletin –Carnegie endowment for international
peace, Brookings Institution, Economist Intelligence Unit, agenzie di stampa.
Movimenti
e coalizioni partecipanti alle elezioni egiziane
In
vista delle elezioni i principali movimenti politici egiziani si sono aggregati in cinque coalizioni
principali. Fino alla presentazione delle liste, comunque, la
configurazione delle coalizioni è apparsa molto incerta e soggetta a
significative variazioni per i numerosi contrasti interni; un numero
significativo di partiti, come si vedrà nella descrizione delle singole
coalizioni, ha preferito alla fine presentare liste autonome. Le coalizioni
risultano essere:
- Alleanza democratica
Il principale partito della
coalizione è il partito Libertà e
Giustizia, nato a giugno, emanazione della dirigenza dei Fratelli musulmani
egiziani e guidato da Mohammed Morsi.
Tra i suoi punti programmatici: l’instaurazione dello Stato di diritto, di un
sistema parlamentare con poteri solo di rappresentanza per il Presidente della
Repubblica, di uno “Stato civile” né teocratico né militare con l’Islam
religione di Stato e la Sharia come fonte di legislazione (come già previsto,
comunque, dall’articolo 2 dell’attuale Costituzione egiziana); l’attribuzione
ad una Corte costituzionale del potere di dichiarare illegittime leggi che
contrastino con i principi islamici di giustizia; il sostegno ai principi
islamici nell’azione di governo, con riconoscimento per i non musulmani del
diritto al proprio status personale e
alla libertà di culto; in politica estera previsione dell’obbligo di referendum
per i trattati di pace ed il sostegno all’autodeterminazione palestinese, ivi
compreso il diritto al ritorno dei profughi e la richiesta di Gerusalemme
capitale.
Merita segnalare che la Fratellanza musulmana
egiziana appare divisa. In particolare la dirigenza conservatrice del movimento
da parte della Guida suprema Muhammed
Badie è contestata dall’esponente riformatore della fratellanza Abd al Fatuh, secondo alcuni possibile candidato
alle elezioni presidenziali, nonché dall’ala
giovanile del movimento, che, a differenza della dirigenza, ha preso convintamente parte alle
manifestazioni di piazza che hanno condotto alle dimissioni di Mubarak. In particolare, oggetto di discussione è la
posizione della Fratellanza rispetto alla laicità dello Stato egiziano. Tale
concetto continua ad essere respinto dalla dirigenza della Fratellanza; gli
esponenti riformisti hanno dimostrato aperture verso il concetto di “Stato
civile”, vale a dire fondato sui diritti di cittadinanza ma rispettoso nei
confronti delle radici religiose egiziane, in coerenza anche con le posizioni
recentemente assunte dall’Università Al Azhar. Ora il concetto di “Stato
civile”, come si è visto, si ritrova anche nel programma del partito Libertà e
giustizia, anche se, in questo caso, il concetto appare prefigurare comunque
un’ampia penetrazione della religione nella vita politica. Il dibattito interno
alla Fratellanza ha determinato la nascita, a fianco del partito “ufficiale”
Libertà e Giustizia, anche di altri partiti come Al Wasat e Al Tayara Al Masry
(cfr. infra).
Dell’Alleanza
democratica fanno parte anche movimenti laici. Merita ricordare il partito Al Ghad (domani) fondato nel 2005 da Ayman Nour, sfidante nello stesso anno
nelle elezioni presidenziali di Mubarak ed a lungo incarcerato dal regime.
Aveva annunciato la sua adesione alla coalizione anche lo storico partito
liberale egiziano Wafd guidato da Sayyed Al Badawi; tuttavia
successivamente il partito ha annunciato la sua intenzione di presentare liste distinte da Libertà e giustizia;
- Blocco egiziano
Il
Blocco egiziano è stato costituito a giugno da una serie di movimenti laici con lo scopo di
perseguire gli ideali della “rivoluzione di piazza Tahrir” realizzando una
“democrazia liberale” ed una “cittadinanza universale”. Sostenendo il concetto
di “Stato civile”, piuttosto che quello di “Stato secolare”, il blocco intende
comunque riconoscere il ruolo dell’Islam nella vita politica, condividendo
l’impostazione del documento del giugno scorso sui rapporti tra religione e
politica (cfr. infra) dell’Università
di Al Azhar. Il blocco risultava
inizialmente costituito dal partito dei liberi egiziani, fondato
dall’imprenditore copto Naguib Sawiris, dal
partito socialdemocratico, dal
partito socialista Al Tagammu (già
presente in Parlamento durante il regime di Mubarak), dall’associazione nazionale per il cambiamento (movimento fondato nel
febbraio 2010 da Mohammed El Baradei),
dal Fronte democratico (movimento
fondato nel 2007 dall’ex-esponente del partito nazionale democratico di Mubarak
Osama al Ghazali-Harb) e dal
movimento di ispirazione sufi partito
della liberazione egiziana. Disaccordi sulla composizione delle liste hanno
indotto molti di questi partiti ad abbandonare il blocco che attualmente
risulta composto solo dal partito dei liberi egiziani, dal partito socialdemocratico e da Al
Tagammu.
- Terza via
La coalizione della “Terza
via” intende collocarsi in una posizione intermedia tra l’Alleanza democratica
dominata dagli islamisti e il Blocco egiziano laico. La coalizione è
attualmente composta dal partito della
giustizia, fondato nel giugno 2011 da alcuni esponenti di movimenti di
dissidenza giovanile come Kifaya e
il movimento del 6 aprile, organizzatori
delle proteste di piazza Tahrir. Alla coalizione aveva inizialmente guardato
con interesse anche il partito Al Wasat,
fondato nel marzo 2011 da esponenti riformisti dalla Fratellanza musulmana che
assumono esplicitamente a modello l’Akp turco (e guidato da Abu El al-lla Mady). Tuttavia il Wasat non è entrato a far parte della coalizione.
- Alleanza islamista
L’Alleanza islamista
raccoglie alcuni movimenti di orientamento salafita
e cioè collocati su posizioni maggiormente integraliste rispetto alla
fratellanza musulmana come Hizb al-Nour (partito
della luce); Bina ‘a wa Tanmia (partito
della costruzione e dello sviluppo, braccio politico del movimento Jamaa al-Islamiya considerato dagli USA
terrorista) e il partito al-Asala (autenticità,
ispirato al pensiero del teorico dei fratelli musulmani Sayyd Qutb, ucciso dal regime di Nasser negli anni Sessanta):
questi movimenti richiedono l’introduzione e l’applicazione letterale della
legge islamica.
- Alleanza per la prosecuzione della
rivoluzione
L’Alleanza per la
prosecuzione della rivoluzione raccoglie una serie di movimenti liberali,
socialisti e islamisti moderati, in precedenza per la maggioranza coinvolti nel
blocco egiziano. Oltre che da partiti come il partito socialista popolare e il partito dell’Egitto libero, l’alleanza è sostenuta dalla maggior
parte degli esponenti della coalizione
giovanile, nata dall’esperienza delle proteste di piazza Tahrir. Fa parte
dell’Alleanza anche il movimento Al
Tayara Al Masry (l’Egitto attuale) guidato dal giovane esponente della
Fratellanza musulmana Islam Lofti,
uscito dall’organizzazione durante l’estate criticandone la struttura
verticistica.
______________________________________________________________________
In
Egitto Il 26 giugno 2011 veniva resa nota la
decisione del Consiglio supremo delle forze armate, presieduto dal maresciallo
Hussein Tantawi, di procedere a un rinvio
di tre mesi nelle elezioni parlamentari precedentemente fissate per il mese
di settembre - senza peraltro nulla specificare sul calendario delle elezioni
presidenziali, che erano previste al massimo un paio di mesi dopo quelle
legislative. Il rinvio delle elezioni legislative è sembrato potersi
interpretare come parziale accoglimento delle richieste venute dal movimento
giovanile protagonista della rivoluzione che aveva condotto alla caduta di
Mubarak, nonché da alcuni partiti dell'opposizione e da possibili candidati
alle elezioni presidenziali come Amr Mussa e Mohammed el Baradei.
La richiesta di rinvio veniva giustificata
con la necessità di dare più tempo alle forze politiche in via
di formazione, per poter affrontare in modo efficace la campagna
elettorale, che diversamente avrebbe visto in posizione di eccessivo vantaggio
i Fratelli Musulmani o persino i residui del Partito Nazionale Democratico al
potere nell'epoca di Mubarak. Il 29
giugno si verificavano comunque ripetuti scontri tra manifestanti e forze
dell’ordine, sin dalla nottata, nella capitale egiziana, soprattutto in
Piazza Tahrir e nei pressi del Ministero dell'interno, che avrebbero provocato circa 600 feriti: i manifestanti
chiedevano soprattutto le dimissioni di Tantawi.
Nel mese
di luglio la situazione in Egitto si è sviluppata poi intorno alla sempre
più chiara dialettica tra le autorità militari provvisorie di governo e il
movimento di protesta, che per alcuni giorni ha avuto come proprio
epicentro Suez: le autorità responsabili hanno dovuto assicurare che nessuna
manifestazione avrebbe messo a rischio la sicurezza della navigazione nel Canale.
Pure il rimpasto di governo
finalmente attuato il 21 luglio con la sostituzione della metà dei ministri, è
stato attaccato dal movimento giovanile di Piazza Tahrir, desideroso di un
ancor maggiore ricambio della classe dirigente, che portasse alla fine completa
di ogni funzione politica degli elementi compromessi con il passato regime. Il 29 luglio la contestazione di Piazza
Tahrir è stata dominata per la prima volta dagli islamisti, dopo la rottura
dell'unità che aveva portato a convocare una grande manifestazione, e il
conseguente ritiro degli altri movimenti politici.
La prima
metà di agosto è stata caratterizzata dall'apertura del processo contro Mubarak, i due figli Alaa e Gamal,
l'ex ministro dell'interno el Adly e sei dei suoi collaboratori, tutti presenti
in aula a partire dal 3 agosto -
unico contumace l'uomo d'affari Hussein Salem, che si trovava in Spagna. Nella
prima udienza l'ex rais, comparso alla sbarra in barella, ha rigettato le accuse di
aver fatto sparare sui manifestanti nei primi giorni della sollevazione
popolare. L'inizio del dibattimento è stato accompagnato al di fuori
dell'aula da continui tafferugli tra sostenitori e avversari di Mubarak, con
particolare virulenza il 15 agosto, quando si è aperta la seconda udienza, che
veniva prontamente rinviata .
Subito dopo, l’Egitto si è trovato coinvolto
in un’aspra polemica con Israele, in
seguito alla reazione ebraica agli attentati del 18 agosto nel Neghev
meridionale, che provocava indirettamente l’uccisione
di cinque guardie di frontiera egiziane: già il 19 agosto si svolgevano
dimostrazioni di centinaia di persone in piazza Tahrir e nei pressi
dell'ambasciata israeliana al Cairo, che giungevano a chiedere la chiusura
della rappresentanza diplomatica e l’espulsione dell'ambasciatore. Anche alcuni
probabili candidati alle elezioni presidenziali egiziane, tra i quali el
Baradei e Amr Mussa, si esprimevano con asprezza nei confronti di Israele. Di
fronte ad alcune voci su un possibile richiamo al Cairo dell'ambasciatore
egiziano in Israele, il Ministro della difesa di Tel Aviv Ehud Barak dichiarava
il proprio rammarico per la morte dei militari egiziani, dando la disponibilità
di Israele a un'inchiesta congiunta con l'Egitto per verificare le circostanze
dell'incidente - che peraltro, secondo i vertici militari israeliani, poteva
non essere stato causato da fuoco israeliano, quanto piuttosto da ordigni
piazzati da terroristi o da loro raffiche.
D’altro canto, però, l'Egitto è sembrato adoperarsi attivamente per spegnere la tensione
rinnovata tra Israele e la Striscia, tanto che nei giorni immediatamente
successivi l'asprezza dello scontro è stata attenuata. Da rimarcare soprattutto
l'accordo tra Egitto e Israele, che
ha visto il consenso di Tel Aviv nel derogare almeno temporaneamente agli accordi
di smilitarizzazione del Sinai fissati nel 1979, onde permettere il
dispiegamento di forze egiziane nella regione per prevenire attacchi contro
Israele. L'impegno egiziano ha altresì consentito l'importante risultato di far
aderire anche la Jihad islamica
palestinese alla sospensione degli attacchi contro Israele, in ciò seguendo
quanto già deciso da Hamas. All'atteggiamento responsabile dell'Egitto, o
meglio di chi in Egitto effettivamente in quel momento aveva la responsabilità
di prendere decisioni, ossia essenzialmente i militari, sembrava tuttavia
corrispondere un certo scollamento della popolazione e anche di importanti
esponenti politici, come i già citati candidati alle presidenziali o il neo segretario della Lega Araba al-Arabi, che più volte sono sembrati
cavalcare gli umori fortemente
antisraeliani di larghe fasce della popolazione egiziana.
Tale schema è sembrato inverarsi il 9 settembre al Cairo, quando, dopo
aver demolito il muro di protezione eretto solo da pochi giorni davanti
all’edificio assai alto, uno dei cui piani è occupato dall'ambasciata israeliana, decine di manifestanti, violando
l’extraterritorialità della sede diplomatica, si sono arrampicati fino ai
locali della rappresentanza, costringendo l'ambasciatore, il personale diplomatico
ed i loro familiari a una fuga precipitosa, mentre sei appartenenti alla
sicurezza israeliani venivano messi in salvo solo per l'intervento di forze
speciali egiziane. Al di fuori dell'ambasciata si sono poi verificati violenti
scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine egiziane arrivate in massa a
fronteggiare la gravissima circostanza. Le
autorità del Cairo hanno poi prontamente reagito il giorno seguente con una
riunione straordinaria del Consiglio supremo delle forze armate e del gabinetto
di crisi del governo, respingendo anzitutto le dimissioni del premier Sharaf, e assicurando il rispetto di tutti trattati internazionali che vincolano
l'Egitto, inclusi quelli relativi alla protezione delle sedi diplomatiche.
Le autorità hanno inoltre ammonito sulla possibilità di ricorrere alla
normativa sullo stato d'emergenza, tuttora in vigore.
Ciononostante, il clima antisraeliano in Egitto è stato poi rinfocolato dalla visita al Cairo del premier turco Erdogan, a sua volta già da tempo in rotta di collisione
con Tel Aviv, che ha sollevato il tema dell'assoluta necessità del
riconoscimento di uno Stato palestinese. Dopo pochi giorni, non a caso, il
premier egiziano Sharaf, intervistato da una televisione turca, si è spinto a
dichiarare che l'accordo di pace del
1979 con Israele non era più considerato come immutabile dall'Egitto, e
avrebbe potuto essere rinegoziato.
Il 5
settembre era intanto ripreso il processo a Mubarak e agli altri imputati per le violenze contro i
manifestanti nella prima fase della rivoluzione egiziana: si è trattato di
un'udienza fiume, durante la quale venivano ascoltati quattro ufficiali della
sicurezza centrale, proprio allo scopo di chiarire il ruolo delle autorità di
governo nella repressione violenta. L'udienza è stata accompagnata dai
consueti tafferugli in prossimità del
tribunale, ma le tensioni si sono trasferite anche nell'aula di giustizia,
dalla quale sono stati allontanati esponenti di opposte idee.
All’inizio di ottobre la situazione egiziana ha visto un nuovo grave focolaio di tensione, quando, per protestare contro l'attacco perpetrato ad Assuan da giovani musulmani contro un edificio appartenente alla comunità copta, accusata di volerlo trasformare in una chiesa senza averne ricevuto l'autorizzazione, appartenenti alla consistente minoranza cristiano-copta del paese hanno inscenato una serie di manifestazioni, dapprima nella stessa località di Assuan, e successivamente nella capitale. Il 9 ottobre le proteste sono degenerate in gravi scontri, dapprima tra i copti e le forze di sicurezza, e successivamente anche tra copti e musulmani, con un bilancio di 26 morti e oltre trecento feriti. I copti avevano portato la protesta al Cairo per richiedere le dimissioni del governatore di Assuan – secondo il quale, peraltro, la costruenda nuova chiesa cristiana non rispondeva ai requisiti di legge. Sullo sfondo, tuttavia, si agitava non solo tra i copti il sospetto di un accordo sotterraneo tra l’elemento militare alla guida del paese e i Fratelli Musulmani – i soli già in possesso di una ramificata struttura organizzativa in vista delle elezioni legislative del 28 novembre -, volto a favorire proprio questo gruppo nei confronti delle forze motrici della rivoluzione di piazza Tahrir.
Nell’udienza generale del 12 ottobre lo stesso pontefice Benedetto XVI denunciava il tentativo in Egitto di porre fine alla coesistenza pacifica tra cristiani e musulmani, colpendo una pacifica manifestazione di copti. Dal canto suo il patriarca di Alessandria d’Egitto Naguib ha rilevato come la Dichiarazione prodotta il 19 luglio dalla prestigiosa Università islamica di Al Azhar, ponendo la legge islamica quale principio ispiratore della Costituzione e delle leggi, contraddicesse i propositi, pure ivi espressi, di contribuire alla nascita di uno Stato moderno e a carattere democratico.
In ogni modo, il 10 ottobre il governo egiziano guidato da Sharaf aveva approvato, in una riunione straordinaria, un pacchetto di misure a favore della minoranza cristiano-copta, tra cui alcune modifiche al codice penale per colpire con pesanti sanzioni detentive e pecuniarie ogni discriminazione religiosa nei luoghi di lavoro e nelle pubbliche attività. L’esecutivo inoltre disponeva un’inchiesta sugli incidenti del giorno prima, come anche l’avvio di una discussione per la riforma della normativa concernente i luoghi di culto, favorendone intanto la costruzione con un progetto di legge per semplificare le relative procedure. Nonostante questa pronta reazione, l’11 ottobre il governo veniva attraversato da forti tensioni, con numerose richieste di dimissioni, di fronte alle quali il premier Sharaf si rimetteva alla volontà delle forze armate, che intanto, per mezzo della Procura militare, ordinavano il fermo di una trentina di persone sospettate di coinvolgimento nei gravi scontri del 9 ottobre.
Mentre si avvicinava l'importantissima
scadenza delle elezioni legislative del 28 novembre, il dibattito politico si incentrava in Egitto sulle conseguenze del
giro di vite sulla sicurezza messo in atto dai vertici militari, tuttora detentori
sostanziali del potere, che avevano disposto l'applicazione della legge di
emergenza dopo i gravi disordini del 9 ottobre. Proprio in relazione a questi
avvenimenti veniva arrestato un noto attivista egiziano, Abdel Fattah,
protagonista anche della mobilitazione su Internet: nei suoi confronti venivano
elevate accuse di incitamento in relazione ai disordini del 9 ottobre, come
anche di uso personale di armi e di avere tentato violenze contro un reparto
militare. Il giovane attivista ha tuttavia abilmente saputo attirare
l'attenzione sulla questione centrale
collegata alla legge di emergenza - risalente all’assassinio di Sadat nel
1979, e della quale il movimento di Piazza Tahrir chiedeva da tempo
l’abolizione -, ovvero la sottoposizione
di civili al giudizio di tribunali militari, alle cui domande egli si è
rifiutato di rispondere, ricevendo al proposito anche la solidarietà di due
candidati alla Presidenza, ovvero el-Baradei e Sabahi. L'asprezza del dibattito
è stata inoltre alimentata anche da iniziative di sciopero della fame e della sete nelle carceri da parte di
manifestanti arrestati, come anche dalla morte
di Essam Atta, un ventiquattrenne detenuto il cui decesso sarebbe stato
provocato dalle torture susseguenti a un tentativo di attivare il suo cellulare
dall'interno dell'istituto di pena. In questo contesto, il 1° novembre diverse
organizzazioni egiziane per la difesa dei diritti umani hanno boicottato il
programmato incontro con il vicepremier Ali al-Selmy, nel quale si sarebbero
dovuti mettere a punto i criteri di massima per dar vita a un’Assemblea
costituente egiziana.
Anche
i copti, che l’11 novembre
hanno manifestato nella capitale per commemorare i morti del 9 ottobre, hanno mostrato una forte diffidenza nei confronti delle forze armate,
le quali, pur avendo imposto una stretta sulla sicurezza proprio dopo il
massacro dei copti, da molti tra questi ne sono state ritenute dirette
responsabili, e dunque scarsamente credibili nell'accertamento della verità.
Ormai nell’imminenza del primo turno delle
elezioni legislative, esplodeva il
contrasto tra le forze che hanno animato la rivoluzione contro Mubarak e i
militari, temporanei custodi della sovranità del paese: inoltre destava
forte opposizione un progetto di riforma costituzionale volto ad abolire i
controlli del Parlamento sui bilanci e le attività delle forze armate egiziane,
disposte a modificarlo solo parzialmente. Su questo sfondo il 19 novembre sono iniziati scontri in Piazza Tahrir, successivamente
estesi anche ad altre località, come Suez, che proseguivano con alterne
fasi, e il cui bilancio ammontava già il 21 novembre a una quarantina di
vittime e diverse centinaia di feriti. Nella stessa giornata si avevano
pertanto le dimissioni di Essam Sharaf, e il 24 novembre, dopo un'altra giornata di gravi disordini con nuove
vittime, i militari hanno affidato all'ex
primo ministro di Mubarak, Kemal al-Ganzuri, l’incarico di dare vita ad un
nuovo governo. Cionondimeno la mobilitazione della Piazza Tahrir è
proseguita, anche se le violenze si sono progressivamente attenuate in vista
dell'appuntamento delle elezioni parlamentari per la Camera Bassa (Assemblea
del Popolo) confermato per il 28 novembre, e al quale, come già accaduto in
Tunisia, si è presentata una variegata galassia di ben 55 formazioni
politiche.
Dopo un lungo
scrutinio sono finalmente stati resi noti (4 dicembre) i risultati del primo
dei tre turni delle elezioni legislative, concernente un terzo dei
governatorati del paese: il successo è andato, anche oltre le
aspettative, ai due partiti islamici maggiori, il partito
Giustizia e Libertà, espressione politica dei Fratelli musulmani (oltre il
36% dei voti), e la coalizione fondamentalista islamica (salafita) al-Nour (più del 24% dei suffragi).
Poco seguito hanno avuto le liste della principale coalizione liberale, il
Blocco egiziano (13,5%), come anche quelle degli islamici progressisti del
Wasat (4,2%).
Dopo la netta affermazione dei partiti
islamici, i dati relativi ai ballottaggi nella quota uninominale sono sembrati
attenuare la portata del successo dei salafiti, poiché questi avrebbero
conquistato solo altri 5 seggi, a fronte dei 36 attribuiti ai Fratelli
musulmani. Il dato complessivo del primo
dei tre turni elettorali vedrebbe dunque, su 168 seggi in palio, 80 seggi ai
Fratelli musulmani, 31 ai salafiti e 18 ai liberal-moderati del Blocco
egiziano.
Il 7
dicembre ha visto la luce il governo di al-Ganzuri.
Il
16 dicembre si è completato lo svolgimento del secondo dei tre turni delle
elezioni legislative, con un’affluenza
di circa il 68% degli aventi diritto: secondo i due principali partiti islamici
anche questo turno elettorale avrebbe marcato una loro netta affermazione.
Frattanto però la violenza si è riaccesa
nel centro del Cairo, con pesanti scontri tra forze di sicurezza e
manifestanti in prossimità dei palazzi del Parlamento e del Governo: il bilancio, tra il 16 e il 17 dicembre, è
stato di una decina di morti e ben oltre duecento feriti. Il nodo del
potere reale tuttora nelle mani dell’esercito restava centrale nelle motivazioni
dei manifestanti, e sembrava relativamente indipendente dallo svolgimento
regolare del programma elettorale previsto.
Il 4
gennaio 2012 si è completato lo svolgimento dei tre turni delle elezioni
legislative, con un’affluenza
diminuita rispetto ai due turni precedenti. In attesa dei risultati elettorali
complessivi è tornata in primo piano la questione della sorte dell’ex rais Hosni Mubarak, nel cui processo, in corso al Cairo, il 5 gennaio è stata chiesta dall’accusa la pena
capitale, da comminare anche all’ex ministro dell’interno el-Adli e a sei
suoi collaboratori: la condanna a morte è stata chiesta in relazione all’ordine
di uccidere i manifestanti che sarebbe partito proprio da Mubarak nei primi
giorni della contestazione di fine gennaio 2011. Nell’udienza del 22 febbraio è
stato poi fissata la conclusione del processo per il 2 giugno.
Il 14 gennaio uno dei principali candidati
alle elezioni presidenziali del 2012, l'ex capo dell'Agenzia internazionale per
l'energia atomica e premio Nobel per la pace Mohammed el Baradei,
liberale, ha annunciato il proprio
ritiro dalla corsa presidenziale, poiché a suo dire l’Egitto non può essere
definito un vero regime democratico, e anzi sembra ormai non vi sia stata
alcuna rivoluzione, con la gestione politica in mano ai militari che si mostra,
oltre che brutale, anche incapace di conseguire gli obiettivi fondamentali
della rivoluzione del 2011. Al di là delle dichiarazioni di el Baradei, la sua
decisione può essere stata influenzata anche dalla realistica constatazione
dell'impossibilità di una sua designazione alla presidenza in un paese con una
maggioranza tanto vasta a favore dei partiti islamisti.
Il
19 gennaio il Ministro degli Esteri Giulio Terzi, in visita al Cairo, ha recato il pieno sostegno del nostro paese alla
transizione democratica in corso in Egitto, ribadendo l’importanza dei legami
culturali ed economici tra i due paesi. Il ministro Terzi ha incontrato tutti i
vertici politici e religiosi egiziani, e ha
tenuto a caldeggiare con rinnovato vigore la necessità del rispetto del
pluralismo e delle minoranze sul terreno religioso.
Pur se non del tutto completi, i
dati della complessa tornata elettorale per la Camera bassa egiziana hanno
confermato nella quota proporzionale
(332 seggi) la grande vittoria dei
partiti islamisti, che hanno totalizzato circa tre quarti dei seggi, ovvero
127 ai Fratelli musulmani, 96 ai salafiti del Nour e 10 al Wasat. Sui
circa trenta partiti presentatisi alla consultazione sono stati quindi tredici
quelli che hanno ottenuto seggi: tra questi, assai lontani dai partiti
islamici, i moderati e i liberali del Wafd e del Blocco egiziano,
rispettivamente con 36 e 33 seggi. Anche la galassia di piccole formazioni
politiche riconducibili al disciolto Partito nazionale democratico di Mubarak
ha portato in Parlamento una quindicina di rappresentanti.
Dopo la sorpresa dei vertici
militari, che hanno proceduto a graziare circa duemila detenuti già
giudicati della giustizia militare, tra i quali il blogger e attivista copto Nabil; il 23 gennaio vi è stata la seduta inaugurale del Parlamento, che con
maggioranza schiacciante ha eletto come proprio presidente Mohammed el-Katatni,
appartenente ai Fratelli musulmani. Il compito più importante che sta di
fronte al nuovo Parlamento è la scelta dei cento componenti dell'Assemblea
costituente incaricati di redigere una nuova Costituzione.
Mentre gli ambienti degli
attivisti manifestavano un profondo scontento in vista dei festeggiamenti del
25 gennaio per l’anniversario della rivoluzione contro Mubarak, il 24 gennaio
il capo del Consiglio militare, maresciallo Tantawi, ha dato soddisfazione a
una delle principali richieste della piazza, annunciando la parziale revoca dello stato di emergenza in vigore dal 1981. Tantawi ha
inoltre ribadito l’intenzione dei militari di abbandonare l’attuale ruolo
politico non appena terminata la lunga fase della transizione istituzionale.
Tensione con gli Stati Uniti si è registrata intanto a seguito del
fermo al Cairo di sei cittadini americani – tra i quali il figlio del
segretario federale ai trasporti Ray Lahood – che avevano partecipato per conto
di alcune organizzazioni non governative americane (l’International Republican Institute, la Freedom House e il National
Democratic Institute) all’osservazione del processo elettorale in corso nel
paese. Gli Stati Uniti hanno replicato
minacciando di non erogare più all’Egitto il cospicuo contributo militare, che
supera il miliardo di dollari. Cionondimeno, i cittadini americani interessati,
nel frattempo divenuti diciannove, sono stati rinviati a giudizio il 5
febbraio, con l'accusa di aver creato e gestito senza autorizzazione proprie
sedi in Egitto, dando vita inoltre a programmi di formazione politica rivolti
ad alcuni partiti – accuse che comportano una pena intorno ai cinque anni di
reclusione. Nell’udienza del 26 febbraio – ove peraltro solo i 14 imputati
egiziani sono comparsi in aula – si è deciso, dopo che l’accusa ha ribadito le
accuse di attività illecite e, in riferimento agli stranieri, di interferenze
nella politica egiziana, di aggiornare il processo alla data del 26 aprile. In
realtà il 29 febbraio, dopo le
dimissioni in blocco dei giudici
interessati dal procedimento, è stato
dato agli stranieri coinvolti nella vicenda il permesso di lasciare l’Egitto,
con evidente volontà di chiudere soprattutto l’incidente con gli Stati Uniti. Tale sviluppo ha però scatenato aspre
critiche interne all’Egitto, tanto da parte dell’opinione pubblica e dei media quanto da parte di importanti
cariche istituzionali – come ad esempio il presidente dell’Assemblea del popolo
Katatni -, con accuse al governo e ai militari di aver ceduto alle pressioni
americane, interferendo indebitamente nel campo giudiziario, il che sarebbe
provato anche dalle dimissioni dei giudici di merito. Il premier el Ganzouri e
altri ministri interessati dalla vicenda sono stati convocati per l’11 marzo a
riferire in Parlamento.
I segnali di miglioramento del clima
politico egiziano, soprattutto in ordine al persistente ruolo di garanzia
politica delle forze armate, sono stati subito smentiti il 1º febbraio quando lo
stadio di Porto Said è stato teatro di un gravissimo episodio di violenza:
i sostenitori della squadra locale, che pure aveva riportato un inatteso
successo contro la squadra cairota della el Ahly, hanno invaso in massa il
campo e scatenato una caccia all'uomo nei confronti dei tifosi ospiti, alla
fine della quale si contavano 73 morti e
circa 1000 feriti. Con il passare dei giorni la vicenda ha rivelato nuovi
contorni, in quanto l'azione dei supporter
di casa sarebbe stata favorita da una
sostanziale inerzia delle forze dell'ordine, pure presenti allo stadio, che
ha condotto i recenti vincitori delle elezioni legislative, i Fratelli
Musulmani, a formulare accuse ai sostenitori del passato regime di aver
consumato nello stadio di porto Said una vendetta pianificata. D'altra parte,
va ricordato che gli ultras della el
Ahly, seppure con motivazioni distanti da quelle politiche, avevano tuttavia
partecipato sin dall'inizio ai moti di Piazza Tahrir, mettendo la propria forza
organizzata al servizio dei manifestanti, soprattutto per una consolidata
ostilità contro le forze di sicurezza del regime di Mubarak.
Il
ruolo delle forze di sicurezza nella vicenda è divenuto presto il fulcro di una
polemica politica che ha visto
parzialmente ridisegnarsi gli equilibri di potere, con la messa in difficoltà
del tacito patto tra il Consiglio militare i Fratelli Musulmani. D'altra parte,
gli ambienti della contestazione di piazza hanno accusato le forze armate di
aver architettato un piano di scatenamento di tensioni per terrorizzare il
paese e, mediante la richiesta di una stretta sulla sicurezza, nuovamente
legittimarsi alla direzione di esso. Nell'immediato, la federazione calcistica
egiziana ha sospeso qualunque partita sine
die, mentre il 2 febbraio si è
riunito il Parlamento in seduta d'urgenza - e ciò non avveniva da circa quaranta anni - mentre le strade e
le piazze circostanti si riempivano progressivamente di manifestanti che
urlavano slogan contro le forze armate.
Dopo le prime misure contro le autorità di
Porto Said e i vertici della federazione calcistica egiziana, la seduta
parlamentare ha visto convergere le forze politiche sulla richiesta di
dimissioni del ministro dell'interno Ibrahim e sull'inizio di un’indagine
parlamentare sui fatti. Divisioni sono tuttavia emerse in merito
all'attribuzione delle responsabilità ai militari, rispetto ai quali sia il
partito espressione dei Fratelli Musulmani che quello salafita hanno evitato
ogni accenno, mentre sono stati apertamente attaccati dalle forze laiche e
liberali, come anche dai pochi deputati espressi dal movimento di piazza.
La rapida evoluzione della situazione ha
però fatto sì che il 3 febbraio, mentre progressivamente si addensavano intorno
ai palazzi istituzionali scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, con i
primi morti, la Guida suprema dei
Fratelli musulmani Mohamed Badie abbia attaccato in modo durissimo il potere
militare, sostenendo che ufficiali conniventi con il vecchio regime hanno
voluto punire il popolo e la sua rivoluzione. Badie ha proseguito richiedendo
immediati provvedimenti di ristrutturazione del ministero dell'interno, come
anche di dare soddisfazione alla piazza eliminando ogni privilegio nella
detenzione degli esponenti del vecchio regime, e in particolare trasferendo
Mubarak nell'ospedale del carcere.
Sulla scorta della maturazione di queste
posizioni, il 6 febbraio la Commissione elettorale egiziana ha annunciato
l'anticipo di un mese, rispetto a quanto previsto dal Consiglio militare, della
data fissata per la presentazione delle candidature per le elezioni
presidenziali, che ha aperto la strada ad un anticipo della stessa
consultazione: infatti il 29 febbraio la
Commissione elettorale presidenziale ha annunciato le date del 23 e 24 maggio
per lo svolgimento delle presidenziali, con eventuale turno di ballottaggio
il 16 e 17 giugno.
In ogni modo, l'11 febbraio ha visto un grave insuccesso della giornata di
disobbedienza civile proclamata da movimenti e attivisti egiziani, con l’unica
eccezione della massiccia adesione di studenti e università. Il fallimento
dell'iniziativa è dipeso soprattutto dal boicottaggio di essa da parte dei
movimenti islamisti, tanto quello dei Fratelli Musulmani quanto quello dei
salafiti, ma neanche i copti hanno aderito all'appello alla disobbedienza
civile.
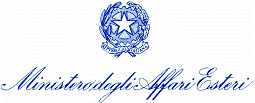
Direzione Generale per gli Affari Politici
e di Sicurezza
Ufficio VIII
SCHEDA PAESE
Repubblica Araba
d’Egitto
CENNI STORICI
Nel 1922 i britannici concedono
l’indipendenza all’Egitto riservandosi il controllo sul Canale di Suez e nel
1947 inizia il definitivo ritiro delle truppe inglesi dal Paese. L’anno
seguente l’Egitto prende parte al Primo
conflitto arabo-israeliano, conclusosi con una sostanziale vittoria
israeliana e l’annessione della Striscia di Gaza da parte egiziana e della
Cisgiordania da parte giordana.
Dopo la rivoluzione degli ufficiali del 1952,
che costrinse Re Farouk all’esilio, il Generale Nasser assume la guida del Paese: la pianificazione economica e la
nazionalizzazione delle banche commerciali e del Canale di Suez sono i caratteri della sua politica. In quegli anni
l’Egitto assume la leadership del mondo arabo, rafforzato dal fallimento
dell’operazione militare anglo-francese nella zona del Canale (1956). La
successiva partecipazione al conflitto arabo-israeliano del 1967 segna,
tuttavia, una pesante sconfitta per Nasser, che perde il controllo della
Striscia di Gaza e del Sinai.
A Nasser succede il suo Vice-Presidente Sadat. Nonostante la sconfitta militare
della guerra del Kippur nel 1973, l’Egitto recupera credibilità e prestigio
internazionale e Sadat inaugura un periodo di liberalizzazione politica ed
apertura all’economia di mercato globale. In politica estera, l’azione di Sadat
è volta a normalizzare le relazioni con gli USA e, nonostante le critiche dei
Paesi arabi, nel 1977 intraprende una storica visita in Israele per
rivitalizzare il processo di pace. Con il summit di Camp David, nel settembre 1978, viene stipulato un trattato di pace
tra Egitto ed Israele in base al quale Israele si impegna a restituire la penisola del Sinai all'Egitto, mentre quest'ultimo riconosce lo
Stato di Israele.
L’assassinio del presidente Sadat (ottobre
del 1981) da parte di un esponente del gruppo Al-Jihad, islamisti radicali
contrari al processo di pace, apre le porte alla successione di Hosni Mubarak, appartenente all’oligarchia
degli Ufficiali delle Forze Armate egiziane, come i suoi predecessori. Mubarak
sposa da subito una linea di continuità con la politica di Sadat, ovvero di
rinuncia al panarabismo nazionalista e socialista di Nasser, per condurre una
politica filo-occidentale e vicina agli Stati Uniti. Con la nuova leadership,
l’Egitto riacquista centralità nel mondo arabo, persa dopo Camp David. Il Paese
è riammesso nella Lega Araba nel 1989 e l’anno successivo svolge un importante
ruolo nella crisi del Golfo nella formazione della coalizione araba contro
Saddam Hussein.
Negli anni ’90, attentati e violenze verso i
turisti, come quello di Luxor del 1997, danneggiano economicamente il Paese.
Il 25 gennaio 2011 gli effetti della
“primavera araba” travolgono anche l’Egitto costringendo Mubarak alle
dimissioni. Il potere è stato ufficialmente assunto dal Consiglio Supremo delle
Forze Armate, guidato dal Ministro della Difesa Tantawi.
Struttura
istituzionale e dati di base
|
Superficie:
|
997.739 Kmq, di
cui soltanto il 5% è abitata e coltivata
|
|
Capitale:
|
Il Cairo
(18.440.076 abitanti)
|
|
Principali
città:
|
Alessandria (4.123.869 ab.) – Porto Said (570.603 ab.) –
Suez (512.135 ab.)
|
|
Nome
Ufficiale:
|
Repubblica Araba
d’Egitto
|
|
Forma
di Governo:
|
Repubblica
presidenziale
|
|
Capo
dello Stato:
|
Generale Hussein
Tantawi (da marzo 2011)
|
|
Capo
del Governo:
|
Primo Ministro
Kamal Ganzuri (dal 24 novembre 2011)
|
|
Vice
Primo Ministro
|
Hazem El Beblawy
Aly El Selmy
|
|
Ministro
degli Esteri:
|
Amb. Mohamed
Kamal Amr
|
|
Sistema
legislativo:
|
Bicamerale
|
|
Sistema
legale:
|
Basato sulla
Costituzione dell’11 settembre 1971
|
|
Suffragio:
|
Sistema
elettorale a suffragio diretto
|
|
Partecipazione
a Organizzazioni Internazionali:
|
ABEDA, ACC,
ACCT, AfDB, AFESD, AL, AMF, BSEC (observer), CAEU, CCC, EBRD, ECA, ESCWA,
FAO, G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD,
IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, MFO, MINURSO,
MONUC, NAM, OAPEC, OAS (observer), OAU, OIC, OSCE (partner), PCA, UN,
UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNMIBH, UNMIK, UNMOP, UNOMIG, UNRWA,
UNTAET, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, WTrO
|
Popolazione ed indicatori sociali
|
Popolazione:
|
84.500.000 (Economist Intelligence Unit,
dicembre 2011)
|
|
Tasso
di crescita:
|
2%
|
|
Aspettativa
di vita alla nascita:
|
popolazione complessiva: 71,5 anni
maschi: 69 anni
femmine: 74 anni
|
|
Gruppi
etnici:
|
Egiziani, Beduini e Berberi (99%); Greci, Nubi,
Armeni ed Europei (1%)
|
|
Religioni:
|
Musulmani (prev. Sunniti) 87%; Cristiani Copti e
altri 13%
|
|
Lingue:
|
Arabo. Inglese e francese sono ampiamente
conosciuti dai ceti più istruiti
|
|
Partiti
politici principali:
|
Freedom and Justice (Fratelli Musulmani), El Nour
(“La Luce”, partito salafita), El Wafd, Free Egyptians, Partito Socialista
Democratico, Tagammu, El Wasat, Partito del Fronte Democratico, Partito
Egitto Libertà, Al Asala, Building and Development, El Ghad.
|
La
situazione in Egitto resta volatile. Il tentativo dello SCAF (Supreme Council
of the Armed Forces) di stabilire principi base di riferimento per
l’elaborazione della nuova Costituzione ha condotto a novembre, prima delle
elezioni, a seri incidenti sfociati nella caduta del PM Sharaf e la nomina del
governo Ganzouri. Ad esso è stato affiancato un Consiglio Consultivo, con la partecipazione di esponenti politici come Amr
Moussa e di rappresentanti dei partiti politici (inclusi i Salafiti ma senza i
Fratelli Musulmani, che osteggiano l’iniziativa), incaricato di assistere il
governo e di sviluppare le modalità per la stesura della nuova Costituzione.
La conclusione del ciclo delle elezioni
parlamentari, avviato con le consultazioni per l’Assemblea del Popolo del
novembre 2011 e terminato con gli ultimi ballottaggi della Camera Alta il 22
febbraio scorso, consentirà al Parlamento di riunirsi in sessione congiunta per
nominare i 100 membri della Commissione incaricata di redigere la nuova
Costituzione, da sottoporre a referendum entro la fine dell’anno. Fino al 10
marzo è poi possibile presentare candidature alla presidenza della repubblica, con
l’obiettivo di poter svolgere le elezioni presidenziali a giugno, in modo da
poter avere un Presidente eletto entro la fine di quel mese e il passaggio dei
poteri all’Amministrazione civile entro il 1 luglio.
Seppur caratterizzate da bassa affluenza alle
urne e scarsa attenzione dei media, le elezioni della Camera Alta – organo
dotato di soli poteri consultivi – hanno confermato il successo elettorale di
novembre dei partiti islamisti, quando
“Giustizia e Libertà” (espressione politica dei Fratelli Musulmani) ed
il partito salafita “El Nour”, si sono assicurati insieme il controllo di circa
il 74% dei seggi della ben più importante Assemblea del Popolo. Questa ha inoltre eletto come suo Presidente una
delle figure principali dei FM, Saad El Katany, mentre sono stati scelti come
vice presidenti un rappresentante dei salafiti ed uno del partito Wafd.
Nonostante
il pragmatismo di cui i FM cercano di dare prova, si teme che essi possano
allearsi con i Salafiti sul tema della riforma costituzionale, profilando in
questo modo un confronto con i militari, non tanto sul riferimento alla Sharia
che nessuno contesta, quanto sulla predominanza o meno del Parlamento nel
sistema di governo. Dal punto di vista tattico i FM hanno tuttavia accettato il
principio che il governo provvisorio guiderà il Paese fino alle presidenziali.
Quanto
ai movimenti di Piazza Tahrir, pur avendo ispirato la rivolta, essi sono stati
incapaci di capitalizzarne il successo ed i risultati elettorali (che vedono
proprio i movimenti rivoluzionari e giovanili come i grandi perdenti) hanno
contribuito a rafforzare il sentimento di “rivoluzione incompiuta”, così come
il mantenimento della legge di emergenza e la diffusa prassi di processare
civili nei tribunali militari. Destano inoltre preoccupazioni le recenti
perquisizioni effettuate dalle forze di sicurezza egiziane negli uffici di
diverse ONG straniere ad inizio gennaio (comprese ONG statunitensi e tedesche).
Le
ricorrenti manifestazioni (spesso infiltrate da provocatori) e proteste
sindacali continuano ad ostacolare l’attività economica e hanno assunto toni
nazionalistici e xenofobi, con impatti negativi sugli investimenti stranieri.
Le pesanti difficoltà economiche in cui versa
il Paese, aggravate dalla drastica riduzione degli introiti legati al turismo e
dall’ondata di rivendicazioni sindacali, alimentano la disoccupazione e
l’insicurezza in un circolo vizioso preoccupante. Diventa in questo contesto
sempre più urgente facilitare il rilancio dell’economia, sia a livello
bilaterale che multilaterale, assicurando l’effettivo afflusso dei
finanziamenti previsti dal Partenariato di Deauville (35 miliardi di USD per i
5 Paesi partner). Ciò anche alla luce delle difficoltà delle autorità egiziane
a raggiungere un accordo con le IFI (scheda in seguito) e della limitatezza dei
fondi provenienti dai Paesi del Golfo.
Desta
infine particolare preoccupazione la situazione di sicurezza in Sinai, con un
forte deterioramento del controllo sul territorio da parte delle autorità. Ciò
comporta ripercussioni negative non solo sullo stesso Egitto, ma anche sulle
condizioni di sicurezza di Israele, dove cresce l’incertezza circa l’impegno di
un governo guidato da forze islamiste verso gli accordi di Camp David.
Principali partiti politici
Nonostante abbiano partecipato alle elezioni
legislative oltre 40 partiti politici, il panorama attuale si suddivide ormai,
principalmente, nelle seguenti formazioni.
1. Freedom and Justice. Il Partito dei
Fratelli Musulmani è stato il grande vincitore delle elezioni parlamentari,
diventando il primo partito politico del Paese (nonostante queste siano state
le prime elezioni in cui è stata ufficialmente consentita la partecipazione dei
Fratelli Musulmani, che partecipavano in precedenza come candidati
indipendenti). Freedom and Justice ha conquistato il 48,5% dei seggi
all’Assemblea del Popolo ed il 59% al Consiglio della Shura.
I leader del movimento, nato nel maggio del
2011, consapevoli dei timori che la natura islamista del partito suscita
all’estero, hanno cercato di accreditare un’immagine più moderata presso
l’opinione pubblica. Essi affermano di voler sostenere la laicità dello Stato
in Egitto, nel senso che le istituzioni non debbano essere governate né da
militari né da teocratici, fermo restando l’intoccabile principio (peraltro
accettato anche dal resto del mondo politico egiziano, inclusi i partiti laici)
che la Sharia sia fonte primaria del diritto. Il programma del partito prevede
il riconoscimento e la tutela della libertà di culto, e Freedom and Justice –
come il resto degli schieramenti politici – ha aderito alla carta dei diritti
fondamentali promossa dall’Università di Al Azhar, che riprende questo
imperativo.
Freedom and Justice vorrebbe abolire il
sistema presidenziale e stabilire un sistema di Governo che preveda
l’accentramento dei poteri di indirizzo politico nelle mani del Presidente del
Consiglio e in cui il Presidente della Repubblica avrebbe funzioni
prevalentemente simboliche.
2. Al Nour. Principale partito dei Salafiti,
che persegue l’obiettivo della creazione di uno Stato che si basi sui principi
della Sharia quale guida principale per la vita politica, economica e sociale
dell’Egitto. La formazione politica ha riscosso un notevole consenso elettorale
(26% all’Assemblea del Popolo, 25% al Consiglio della Shura), facendo emergere
timori per le possibili conseguenze di un eventuale sodalizio con il partito
dei Fratelli Musulmani.
3. Al WAFD. Il più antico fra i partici
politici egiziani, ha svolto un ruolo fondamentale nella vita politica
dell’Egitto per molti decenni, prima della rivoluzione del 1952. È un partito
laico ma conservatore, che conta anche diversi ex membri del PND, partito di
Mubarak sciolto a seguito della caduta del regime. Il partito si è assestato
come terzo partito egiziano a seguito delle elezioni, in cui ha raccolto quasi
l’8% dei consensi sia per l’Assemblea del Popolo che per il Consiglio della
Shura.
Sebbene non vi siano alleanze formali di Al
WAFD con il partito dei Fratelli Musulmani, sembra tuttavia essersi innescato
un processo di positiva collaborazione, che consente ad Al WAFD di svolgere
un’azione moderatrice sul primo schieramento egiziano.
4. Free Egyptians. Insieme al Social
Democratic Party ed al partito Tagammu, Free Egyptians è una delle anime
dell’Egyptian Block, che ha ottenuto circa il 7% all’Assemblea del Popolo e
poco più del 4% al Consiglio della Shura. Si tratta di un partito liberale,
laico, fondato da Naguib Sawiris nell’aprile scorso, cui fanno parte molte tra
le principali figure imprenditoriali egiziane e che rappresenta il partito più
orientato verso la difesa del capitalismo e del liberismo in Egitto.
5. Social Democratic Party. Il SDP è il
partito che ha riunito le principali figure – laici e progressisti –
protagoniste della Rivoluzione. Partito progressista che si propone
l’instaurazione di principi di libero mercato, pur riconoscendo la necessità di
maggiore giustizia sociale, esso sostiene la creazione di uno stato laico,
moderno e democratico che riconosca i diritti umani dell’individuo e le libertà
fondamentali, ispirandosi dichiaratamente al Partito Democratico statunitense
ed al Labour britannico.
6. Tagammu. Uno dei partiti storici, fondato
nel 1976, ha perseguito per anni l’instaurazione di una società socialista in
Egitto ma ha poi moderato la sua posizione avvicinandosi al PND (partito
dell’ex Presidente Mubarak). Sostegno per molto tempo da operai ed
intellettuali, ha perso molto del suo seguito.
Processo
Mubarak
È stata formalizzata il 5 gennaio la
richiesta della pena capitale nei confronti dell’ex Presidente Mubarak per
l’uccisione di 850 manifestanti in Piazza Tahrir fra gennaio e febbraio dello
scorso anno. All’ex Presidente viene in particolare mossa l’accusa di aver dato
l’ordine di sparare sui manifestanti, o – nella migliore delle ipotesi – di non
essere intervenuto in aiuto alla sua gente pur essendo pienamente al corrente
di tale ordine. La richiesta dell’accusa, che avviene in un momento di
crescenti critiche di gran parte della popolazione nei confronti dei militari
appare in gran parte legata all’obiettivo di stabilizzare la situazione
interna, indicando che non vi è alcuna continuità fra l’attuale regime e quello
di Mubarak. Le precarie condizioni di salute dell’ex Presidente rendono
improbabile un’effettiva esecuzione di un’eventuale sentenza, soprattutto
tenuto conto della possibilità di un appello alla decisione, la cui durata
difficilmente sarebbe compatibile con le aspettative di vita – considerate
ridotte – di Mubarak.
L’elemento religioso
I recenti, ripetuti attentati ai danni di
minoranze religiose rappresentano il segnale di una tendenza che mette in
pericolo i principi della libertà di religione e, talvolta, l’esistenza stessa
di comunità religiose in alcuni paesi, spesso costrette all'emigrazione
forzata. L'attentato avvenuto la notte di Capodanno 2010, contro la comunità
cristiana copta vicino ad una chiesa di Alessandria che ha causato 21 vittime,
ha rappresentato uno dei primi segnali di una preoccupante tendenza che mette
in pericolo non solo i principi della libertà di religione ma la stessa
esistenza delle comunità cristiane in alcuni paesi mediorientali. L’attentato
di Alessandria era stato preceduto da altri episodi di violenza e intolleranza
contro i copti nel corso del 2010 e purtroppo è seguito da nuovi episodi nel
2011. In particolare dopo i gravi incidenti dell’8 marzo 2011, in cui sono
morti 12 Copti, e l'incendio del 7 maggio delle due chiese di Imbaba, con gli
scontri tra Salafiti e Copti che hanno provocato 15 morti e centinaia feriti, i
Copti hanno dato vita ad un lungo sit-in di protesta per chiedere il
riconoscimento dei loro diritti e la garanzia della libertà di culto. Molti
Copti ritengono che oggi la situazione sia peggiorata rispetto al passato
regime di Mubarak. Sebbene la rivoluzione e i giorni di piazza Tharir abbiano
segnato un momento di unione tra gli egiziani, la situazione è sensibilmente
cambiata con il successivo rafforzamento di correnti radicali islamiche di tipo
salafita.
Tra i dati positivi, che denotano comunque un
interesse delle Autorità egiziane, va segnalata la istituzione di una
Commissione d’inchiesta sugli ultimi attacchi contro la Comunità copta avvenuti
ad ottobre dell’anno scorso. Inoltre, il Consiglio dei Ministri sta lavorando
al testo di una legge (cd. “Unified House Workship Law”) sulla costruzione di
luoghi di culto copti, considerata insufficiente ad attenuare la tensione
interreligiosa.
Va, infine, segnalata l’azione della nostra
Ambasciata al Cairo, che mantiene un contatto diretto e costante con lo stesso
Capo della Chiesa copta, Papa Shenouda III, il quale ha manifestato
apprezzamento per il ruolo dell’Italia in favore della comunità copta d’Egitto
e per i programmi di cooperazione nel settore della formazione e
dell’educazione. Allo stesso tempo, sono particolarmente cordiali i rapporti
con il Gran Mufti d’Egitto, Ali Gomaa. Quest’ultimo si è recato in visita alla
nostra Ambasciata, sottolineando l’importanza di evitare l’escalation della
tensione e dell’odio interreligioso. Anche a al Gran Mufti è stata confermata la
disponibilità italiana a rafforzare la cooperazione in settori quali la
formazione e la specializzazione dei giovani egiziani.
Proprio
a partire dall’attentato di Alessandria l'Italia ha ulteriormente intensificato
la sua azione affinché la libertà religiosa sia fatta oggetto di una rinnovata
attenzione sul piano internazionale e da parte di tutte le istanze che possono
svolgere un ruolo a questo fine, a cominciare dall'Unione Europea.
La difesa della libertà religiosa e di culto
e la tutela degli appartenenti a minoranze religiose costituiscono in effetti
da tempo una delle principali priorità della politica estera italiana nel campo
dei diritti umani. La discriminazione basata sulla religione
(che non è limitata ad una specifica confessione né ad una specifica regione
del mondo, ma che negli ultimi tempi sta colpendo soprattutto le minoranza
cristiane) rappresenta una grave violazione dei diritti umani.
In
ambito europeo, già alla fine del 2009, prendendo spunto dai numerosi attacchi
sopra menzionati, l’Italia aveva promosso l’adozione da parte del Consiglio
dell’Unione Europea di Conclusioni ad
hoc sulla libertà di religione e, successivamente (giugno 2010) di un “Piano d'Azione”, elaborato a cura
della ''Task Force sulla Libertà di
religione'', che si riunisce periodicamente a Bruxelles per dare impulso a
varie misure di tutela della libertà religiosa da parte dell’Unione Europea.
Inoltre è stato elaborato un documento di lavoro intitolato "Key messages
/ line to take on freedom of religion or belief", che riassume, ad uso
soprattutto delle Delegazioni UE nei paesi terzi, i punti essenziali
caratterizzanti la posizione europea in materia di libertà di religione.
La
forte azione esercitata dall'Italia in ambito Consiglio Affari Esteri, non
priva di ostacoli e difficoltà, ha stimolato l'Unione Europea a rinnovare la sua condanna per il crescente numero
di atti di intolleranza compiuti ai danni di cristiani ed altre comunità
religiose, e dei loro luoghi di culto. L'Unione Europea, con l’attivo concorso
del nostro Paese, ha quindi avviato un esercizio di monitoraggio finalizzato
all’elaborazione periodica di un rapporto sullo stato della libertà religiosa
nel mondo. Questo risultato contempera le posizioni di tutti i Ventisette su
una questione, per noi di massima priorità, che richiede equilibrio tra diverse
sensibilità, senza però attenuare la gravità né la natura dei fatti che hanno
colpito diverse minoranze religiose nel mondo, in modo particolare quelle
cristiane. Si tratta della base di partenza, e non certo di un punto d’arrivo,
di un processo - al cui sviluppo
l’Italia sta continuando a lavorare - che dovrà portare l’UE ad un ancor più
efficace coinvolgimento in materia di protezione dei diritti delle minoranze
religiose nel mondo.
In
ambito Nazioni Unite, abbiamo
contribuito in modo sostanziale alla risoluzione contro ogni forma di
intolleranza e discriminazione religiosa, promossa dall’UE ed adottata
dall’Assemblea Generale nel dicembre 2011. Grazie all’azione dell’Italia, la
risoluzione contiene elementi specifici che richiamano l’aumento degli episodi
di violenza contro gli appartenenti a minoranze religiose e il dovere ogni
Stato di esercitare la massima vigilanza per prevenirli e punirne i
responsabili. Analoga iniziativa è stata adottata dal Consiglio Diritti Umani,
a seguito del rapporto del Relatore Speciale ONU sulla libertà di religione.
I
risultati elettorali in Egitto, con la netta affermazione dei partiti islamisti
(abbinata allo scarso risultato ottenuto dall’Egyptian Block, coalizione di cui fa parte Naguib Sawiris, imprenditore di fede copta) costituiscono una fonte
di forte preoccupazione per la comunità copta, che teme possibili restrizioni
sull’esercizio delle proprie libertà religiose. A ciò si aggiunge il recente
rinvio a giudizio di Naguib Sawiris per “vilipendio della religione”, dopo la
pubblicazione di una vignetta satirica che sollevò indignazione non solo tra i
salafiti ma anche tra molti musulmani, che concretizza il timore di vedere
emergere in Egitto la pericolosa tendenza a fare dell’offesa alla religione il
metro di giudizio per vari aspetti della vita quotidiana, a cominciare dalla
libertà di espressione.
Islam
Politico
I
mutamenti in corso nella regione MENA ed il processo di democratizzazione da
essi innescati non potranno non tradursi in una maggiore influenza dei partiti
islamici, come testimoniato dalle consultazioni elettorali in Tunisia, Marocco
ed Egitto, sebbene gli islamisti non siano stati il motore principale delle
rivolte democratiche in nessuno di questi Paesi.
In
questo quadro, sono emersi in diversi Paesi una serie di partiti islamici
“moderati” (nel senso di aver aderito ai principi della non-violenza, dello
stato di diritto e della democrazia), che – anche in Egitto – avranno una
notevole influenza sui rispettivi processi costituzionali, in considerazione
dei successi elettorali che essi stanno conseguendo. Il panorama islamico resta
ad ogni modo molto frastagliato, con profonde divergenze sul versante
ideologico, storico ed organizzativo dei diversi movimenti, nonché differenze
relative alle fonti di finanziamento ed alla concezione stessa dell’attività
politica. A ciò si aggiunge un divario di carattere generazionale, illustrato
dell’approccio più modernizzatore e pragmatico propugnato dai movimenti islamici
giovanili.
L’Islam
svolge un ruolo di primo piano nelle società di questi Paesi, in cui gran parte
della popolazione ritiene fortemente interconnesse le questioni religiose,
sociali, politiche e private. I partiti di orientamento religioso sono pertanto
percepiti come un fenomeno naturale, piuttosto che come segnali di tendenze
estremiste nella società. I partiti e movimenti affiliati ai Fratelli Musulmani
o a visioni moderate dell’Islam godono infatti di forte rispetto da parte della
popolazione, legato in particolare alle attività da essi svolte da tempo sul
versante sociale e caritatevole. Hanno inoltre acquisito grande credibilità
nella loro veste di oppositori ai regimi passati. Altri movimenti, come quelli
dei Salafiti e Wahabiti, ricevono sostegno nella regione e possono contare su
finanziamenti esterni.
I
movimenti moderati, come i FM, hanno riconosciuto che le rivoluzioni arabe sono
legate alla richiesta di diritti democratici, di libertà e di dignità.
L’islamizzazione della società non viene pertanto presentata come una questione
centrale, mentre viene generalmente accettato, anche in Egitto, che l’Islam
costituirà il punto di riferimento essenziale per la costruzione delle società
post-rivoluzionarie.
In
generale, questi movimenti sottolineano la loro adesione ai principi
democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani. Resta da vedere come
tali posizioni di principio si tradurranno in azioni politiche nel contesto
democratico. Esistono peraltro forti divergenze di interpretazione (rispetto
all’occidente) circa il ruolo della religione, la tutela delle minoranze ed i
diritti delle donne.
La
retorica anti-israeliana è diffusa anche fra i partiti islamici moderati, che
sono propensi a sfruttare l’opinione pubblica a fini elettorali. Molti di essi
hanno tuttavia adottato una posizione più defilata al riguardo, sottolineando
pubblicamente l’importanza della stabilità regionale e del rispetto dei
trattati internazionali.
In
un simile contesto, un ruolo di grande importanza viene svolto dall’Università
di Al Azhar, che promuove una visione moderata dell’Islam all’insegna del
dialogo e della libertà di credo e di espressione. Fra le varie iniziative
avviate in tal senso da Al Azhar (e dal suo Grande Imam, Ahmed el Tayeb), si
segnala in particolare il lavoro svolto sulla stesura di principi
costituzionali generalmente condivisi, che sono stati sottoscritti – in forma
non vincolante – da tutti i partiti politici egiziani.
Prima della crisi
innescata con la “primavera araba”, a partire del gennaio del 2011, l’economia
egiziana aveva registrato un tasso di crescita del 5,1%. A tale risultato
avevano contribuito il brillante andamento del settore turistico, i solidi
flussi di rimesse dall'estero, il miglioramento del comparto delle costruzioni
e la ripresa dell'attività del canale di Suez.
Il
nuovo assetto politico ha interrotto tali dinamiche e l'attenzione è ora
rivolta alla ripresa economica. La crescita del PIL continua ad essere
praticamente ferma a zero, anche in ragione di flussi di investimento
sostanzialmente congelati ed entrate del settore turistico ancora nettamente al
di sotto dei livelli pre-rivoluzionari. L’inarrestabile emorragia delle riserve
valutarie, nel solo mese di gennaio, ha raggiunto il limite dei 16,3 miliardi
di dollari, (oltre 1,7 miliardi di dollari in meno rispetto al mese
precedente), mostrando tuttavia un rallentamento del ritmo di contrazione
rispetto a quello registrato negli ultimi mesi del 2011, mediamente superiore
ai due miliardi di dollari.
Continua,
dunque, una dinamica di marcato deflusso e mancato afflusso di capitali (molti
operatori esteri hanno deciso di non rinnovare i titoli di Stato egiziani in
scadenza che detenevano, preferendo rimpatriare i propri capitali) una tendenza
cui le autorità egiziane stanno cercando di porre parzialmente rimedio anche
rendendo più rigorosi i controlli amministrativi sui pagamenti di fatture verso
l'estero (apparentemente utilizzate per trasferire fondi al di fuori del paese
in maniera surrettizia), ed imponendo agli importatori adempimenti sempre più
stringenti, che si traducono di fatto nell'imposizione di barriere non
tariffarie.
Il temporaneo miglioramento del clima di fiducia, testimoniato anche dal
rimbalzo delle quotazioni di Borsa (+28 per cento a gennaio), rischia di essere
compromesso dai sanguinosi incidenti a Port Said e dagli ulteriori sviluppi
negativi del contesto di sicurezza, con implicazioni depressive per il quadro
macro-economico.
Sul
versante delle finanze pubbliche, la situazione rimane fragile: in base ai dati
resi noti dal Ministero delle Finanze egiziano, nel secondo semestre 2011, il
disavanzo è aumentato di oltre il 20% in termini nominali rispetto al
corrispondente periodo dell'anno precedente, mentre in rapporto al PIL, la sua
incidenza è di oltre il 9,4% in termini annuali. In un contesto dove le entrate
fiscali fanno sostanzialmente segnare il passo, il bilancio pubblico appare
sempre più dipendente dalle entrate non tributarie, quale l'apporto di aiuti dall'estero
(un miliardo di dollari è giunto, equamente diviso, da Qatar e Arabia Saudita).
Per quanto riguarda le spese, assumono invece speciale rilievo gli incrementi
dei costi per retribuzioni, interessi e sussidi, in particolare quelli
energetici che rappresentano quasi l'80% delle uscite complessive. Sul fronte
dei prezzi non si registrano al momento specifiche tensioni, la domanda
interna rimane debole con la conseguente
stagnazione dei consumi, soprattutto di beni durevoli.
Gli
osservatori ritengono comunque che, nel medio termine, il risanamento della
bilancia dei pagamenti possa avvenire soltanto attraverso il ritorno massiccio
dei turisti e degli investitori esteri, ma tali condizioni potranno verificarsi
solo con il ripristino delle condizioni di sicurezza nel paese. A tale
proposito, va tenuto presente che le entrate valutarie complessive da turismo,
rimesse e canale di Suez assommano a quasi il 13% del PIL. La loro importanza
risiede soprattutto nel sostegno che forniscono alla domanda per consumi e
all'occupazione (formale e non), in particolare al settore turistico che,
incluso l'indotto, si stima impieghi quasi il 12% della forza lavoro egiziana.
Il
grave deterioramento della bilancia dei pagamenti e le crescenti pressioni
sulle finanze pubbliche hanno indotto al declassamento del paese (il quarto,
dall'inizio dell'anno), portandolo a B2, nonché delle tre grandi banche
pubbliche (National Bank of Egypt, Banque Misr e Banque du Caire) e dei due
principali istituti di credito privati (Commercial International Bank e Bank of
Alexandria).
Sul
versante finanziario, la Banca Centrale continua la propria opera di sostegno
al sistema bancario attraverso l'apporto di liquidità agli intermediari e il
mantenimento dell'orientamento espansivo della politica monetaria. Tali manovre
sono mirate principalmente a favorire l'assorbimento delle emissioni di titoli
pubblici.
Per
gli investimenti diretti esteri si stima invece una netta flessione, su base
annuale, che dovrebbe aggirarsi intorno al 50%, mentre riguardo al Canale di
Suez non sembrano profilarsi problemi: a conclusione dell’anno fiscale
2010/2011, gli introiti erano anzi aumentati dell’11% rispetto all’anno fiscale
2009/2010. Anche gli operatori più ottimisti ritengono che, nel 2011, le
entrate del settore turistico si siano ridotte della metà rispetto allo scorso
anno, e sembra che la contrazione degli introiti del dicembre 2011 abbia
addirittura sfiorato il 90% rispetto al dicembre 2010.
L'incognita
politica continua dunque a condizionare in maniera determinante i futuri
sviluppi del quadro economico: alla sostanziale assenza di iniziative di
rilievo dell'attuale governo di transizione e ai crescenti timori riguardo alla
possibile inversione di rotta rispetto alle politiche di liberalizzazione economica
e privatizzazione perseguite dal precedente esecutivo (come testimoniato dalla
rinazionalizzazione di alcune imprese operanti nel paese), si aggiunge una
forte e persistente diffidenza degli operatori economici. Su tali tematiche si
è già concentrata l'attenzione degli Ambasciatori G8 ed UE, che anche su forte
impulso italiano ha condotto il 26 dicembre 2011 ad una demarche congiunta a
tutela degli investimenti stranieri nei confronti del Primo Ministro
Ganzouri.
Dalla
fine di gennaio 2011, l’attività economica del Paese è inevitabilmente
rallentata. Conseguentemente, anche per le imprese estere presenti nel Paese
(tra cui quelle italiane) si segnala un calo delle attività industriali e
finanziarie, soprattutto a causa degli scioperi dei lavoratori che rivendicano
migliori condizioni economiche e sociali, assumendo talvolta toni xenofobi e
nazionalistici.
Le autorità egiziane hanno deciso di
mantenere inalterati i tassi di interesse di riferimento (rispettivamente, al
9,25 per cento sui depositi e al 10,25 per cento sui finanziamenti). Rimane
tuttavia da vedere se le pressioni verso il basso del tasso di cambio non
provocheranno un nuovo rialzo dei tassi (dopo quello di fine novembre 2011) per
cercare di sostenere il valore della lira egiziana e contrastare il processo di
''dollarizzazione'' dei depositi bancari, fenomeno che prosegue a cadenza
graduale ma ininterrotta.
A breve termine, la sfida principale cui le
autorità egiziane devono far fronte per stabilizzare la situazione economica è
la conclusione dell'accordo sul finanziamento da parte del Fondo Monetario. In
tal modo, sarebbero verrebbero resi disponibili 3,2 miliardi di dollari del
prestito, ma anche consistenti risorse aggiuntive su base multilaterale
(sarebbero allo stadio avanzato trattative per la concessione di prestiti per
un miliardo di dollari dalla Banca Mondiale e 0,5 miliardi dalla Banca Africana
di Sviluppo e bilaterale. Il Primo Ministro egiziano ha, del resto, chiaramente
affermato che i donatori internazionali dei paesi occidentali e arabi ritengono
la conclusione delle trattative con il Fondo propedeutica all'erogazione dei
loro finanziamenti.
In tale contesto, il Ministro delle Finanze
ha quantificato in 11 miliardi di dollari il fabbisogno finanziario per i piani
di sviluppo economici dell'Egitto dei prossimi anni, ed ha prospettato
l'elaborazione di un programma di riforme da sottoporre all'esame del
Parlamento prima di essere presentato agli esperti del Fondo. Tale piano
introdurrebbe misure volte al contenimento del disavanzo pubblico, da
realizzarsi attraverso la riduzione delle spese (prevalentemente tagli ai
sussidi energetici, mentre quelli alimentari non sarebbero toccati) e
l'incremento delle entrate (tramite introduzione dell'imposta sul valore aggiunto
in sostituzione dell'attuale tassa sulle vendite e la modifica della tassazione
delle proprietà immobiliari - va rilevato che entrambe le misure sono in
cantiere da anni). Inoltre, per reperire risorse aggiuntive in valuta, le
autorità hanno deciso di far ricorso alla consistente diaspora egiziana,
stimata in oltre 5 milioni di persone. Dovrebbe infatti essere offerta ai
residenti all'estero la facoltà di sottoscrivere certificati di deposito
denominati in dollari. Sarebbero inoltre allo studio un programma di emissioni
di obbligazioni islamiche (sukuk) operazione che incontrerebbe il favore dei
partiti islamisti che controllano il nuovo Parlamento e la vendita di terreni
di proprietà pubblica, sempre da regolare in valuta straniera. Il Ministro ha aggiunto
che il 25% delle risorse aggiuntive liberate sarà utilizzato per lo sviluppo
delle aree più depresse del Paese (specie in Alto Egitto) ma anche per il
rafforzamento delle iniziative volte a realizzare costruzioni di abitazioni a
basso costo, progetti alimentari scolastici, estensione delle pensioni sociali.
In attesa che
il governo che uscirà dalle prossime elezioni definisca gli orientamenti di
politica economica del Paese, risultano tuttora in vigore le riforme approvate
dalla precedente amministrazione. A sostegno degli investimenti stranieri è stata introdotta la normativa contro il
riciclaggio dei capitali e il finanziamento al terrorismo, che hanno consentito
il depennamento del Paese dalla “lista nera” dell’OCSE. Nuovi provvedimenti
sugli investimenti prevedono l’apertura, in ogni Governatorato, di “Sportelli
unici” per gli investitori, la semplificazione delle procedure per l’apertura
di filiali e uffici di rappresentanza di imprese straniere e per l’avvio di
progetti industriali, la riforma delle dogane che implica semplificazioni
amministrative e l’introduzione di procedure informatizzate.
Da segnalare,
inoltre, la creazione della “General Authority for Industrial Development”
(GAID) che ha come obiettivo principale quello di realizzare le infrastrutture
necessarie nelle cosiddette “zone
industriali”, allo scopo di attrarre nuovi investimenti. La GAID
collaborerà con la GAFI (General Authority for Investment and Free Zones), che
è invece responsabile delle zone franche e delle QIZ (Qualifying Industrial
Zones), nonché della gestione delle procedure burocratiche per l’avvio di
imprese e joint venture. Si noti che, in questi anni, la buona gestione della
GAFI ha contribuito all’insediamento di 16.000 nuove società straniere nel
Paese.
Mancano,
tuttavia, significativi progressi nella tutela della concorrenza e nella
normativa contro le pratiche monopolistiche. Il mercato interno è infatti
dominato dalla presenza di monopoli in alcuni settori chiave, tra cui quelli
del ferro, del cemento, delle telecomunicazioni e dei generi alimentari di
prima necessità.
Si registra in
Egitto, dopo la rivoluzione una crescente contestazione delle privatizzazioni
di imprese pubbliche, un processo cui Mubarak ed i Ministri di profilo
tecnocratico del Governo Nazif avevano dato un forte impulso negli ultimi anni.
Dal 2004 al 2008, il Ministero degli Investimenti egiziano aveva provveduto
alla vendita di 53 società a partecipazione statale. In questo piano di
privatizzazione, sono rientrate la vendita del 36% delle azioni di Bisco Misr (17 milioni di USD circa),
la vendita della quota di azioni della banca NSGB controllate dalla National Bank of Egypt (93 milioni di USD
circa) e la privatizzazione parziale dell’operatore telefonico nazionale Telecom Egypt. A seguito della vennndita
della Bank of Alexandria, si è ridotto a tre il numero delle banche di
proprietà pubblica: la National Bank of Egypt, la Banca Misr e la Banque du
Caire.
La
contestazione del processo di privatizzazione ha conosciuto nei mesi scorsi una
preoccupante evoluzione, con accuse di scarsa trasparenza, di vendita di asset
statali a prezzi stracciati, nonché di corruzione e favoritismi. Un tribunale
del Cairo ha ordinato il ritorno in mani pubbliche di tre imprese, operanti nei
settori tessile, energetico e della produzione di elettrodomestici, cedute a
suo tempo a gruppi esteri. Oltre a costituire un segnale negativo di chiusura
verso gli investimenti esteri, la decisione, se confermata nelle successive
istanze, potrebbe stabilire un pericoloso precedente. La sentenza preoccupa
anche perché continua a spostare indietro l'orizzonte temporale delle
operazioni oggetto di contestazione (la cessione dell’impresa di
elettrodomestici risale al 1994). Un provvedimento di nazionalizzazione ha
coinvolto anche un'impresa di proprietà ellenica operante nel settore della
produzione di cemento.
Si tratta di uno sviluppo preoccupante e che,
ove confermato, rischierebbe di coinvolgere anche imprese di primissimo piano
del Sistema Italia come Italcementi,
Pirelli e Banca Intesa-San Paolo
L’Egitto punta
molto sull’espansione del settore degli idrocarburi e ha promosso
l’accelerazione dello sviluppo dell’estrazione del gas naturale, la cui
produzione si attesta, attualmente, intorno ai 60 miliardi di metri cubi
all’anno. L’Egitto occupa il secondo
posto (dopo l’Algeria) tra i Paesi africani produttori di gas naturale, e la
sesta posizione tra i Paesi maggiori esportatori di gas naturale a livello
mondiale. La maggior parte delle scoperte di giacimenti di gas naturale
sono avvenute lungo la costa mediterranea in prossimità del delta del Nilo e
nel Deserto Occidentale, a sud della città costiera di Marsa Matrouh. Le
riserve sono stimate tra i 2 e i 3 mila miliardi di metri cubi.
Procede,
inoltre, la seconda fase dei lavori per gli accordi finalizzati all’ampliamento
dell’ “Arab Gas Pipeline” che collega l’Egitto (da Borsaed) alla Giordania e
alla Siria. Il gasdotto si estende per 390 km da Aqaba (Giordania) fino a Homs
(Siria) e da qui fino al Libano. Dalla Siria si svilupperà, in un secondo
tempo, fino al confine con la Turchia, per estendersi, poi, verso l’Europa
centrale.
Per
il quinquennio 2007-2012, il piano di investimenti sulla rete energetica
nazionale prevede la realizzazione di diverse centrali elettriche con capacità complessiva di 7.000 megawatt.
Alle società private viene consentita anche la distribuzione dell’elettricità
prodotta dalle centrali pubbliche.
A seguito della
crisi politica del gennaio 2011, si è riproposta anche la questione relativa
alla gestione delle risorse energetiche del Paese, che il Governo intenderebbe
affrontare avviando una revisione degli accordi di fornitura di gas con i Paesi
partner, al fine di riequilibrare la necessità del mercato domestico (ancora
fortemente sussidiato) e la possibilità di generare introiti attraverso
l’esportazione di tale risorsa energetica, principale voce dell’export
egiziano. Rimane ancora insoluta la problematica relativa alla struttura dei
sussidi sui prodotti petroliferi, per la quale sarà necessario riconsiderare
l’adozione di una riforma mirata (sebbene impopolare), già annunciata dal
precedente regime ma mai attuata anche nelle passate fasi economiche espansive.
Sono
allo studio diversi progetti per la costruzione di centrali atomiche e solari
per la produzione di energia pulita (eolico e solare). In particolare, per quanto riguarda il
nucleare per uso civile, è prevista la costruzione di quattro centrali e la
prima dovrebbe sorgere sulla costa mediterranea.
Il Ministero dei Trasporti egiziano ha predisposto un piano di
potenziamento del sistema di trasporti. Tra le infrastrutture previste è
compresa la costruzione di tratti autostradali e ponti in diversi governatorati
del paese, per un costo totale di circa 35 milioni di Euro.
Per i trasporti ferroviari è stato varato un piano di ristrutturazione e
miglioramento dell’intera rete per il quale è previsto uno stanziamento di 860
milioni di dollari.
I porti di Alessandria,
Porto Said e Damietta sono stati inseriti in un progetto dell’Unione Europea di
modernizzazione delle linee di trasporto marittimo tra i Paesi del
Mediterraneo. In particolare, è in corso l’ampliamento del porto di Alessandria
che dovrebbe diventare un punto di riferimento per tutto il bacino del
Mediterraneo.
Tramite il nuovo piano economico quinquennale per il periodo 2007-2012
che prevede lo stanziamento di circa 170 miliardi di Euro, il
Governo intende dare piena attuazione ai progetti di investimento
infrastrutturali, soprattutto nell’area dell’Alto Egitto, che riguardano
principalmente il settore idrico, l’agricoltura e la costruzione di autostrade
e il turismo (zona di Luxor).
Anche la Banca
Mondiale ha contribuito con circa 1,4 miliardi di dollari al finanziamento di
progetti nel campo dell’irrigazione, dell’ambiente, dell’elettricità,
dell’istruzione, delle infrastrutture e per l’ammodernamento degli aeroporti
del Cairo e di Sharm El Sheikh, e con circa 17,3 milioni di dollari in aiuti e
assistenza tecnica.
A seguito
dell’entrata in vigore dell’Arab
Free Trade Agreement (AFTA) nel
2005, si sono intensificate le relazioni tra l’Egitto e i Paesi del Golfo, con
un aumento dell’80% del volume dell’interscambio commerciale.
Nel
gennaio 2007, a latere del Forum Mondiale dell’Economia, l’Egitto ha firmato un
accordo di libero scambio con i Paesi membri dell’European Free Trade Association (EFTA) riguardante principalmente
le materie prime, gli autoveicoli e diverse tipologie di beni. L’accordo
prevede la liberalizzazione commerciale di numerosi prodotti agricoli e
industriali tramite la riduzione dei dazi doganali, e una maggiore tutela dei
diritti d’autore.
Nel
febbraio 2007, è stato promulgato il decreto presidenziale con il quale sono
state ridotte del 25% le tariffe doganali su oltre 1.000 prodotti
d’importazione, tra i quali sono compresi alcuni beni semilavorati, beni
capitali, prodotti alimentari e medicine.
I
dazi sulle importazioni di autoveicoli rimangono ancora molto elevati (circa il
40%) del valore), fatta eccezione per i veicoli ecologici per i quali è
prevista una riduzione delle tariffe del 25%.
Ad agosto 2010, è stato firmato l’Accordo di Libero Scambio tra
Egitto e Mercosur che prevede la progressiva eliminazione dei dazi doganali per
diversi prodotti agricoli ed industriali.
Provengono da oltre 35 Paesi, nonostante il
flusso si sia notevolmente ridotto alla luce della transizione in corso. Le
principali fonti sono: l’Unione Europea, gli Stati Uniti e gli investitori
arabi (in particolare i Paesi del Golfo). In base a dati Eurostat, i principali
Paesi investitori dell’U.E. in Egitto sono: il Regno Unito, la Spagna, la
Germania, la Francia e l’Italia, con circa il 70% del totale dei flussi degli
IDE provenienti dall’Unione Europea. Alla fine del 2008, gli investimenti
europei nel Paese hanno raggiunto i 20,2 miliardi di dollari, con un aumento di
circa il 40% rispetto all’anno precedente, rappresentando quasi il 50% del
totale degli IDE dell’Unione Europea nelle aree del Maghreb e del Mashrek.
A causa della crisi internazionale, l’anno
fiscale 2008/2009 ha invece evidenziato una riduzione rispetto al 2007/2008,
registrando un totale di 8,1 miliardi di dollari. Su un totale di 12
miliardi di dollari di investimenti esteri diretti indirizzati verso l’Egitto,
nel corso del 2009, una quota tra il 30-40% è originata dai paesi del “blocco
comunitario”.
|
PIL
Nominale (mld US$)
|
214,5
|
230,9
|
254,5
|
|
PIL Nominale (mld E£)
|
1.207
|
1.372
|
1.540
|
|
Variazione reale PIL
|
5,1%
|
1,8%
|
2,3%
|
|
Composizione PIL
|
Agricoltura13,5%
Industria 37,9%
Servizi
48,6%
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Popolazione (mln)
|
84,5
|
86,1
|
87,7
|
|
PIL
procapite (US$)
|
5.910*
|
6.009
|
6.182
|
|
Disoccupazione (media)
|
9,0%*
|
12,2%
|
11,5%
|
|
Debito nazionale (%PIL)
|
81,4%*
|
84,1%
|
85,8%
|
|
Inflazione (media)
|
11,1%
|
9,9%
|
8,5%
|
|
Tasso di cambio medio (E£:US$)
|
5,63
|
5,94
|
6,05
|
|
Tasso di cambio medio (E£:Euro)
|
7,47
|
8,29
|
7,76
|
|
Bilancia partite correnti (mln US$)
|
-4.435
|
-4.427
|
-7.030
|
|
Bilancia commerciale (mln US$)
|
-26.513
|
-24.592
|
-26.812
|
|
Esportazioni (mln US$)
|
25.024
|
28.705
|
31.770
|
|
Importazioni (mln US$)
|
-51.537
|
-53.297
|
-58.582
|
|
Principali esportazioni
|
Petrolio greggio, gas
naturale
Cotone
Prodotti tessili
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Principali importazioni
|
Macchinari e
apparecchiature
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Principali Paesi fornitori
1. USA
2. Cina
3.
Italia
4. Germania
|
12,2%
10,8%
6,7%
6,7%
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Principali Paesi clienti
1. USA
2.
Italia
3. Spagna
4. India
|
8,1%
7,8%
5,8%
5,6%
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Debito estero (mln US$)
|
35.509*
|
36.209
|
40.875
|
|
Riserve internazionali (mln US$)
|
35.792
|
21.970
|
26.459
|
|
Fonte:
Economist Intelligence Unit,, dicembre 2011; Central Intelligence Agency
Factbook, dicembre 2011 - * Stime - **Previsioni – n.d.: non disponibile
|
|
|
|
|
|
|
Nonostante i timori nati dalla rivoluzione
che i movimenti di piazza possano influire in profondità sui tradizionali orientamenti
dell’Egitto sul versante della politica estera, tale scostamento non è avvenuto
per il momento, sotto la guida della giunta militare. Le iniziali aperture
verso l’Iran ed Hamas (con la fine della chiusura del valico di Rafah) sembrano
essere rientrate, e l’Egitto è riuscito ad assumere un ruolo proattivo nel
processo di riconciliazione palestinese, come testimoniato anche dall’ incontro
al Cairo fra Abbas e Meshaal il 22 dicembre 2011. La collaborazione con
l’occidente e gli USA (oltre che con l’Arabia Saudita) resta sui binari
consolidati, così come la collaborazione (a livello di Difesa ed Esteri) con
Israele. L’attenzione prioritaria rimane tuttavia rivolta, per il momento, ai
dossier regionali meno controversi sotto il profilo interno, come quelli
africani (Sudan, Nilo).
La situazione interna del Paese, ancora
fluida, non ha sinora consentito di giungere al rilancio delle relazioni
auspicato da parte UE. Nei rapporti con la nuova dirigenza le Istituzioni
comunitarie sono infatti tuttora impegnate a calibrare attentamente i confini
fra dialogo e ingerenza, tenendo conto della tradizionale insofferenza egiziana
rispetto ad atteggiamenti europei considerati troppo prescrittivi. In questo
contesto non è stata ancora presa in considerazione la ripresa dei colloqui per
un upgrading dei rapporti, avviati nell’aprile 2010 con il forte sostegno
italiano e sospesi a seguito della crisi del regime di Moubarak. Il CAE
Commercio del 14 dicembre scorso ha nondimeno conferito alla Commissione il
mandato a negoziare anche con l’Egitto (oltre che con Tunisia, Giordania e
Marocco) un’intesa di libero scambio ampia e approfondita, finalizzata a
promuovere un salto di qualità nei rapporti economici attraverso una
progressiva integrazione dell’economia egiziana nel mercato unico europeo. Il
lancio formale dei negoziati interverrà a conclusione dell’esercizio di
perimetraggio che verrà avviato dalla Commissione per valutare lo stato di
preparazione del Paese e chiarirne priorità ed ambizioni negoziali. Proposto
anche da parte UE l’avvio di un dialogo strutturato su mobilità, migrazione e
sicurezza, in vista dell’istituzione di un Partenariato di mobilità, che non
sembra tuttavia al momento rientrare fra le priorità egiziane.
Quanto all’assistenza finanziaria, a seguito
della primavera araba non sono state accordate al Paese risorse aggiuntive
rispetto allo stanziamento di circa 450 milioni di euro previsto per il periodo
2011-2013 nel quadro dello strumento per il Vicinato ENPI. La Commissione ha
tuttavia deciso di tener conto del mutato quadro, riallocando una parte delle
risorse stanziate per il 2011 (complessivamente pari a 122 milioni) in favore
di programmi di sostegno allo sviluppo di PMI nel settore agricolo (per un
valore di 22 milioni). Quanto ai fondi rimanenti, 60 milioni sono destinati al
sostegno alle politiche nel settore energetico, 20 al potenziamento del mercato
interno e del commercio e 20 alla riqualificazione delle aree urbane del Cairo.
Francia
La Francia ha rilanciato i rapporti con
l’Egitto, anche per far fronte alle polemiche originate dall’approccio alla
crisi tunisina ed egiziana da parte di Alliot-Marie, confermando la sua
presenza nella regione rendendo pubblica l’intenzione di destinare fra i 150 e
250 milioni di euro a favore delle PMI nel Paese. Sempre in ambito finanziario,
la Francia ha appoggiato l’avvio del Partenariato di Deauville, nonché le
proposte di ampliamento geografico delle operazioni della BERS, nonché di
revisione del plafond della BEI e di “riciclo” dei prestiti.
Gran
Bretagna
La Gran Bretagna ritiene essenziale un netto
impegno europeo per il sostegno alla fase di transizione in Egitto. Oltre
all’avvio del Partenariato di Deauville, ha condiviso la azioni intraprese
finora a livello europeo, rilevando tuttavia che l’eccezionale impegno nella
contingenza non deve far perdere di vista gli obiettivi di riforma di lungo
termine della Politica di vicinato; questa, nella prospettiva britannica, deve
essere in grado sia di offrire prospettive ed incentivi ai Paesi coinvolti che
di porre una più marcata condizionalità all’impegno europeo nei loro confronti
(come fatto in passato con i Paesi dell’est europeo).
Sul versante politico, il ruolo esercitato
dai militari rimane per Londra essenziale per garantire la cornice di sicurezza
durante il lungo percorso elettorale e per continuare l’azione di contrasto al
settarismo ed agli elementi estremisti. I britannici ritengono tuttavia che i
vertici militari dovrebbero decretare immediatamente la fine dello stato di
emergenza ed interrompere i procedimenti penali nei confronti di civili da
parte dei tribunali militari, per contribuire al rasserenamento della
situazione.
Il
mantenimento dell’alleanza strategica
con l’Egitto, la tenuta del quadro di sicurezza che ruota intorno agli
accordi di pace con Israele e la prevenzione di un riorientamento della
politica estera del Cairo in senso anti-occidentale costituiscono dei punti
cardine per gli USA.
Gli
USA forniscono all’Egitto assistenza
militare per circa 1,3 miliardi di USD. Inoltre, Washington ha deciso
l’allocazione di 250 milioni di USD (Economic
Support Fund) a sostegno della crescita economica e democratica, dello
sviluppo del sistema sanitario e scolastico, e di progetti di cooperazione
scientifica e tecnologica. Per aiutare la popolazione egiziana nel periodo di
transizione, gli USA hanno reso disponibili 165 milioni di dollari (Transition Assistance) di cui 100 sono
per le esigenze di ripresa economica nel breve periodo e 65 per sostenere la
transizione democratica. Il Congresso e il governo americano stanno lavorando
alla creazione di un Enterprise Fund for
Egypt per il sostegno alle piccole imprese (il finanziamento iniziale
dovrebbe essere di 60 milioni di USD). Nel dicembre 2011 il Congresso ha
approvato il piano di conversione del debito egiziano di 1 miliardo di dollari
che dovrebbe essere realizzato in tre tranches nel corso di tre anni. Infine,
l’OPIC (Overseas Private Investment Corporation) erogherà prestiti garantiti all’Egitto
fino a un miliardo di USD. Si segnala che gli aiuti statunitensi restano
condizionati al rispetto del Trattato di Pace con Israele, all’impegno dei
militari a trasferire il potere ad un’autorità civile ed all’attuazione di
politiche che promuovino i diritti umani e lo stato di diritto.
Gli
USA hanno sostenuto iniziative volte ad assicurare stabilità finanziaria, a
partire dal Partenariato di Deauville, auspicando inoltre una positiva
conclusione degli accordi con le IFI (in particolare con il FMI, con cui sono
in corso negoziati per un prestito di circa 3,2 miliardi di USD), vincolati
all'adozione di specifiche misure economiche e alla supervisione tecnica. In
aggiunta all’assistenza bilaterale, ONG americane hanno offerto 2,8 milioni a
sostegno dello sviluppo democratico e della prosperità economica.
Washington ha commentato positivamente
l’avvio del processo elettorale, anche alla luce delle testimonianze di ONG
americane, dispiegate sul terreno. Gli osservatori americani hanno riportato
alti livelli di partecipazione, senza finora rilevare incidenti o gravi
irregolarità nello svolgimento del voto.
Gli Stati Uniti hanno caldeggiato l’adozione
di principi costituzionali volti a garantire il rispetto delle regole
fondamentali di un sistema democratico, pur astenendosi dal formulare
valutazioni sulle proposte della giunta militare, e preso atto degli sforzi
compiuti dai militari in risposta ad alcune richieste dei manifestanti, in
particolare le assicurazioni sul trasferimento entro il 30 giugno 2012 dei
poteri esecutivi a un Presidente eletto. Permangono le esortazioni americane
per la revoca dello stato di emergenza (parzialmente abrogato il 25 gennaio) e
la cessazione dei processi militari ai civili.
Riguardo ai FM, l’Amministrazione non ha
posto finora preclusioni di principio verso alcun raggruppamento che rispetti i
diritti fondamentali e i principi democratici (incluse la parità delle donne e
delle minoranze) e riconosca gli obblighi internazionali derivanti dagli
Accordi di Camp David. Alla luce dei risultati elettorali, gli Stati Uniti
hanno impresso un deciso “upgrading” ai loro contatti con i vertici dei FM, che
il numero due del dipartimento di Stato statunitense William Burns ha
incontrato al Cairo l’11 gennaio (mentre non vi è stato nessun incontro con la
leadership politica dei salafiti).
Rapporti
con la Turchia
La visita del PM Erdogan al Cairo, lo scorso
settembre, era ispirata dall’obiettivo di approfittare della nuova realtà
creatasi nella regione in seguito alla Primavera araba, al fine di instaurare
un nuovo partenariato strategico con il mondo arabo e il nuovo Egitto. Va
tuttavia registrata la ritrosia della leadership egiziana ad imbarcarsi in
crociate anti-israeliane, così come una non dichiarata resistenza, comune anche
ad altri Paesi arabi, nei confronti del tentativo di stewardship turca nella
regione. La visita di Erdogan ha cercato di promuovere il “modello politico
turco”, ma soprattutto di aumentare la penetrazione economica e commerciale in
Egitto, avviando intese per il rafforzamento della cooperazione nel settore dei
trasporti, dell’energia, delle banche e del turismo.
Intenta ad esportare il “modello turco”
nell’area, con l’instaurazione di un sistema secolare in Egitto, Ankara sta
tuttavia suscitando forti contestazioni da parte dei Fratelli Musulmani, ciò
che potrebbe avere conseguenze negative sui rapporti bilaterali nel caso della
formazione di un Governo da essi controllato.
Per ciò che
concerne i rapporti intercorrenti tra Egitto e Nazioni Unite, è da evidenziare come la posizione egiziana in
materia di riforma del CdS sia stata finora improntata al rifiuto di soluzioni
parziali per l’allargamento del Consiglio, all’importanza del consensus
allargato e, soprattutto, al fermo rispetto degli impegni assunti in ambito
africano (cd. “Consensus di Ezulwini”).
Nel corso del
Summit del G8 nel 2007 è stato avviato il “processo
di Heiligendamm”, un dialogo con le
grandi economie emergenti, come Cina, India, Brasile, Messico e Sudafrica. Dovrà servire per
mettere a punto un impegno comune contro il protezionismo e su questioni quali
i cambiamenti climatici, l'energia, la proprietà intellettuale e la correttezza
degli investimenti, che non possono essere affrontate dagli Otto Paesi da soli.
La Presidenza italiana nel 2009 ha inoltre
promosso la partecipazione dell’Egitto in outreach
alle attività del G8, confermata
anche per il Vertice di Deauville del 2011.
RELAZIONI
POLITICHE
La rivoluzione
del 25 gennaio ha avuto un duro impatto sull’economia egiziana. Le IFI
prevedono che il Pil del Paese diminuirà nel 2011 attorno al 3-4 per cento, a
causa della paralisi delle attività produttive, della fuga di capitali, dei
mancati introiti del turismo. La conseguente perdita di posti di lavoro è resa
più acuta dal progressivo rientro del circa milione e mezzo di emigrati in
Libia. La pressione sindacale si è tradotta in aumenti salariali che hanno
aggravato la situazione delle finanze pubbliche con un netto peggioramento del
deficit statale e del debito pubblico ed un concreto rischio di default.
In questa direzione, i contributi principali
che l’Egitto si attende da noi sono a favore dell’aumento del flusso di
capitali, del sostegno ai progetti infrastrutturali ed alle PMI, oltre che in
direzione di una maggiore integrazione economica e commerciale con il mercato
europeo. Occorre inoltre agire per consentire all’Egitto di riprendere in tempi
ragionevoli la crescita, adoperandosi in particolare modo a favore della job
creation.
L’Italia ha mantenuto immutati, anche nel
corso della difficile fase di transizione democratica, i suoi rapporti
bilaterali con le autorità egiziane, con una visita dell’allora Ministro
Frattini al Cairo già il 22 febbraio, nonostante il rinvio del IV Vertice (in programma
a Luxor per il 21 e 22 febbraio) a seguito della crisi politica. Oltre a
consentire l’avvio di un primo contatto
con le autorità rivoluzionarie (la missione è stata fra le primissime nel Paese
dopo la caduta di Mubarak ed il Ministro ha incontrato il Maresciallo Tantawi,
l’allora Primo Ministro Shafik e l’allora Ministro degli esteri Aboul Gheit),
ciò ha rappresentato un messaggio di forte sostegno alla leadership egiziana,
indicando come l’Italia si sarebbe adoperata per sollecitare il sostegno dell’UE
verso l’Egitto (nel quadro di un Nuovo Patto per il Mediterraneo) e –
bilateralmente – a favore del turismo e del rilancio economico. Il
Ministro degli Esteri egiziano El Arabi è venuto in visita a Roma il 17 maggio,
seguito dal Premier Sharaf il 2 giugno, in occasione della festa nazionale.
L’Italia ha deciso di venire incontro alle
esigenze egiziane in primo luogo attraverso la firma, in occasione della visita
a Roma dell’allora MAE egiziano El Arabi il 17 maggio 2011,di una Dichiarazione d’intenti sulla III tranche
del programma di conversione del debito. Abbiamo inoltre sostenuto la
ripresa del turismo (attraverso l’adeguamento dei Travel Warning per le
località turistiche del Mar Rosso) ed il mantenimento della presenza economica
italiana nel Paese. La firma di un accordo in materia di maggiore integrazione
dei mercati del lavoro, insieme alla colazione organizzata con gli imprenditori
in occasione della visita di El Arabi, rientra in questa strategia, così come
la conclusione, a giugno del 2011, di un accordo sul turismo.
L’Italia ha inoltre avviato diverse
iniziative a favore delle PMI, con la costituzione di un Mediterranean
Partnership Fund (su cui abbiamo tenuto un Seminario a Palermo il 20 maggio) e
di un Centro Euro-mediterraneo di assistenza tecnica alle PMI con sede a
Milano. Abbiamo inoltre promosso l’allargamento dell’area di competenza della
BERS alla regione.
Durante la sua
visita al Cairo del 19 gennaio 2012, il Ministro Terzi ha annunciato la
disponibilità dell’Italia ad avviare i negoziati per la III Tranche del programma di conversione del debito (del valore di
100 milioni di USD), mentre sono in fase di negoziazione alcune intese, fra cui
un MoU tra i due Ministeri dei Trasporti
e due Accordi doganali (un Accordo
generale di assistenza in materia doganale e un Accordo tra le Autorità di
Venezia e di Alessandria), che costituiscono il nucleo del Green Trade Corridor per favorire l’arrivo sui mercati europei
della produzione agricola egiziana, oltre ad un Accordo tra Poste Italiane ed
Egypt Post relativo all’emissione di carte prepagate co-branded. È inoltre
in progetto l’istituzione di un’Università
Italo-Egiziana (EIU), prevalentemente a indirizzo tecnologico, che – oltre
ad arricchire i legami bilaterali e formare personale specializzato – potrà
servire come polo per la diffusione della cultura, dei valori e del know-how
italiani nel mondo arabo.
Sul versante
della collaborazione trilaterale, sono in corso negoziati per esplorare la
possibilità di avviare progetti comuni in Libia volti a promuovere
l’utilizzazione della manodopera egiziana in progetti infrastrutturali.
Fra i diversi ambiti di cooperazione
bilaterale, è stato concordato nel 2005, l’adozione di un Piano d’Azione
Triennale che prevede collaborazioni in materia di centri tecnologici e di
trasferimenti di tecnologia, incentivi finanziari (fondi SIMEST) per la
creazione di joint-venture, collaborazioni fra i settori bancari, sviluppo
congiunto di aree industriali e progetti di trasporto intermodale,
collaborazione in campo euro-mediterraneo e assistenza agli investimenti
italiani. Il Piano ha stabilito anche la creazione di un Consiglio Ministeriale (Ministerial Council) e l’impegno a tenere
riunioni con cadenza regolare, sia a livello di ministri che di gruppo di
lavoro misto, con la partecipazione dei rispettivi Ministeri degli Affari
Esteri e delle Ambasciate. I Ministri hanno anche sottoscritto l’impegno per
l’istituzione del Business Council
Italo-egiziano (composto da esponenti di alto profilo dell’imprenditoria
dei due paesi e che opera con il Consiglio Ministeriale).
Il Business Council è stato istituito
formalmente a Milano nel gennaio 2006. Esso progetto gode dell’adesione sia dei
principali imprenditori italiani operanti nel paese, sia dei principali
esponenti politico-imprenditoriali egiziani.
Vengono inoltre organizzate periodiche “Missioni di Sistema” in Egitto, alle
quali partecipano il Ministro dello Sviluppo Economico e rappresentanti del
settore economico-finanziario italiani.
In occasione del secondo Vertice bilaterale del maggio 2009, è stato
firmato il nuovo Piano d’Azione per il
triennio 2009-2012 che prevede ulteriori possibilità di collaborazione
bilaterale soprattutto nei settori delle energie alternative, tecnologie pulite
e delle telecomunicazioni, nonché iniziative per il coinvolgimento delle
piccole e medie imprese dei due Paesi.
Si segnala, inoltre, la visita in Egitto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoli, che ha avuto luogo nel
luglio 2010 e nel corso della quale è stato firmato un Memorandum di Cooperazione nel settore dei trasporti ferroviari e
marittimi, con il quale si conferma l’interesse reciproco a sviluppare i
progetti già in corso o ad avviarne di nuovi. Preme sottolineare che i
trasporti e le infrastrutture sono comparti che offrono ottime opportunità di
investimento per il nostro Paese, grazie anche ai rapporti privilegiati che si
sono instaurati a livello bilaterale e alla fiducia accordata alle imprese
italiane dalle Autorità egiziane.
Tra le Per quanto riguarda le iniziative più
recenti, si segnala la missione al Cairo, nel novembre 2011, di 35 enti ed
operatori economici italiani di vari settori (tra cui quello turistico, della
logistica, delle infrastrutture e dei servizi finanziari), organizzata dall’Associazione di Amicizia Italia-Egitto
che si è articolata in incontri istituzionali e con imprese egiziane. Nel
febbraio del 2012, nel corso di un incontro tenutosi a Roma tra il
sottosegretario Braga e il sottosegretario al Commercio internazionale egiziano
Alaa Kenawy, si è discusso della collaborazione in materia di sistemi
informativi per l’agricoltura tra la Federazione delle Camere di Commercio
egiziane e la Società SIN (partecipata da AGEA, che si occupa del sistema
informativo agricolo nazionale).
Elemento fondamentale del sostegno italiano
alla transizione democratica in corso in Egitto è il mantenimento della nostra presenza economica. L’obiettivo è di
“rassicurare” l’Egitto circa la continuità del nostro impegno verso il Paese ed
“esserne rassicurati” quanto alla tutela dei nostri investimenti. In tal senso,
dopo l’incontro con le imprese effettuato dall’allora Ministro degli Esteri El
Arabi a Roma a maggio del 2011, una seconda riunione è stata organizzata a
febbraio del 2012 in occasione della visita in Italia del MAE Kemal Amr. Essa
ha consentito un approfondito dialogo sulle prospettive di investimento nel
Paese e sulle diverse questioni aperte che vedono coinvolte diverse nostre
imprese in Egitto.
L’Italia è il primo partner commerciale
dell’Egitto in Europa ed il secondo a
livello mondiale (dopo gli USA): per le esportazioni egiziane, con forte
incidenza della componente petrolio, mentre per le esportazioni italiane con
prevalenza della componente macchinari (in costante aumento dal 2004). Le
importazioni italiane dall’Egitto hanno avuto un forte aumento della componente
energetica e dei prodotti finiti. Da notare il raddoppio dell’interscambio, nel
periodo 2005-2008, che è passato da 2.666 a 5.152 milioni di euro.
In base ai dati
dell’ISTAT relativi al 2010, l’interscambio è ammontato a 4.823,5 milioni di euro (+19,2% rispetto al 2009), le esportazioni italiane verso l’Egitto si sono attestate a 2.935,5 milioni di euro (+12,8%),
mentre le importazioni italiane
dall’Egitto sono state di 1.888 milioni
di euro (+30,9%). Il saldo, positivo
per l’Italia, è stato pertanto di 1.047,5 milioni di euro. Tra le voci
merceologiche delle esportazioni italiane verso l’Egitto che hanno registrato
consistenti aumenti, si trovano i prodotti in metallo e i prodotti petroliferi
raffinati. Hanno invece registrato una contrazione i prodotti della
metallurgia. Per quanto riguarda i prodotti
importati dall’Egitto, si segnala un aumento dei prodotti della metallurgia,
delle apparecchiature elettriche e dei prodotti tessili. In base ai dati
relativi al periodo gennaio-settembre
2011, l’interscambio è ammontato
a 3.885,4 milioni di euro (+ 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2010), le esportazioni italiane verso l’Egitto (principalmente
del comparto della meccanica strumentale, delle materie plastiche e dei
prodotti chimici) sono state di 1.985,7
milioni di euro (-7,5% rispetto allo stesso periodo del 2010), e le importazioni italiane dall’Egitto hanno
totalizzato 1.899,7 milioni di euro (+34,5% rispetto allo
stesso periodo del 2010). Il saldo,
positivo per l’Italia, è stato
pertanto di 86 milioni di euro.
INVESTIMENTI
Comparto
d’eccellenza per gli italiani è da
sempre quello dell’energia, in particolare petrolio
e gas con ENI (presente nel
Paese da oltre 50 anni) ed Edison.
Nel giugno 2011, ENI ha annunciato un nuovo piano di investimenti per 3
miliardi di dollari per la perforazione di nuovi pozzi petroliferi e il
rilancio delle attività di esplorazione, nel deserto occidentale, nel
Mediterraneo e nel Sinai. Si segnalano da ultimo gli importanti accordi
relativi all’impianto di liquefazione del gas a Damietta e l’intesa strategica
con il Ministero del Petrolio egiziano firmata nel 2010 per operazioni
congiunte nei Paesi terzi.
Edison ha rilevato nel 2008
(per 1.4 miliardi di dollari) i diritti di esplorazione, produzione e sviluppo
della concessione off-shore di Aboukir.
ENEL ha
concluso un’intesa con il Ministero del Petrolio egiziano che ha lo scopo di
inserire l’azienda italiana (come partner) nei progetti di ampliamento degli
attuali impianti egiziani di
liquefazione di gas naturale e di esplorazione. (un primo risultato è stato
conseguito con la partecipazione al 10% in un consorzio a guida francese per
l’esplorazione off-shore al largo di Alessandria).
E’ anche
interessata all’avvio di progetti nel settore dell’energia rinnovabile, sul
quale si stanno concentrando le attività di diversificazione delle fonti
energetiche egiziane.
Dopo la
rivoluzione, l’Italia è riuscita ad assicurarsi nuove importanti commesse (tra le poche assegnate), da Technimont (costruzione di un impianto
di fertilizzanti ad Assuan, del valore di 520 milioni di dollari, in un settore
tradizionalmente dominato da aziende tedesche) ad Ansaldo (contratto da 245 milioni di euro per la realizzazione di
una nuova centrale elettrica). Inoltre, l’Ansaldo fornirà quattro turbine a
vapore (per un valore di oltre 170 milioni) nell’ambito di progetti finanziati
dalla Banca Mondiale e dall’Arab Fund (in tale contesto altre società italiane,
STS Trifone e Ansaldo caldaie hanno
acquisito commesse per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro).
Techint/Cimimontubi,
Socotherm, Termokimik e la Walter Tosto operano anche’esse in Egitto nel settore della costruzione
di stabilimenti e delle forniture per la produzione e distribuzione di energia.
Italgen
(società del Gruppo Italcementi)
è interessata alla creazione di un parco eolico sulla costa del Mar Rosso,
mentre ENEA ha mostrato interesse ad
avviare progetti di collaborazione bilaterale nel settore delle energie
rinnovabili, in particolare, per lo sviluppo della tecnologia del solare
termodinamico.
FIAT
IVECO e INTRACO sono impegnate
nel progetto di riduzione dell’inquinamento urbano mediante l’impiego di veicoli
per il trasporto pubblico alimentati a gas naturale.
Nei settori industriale,
agroalimentare, servizi, impiantistica, meccanica, edilizia, turismo, tessile, gli
investimenti italiani sono prevalentemente concentrati nelle zone franche. Nel
campo dei servizi, la società AMA e la Jacorossi si sono aggiudicate gli appalti per la gestione dei
rifiuti solidi rispettivamente nelle aree di Cairo Nord e di Giza, mentre la COM.INT si è aggiudicata la fornitura
di attrezzature e veicoli nel settore della gestione dei rifiuti solidi nella
zona sud del Sinai.
La società System, leader mondiale nel settore dei macchinari per l’industria
della ceramica ha aperto una filiale egiziana (System Egypt) e la Pirelli, con sede ad Alessandria, sta
procedendo all’ampliamento dei suoi stabilimenti (già i più grandi del Medio
Oriente) per la produzione di pneumatici per camion.
La Danieli ha acquisito dall’azienda
egiziana Suez Steel una commessa per la realizzazione di un’acciaieria e
partecipa anche ad un investimento dell’azienda egiziana El Ezz Steel, per la
costruzione di un nuovo stabilimento. Questi progetti subiscono oggi le conseguenze
giuridiche delle sentenze emesse contro il Presidente del suddetto Gruppo
egiziano, grande magnate vicino a Mubarak, con rischi di revoca delle licenze
per la societa’ italiana.
La BTicino
(Gruppo Legrand) e la Imagro
(subfornitrore della Bticino) sono presenti a Sadat City, con due stabilimenti
per la produzione di apparecchiature elettriche e, per quanto riguarda BTicino
si segnalano alcune problematiche dovute alle rivendicazioni salariali e
contrattuali di una minoranza di lavoratori. Nel novembre 2010, la Rizzani de Eccher S.p.A. è stata
ammessa alla fase finale della gara per la costruzione del nuovo Grande Museo
Egizio del Cairo. Nel novembre 2011, la Tekno
Equipment ha fornito i macchinari per la realizzazione del primo panificio
meccanizzato egiziano, nel Governatorato del 6 ottobre (a 40 km dal Cairo).
Il Gruppo
Italcementi ha acquisito il controllo di maggioranza della società egiziana
Suez Cement (investimento di circa 1.5 milardi di euro), che con cinque
cementifici è market leader in Egitto. Il gruppo è tuttavia stato oggetto di
forti ostilità dopo la rivoluzione, sfociata nell’intervento dell’esercito,
nonché di campagne stampa infamanti (l’On. Ministro ha richiamato l’attenzione
della leadership egiziana sul caso durante la sua visita del 22 febbraio 2011).
Problematica anche la situazione di Sinai White Cement (Cementir, gruppo Caltagirone), leader sul mercato del cemento bianco,
che risente della situazione di sicurezza e delle continue interruzioni del
gasdotto verso Israele.
In alcuni settori quali l’informatica, la formazione tecnica e manageriale ed alcuni
settori del “non-oil”, si presentano maggiori e concrete opportunità di
cooperazione con il sistema industriale italiano, sotto forma di joint-venture,
trasferimenti di tecnologia e di expertise, anche come consulenze nell’ambito
del programma ENPI.
Nel settore della difesa e delle alte
tecnologie, la Rheinmetall (ex Oerlikon Contraves fornisce materiali per l’ammodernamento degli
“Skyguard” (prodotti in Italia) del sistema di difesa egiziano “Amoun”, mentre Alenia Aeronautica (Gruppo Finmeccanica) sta
partecipando ad una gara per la fornitura di 6 velivoli “C27J” per il trasporto
tattico. Agusta Westland (Gruppo
Finmeccanica) si è aggiudicata la fornitura di 2 elicotteri ad uso civile
alla società egiziana Petroleum Air Services. Il Paese risulta difficilmente
penetrabile nel mercato della difesa in quanto l’approvvigionamento di
equipaggiamenti si attua prevalentemente attraverso fondi FMS statunitensi (Foreign Military Sales). In ogni caso,
le principali opportunità si presentano nel settore aeronautico, avionico,
nonché della sistemistica e componentistica navale e subacquea.
Per gli investimenti nel settore turistico si segnalano la società Marsa Alam e il gruppo Domina.
Trasporti - La
società Sea Train è impegnata nella
realizzazione di collegamenti ferroviari con relativi servizi tecnici di bordo
e di terra.
Nel gennaio 2008, è stato firmato il Memorandum d’Intesa relativo all’Accordo
operativo tra Italia ed Egitto per la ristrutturazione delle ferrovie egiziane.
Il programma, che dovrebbe durare cinque anni, prevede l’assistenza tecnica da
parte italiana e la formazione della classe dirigenziale delle ferrovie
egiziane. Sempre in ambito ferroviario, nel maggio 2009, è stato firmato un Memorandum d’Intesa per lo studio di prefattibilità da parte di
Italferr (Gruppo FS) relativo alla linea
ad alta velocità tra Il Cairo ed Alessandria d’Egitto. Italferr ha anche stipulato un contratto con Egyptian
Railways per la progettazione e la direzione dei lavori per la segnaletica del
corridoio ferroviario n. 4 (Banha/Zagazig/Ismailia/El Qantara/Port Said). Sono
inoltre in corso alcune gare per la fornitura di sistemi di segnalamento in
altre tratte, di servizi informatici e per la manutenzione del materiale
rotabile che potrebbero offrire ulteriori opportunità alle imprese italiane.
Sono stati avviati studi di fattibilità da parte di Grandi Stazioni (Gruppo FS) per la valorizzazione commerciale delle
principali stazioni e si attende una decisione, da parte egiziana, circa la
prosecuzione del progetto. E’ inoltre in programma il rinnovamento della rete
tramviaria urbana di Alessandria. La società Salcef si è aggiudicata una commessa (finanziata dalla Banca
Mondiale nell’ambito del progetto di ristrutturazione delle ferrovie egiziane)
per il rinnovamento dei binari della tratta Il Cairo-Alessandria.
La Elsag
Datamat (Gruppo Finmeccanica) si è aggiudicata un contratto per la
fornitura di servizi di biglietteria e una commessa per l’installazione di un
sistema di controllo della segnaletica ferroviaria.
La società Gemmo fornisce servizi presso l’aeroporto internazionale del Cairo.
Da segnalare anche la firma del Memorandum d’Intesa tra il Porto di Venezia
e il Porto di Alessandria d’Egitto, nell’ottobre 2009, il cui scopo è
quello di sviluppare la collaborazione in particolare per quanto concerne il
traffico ortofrutticolo bilaterale, l’istituzione
di una linea di navigazione veloce per merci e passeggeri (inaugurata dalla
società Visemar il 20 maggio 2010, a latere del III Vertice bilaterale, ma
successivamente sospesa nel luglio 2011 a causa del drastico calo del traffico
dopo la Rivoluzione), nonché l’ammodernamento del nuovo terminal crocieristico
di Alessandria.
Da segnalare anche la gestione da parte di Gemmo di tutti i servizi di facility
management del terminal 3 dell’aeroporto internazionale del Cairo. Il contratto
per tali servizi è in scadenza nell’aprile 2012 ed un’azione di
sensibilizzazione delle autorità competenti per un pronto rinnovo è stata
avviata da parte dell’Ambasciata.
Settore bancario-finanziario – Il Gruppo
Intesa San Paolo detiene la maggioranza di controllo di Alexbank, una delle
principali banche del Paese, essendosi aggiudicata la procedura di
privatizzazione per circa 1.5 miliardi di euro. Sono stati successivamente
effettuati ingenti investimenti, che hanno portato la banca a performare in
maniera virtuosa. La rivoluzione ha tuttavia portato a violentissime
contestazioni nei confronti del top management egiziano (oggi sostituito da
management totalmente italiano) ed è in corso un procedimento giudiziario volto
a contestarne la privatizzazione.
E’ inoltre presente un ufficio di
rappresentanza del Monte dei Paschi di Siena.
La BIIS (Banca Infrastrutture, Innovazione e
Sviluppo), ramo operativo del Gruppo Intesa San Paolo, è interessata al settore
delle infrastrutture egiziano, in particolare al project financing per il Porto di Alessandria per il quale si
prevede il coinvolgimento delle principali imprese di costruzione italiane.
E’ inoltre operativo un Memorandum di Intesa tra la Commissione Nazionale per le Società e per
la Borsa (CONSOB) e la Capital Market Authority dell’Egitto, nel quale si
prevedono obblighi di assistenza reciproca e scambio di informazioni per
finalità di cooperazione internazionale.
La Società
Italiana per l’Automazione (SIA) si è aggiudicata un progetto per la
modernizzazione dei servizi bancari egiziani.
E’ stata
avviata anche la collaborazione bilaterale nel settore postale con la firma di
una Dichiarazione congiunta tra Poste
Italiane e Egypt Post che prevede lo sviluppo e l’integrazione dei servizi
telematici tra i due Paesi e, con una successiva intesa,
per la definizione di un Master Plan per il settore della logistica. Nel
settembre 2010, Poste Italiane ha inoltre concluso un Memorandum di collaborazione con il Ministero dei Trasporti egiziano,
relativo a servizi di consulenza per la riforma della logistica dei trasporti
intermodali che verranno forniti dalla società ‘Italia Logistica’ (partecipata
da Poste e FS).
Abbigliamento/Tessile – Paul & Shark e Benetton/Sisley sono presenti a Il
Cairo con due importanti punti vendita. Il Gruppo Miro Radici, leader mondiale nel
settore tessile e meccanotessile, che detiene la quota del 50% nella
joint-venture con l’egiziana Oriental Weavers, ha costruito un impianto per la
produzione di prodotti tessili per la casa, destinati all’esportazione. La società Cotonificio Albini, che già intrattiene rapporti commerciali
consolidati con i maggiori produttori di filati egiziani, partecipa anche al
progetto di sviluppo della nuova zona industriale specializzata nelle
manifatture tessili di Bourg El Arab, ma a causa della crescente conflittualità
tra una parte delle maestranze e la dirigenza dell’azienda (dovuta
essenzialmente alla richiesta di aumenti salariali) è stata costretta ad
interrompere le attività di produzione.
Arredamento/Design
– Sono presenti
nel Paese, con punti vendita e sale di esposizioni, importanti marchi italiani
del settore quali, Natuzzi, Moroso,
B&B, Poltrona Frau, Kartell.
Il problema del mancato
rispetto dei termini contrattuali che legano alcuni enti
pubblici egiziani ad importanti imprese italiane riguarda, in particolare,il
caso AMA-Arab (e, in maniera minore,
la ditta IES, riconducibili entrambe
al Gruppo Gesenu) attiva nella gestione dei rifiuti nei Governatorati del Cairo
e di Giza, che nel periodo post-rivoluzionario ha subito l’interruzione del
pagamento delle spettanze. Per questa ragione è stata trascinata sull’orlo del
collasso operativo. Problemi analoghi di pesanti ritardi nei pagamenti vengono
lamentati da altre grandi realtà imprenditoriali quali ENI e Technint. Il clima
di diffidenza instauratosi dopo la rivoluzione ha indotto le nuove Autorità a
procedere ad una ricognizione/revisione approfondita e dettagliata di tutte le
operazioni condotte dal precedente regime con le società straniere e dei
relativi contratti stipulati dalle Amministrazioni egiziane. In tale contesto
anche il contratto di AMA, stipulato con il precedente Ministro delle Finanze,
Boutros Ghali (nel frattempo condannato in contumacia a 30 anni per corruzione)
è sottoposto al vaglio degli organi di controllo. Vi sono, inoltre, numerosi contenziosi nel settore immobiliare (specialmente
nella zona del Mar Rosso) in cui gli investimenti di numerosi cittadini
italiani sono a rischio. Tra questi le proprietà Coral Bay a Sharm el Sheikh colpite sia dalla normativa egiziana
del 2005, che consente agli stranieri di esercitare sui terreni del Sinai non
più un pieno diritto di proprietà, bensì un mero diritto di usufrutto per 99
anni (mentre gli investitori hanno acquisito un titolo di proprietà, anche se
non registrato), sia da recenti accertamenti giudiziari che contestano
all’imprenditore italiano Preatoni asserite irregolarità nei contratti relativi
ad acquisizioni e cessioni dei terreni su cui sorge il complesso. A tale vicenda,
si aggiungono le problematiche di investitori italiani nell’area di Hurghada e Marsa Alam che, pur avendo pagato somme ingenti per l’acquisto
degli immobili, lamentano la mancata consegna delle abitazioni. Le vertenze in
questione, che specialmente nell’ultimo caso potrebbero essere riconducibili ad
episodi di truffa ai danni dei nostri investitori (questione che è al vaglio
della magistratura egiziana ma anche di quella italiana e britannica), sono
ulteriormente complicate da un clima di crescente sospetto nei confronti di
tutte le cessioni di terreni, specialmente a stranieri, concluse sotto il
precedente regime (su cui aleggiano accuse di corruzione nei confronti delle
autorità egiziane coinvolte).
Anche a causa della mancanza di trasparenza
dei progetti, le autorità egiziane avrebbero avviato delle indagini per
verificare la correttezza delle procedure seguite per la concessione dei
permessi di edificabilità (oltre che la congruità dei prezzi associati a tali
concessioni).
Il contenzioso con Catas S.p.A. è invece scaturito da asserite irregolarità nelle
modifiche dei termini contrattuali inizialmente pattuiti per la fornitura e
l'attivazione dei macchinari presso il Centro Tecnologico del Mobile di
Damietta, che ha portato all’escussione delle garanzie bancarie di Catas da
parte degli organi di controllo egiziani, in via precauzionale.
Negli
ultimi mesi del 2011, il Direttore Esecutivo del Centro arabo per l'integrità'
e la trasparenza, Muhammad Shihata, ha presentato un ricorso contro la privatizzazione
della Bank of Alexandria, detenuta in maggioranza dal gruppo Intesa. Un
tribunale amministrativo del Cairo, nel mese di gennaio del 2012, ha imposto
alla banca una moratoria cautelativa sulla vendita delle proprietà immobiliari
delle sue filiali in attesa della sentenza.
COOPERAZIONE IN AMBITO SICUREZZA
Sul fronte delle cooperazione in ambito
sicurezza, va registrata una collaborazione particolarmente intensa e positiva
sia tra le rispettive Forze di Intelligence che tra i rispettivi Ministri dell’Interno.
Il Capo dei Servizi Esterni, Gen. Mowafi, ha deciso di compiere proprio in
Italia una delle sue prime missioni all’Estero e ha molto apprezzato la
disponibilità del Ministro Terzi di incontrarlo, il 18 gennaio 2012, proprio
alla vigilia della Sua visita al Cairo.
Quanto alla cooperazione tra i Ministeri
dell’Interno, sono state avviate nuove iniziative per una più incisiva azione
coordinata nel contrasto all’immigrazione clandestina, sullo sfondo di un
accordo bilaterale di riammissione che consente ogni anno il rimpatrio in
Egitto – anche grazie all’ottima collaborazione delle autorità egiziane – di
moltissimi immigrati egiziani illegalmente giunti in Italia. Si tratta in
particolare della fornitura da parte del nostro Ministero dell’Interno di
veicoli ed apparecchiature informatiche ad elevato valore aggiunto (elicotteri,
veicoli fuoristrada, strumentazioni per la raccolta di impronte digitali,
computer, ma anche corsi di formazione per agenti di polizia egiziani) che
dovrebbero auspicabilmente rafforzare le capacità operative di queste forze di
sicurezza (gravemente indebolite dagli eventi dei mesi scorsi) ma anche offrire
un segno tangibile del nostro interesse e della nostra viva aspettativa per una
continua collaborazione con le Autorità egiziane nel settore della sicurezza e
contrasto alle migrazioni illegali.
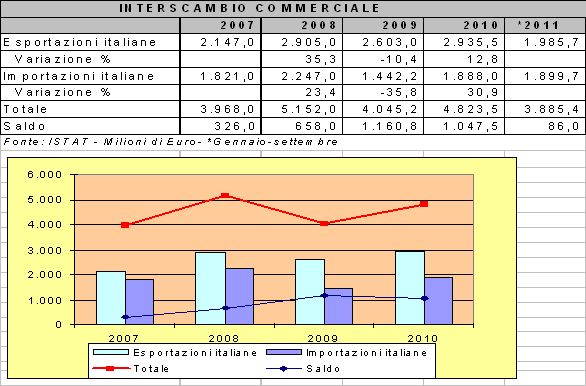
|
PRINCIPALI ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI ITALIANE - Gen.-
Dic. 2010
(e % su totale)
|
|
ESPORTAZIONI
|
IMPORTAZIONI
|
|
1. Macchinari e apparecchiature meccaniche (37,2%)
|
1. Petrolio
greggio (40,9%)
|
|
2. Prodotti chimici (11,7%)
|
2. Prodotti della
metallurgia (15,1%)
|
|
3. Prodotti petroliferi raffinati (10,2%)
|
3. Prodotti petroliferi raffinati (13,9%)
|
|
4. Prodotti in metallo (5,9%)
|
4. Prodotti tessili (7%)
|
|
5. Apparecchiature elettriche (5,8%)
|
5. Prodotti chimici (6%)
|
|
Fonte: elaborazione ICE
su dati ISTAT
|
|
INCIDENZA
INTERSCAMBIO SUL COMMERCIO ESTERO ITALIANO 2010
|
|
Esportazioni verso l’Egitto sul totale
delle esportazioni italiane
|
0,9%
|
|
Importazioni dall’Egitto sul totale delle
importazioni italiane
|
0,5%
|
|
Fonte:ISTAT
|
|
QUOTE DI MERCATO 2010
|
|
PRINCIPALI
FORNITORI
|
% su import
|
PRINCIPALI CLIENTI
|
% su export
|
|
1. USA
|
12,2%
|
1. USA
|
8,1%
|
|
2. Cina
|
10,8%
|
2. Italia
|
7,8%
|
|
3. Italia
|
6,7%
|
3. Spagna
|
5,8%
|
|
4. Germania
|
6,7%
|
4. India
|
5,6%
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: Economist
Intelligence Unit, dicembre 2011
|
|
ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE DEBITORIA
|
|
Ultimo
Accordo bilaterale di conversione del debito
|
3 giugno 2007
($USA 100 mln – Scadenze debitorie dal 2007 al 2012)
|
|
SACE
|
|
Categoria di rischio
5 su 7
|
|
Fonte: SACE
|
|
FLUSSI
INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI (2011)
(Euro)
|
|
in
Egitto
|
in
Italia
|
|
512.000.000
|
5.000.000
|
|
Fonte: Banca d’Italia, febbraio 2012
|
Le relazioni culturali italo-egiziane sono
regolate dall’Accordo di Cooperazione Culturale dell’8 gennaio 1959, e
dall’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica del 29 aprile 1975.
Le collaborazioni culturali sono
numerosissime ed interessano molteplici settori. La presenza culturale italiana
in Egitto è tra le principali, non solo nel settore dell’insegnamento della
lingua, ma anche in tema di mostre, eventi culturali, concerti, nonché per le
attività e le collaborazioni più o meno istituzionali che avvengono
regolarmente tra enti e centri dei due Paesi. Particolare attenzione viene
dedicata al settore della valorizzazione e conservazione del patrimonio
culturale e archeologico. Nel corso del
2009, sono state realizzate numerose iniziative congiunte per celebrare
l’Anno Italo-Egiziano della Scienza e
della Tecnologia. Tra i numerosi eventi organizzati spiccano quelli
dedicati alle tematiche delle tecnologie applicate alla tutela dei beni
culturali, fisica applicata e nucleare, energia ed ambiente (in particolare,
l’Acqua), medicina, Information &
Communication Technology, agricoltura, trasporti, astronomia. Oltre ad
essere stata un’importante iniziativa in ambito culturale, l’Anno
Italo-Egiziano della Scienza e della Tecnologia ha rappresentato anche una
grande iniziativa promozionale, che, attraverso un filo di lettura
tecnico-scientifico, ha valorizzato il Made
in Italy, contribuendo concretamente a sostenere il nostro Sistema Paese.
Accordi di Collaborazione con vari Centri di Ricerca (CNR, Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali, Centro di Ricerche in Agricoltura) e Università italiane
sono stati firmati come follow-up dell’evento. Tra le numerose iniziative di
grande interesse e di successo, si segnalano la Settimana della cultura italiana e la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro a Il Cairo,
che hanno luogo annualmente.
L’Istituto Italiano di Cultura ha la sede
principale a Il Cairo e un ufficio
ad Alessandria. Nel Paese è presente
anche un comitato “Dante Alighieri”.
Una delle attività primarie dell’Istituto di
Cultura, principale soggetto della programmazione culturale italiana in Egitto,
è consistita nella valorizzazione degli
interventi italiani sul patrimonio archeologico egiziano, che è ora di
competenza del Centro Archeologico
Italiano de Il Cairo. L’aggiornamento
e il potenziamento informatico della biblioteca archeologica ad opera
degli archeologi italiani ha inoltre comportato una visibilità ancora maggiore,
come pure il contributo al progetto internazionale a favore della Biblioteca
Alessandrina, gestito dalla Cooperazione allo Sviluppo italiana.
UNIVERSITÀ ITALO-EGIZIANA
Il
progetto per l’istituzione dell’Università Italo-egiziana si propone di
arricchire i legami storici e culturali tra i due Paesi, sviluppare
ulteriormente la partnership bilaterale nei settori dell’istruzione e della
ricerca e formare personale specializzato (con particolare attenzione ai
bisogni delle aziende italiane operanti in Egitto e in Medio Oriente).
L’Università sarà prevalentemente a indirizzo tecnologico (Ingegneria,
Architettura ed Economia), cui si affiancheranno discipline umanistiche e
rilascerà titoli accademici doppi o congiunti di I e II livello e Dottorati di
Ricerca che saranno riconosciuti dall’Egitto e dalle università italiane
coinvolte nel progetto. L’Ateneo si baserà sul modello economico del
Partenariato Pubblico-Privato, come stabilito dalle norme egiziane per
l’istituzione delle università private.
QUADRO
INFORMATIVO :
L’Italia è un importante Paese donatore per
l’Egitto, con iniziative in corso del valore complessivo di 158 milioni di
euro:
47 milioni di euro a dono per iniziative bilaterali
di cooperazione allo sviluppo;
28 milioni di euro a credito d’aiuto;
100 milioni di dollari per il secondo Programma di
Conversione del Debito (debt swap).
I recenti eventi che hanno interessato i paesi della
sponda sud del Mediterraneo non hanno causato situazioni di grave crisi
umanitaria in Egitto. La Cooperazione Italiana su specifica richiesta delle
Autorità egiziane, ha potuto fornire il proprio supporto per favorire
l’evacuazione dei cittadini egiziani fuggiti in Tunisia dalla Libia. In tale
circostanza la DGCS, d’intesa con la Difesa, ha proceduto alla realizzazione di
3 voli da Djerba al Cairo che hanno consentito di rimpatriare 111 cittadini
egiziani.
Gli sviluppi politici e sociali in Egitto hanno
invece fatto emergere la forte insofferenza della fascia medio bassa della
popolazione e della piccola borghesia per l'iniqua ripartizione interna di
risorse e ricchezza. La società egiziana domanda con forza un concreto ruolo
nella vita politica del Paese.
Di fronte a tali
sviluppi, in linea con quanto emerso anche in ambito europeo, la Cooperazione
italiana procederà lungo 2 direttrici principali: di breve/medio periodo per
rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione con gli strumenti
attualmente già a disposizione (aiuti a dono in fase di erogazione e crediti
d’aiuto attivi) ricalibrandoli coerentemente; di più lungo periodo, con una
programmazione delle risorse che riesca a generare reddito diffuso a vantaggio
della popolazione ed offrire realmente un contributo alle legittime aspirazioni
della popolazione verso un maggior coinvolgimento nella vita politica del
proprio Paese, attraverso il sostegno alla Governance democratica ed alla
società civile.
DELIVERABLES:
Aiuti
d’emergenza
A
fronte di un’esplicita richiesta da parte egiziana, volta a calmierare i prezzi
dei principali generi alimentari (farina,
tè, zucchero, olio e riso) in alcune aree del Paese, l’Italia ha
approvato e finanziato l’acquisto di aiuti alimentari per 2 milioni di euro, da
distribuire alle fasce più vulnerabili della popolazione del Governatorato di
Beni Suef.
Doni
8 milioni di
euro disponibili per il triennio 2011-2013, di cui:
- Circa 2 milioni di euro già allocati (a favore
dei minori e della famiglia e per la Cooperazione interuniversitaria);
- 6 milioni di euro in settori da identificare;
- 18 milioni di euro ancora disponibili nelle
casse egiziane, che finanzieranno acquisti della Pubblica Amministrazione
egiziana attraverso il Programma di Commodity Aid. Il Programma tuttavia
registra fortissimi ritardi a causa del mancato lancio di molte gare da
parte egiziana. (circa
20 milioni di euro su 37 sono ancora disponibili nelle casse egiziane per
finanziare acquisti di beni e servizi italiani collegati).
- Non
appena sarà firmato da parte egiziana il relativo accordo bilaterale, sarà
avviata un’iniziativa a dono a
favore dei minori e della famiglia da 1,5 milioni di euro, già
approvata dal Comitato Direzionale il 26 settembre u.s;
- È
stato approvato e sarà avviato nel 2012 un programma di formazione presso
l’Università di Bologna “
Governance e sviluppo delle Piccole e Medie Imprese in Egitto e Tunisia”
destinato a 30 studenti egiziani e 30 studenti tunisini, del valore di 1
milione di euro.
Crediti
d’aiuto:
·
13 milioni di euro immediatamente disponibili a
favore delle microimprese egiziane (Social Development Fund). Questa linea di credito entrerà in funzione
non appena saranno approvate da parte egiziana le modifiche di semplificazione
mutualmente concordate.
- Al fine
di rilanciare lo strumento a favore delle imprese più piccole,
presenteremo mirati emendamenti al prossimo Comitato Direzionale del 24
maggio p.v.
- 5
milioni di euro disponibili nelle casse egiziane come tranche finale
della Linea di credito a sostegno
delle PMI egiziane;
Principali
Programmi in corso
L’ultimo Rapporto sullo Sviluppo Umano elaborato
delle Nazioni Unite colloca l’Egitto al 101° posto su un totale di 169 Paesi,
con un PIL pro capite pari a circa $5.889 l’anno. Il 36,1% della popolazione
vive sotto la soglia di povertà, il tasso di occupazione si attesta al 43,2% ed
il 33,6% della popolazione è analfabeta. Il tasso di mortalità materna è pari
all’1,3% .
1.
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE BILATERALE
2011-2013 (firmato in occasione del Vertice di maggio 2010)
- Sarà presentato al primo Comitato Direzionale
utile il programma “Promoting Children’s Rights and Family Empowerment in
Fayoum Governorate”, che sarà realizzato in collaborazione con il
Ministero della Salute e Popolazione e che vedrà il coinvolgimento
dell’ISTAT (1.5 milioni di euro).
- Sarà anche presentato al primo Comitato
Direzionale utile un“Programma di Cooperazione italo-egiziano per la
Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica”, cui Italia ed Egitto
parteciperanno con un contributo complessivo di 1.350.000 euro, equamente
ripartito.
Una volta che la situazione sarà stabilizzata, fatta
salva verifica con il Governo egiziano circa le nuove priorità d’azione,
potranno anche essere finalizzati i seguenti progetti:
- “Programma di sviluppo socioeconomico della
Costa Nord-Ovest”, da 1,5 ME a dono, in cui l’Italia potrebbe assumere un
ruolo coordinatore di una più ampia in iniziativa dell’Unione Europea.
- Terza fase del “Programma ambientale” (3
milioni di euro in 3 anni. L’iniziativa sarà svolta in collaborazione con
il Global Environmental Facility (GEF) dell’UNDP.
- Iniziativa di cooperazione trilaterale a
beneficio del Sud Sudan che consentirà alle ostetriche sudanesi di recarsi
ad Alessandria per un periodo di formazione di tre settimane.
- L’Etiopia beneficerà invece di un’iniziativa
trilaterale per il controllo della malaria È all’esame dei competenti
uffici la proposta di progetto trasmessa a questa DGCS dal Ministero della
Sanità etiopico, che prevede il coinvolgimento, in forma diretta e in
qualità di unico esecutore, dell’Ente egiziano dell’Ente egiziano InRaD
(Innovative Research and Development).
2.
COMMODITY AID. 31 milioni di euro più circa 5
milioni di interessi attivi, di cui residuo di cassa di 17,8 milioni.
Il programma, avviato nel 1994, dispone ancora di un
residuo di cassa di 17,8 milioni di euro, che sarà esaurito qualora i bandi e
le gare in preparazione e in corso di svolgimento andassero a buon fine.
3.
CREDITI D’AIUTO.
a.
Linee di credito Piccole e Medie Imprese
(PMI) – 15 milioni di euro, di cui 5 residui.
Da parte della DGCS, l’erogazione delle somme
concordate è stata completata con l’accredito, nel 2009, della terza ed ultima
rata di 5 milioni di euro. Si auspica il rapido esaurimento di tale tranche,
che potrà costituire una concreta base di riferimento per fissare i termini per
l’avvio della annunciata nuova linea di 45 milioni di euro.
b.
Linea di credito Social Fund Development
(SFD) – 12,9 milioni di euro
Raggiunta
l’intesa di procedere ad un emendamento all’Accordo vigente con il quale si
prevede una modalità di erogazione dei finanziamenti più agevole, tale variante
sarà presentata al prossimo Comitato Direzionale utile per approvazione.
4.
CONVERSIONE DEL DEBITO. 100 milioni di
dollari.
La prima fase del programma, da 149 milioni di
dollari, è stata avviata nel 2001 e si è conclusa nel 2008, mentre la seconda,
da 100 milioni di dollari (di cui 75 milioni non ancora spesi), è stata avviata
nel 2007. Il
programma prevede che il debito dovuto dall’Egitto all’Italia nel periodo
2007-2012 non sia restituito ma sia convertito in valuta locale e trasferito su
un Fondo di contropartita per finanziare progetti di sviluppo in Egitto. Il
termine previsto dall’Accordo in vigore per l’esecuzione dei progetti è il 2014
ma, a partire dal giugno 2012, in assenza di un nuovo Accordo di Conversione,
l’Egitto dovrebbe ricominciare a restituire le rate di debito dovute. L’Italia ha intanto aderito alla
richiesta egiziana di estendere di dodici mesi la durata della seconda fase
(fino al 2015), al fine di consentire la realizzazione dei progetti già
approvati e, in occasione della visita del Ministro Terzi al Cairo del gennaio 2012,
è stata annunciata la disponibilità da parte italiana ad avviare il negoziato
per la terza fase del programma e, successivamente, è stata concordata una
bozza condivisa del nuovo Accordo che, tra
le novità principali, prevede che la cancellazione del debito riguardi le
somme effettivamente trasferite dal fondo del programma (Fondo di contropartita
in valuta locale) ai conti ufficiali dei Ministeri competenti, su base annuale.
5.
UNIVERSITÀ
ITALO-EGIZIANA. La DGCS ha prontamente assicurato il proprio sostegno
per istituzione dell'Università Italo-egiziana attraverso un'intesa con il
Gruppo di lavoro congiunto per l'Università Italo-Egiziana, in modo da
assicurare la disponibilità finanziaria a sostenere i costi iniziali di quanto
previsto, per parte italiana, con l'Accordo intergovernativo del 12 maggio 2009
(mobilità e stipendi personale docente italiano e contributo per la creazione
di programmi). Inoltre, la DGCS ha già rappresentato alle controparti la
disponibilità ad attingere alle risorse del programma di Conversione del Debito
o dai fondi del Commodity Aid. Il Ministero dell’Istruzione Superiore egiziano
sta completando le procedure per l’acquisizione del terreno e, nel gennaio
2012, ha convocato un primo incontro con investitori ed esponenti di imprese
italiane ed egiziane in previsione del bando di gara per il coinvolgimento del
settore privato.
6.
ALTRE INIZIATIVE
- Settore ambientale e risorse naturali. Si è
appena concluso l’importante seconda fase del Programma ambientale
nell’ambito del quale una componente è volta al sostegno e allo sviluppo
delle Aree protette. La DGCS finanzia con circa 9 milioni di euro il
progetto con l’assistenza all’Agenzia egiziana per l’Ambiente. La consegna
ed apertura al pubblico del Visitor Center di Medinet Madi, componente
culturale del Programma, si è svolta alla presenza del Ministro delle
Antichità Zahi Hawass.
- Trasporti. È in corso il programma triennale a
sostegno della ristrutturazione del sistema ferroviario egiziano da 4,8 ME
(dono), consistente nell’affiancamento di un team di esperti delle
Ferrovie dello Stato italiane (FS) al management dell’Egyptian National
Railways.
- Patrimonio culturale. Sosteniamo il
sistema museale egiziano con un progetto da 1,3 milioni di euro per
assistenza tecnica fornita dal MiBAC. Un ulteriore contributo di circa 600
mila euro è stato destinato alla
Biblioteca Alessandrina, per la creazione, tramite UNESCO, di
laboratori di restauro di manoscritti antichi e di libri rari. La DGCS ha
inoltre accolto la richiesta egiziana di assistenza tecnica per la
formulazione dei termini di riferimento per il lancio di una gara
finalizzata all’elaborazione di uno studio dell’area del vecchio Teatro
dell’Opera del Cairo.
- ONG. Finanziamo tre progetti delle ONG COSPE e
VIS per un importo totale di 2,6 ME. I progetti delle due ONG riguardano
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale nel governatorato di Giza e
nella capitale e la salvaguardia ambientale.
Visite istituzionali
Þ
Visita
del Presidente della Repubblica Araba d’Egitto Hosni Mubarak (Roma, 9-11 febbraio 2009)
Þ
Visita del
Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi (Egitto, 12 maggio 2009)
Þ
Visita del Ministro degli Affari Esteri On. Franco Frattini (Egitto, 12 maggio
2009)
Þ
Visita del Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali On. Luca Zaia
(Egitto, 30 settembre 2009)
Þ
Visita del Presidente della Repubblica Araba
d’Egitto, Hosni Mubarak (Roma, 17-18 ottobre 2009)
Þ
Visita
del Ministro degli Affari Esteri On.
Franco Frattini (Egitto,15-16 gennaio 2010)
Þ
Visita
del Segretario Generale Giampiero Massolo
(Egitto, 13-14 aprile 2010)
Þ
Visita
del Ministro dell’Interno, Roberto Maroni (Egitto, 5 maggio 2010)
Þ
Vertice bilaterale Italia-Egitto (Roma,
19 maggio 2010) a cui hanno partecipato: il Presidente della Repubblica
Araba d’Egitto Hosni Mubarak, il
Ministro degli Esteri Ahmed Aboul Gheit,
il Ministro per la Cooperazione Internazionale Fayza Aboulnaga, il Ministro dell’Agricoltura Amin Abaza, il Ministro del Commercio e dell’Industria
Rachid Muhammad Rachid.
Þ
Visita
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli (Egitto, 20-21 luglio 2010)
Þ
Visita
del Sottosegretario agli Esteri, On.
Stefania Craxi (Egitto, 19-21 ottobre 2010)
Þ
Incontro
del Ministro degli Affari Esteri On.
Franco Frattini con il Ministro del Commercio e dell’Industria Rashid Mohamed Rashid (Roma, 26 gennaio
2011)
Þ
Visita
del Ministro degli Affari Esteri On.
Franco Frattini (Egitto, 22 febbraio 2011)
Þ
Visita
del Ministro degli Affari Esteri Nabil El
Araby (Roma, 17 maggio 2011)
Þ
Visita
del Ministro dell’Ambiente egiziano George
Maged (Roma, 2 giugno 2011)
Þ
Visita
del Segretario Generale Giampiero Massolo
(Egitto, 2-4 ottobre 2011)
Þ
Visita
del Ministro degli Affari Esteri Amb.
Giulio Terzi di Sant’Agata (Egitto, 19 gennaio 2012)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DÌ SICUREZZA
Ufficio VIII
Visita
in Egitto del Presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei
Deputati, On. Stefano Stefani
(6-8
marzo)
Egitto. Partiti politici.
Nonostante abbiano partecipato alle elezioni
legislative oltre 40 partiti politici, il panorama attuale si suddivide ormai,
principalmente, nelle seguenti formazioni.
1. Freedom and Justice. Il Partito dei
Fratelli Musulmani è stato il grande vincitore delle elezioni parlamentari,
diventando il primo partito politico del Paese (nonostante queste siano state
le prime elezioni in cui è stata ufficialmente consentita la partecipazione dei
Fratelli Musulmani, che partecipavano in precedenza come candidati
indipendenti). Freedom and Justice ha conquistato il 48,5% dei seggi
all’Assemblea del Popolo ed il 59% al Consiglio della Shura.
I leader del movimento (nato nel maggio del
2011), consapevoli dei timori che la natura islamista del partito suscita
all’estero, hanno cercato di accreditare un’immagine più moderata presso
l’opinione pubblica. Essi affermano di voler sostenere la laicità dello Stato
in Egitto, nel senso che le istituzioni non debbano essere governate né da
militari né da teocratici, fermo restando l’intoccabile principio (peraltro
accettato anche dal resto del mondo politico egiziano, inclusi i partiti laici)
che la Sharia sia fonte primaria del diritto. Il programma del partito prevede
il riconoscimento e la tutela della libertà di culto, e Freedom and Justice –
come il resto degli schieramenti politici – ha aderito alla carta dei diritti
fondamentali promossa dall’Università di Al Azhar, che riprende questo
imperativo.
Freedom and Justice vorrebbe abolire il
sistema presidenziale e stabilire un sistema di Governo che preveda
l’accentramento dei poteri di indirizzo politico nelle mani del Presidente del
Consiglio e in cui il Presidente della Repubblica avrebbe funzioni
prevalentemente simboliche.
2. Al Nour. Principale partito dei Salafiti,
che persegue l’obiettivo della creazione di uno Stato che si basi sui principi
della Sharia quale guida principale per la vita politica, economica e sociale
dell’Egitto. La formazione politica ha riscosso un notevole consenso elettorale
(26% all’Assemblea del Popolo, 25% al Consiglio della Shura), facendo emergere
timori per le possibili conseguenze di un eventuale sodalizio con il partito
dei Fratelli Musulmani.
3. Al WAFD. Il più antico fra i partici
politici egiziani, ha svolto un ruolo fondamentale nella vita politica
dell’Egitto per molti decenni, prima della rivoluzione del 1952. È un partito
laico ma conservatore, che conta anche diversi ex membri del PND, partito di
Mubarak sciolto a seguito della caduta del regime. Il partito si è assestato
come terzo partito egiziano a seguito delle elezioni, in cui ha raccolto quasi
l’8% dei consensi sia per l’Assemblea del Popolo che per il Consiglio della
Shura.
Sebbene non vi siano alleanze formali di Al
WAFD con il partito dei Fratelli Musulmani, sembra tuttavia essersi innescato
un processo di positiva collaborazione, che consente ad Al WAFD di svolgere
un’azione moderatrice sul primo schieramento egiziano.
4. Free Egyptians. Insieme al Social
Democratic Party ed al partito Tagammu, Free Egyptians è una delle anime
dell’Egyptian Block, che ha ottenuto circa il 7% all’Assemblea del Popolo e
poco più del 4% al Consiglio della Shura. Si tratta di un partito liberale,
laico, fondato da Naguib Sawiris nell’aprile scorso, cui fanno parte molte tra
le principali figure imprenditoriali egiziane e che rappresenta il partito più
orientato verso la difesa del capitalismo e del liberismo in Egitto.
5. Social Democratic Party. Il SDP è il
partito che ha riunito le principali figure – laici e progressisti – protagoniste
della Rivoluzione. Partito progressista che si propone l’instaurazione di
principi di libero mercato, pur riconoscendo la necessità di maggiore giustizia
sociale, esso sostiene la creazione di uno stato laico, moderno e democratico
che riconosca i diritti umani dell’individuo e le libertà fondamentali,
ispirandosi dichiaratamente al Partito Democratico statunitense ed al Labour
britannico.
6. Tagammu. Uno dei partiti storici, fondato
nel 1976, ha perseguito per anni l’instaurazione di una società socialista in
Egitto ma ha poi moderato la sua posizione avvicinandosi al PND (partito
dell’ex Presidente Mubarak). Sostegno per molto tempo da operai ed
intellettuali, ha perso molto del suo seguito.
§ Rappresentanze
diplomatiche
|
Ambasciatore dell’Egitto a Roma: Mohamed Farid Mohamed
Monib (dal 25/05/2011)
Ambasciatore d’Italia al Cairo: CLAUDIO PACIFICO (dal 1° settembre 2007)
Si segnala che l’on. Gennaro Malgieri, Presidente
della Parte italiana del Gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Egitto
(su cui si veda infra), è stato incaricato dal Presidente della Camera di
coordinare i rapporti tra la Camera ed i Parlamenti dei Paesi arabi che si
affacciano sul Mediterraneo.
§ Incontri del
Presidente
|
Il 13 aprile 2010, Presidente della
Camera, on. Gianfranco Fini, ha ricevuto la visita dell’allora Presidente
dell’Assemblea del Popolo d’Egitto, Ahmed Fathi Sorour. All’incontro, cui ha
partecipato l’on. Gennaro Malgieri, era presente anche Mohamed Aboul Enein,
allora Presidente della Commissione per l’Industria e l’Energia dell’Assemblea
del Popolo.
Il Presidente
della Camera, on. Gianfranco Fini, si è recato in visita ufficiale in
Egitto il 22 e 23 febbraio 2009.
Il Presidente
Fini, la cui presenza nella riunione plenaria dell’Assemblea del Popolo è stata
salutata calorosamente dai parlamentari egiziani, ha avuto colloqui con i
massimi livelli istituzionali egiziani.
In occasione
dell’incontro con l’allora Presidente dell’Assemblea del Popolo egiziano, Ahmed Fathi Sorour, è stato firmato dai
due Presidenti un Memorandum aggiuntivo al Protocollo di collaborazione
parlamentare (vedi infra) con
l’obiettivo di intensificare le relazioni bilaterali e approfondire il reciproco
coordinamento nelle sedi multilaterali
Il Presidente
della Camera, on. Gianfranco Fini,
ha incontrato a Roma, il 16 dicembre
2008, l’Ambasciatore italiano al Cairo,
Claudio Pacifico.
Il Presidente
della Camera, on. Gianfranco Fini,
ha incontrato a Roma, il 26 novembre
2008, allora Presidente dell’Assemblea del Popolo della Repubblica Araba
d’Egitto, Ahmed Fathy Sorour, accompagnato
dall’allora Presidente della Commissione per l’Industria e l’Energia
dell’Assemblea del Popolo, Mohamed Aboul
Enein, che era altresì Presidente della parte egiziana del Gruppo di
cooperazione Italo-egiziano (cfr. infra). All’incontro
ha partecipato anche l’on. Gennaro
Malgieri Presidente della parte italiana del Gruppo di cooperazione
Italo-egiziano (cfr. infra)..
Il Presidente
della Camera, on. Gianfranco Fini,
ha incontrato a Roma, il 5 giugno 2008, l’allora Presidente della
Repubblica Araba d’Egitto, Hosni Mubarak.
|
§
Incontri delle Commissioni
|
Il 21
ottobre 2011, l’on. Gennaro Malgieri,
che ha l’incarico di coordinare in via
generale i rapporti tra la Camera e i Paesi arabi che si affacciano sul
Mediterraneo, ha incontrato presso l’Ambasciata della Repubblica Araba
d’Egitto a Roma, l’Ambasciatore
Mohamed Farid Mohamed Monib. Al
centro del colloquio i nuovi assetti dell’Egitto, la situazione dei cristiani
copti e i possibili sviluppi della primavera araba.
Il 23
gennaio 2009, l’on. Malgieri ha
invitato gli ambasciatori dei Paesi arabi presso lo Stato italiano ad una
colazione di lavoro. All’evento ha partecipato l’allora ambasciatore d’Egitto, Ashraf Rashed, che precedentemente, il 23 dicembre 2008, era stato ricevuto
dall’on. Malgieri. In tale occasione si era proceduto ad uno scambio di idee
sui temi al centro della prossima riunione del Gruppo di collaborazione
parlamentare Italia-Egitto.
Il 19 ottobre 2010 il Presidente della
Commissione Esteri, on. Stefano Stefani
ha incontrato l’Ambasciatore Wafaa Bassim, Capo di Gabinetto del Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Araba d’Egitto.
Il Presidente
della Commissione Esteri, on. Stefano
Stefani, ha incontrato a Roma, il 25
settembre 2008, l’allora ambasciatore egiziano Ashraf Rashed.
§
Il Protocollo di cooperazione parlamentare e il
Memorandum d’intesa
|
La Camera dei deputati e l’Assemblea del Popolo
egiziano hanno firmato un Protocollo di collaborazione il 10 marzo 1999. Tale protocollo, che ricalca nello schema in parte
quelli firmati con l’Assemblea del popolo algerina ed il Parlamento tunisino e
che costituisce lo strumento più
importante cui la Camera dei deputati italiana ricorre per sancire una cooperazione bilaterale rafforzata,
prevede un dialogo politico più intenso a livello di Commissioni, lo scambio
periodico di visite di studio da parte di funzionari parlamentari, dedicate a
temi specifici di comune interesse e correlate ad iniziative culturali.
Il Protocollo prevede altresì la costituzione di un
Gruppo di cooperazione parlamentare
tra le due Assemblee. Nella XVI
legislatura, il Gruppo è presieduto dall’on. Gennaro Malgieri (che ricopre anche l’incarico di Coordinatore delle attività di cooperazione parlamentare con i Paesi arabi del
Mediterraneo), e dagli onorevoli Nicolò Cristaldi, Sergio D’Antoni, Eugenio
Mazzarella, Giuseppe Naro, Souad Sbai, Guido Dussin.
La parte
egiziana era presieduta dall’on. Mohamed
Aboul Enein, allora Presidente del Comitato industria ed energia
dell’Assemblea del Popolo egiziana. Gli altri componenti della parte egiziana del Gruppo di collaborazione erano
i deputati: Mohamed Aboul Abaza, Mostafa Ahmed Korashy, Hani Mamdouh Sorour,
Amin Abdel Hamid Radi, Hisham Mostafa Khalil, Ahmed Abdel Aziz Shoubeir,
Iskandar Gulrguis Ghattas, Khaled Ahmed Khairy e Siada Elham Greis.
La V riunione del Gruppo di cooperazione
parlamentare si sarebbe dovuta tenere a Roma, l’11 maggio 2010 ma è stata
annullata il giorno prima dalla delegazione egiziana per sopravvenuti impegni
istituzionali.
Si ricorda che la
riunione era stata posticipata in due occasioni, nel maggio e nel novembre
2009, su richiesta della parte egiziana per sopraggiunti impegni istituzionali.
L’ultima riunione del Gruppo di cooperazione si è
svolta, durante la XV legislatura, al Cairo dal 3 al 5 giugno 2007 (cfr. infra).
In occasione della visita ufficiale in Egitto del
Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, il 23 febbraio 2009 (su cui cfr.
supra), è stato firmato un nuovo Memorandum
d’intesa che rilancia gli strumenti di dialogo e di coordinamento e
stabilisce che il Gruppo di cooperazione parlamentare, istituito ai sensi del
Protocollo del 1999, si costituisce in Alto
Comitato Congiunto di Coordinamento per lo svolgimento periodico della
Giornata parlamentare prevista dal medesimo Protocollo.
L'Alto Comitato si adopererà per aumentare il
livello delle attività interparlamentari e consultarsi in merito alle questioni
regionali ed internazionali di comune interesse. Sarà compito dell’Alto
Comitato monitorare i progressi realizzati nel contesto della cooperazione
bilaterale, soprattutto nel settore economico e culturale, ed esaminare le
possibilità di consolidare il quadro generale di cooperazione esistente. Il
documento prevede, inoltre, che le Parti si consultino in merito alle questioni
in agenda dell’AP-UpM e prevedano di incrementare le occasioni di incontro, in
particolare, a livello di commissioni omologhe.
Nella XV legislatura,
il Gruppo di cooperazione parlamentare è stato presieduto, per la parte
italiana, dal Presidente della Commissione Affari esteri, on. Umberto Ranieri.
Gli altri componenti
della parte italiana del Gruppo di collaborazione, per la XV legislatura,
erano i deputati Tana de Zulueta, Presidente di turno della Commissione Cultura
dell’APEM, Khalil detto Alì Rashid, Alessandro Forlani, Leoluca Orlando,
Patrizia Paoletti Tangheroni, Giacomo Stucchi, Nicola Tranfaglia e Adolfo Urso.
La IV
riunione del Gruppo si è tenuta al Cairo
dal 3 al 5 giugno 2007 ed ha
riguardato i seguenti temi:
·
iniziative per il rafforzamento dell’interscambio e
della cooperazione in campo economico tra Italia ed Egitto, con particolare
riferimento ai settori delle infrastrutture, dei trasporti, degli investimenti
commerciali, del turismo e dell’energia;
·
cooperazione nel settore dell’istruzione scolastica
ed universitaria: esperienze a confronto e prospettive di interscambio. La
proposta di istituire una Università italo-egiziana;
·
le sfide del Mediterraneo ed il ruolo della
diplomazia parlamentare, con particolare riguardo alla situazione dell’area
medio-orientale, al Libano ed al Darfur, alle iniziative per la lotta al
terrorismo internazionale e per il contrasto alla proliferazione di armi
nucleari;
·
la
cooperazione parlamentare tra Italia ed Egitto, anche alla luce della comune
partecipazione in fori internazionali quale l’Assemblea parlamentare
euro-mediterranea, ed il ruolo delle donne nei processi decisionali.
Nella XIV legislatura, il Presidente della
Camera aveva designato quale Presidente del Gruppo il Presidente della
Commissione Difesa, on. Luigi Ramponi (AN), dato il particolare rilievo che le
tematiche della sicurezza nel Mediterraneo rivestono in tale Gruppo di collaborazione.
Erano stati inoltre chiamati a farne parte gli Onorevoli Giovanna Bianchi
Clerici, Laura Cima, Alessandro De Franciscis, Rodolfo De Laurentiis, Giovanna
Grignaffini, Angela Napoli, Manlio Collavini, Giuseppe Cossiga, Patrizia
Paoletti Tangheroni, Adriano Paroli e
Umberto Ranieri.
La parte egiziana era presieduta dall’on.
Amal Osman, allora vice Presidente dell’Assemblea del Popolo egiziana.
La prima riunione
del Gruppo si è tenuta a Roma, il 24 e 25 giugno 2002, ed è stata
dedicata a due tematiche:
- dialogo tra
le culture;
- sicurezza nel
bacino mediterraneo.
Il Gruppo è
tornato a riunirsi al Cairo, il 10 e 11 giugno 2003 ed ha dedicato i
lavori alle seguenti tematiche:
- la sicurezza
e la pace nel Mediterraneo;
- il ruolo
europeo nello sviluppo delle economie dei Paesi a Sud del Mediterraneo;
- il rispetto
reciproco tra le culture europee e mediterranee.
Il 26 e 27 maggio 2004, si è tenuta a Roma
la III riunione del Gruppo che si è articolata in due sessioni dedicate
rispettivamente a:
- Strategie di
contrasto del terrorismo internazionale;
- Iniziative di
tutela dell’ambiente mondiale.
|
§
Cooperazione
multilaterale
|
Dall’11
al 13 settembre 2009 si è tenuta presso la Camera l’ottava riunione dei Presidenti delle Camere G8.
Alla
riunione hanno preso parte i Presidenti delle Camere basse di Canada, Francia,
Germania, Italia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti d'America, nonché il
Presidente del Parlamento europeo.
Nell’ambito
dei lavori, una sessione si è svolta,
per la prima volta, allargando la partecipazione ai Presidenti delle omologhe
Assemblee di alcuni Paesi emergenti (Brasile, Cina, Egitto, India e Sud Africa). Per l’Egitto ha partecipato l’allora Presidente dell’Assemblea del Popolo, Ahmed Fathi Sorour. L'incontro,
svoltosi nel pomeriggio del 13 settembre,
ha avuto per oggetto il contributo dei Parlamenti nella lotta al traffico della
droga e al crimine organizzato. Sull'argomento ha riferito il Sottosegretario
generale delle Nazioni Unite, nonché Direttore esecutivo dell'Ufficio ONU
contro la droga e il crimine, Antonio Costa.
L’Egitto prende parte alla cooperazione
parlamentare nell’ambito del Partenariato
euro mediterraneo e all’Assemblea
Parlamentare dell’Unione per il
Mediterraneo (AP-UpM), la cui presidenza
di turno è stata esercitata, per il periodo marzo 2010-marzo 2011, dal Parlamento italiano. Attualmente la
Presidenza è passata al Presidente della Camera dei Rappresentanti del Regno
del Marocco. Mohammad Abdul Enein era Presidente della Commissione economica e
finanziaria.
In tale veste, Enein aveva ospitato una riunione
della Commissione economica il 19 novembre 2009, cui ha partecipato l’on.
Sergio D’Antoni. Il giorno successivo, il 20 novembre 2009, l’Assemblea del
popolo d’Egitto ha ospitato la riunione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Si ricorda altresì
che l’allora Presidente Sorour aveva esercitato la Presidenza di turno dell’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea (che
ha modificato il nome in AP-UpM a marzo 2010, in occasione della Plenaria di
Amman) per il periodo marzo 2004-marzo
2005 ed aveva ospitato al Cairo le prime due riunioni dell’Ufficio di
Presidenza dell’APEM, rispettivamente il 30 giugno 2004 e il 24 novembre 2004,
e la Sessione plenaria dal 12 al 15
marzo 2005.
L’allora Presidente della Commissione Economica e finanziaria
dell’AP-UpM, Abul Enein, aveva partecipato al Bureau allargato dell’AP-UpM, organizzato dalla Presidenza
italiana il 12 novembre 2010 e il 21 gennaio 2011 a Roma.
All’ultima Sessione
plenaria dell’Assemblea, svoltasi a Roma
il 3-4 marzo 2011, la delegazione egiziana non ha partecipato.
L’Egitto partecipa altresì all’Assemblea Parlamentare
Mediterranea[5], la cui Sessione inaugurale si è svolta ad Amman
il 10 e 11 settembre 2006 sotto l’egida dell’Unione interparlamentare.
Nell’ambito della sessione Plenaria del
28-20 ottobre 2010 svoltasi in Marocco
era stato eletto a Presiedere l’Assemblea l’on. Mohammad Abul Enein,
successivamente sostituito da Abdelwahed Radi (allora
Presidente della Camera dei Rappresentanti del Regno del Marocco e attuale
Presidente dell’Unione Interparlamentare), e poi dal giordano Fayez
al-Tarawneh.
L'Italia ha
ospitato a Palermo, nell’ottobre 2011, la sessione plenaria dell'Assemblea.
L'Assemblea del Popolo della Repubblica Araba
d'Egitto ha ospitato inoltre ad Alessandria,
del maggio 2000, la Conferenza dei
Presidenti dei Parlamenti euromediterranei. Insieme ai Presidenti delle
Camere basse di Spagna, Tunisia e Italia, l’Assemblea d’Egitto fa parte del Gruppo di collegamento, ovvero, un
nucleo di coordinamento interno alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti,
la cui ultima riunione è stata ospitata dal Congresso spagnolo a Madrid il 27
giugno 2005 in vista della V
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti euromediterranei che si è tenuta a
Barcellona il 25 e 26 novembre 2005.
L’Assemblea egiziana faceva altresì parte del Comitato di coordinamento del Forum euromediterraneo delle donne parlamentari, insieme a
Tunisia, Italia, Marocco, Spagna, Regno Unito, Parlamento europeo. La quarta riunione del Forum si è tenuta in Giordania
nell’ottobre 2003. Successivamente, a seguito della creazione della Commissione
per i diritti della donna nel Mediterraneo, nell’ambito dell’APEM, il Forum non
è tornato a riunirsi (si ricorda, a tale riguardo che la Presidente di turno
del Forum, la senatrice francese Gauthier, ha partecipato alla riunione
inaugurale dell’allora Commissione ad hoc
per i diritti della donna ed è stata invitata a quelle successive).
Il 14 e 15
dicembre 2009, si è tenuta al Cairo
la Conferenza mediterranea organizzata
dall’OSCE, cui ha partecipato l'on. Riccardo Migliori, Presidente della
Delegazione, e l'on. Matteo Mecacci.
§ Cooperazione
amministrativa
|
L’allora Presidente dell’Assemblea del Popolo
dell’Egitto, Fathy Sorour, il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Libano,
Nabih Berry, ed il Presidente del Consiglio dei rappresentanti del Parlamento
iracheno, Ayad Al Samara’i, avevano inviato – rispettivamente in data 9
febbraio, 10 febbraio e 19 febbraio 2010 - una lettera con la quale manifestano
al Presidente Fini l’interesse delle rispettive Assemblee parlamentari ad
intensificare ulteriormente i rapporti in materia di strumenti tecnici ed
amministrativi a sostegno dell’attività parlamentare. Nella lettera si fa
riferimento alla promozione di iniziative di formazione e di scambio di esperienze tra funzionari ed
anche tra parlamentari dei rispettivi Paesi, nell’ambito del progetto
predisposto dall' IPALMO (Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i paesi
dell'Africa, dell'America Latina e del Medioriente) e dall’IDLO (International
Development Law Organization) a favore dei Parlamenti di Egitto, Iraq e Libano,
in materia di “Rafforzamento del ruolo del Parlamento nella gestione dei costi
sociali delle riforme economiche e per la promozione dell’e-Parliament”.
In tale contesto si segnalano le seguenti iniziative:
-
dal 7 all’8 giugno 2011 a Beirut si è svolto il
Workshop sul tema, al quale hanno partecipato, per la Camera dei deputati
italiana, l’on. Antonino Foti per la Commissione Lavoro, e l’on. Lino Duilio
per la Commissione Bilancio.
-
dall’11 al
13 luglio 2011 la Camera dei
deputati ha ospitato una visita di studio per delegazioni provenienti dalle
istituzioni di Egitto, Giordania, Iraq e Libano, nell'ambito del citato
programma. Nel corso della visita si sono svolti un Seminario ed incontri con
le Commissioni e con gli uffici. All'evento hanno partecipato: il Presidente
della Commissione Bilancio, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della
Commissione Lavoro, Silvano Moffa, la Commissione Affari esteri e il suo
Presidente, Stefano Stefani, gli onorevoli Donato Bruno e Roberto Zaccaria,
rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione Affari
Costituzionali, nonché i deputati Sergio D'Antoni, Antonino Foti e Lino Duilio.
§ Unione
Interparlamentare
|
All’interno dell’Unione interparlamentare opera una
sezione bilaterale di amicizia Italia-Egitto,
presieduta dall’on. Marilena Samperi e composta dagli onn. Emerenzio BARBIERI,
Claudio D’AMICO, Donatella FERRANTI,
Angela NAPOLI, Osvaldo NAPOLI,
Antonio RAZZI e dal senatore Gianpiero D’ALIA.
Le relazioni tra
l’Unione europea e la Repubblica araba di Egitto sono disciplinate dall’Accordo
euromediterraneo di associazione firmato il 25 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1° giugno 2004.
L’Accordo è stato firmato nel quadro del Partenariato euromediterraneo, poi
evolutosi nell'Unione per il Mediterraneo (approvata dal
Consiglio europeo del marzo 2008), con l’obiettivo di rilanciare e rendere più
visibili le relazioni dell'UE con i partner della regione mediterranea[6].
Come gli altri
accordi dello stesso tipo[7], l’Accordo euromediterraneo stabilisce
un’associazione tra UE, Stati membri ed Egitto con l’obiettivo di rafforzare i
legami esistenti, instaurando su basi equilibrate relazioni fondate sulla reciprocità,
la compartecipazione e il co-sviluppo nel rispetto dei principi
democratici e dei diritti umani.
L’Accordo prevede
importanti concessioni in materia commerciale, con l’obiettivo di una
reciproca e progressiva liberalizzazione
degli scambi di beni agricoli e industriali, nonché previsioni su libertà di
stabilimento, liberalizzazione dei servizi, libera circolazione dei capitali e
concorrenza.
L’Accordo copre anche
aree diverse da quelle economiche e commerciali, prevedendo
l’istituzionalizzazione di un dialogo
politico intensificato e la cooperazione scientifica, tecnologica e
culturale nonché in materia di giustizia e affari interni. A questo proposito
un importante capitolo è riferito al tema della migrazione, includendo aree
quali migrazione legale, integrazione dei cittadini egiziani che vivono
legalmente nell’Unione, ricongiungimento familiare e armonizzazione dei sistemi
di sicurezza sociale.
Il dialogo politico regolare tra UE e Egitto si svolge
nell’ambito del consiglio di
associazione, costituito da un lato da membri del Consiglio e della
Commissione e dall’altro da membri del Governo egiziano[9]. E’ previsto
inoltre un comitato d’associazione,
che si riunisce a livello di funzionari, con il compito di seguire
l’applicazione dell’accordo e preparare le riunioni del consiglio di
associazione.
Si segnala che
l’Egitto ospita la sede della “Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il
dialogo fra le culture” istituita per promuovere il dialogo tra civiltà e
culture dalla VI Conferenza
ministeriale euromediterranea di Napoli del 2 e 3 dicembre 2003.
A partire dal 2003 le
relazioni tra Unione europea ed Egitto si svolgono anche nel contesto della politica europea di vicinato inaugurata dalla Commissione con l’obiettivo di
prevenire l’emergere di nuove linee di divisione tra l’Unione europea allargata
e i suoi vicini, condividendo con questi ultimi i benefici dell’allargamento e
consentendo loro di partecipare alle diverse attività dell’UE, attraverso una
cooperazione politica, economica e culturale rafforzata.
Nell’ambito della
PEV, il 6 marzo 2007, in occasione del Consiglio di associazione UE-Egitto è
stato approvato il piano d’azione per
l’Egitto, della durata di 5 anni, che individua gli
obiettivi strategici della cooperazione politica ed economica bilaterale e mira
al contempo a favorire l’applicazione dell’Accordo di associazione. Nelle
intenzioni della Commissione l’attuazione del piano di azione dovrebbe contribuire
in maniera significativa al ravvicinamento della legislazione, delle norme e
degli standard del paese a quelli
dell’UE.
Il piano
d’azione prevede, in particolare, il rafforzamento della democrazia, della
legalità e dei diritti umani, l’attuazione di riforme socio-economiche, il
miglioramento dell’ambiente economico e la riduzione della povertà, la
risoluzione pacifica dei conflitti; gli aspetti inerenti alla giustizia ed alla
sicurezza, compresa la gestione delle frontiere; la cooperazione regionale ed
il ravvicinamento della legislazione in molti settori, inclusi energia e
trasporti.
Dall’inizio della crisi, l’UE ha difeso i diritti degli egiziani di
dimostrare pacificamente e condannato l’uso della forza da parte delle autorità.
Immediatamente dopo la partenza dell’ex Presidente Mubarak e in risposta alle
aspirazioni del popolo egiziano al rispetto dei diritti civili, politici e
socio-economici, l’UE ha istituito un
pacchetto di 20 milioni per la società civile. Inoltre, alla luce delle
nuove circostanze, l’assistenza prevista nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI - vedi infra) per il periodo 2011-2013 è stato rivisto: per il 2011 sono stati approvati programmi per un valore
di 132 milioni di euro e per il 2012 sono già in avvio iniziative per 95
milioni di euro. I programmi 2011 hanno sostenuto il miglioramento delle
condizioni di vita nelle aree povere del Cairo, gli scambi e la crescita
economica (e la conseguente creazione di posti di lavoro), le piccole e medie
imprese, la riforma dei settori dell’energia e dell’acqua.
L’UE ha anche offerto
missioni di osservazione elettorale in occasione delle elezioni parlamentari e
presidenziali, che le autorità egiziane hanno rifiutato, accettando invece il
sostegno di 2 milioni di euro offerti dall’UE nell’ambito dello strumento di
stabilità per assistere l’Alta commissione elettorale nel suo lavoro. L’UE ha anche inaugurato dialoghi
preparatori al Cairo per un partenariato della mobilità; per integrare
progressivamente l’economia egiziana nel mercato unico europeo e migliorare
l’accesso dei prodotti egiziani al mercato europeo si sta preparando inoltre
l’avvio dei negoziati su un’area di libero scambio non appena il paese sarà
pronto. In tutti e due i casi, come dichiarato dalle
autorità egiziane, gli impegni potranno essere assunti soltanto quando sarà in
carica un nuovo governo eletto dai cittadini. A tale proposito, il Consiglio
affari esteri del 27 febbraio 2012 ha espresso la propria soddisfazione per la
conduzione delle elezioni parlamentari, congratulandosi con i candidati e con
quanti hanno preso parte al processo democratico. Nell’occasione, profonda
preoccupazione è stata espressa per quanto riguarda le recenti violenze e le
restrizioni imposte alle organizzazioni della società civile nonché per il
deterioramento della situazione economica nel paese.
Oltre che con il sostegno ai singoli paesi, l’Unione europea ha
risposto agli eventi della primavera araba con una serie di iniziative di
carattere generale, messe in atto già a partire dall’inizio del 2011, riconoscendo - insieme all’importanza
delle sfide poste dalla transizione politica ed economica della regione - anche la necessità di un nuovo approccio
nelle relazioni con i suoi vicini meridionali.
A tal fine, l'Alto
Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR),
Catherine Ashton, ha istituito una task force volta a riunire il
Servizio europeo di azione esterna e gli esperti della Commissione per adattare
gli strumenti già a disposizione dell’UE al fine di aiutare i Paesi del Nord
Africa. L'obiettivo è quello di fornire un pacchetto completo di misure
adeguate alle esigenze specifiche di ciascun Paese.
La risposta
strategica dell’UE è arrivata già durante il Consiglio europeo dell’11 marzo 2011, quando l’Alto
rappresentante e la Commissione hanno presentato un documento orientativo, volto a proporre
un nuovo partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il
Mediterraneo meridionale. Tale partenariato dovrebbe essere fondato su una
maggiore integrazione economica, un accesso al mercato più ampio e la cooperazione
politica. La comunicazione sottolinea la necessità di sostenere la domanda di
partecipazione politica, dignità, libertà e opportunità di occupazione
proveniente dai popoli della regione e di delineare un approccio basato sul rispetto dei valori universali e su interessi
condivisi. Si propone inoltre il principio del “more for more” in base al quale maggiore assistenza finanziaria, mobilità
incrementata e accesso al mercato unico dell’UE saranno resi disponibili ai
paesi partner più avanzati sulla strada delle riforme.
Tale approccio è
stato ulteriormente elaborato nella comunicazione
“Una nuova risposta ad un vicinato in mutamento” (COM (2011) 313) che l’Alto rappresentante e la Commissione
hanno presentato il 25 maggio 2011
nell’ambito dell’annuale pacchetto sulla politica di vicinato. Secondo quanto
indicato nella comunicazione, i risultati di un’ampia consultazione con le
parti interessate avviata già nell’estate 2010 nonché i recenti avvenimenti nei
paesi del bacino meridionale del Mediterraneo hanno mostrato che il sostegno
dell’UE alle riforme politiche nei paesi vicini ha ottenuto risultati limitati; è emersa dunque la necessità di una maggiore
flessibilità e di risposte più adeguate, in linea con la rapida evoluzione
della situazione nei partner. Su tali basi, l’UE è impegnata nel breve e lungo
periodo ad aiutare i suoi partenr in due
importanti sfide:
·
in primo luogo, costruire una democrazia solida, non
soltanto scrivendo costituzioni democratiche e conducendo libere elezioni, ma
anche creando e sostenendo sistema giudiziario indipendente, libera stampa,
società civile dinamica e tutte le altre caratteristiche di una democrazia
matura;
·
in secondo luogo,
assicurare una crescita economica
inclusiva e sostenibile, senza la quale la democrazia non può attecchire.
Una particolare sfida è rappresentata dalla creazione di nuovi e solidi posti
di lavoro.
Su tali basi, il Consiglio europeo dell’1 e 2 marzo 2012
ha chiesto alla Commissione e all’AR di presentare entro la fine dell'anno una tabella di marcia intesa a definire e
orientare l'attuazione della politica dell'UE nei confronti dei partner del Mediterraneo meridionale, che elenchi
gli obiettivi, gli strumenti e le azioni, concentrandosi sulle sinergie con
l'Unione per il Mediterraneo e altre iniziative regionali. Il Consiglio europeo
ha inoltre ribadito la volontà dell’UE
di far corrispondere l’entità del sostegno economico al livello delle riforme
democratiche, “offrendo maggiori aiuti ai partner che compiono maggiori
progressi verso sistemi democratici inclusivi, riconsiderando il sostegno ai
governi in casi di oppressione o di gravi o sistematiche violazioni dei diritti
umani''.
Dal 1996 al 2006 l’Egitto ha beneficiato dei
finanziamenti del Programma MEDA, finalizzato a fornire assistenza tecnica ai
paesi partner del processo euromediterraneo, con una dotazione finanziaria
globale di 5.350 milioni di euro per il periodo 2000-2006. Tra i paesi
dell'area mediterranea l'Egitto è stato il maggiore beneficiario della
cooperazione finanziaria, ricevendo il
31% totale dei fondi MEDA disponibili per l'intera regione.
A partire dal 2007, nel quadro delle prospettive finanziarie
2007-2013, l’assistenza all’Egitto, come agli altri paesi del partenariato
euromediterraneo, viene fornita attraverso lo strumento europeo di vicinato
e partenariato (anche detto ENPI)
destinato alla frontiera esterna dell’UE allargata[14]. Tale strumento ha sostituito i programmi
geografici e tematici esistenti, compreso il programma MEDA.
Nel quadro dell’ENPI,
per l’intero periodo sono stati destinati all’Egitto oltre 1.000 milioni di
euro concentrati nelle aree seguenti:
·
competitività
e produttività dell’economia;
·
sviluppo
sostenibile e gestione delle risorse umane e naturali, attraverso il
sostegno alle riforme nei settori dell’istruzione e della sanità, che sono
cruciali per lo sviluppo del paese;
·
democrazia,
diritti umani e giustizia, attraverso il sostegno all’agenda politica del
governo egiziano.
Ministro degli Affari Esteri, Mohamed Kamel Amr

Mohamed Kamel Amr nasce il 1 dicembre 1942.
Laureatosi nel 1965 in Economia e Scienze Politiche all’Università di
Alessandria, Kamel Amr intraprende la sua carriera diplomatica come Consigliere
alla Missione Egiziana presso le Nazioni Unite (1982) ed in seguito come
rappresentante egiziano al Consiglio di Sicurezza (1983-1984).
Gli anni dal 1984 al 1997 lo vedono impegnato in un’intensa attività
diplomatica: presta servizio in varie ambasciate egiziane all’estero, fra cui
Addis Abeba, Londra, Pechino e Canberra. Rientrato al Cairo nel 1987, è
responsabile per le Organizzazioni Multilaterali del Gabinetto del Vice Primo
Ministro e Ministro degli Affari Esteri egiziano, prima di trasferirsi
all’Ambasciata egiziana a Washington dal 1989 al 1993. Rientrato al Cairo nel
1993, diventa assistente del Ministro degli Esteri egiziano presso le
Organizzazioni Africane (1993-1995). Dal 1995 al 1997, è ambasciatore d’Egitto
in Arabia Saudita.
Nel 1997, si trasferisce alla Banca Mondiale, dove è Direttore Esecutivo
Supplente e Rappresentate dell’Egitto e dei 13 Paesi arabi.
Il 18 giugno del 2011, sostituisce El Oraby come Ministro degli Affari
Esteri del Governo Sharaf, in virtù della sua decennale esperienza diplomatica
e della sua profonda conoscenza delle questioni di materia economica.

El-Katatny è
nato il 3 aprile 1952. Laureato in Botanica presso l’Università di Assiut,
specializzato in microbiologia. Professore ordinario presso l’Università di
Minia.
Dal 2005 al
2010, El Katatny è stato capogruppo del Partito politico dei fratelli
musulmani; successivamente ha guidato l’Ufficio di Presidenza del Partito.
Quando dal
raggruppamento dei Fratelli Musulmani si è formato il Partito Libertà e
Giustizia, il 30 aprile 2011, El Katatny è stato eletto Segretario generale.
Il 22 gennaio
2012 si è dimesso da tale incarico in vista della sua elezione alla Presidenza
dell’Assemblea del Popolo d’Egitto, avvenuta il giorno successivo con 399 su
503.

Schenuda III (il cui vero nome è Nazīr Jayyid Rūfāīl) è
nato a Salam, nell’Alto Egitto, il 3 agosto 1923. All'età di 16 anni divenne
attivo nel movimento per le scuole domenicali copte e insegnò catechismo, prima nella
chiesa di Sant'Antonio a Shubra e poi nella
chiesa di Santa Maria a Mahmasha.
Dopo la laurea in storia all'università del Cairo lavorò come
insegnante di scuola superiore di lingua inglese e scienze sociali e frequentò di
sera corsi al Seminario teologico copto. Dopo il diploma del seminario
nel 1949 insegnò
studi neotestamentari.
Il 18 giugno 1954 il giovane
Gayed si ritirò a vita monastica nel monastero di al-Suryan
nel deserto occidentale dell'Egitto; assunse il nome di padre Antonyos
al-Suryānī. Per sei anni, dal 1956 al 1962, visse in
solitudine in una grotta a circa sette miglia dal monastero, dedicandosi
alla preghiera, alla meditazione e all'ascesi.
In seguito divenne ieromonaco al monastero
della Theotokos Vergine Maria dei Siriani, col nome di padre Antonio. Durante
un periodo in cui padre Antonio visse in eremitaggio, papa Cirillo VI
di Alessandria lo scelse come vescovo per l'educazione cristiana e decano
dell'università teologica copta ortodossa, e Antonio scelse il nome di Shenuda.
Durante la gestione di Shenuda, il numero degli studenti triplicò.
Shenuda ebbe la consacrazione papale col
nome di Shenuda III, 117º papa di Alessandria e patriarca della sede di San Marco il 14 novembre 1971.
Il 3 settembre 1981 il
presidente egiziano Anwar al-Sadat mandò papa
Shenuda in esilio nel monastero
di San Bishoi. Altri 8 vescovi,
24 preti e numerosi esponenti di spicco della comunità copta furono arrestati.
Sadat rimpiazzò la gerarchia copta con una commissione di 5 vescovi e considerò
Shenuda come "ex papa". Il 2 gennaio 1985, più di tre anni
dopo l'omicidio di Sadat del 1981, il
presidente Hosni Mubarak liberò papa
Shenuda dall'esilio. Rientrato al Cairo, celebrò la messa di Natale il 7 gennaio davanti a
più di 10.000 partecipanti.
Il papato di
Shenuda ha coinciso con l'espansione mondiale della Chiesa copta. Nel 1971 le
chiese copte erano solo 4 in tutto il Nord America mentre ora
sono più di 100 con due vescovi. In Europa più di 50
chiese e 10 vescovi. In Australia vi sono due
vescovi e numerose parrocchie, in Africa 2 vescovi
missionari in 9 paesi africani (Egitto escluso). Vi sono chiese copte anche
nei Caraibi e in Sud America.
Quando l'Eritrea divenne
politicamente indipendente dall'Etiopia, il
presidente Isaias Afwerki impose che
la Chiesa locale si rendesse indipendente dalla Chiesa
ortodossa d'Etiopia, che dipendeva da Alessandria. Papa Shenuda III
ordinò il primo patriarca d'Eritrea col nome di "sua santità patriarca
Filippo I" (Abuna Philipos di Eritrea). Questa fu la seconda ordinazione
di un patriarca da un papa di Alessandria nel XX secolo, poiché la prima
fu quella di papa Cirillo III con il primo catholichos di
Etiopia negli anni sessanta.
Nel 1973 papa
Shenuda fu il primo papa copto a incontrarsi con il papa di Roma
(all'epoca Paolo VI)
dopo più di 1500 anni. Durante la visita i due papi firmarono una dichiarazione
comune sulla cristologia e
si accordarono per ulteriori colloqui in materia di ecumenismo. Ci furono
anche dialoghi con diverse chiese protestanti. L'impegno ecumenico del papa si
è concretizzato nell'ingresso della Chiesa copta in diversi
organismi ecumenici e nella visita a chiese sorelle della tradizione ortodossa,
come Costantinopoli, Mosca, Antiochia.

Ahmed Fahmy, laureato in Farmacia,
specializzato presso l’Università di Tubinga, in Germania, è professore
ordinario presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Zagazig ed è membro
del Consiglio Specializzato Nazionale dell’Unione Generale dei Farmacisti.
Nel 2004 è stato nominato “uomo dell’anno”
dall’istituto di scienze biologiche statunitense per i significativi contributi
nella ricerca scientifica.
Nel 1978 ha aderito al movimento dei
Fratelli musulmani.
Successivamente membro del Partito Giustizia
e libertà è stato eletto alla Presidenza della Shura nella seduta inaugurale,
avvenuta il 28 febbraio 2012, con 175 voti su 180.
Ahmed Fahmy è sposato, ha tre figli e
quattro nipoti.
Nabil El Arabi
 Segretario
Generale della Lega Araba
Segretario
Generale della Lega Araba
Nabil El Araby nasce al Cairo (Egitto) il 15
marzo 1935.
Nel 1955 si laurea in Giurisprudenza presso
l’Università del Cairo. Negli anni successivi compie ulteriori studi nel campo
delle scienze giuridiche, conseguendo nel 1969 un Master in Diritto
Internazionale e nel 1971 un Dottorato in Scienze Giuridiche presso la New York
University Law School.
Nel 1976 comincia la sua lunga ed intensa
carriera diplomatica.
Dopo aver ricoperto, nel 1978, il ruolo di
Consigliere Legale per la delegazione egiziana durante la Conferenza di Ginevra
sul Processo di Pace in Medio Oriente e sugli accordi di Camp David, tra il
1982 e il 1992, arbitra una controversia internazionale relativa al Canale di
Suez presso la Camera di Commercio Internazionale.
Nel corso della sua carriera ricopre numerosi
incarichi in qualità di Consigliere e Direttore giuridico del Dipartimento dei
Trattati e degli Affari Giuridici del Ministero degli Esteri (1976-1978 e
1983-1987).
Gli anni compresi tra il 1978 e il 1999 lo
vedono impegnato in ruoli di grande responsabilità, tra cui quelli di Vice
Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a New York (1978-1981),
Ambasciatore in India (1981-1983), Rappresentante Permanente presso le Nazioni
Unite a Ginevra (1987- 1991), Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite
a New York (1991-1999).
Dal 1990 è impegnato in qualità di giudice
presso il Tribunale Giudiziario dell’OPEC.
Dal 2000 è membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto di Ricerca per la Pace Internazionale di
Stoccolma.
Dal 2000 al 2006 ha ricoperto l’incarico di
Giudice internazionale presso la Corte di Giustizia e, dal 2005 è membro della
Corte Permanente di Arbitrato dell’Aja.
Il 6 marzo 2011 è stato designato Ministro
degli Affari Esteri, incarico che lascia il 1 luglio del 2011 per assumere le
sue funzioni come Segretario Generale della Lega Araba.
Nell’arco della sua carriera è stato
insignito di importanti onorificenze ed è autore di numerose pubblicazioni.
![[Al-Sayed Al-Badawi. Image from bp.blogspot.com]](Es1063_file/image021.jpg)
El-Sayyid el-Badawi Shehata, nato nel 1950, è un
uomo d’affari egiziano. Laureato in Farmacia presso l’Università di
Alessandria, è proprietario e Capo del Consiglio di amministrazione della
televisione egiziana satellitare Al-Hayah. Ha fondato ed è Presidente della
casa farmaceutica Sigma.
Ha aderito al
Partito Wafd in età giovanile, divenendo nel 1983 segretario del partito nella
provincia di Al-Gharbeya. Nel 1989, fu promosso al Consiglio Supremo,
diventando il più giovane membro ai vertici del partito e, successivamente,
Segretario.
Nel 2010 è
stato eletto Presidente del Partito.

Mohammed Badi’ è nato a El-Mahalla
El-Kubra, il 7 agosto 1943.
Laureato in medicina veterinaria al Cairo nel 1965,
nello stesso anno venne arrestato per la prima volta a causa della sua attività
politica nella Fratellanza Musulmana, durante un rastrellamento a
livello nazionale di attivisti. Condannato a 15 anni di carcere da un tribunale
militare, venne liberato sulla parola insieme a quasi tutti gli altri
prigionieri nel 1974 dal nuovo presidente egiziano, Anwar al-Sadat.
Badi’ ha quindi concluso gli studi e ha
iniziato una carriera di insegnamento presso varie università egiziane.
Attualmente continua a lavorare a tempo parziale come professore di patologia
alla scuola veterinaria dell'Università di Beni Suef.
In una recente intervista, all’indomani
delle elezioni legislative, Badi’ ha affermato che “la Sharia è un riferimento costituzionale, non è lo strumento di una
dittatura. Coloro che hanno votato le liste della Fratellanza, i suoi
candidati, lo hanno fatto sapendo perfettamente quale era il programma,
l’identità culturale e l’Islam. La Fratellanza è parte fondamentale della
società egiziana e il voto ne è la conferma. Crediamo nelle riforme graduali
che avvengono in modo pacifico e nel rispetto delle istituzioni. Rigettiamo la
violenza e la denunciamo in tutte le sue manifestazioni”.
Gran Muftì della Repubblica Araba d’Egitto,
Prof. Ali Gomaa Mohamed Abd El Wahab,

Ali Gomaa Mohamed
Abd El Wahab nasce il 03.03.1952 a Beni Suef.
Professore di
Diritto Canonico Musulmano presso la Facoltà degli Studi islamici e Lingua
araba dell’Università di Al Azhar, è dal 2003 Gran Muftì della Repubblica Araba
d’Egitto.
Laureatosi in
Diritto Islamico nel 1979, egli ottiene, rispettivamente nel 1985 e nel 1988,
un Master ed un Dottorato in Diritto Canonico Musulmano presso la Facoltà di
Shariia e Diritto dell’Università Al Azhar.
Membro dal 1995 al
1997 del Comitato del Fatwa di Al Azhar, egli ricopre dal 2000 l’incarico di
Ispettore generale della Moschea di Al Azhar.
Nel 2004 diventa membro del Concilio delle Ricerche islamiche di Al
Azhar, nonché del Consiglio del Fiqh dell’Organizzazione della Conferenza
Islamica (Gedda) e della Conferenza del Fiqh in India.
Il Gran Muftì è
autore di numerose pubblicazioni e svolge un’intensa attività scientifica e
accademica. Esperto all’Accademia di Lingua Araba, ha supervisionato la
redazione di molte enciclopedie, insegna nei circoli dell’Azhar, fa lettura dei
libri del Patrimonio religioso e tiene presso la Moschea del Sultan Hassan il
Sermone del Venerdì. È co-fondatore e membro costituente della facoltà della
Sharia nel Sultanato di Oman. Ha insegnato presso l’Università Islamica
Internazionale in Malesia ed è supervisore di numerosi progetti (economia
islamica, relazioni internazionali, rivalutazione istituzioni bancarie
islamiche) presso l’Istituto superiore del pensiero islamico al Cairo.
Ali Gomaa è
sposato, ed ha tre figlie.
ISPI dossier gennaio 2012
Egitto
un anno dopo: rivoluzione continua
- Background
POLITICA INTERNA
·
Una transizione difficile. A un anno dall’esplosione della rivolta popolare contro
il trentennale governo di Hosni Mubarak, l’ Egitto sta ancora affrontando una
difficile transizione politica dall’esito incerto (l’evoluzione verso un
sistema di tipo democratico non è affatto scontata). All’indomani delle
dimissioni del rais, l’11
febbraio 2011, il Consiglio supremo delle forze armate (Csfa) si è assunto la
responsabilità di guidare il -paese per garantire la continuità del
funzionamento dell’apparato statale e di programmare tempi e fasi della
processo elettorale. Nonostante l’ampio consenso popolare sul quale, in una
prima fase, potevano contare tanto il Csfa quanto il nuovo -governo guidato da
Essam Sharaf, la mancanza di un programma di transizione trasparente, i
tentativi di salvaguardare interessi particolari (su tutti il mantenimento dell’autonomia
finanziaria delle forze armate) e il ricorso sempre più frequente a metodi
autoritari (mantenimento della trentennale legge di emergenza e processi
sommari) ha alimentato un diffuso malcontento unito a un crescente senso di
frustrazione, culminato con l’occupazione di Piazza Tahrir lo scorso novembre.
·
Le divisioni interne. In generale, le difficoltà emerse nel corso degli ultimi
mesi sono state acuite dalla frammentazione della base sociale all’indomani
della caduta del regime. Per un verso, infatti, si è sollecitato il repentino
trasferimento del potere a un’autorità civile democraticamente eletta; per
altro verso le forze liberali e i movimenti giovanili hanno accusato i militari
di aver favorito le forze politiche islamiste rifiutando di posticipare le
elezioni per consentire ai neonati partiti di organizzarsi adeguatamente in
vista delle prime tornate elettorali. Infine, l’emersione di tensioni settarie,
cui ha in parte contribuito la crescente diffusione del salafismo, ha
costituito un’ulteriore elemento di instabilità.
·
Le elezioni parlamentari. Nonostante la vigilia del voto per l’elezione
dell’Assemblea del Popolo (la camera bassa) sia stata segnata da forti tensioni
tanto tra movimenti laici e forze d’ispirazione religiosa quanto tra movimenti
politici e Csfa, le elezioni hanno fatto registrare un’affluenza alle urne
relativamente alta (62% al primo turno; *
al secondo turno, 54% al terzo turno). La nuova Assemblea,
riunitasi per la prima volta il 23 gennaio, è dominata dal partito islamista dei
Fratelli Musulmani ”Libertà e Giustizia”
che ha ottenuto il 47% dei seggi; il secondo partito del Paese, con il 28% dei
seggi, è l’ultra-ortodosso movimento salafita al-Nour (Partito della Luce). Il restante quarto della
camera è diviso tra movimenti liberali, laici e membri indipendenti. Il
risultato elettorale dovrebbe essere confermato anche nell’imminente elezione
dei membri del Consiglio consultivo (la camera alta) che si svolgerà in tre
turni: il 29 gennaio, il 14 febbraio e il 4 marzo.
·
Le coalizioni. L’apertura del sistema politico e il vuoto lasciato dallo
scioglimento del Partito democratico nazionale (Pdn) hanno prodotto un panorama
politico molto frazionato con più di cinquanta partiti che hanno proposto liste
in tutto il paese o solo in alcuni distretti. La coalizione principale è l’Alleanza democratica (Ad); nata a
luglio dall’intesa di numerosi partiti di sinistra, liberali e
islamico-moderati, essa conta al suo interno tre attori principali (oltre ad
otto movimenti minori): Partito libertà e giustizia (Plg), al-Ghad al-Jedid
(“partito del domani”), nato da una costala del partito Wafd, laico e liberale,
e al-Karama (“dignità”), d’ispirazione nazionalista. La seconda formazione per
importanza è il Blocco egiziano,
costituito da: Partito degli egiziani liberi (Pel), Fronte democratico (Fd) e
al-Tagammu. Essi sono a favore del rispetto dei diritti civili e politici,
inclusa la libertà di culto, di uno stato laico basato su una solida
separazione e bilanciamento dei poteri ma differiscono in materia economica.
Molti partiti islamici conservatori che avevano inizialmente valutato la
possibilità di seguire il Plg nell’Ad, hanno invece dato vita a una coalizione
separata, l’Alleanza islamica
a causa di un profondo disaccordo sul ruolo della religione. Questa alleanza,
che riunisce partiti salafiti con un programma politico marcatamente
tradizionalista basato sulla sharia
come fondamento giuridico dello stato, è guidato da al-Nour (che sostiene la
necessità di creare uno status legale separato per i non-musulmani) e Al-Banna’
wa al-Tanmiyya (“Ricostruzione e sviluppo”) che propone addirittura la
reintroduzione delle punizioni corporali tradizionali. Dalla parte opposta
dello spettro politico si trova l’Alleanza
per il completamento della rivoluzione, che riunisce partiti e
movimenti più “radicali”: socialdemocratici, esponenti dei movimenti giovanili
che hanno guidato le manifestazione di piazza e i partiti islamici moderati
come il Partito per la liberazione dell’Egitto, d’ispirazione sufista ma che
conta tra i suoi membri minoranze etniche e religiose, in particolare copti e
armeni. Tra i partiti appartenenti a coalizioni minori o che si presentano
autonomamente spiccano il nazionalista liberale al-Wafd (“Delegazione”) e al-Wasat (”Centro”), islamista moderato
ispirato alla scuola di pensiero liberale wasatiyya.
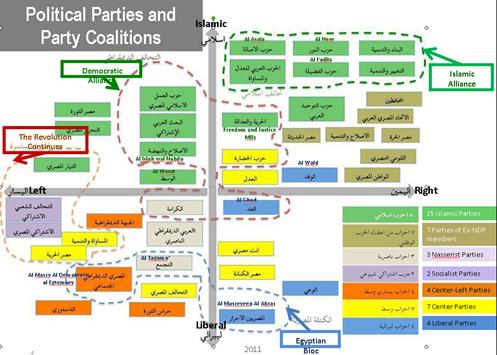
A
cura di Sally Khalifa Isaac (Cairo University)
SITUAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA
·
Povertà. Una delle principali cause alla base dell’esplosione delle
proteste in Egitto è da rintracciare nelle contraddizioni e nelle deficienze
del modello di sviluppo economico e sociale portato avanti dal regime di
Mubarak. Lo sviluppo economico non è stato accompagnato da riforme mirate
all’ottimizzazione della qualità della governance che avrebbero contribuito a
implementare un’efficace ed equa redistribuzione delle risorse del paese. Come
risultato, il tasso di povertà, che nel corso degli anni Novanta era
progressivamente diminuito (dal 24,18% della popolazione nel 1990 al 16,74% nel
2000), durante l’ultima decade ha fatto registrare un continuo aumento sino a
superare, nel corso del 2009, i livelli del 1994/95.
·
Disoccupazione e tagli alla spesa pubblica. Le classi medio-basse sono state colpite dalle politiche
fiscali fortemente restrittive praticate dal governo al fine di ridurre il
deficit e il debito pubblico. I radicali tagli della spesa pubblica – in
particolare, nei settori della sanità, dell’educazione e degli ammortizzatori
sociali – hanno determinato un drastico abbassamento della qualità della vita
di larghe fasce della popolazione. Inoltre, la natura neo-patrimoniale del
regime ha impedito che le liberalizzazioni alimentassero la crescita economica,
con effetti negativi sull’occupazione (all’11,5% nel 2011, contro il 10,4% del
2010, secondo i dati ufficiali, mentre stime non ufficiali danno percentuali
più elevate). Il dato è ancora più significativo poiché interessa i giovani: un
quinto della popolazione complessiva ha un’età compresa tra 15 e 24 anni e,
secondo le stime ufficiali, un quarto di essi è disoccupato.
·
La crescita economica aveva già conosciuto un forte rallentamento tra il 2008 e
il 2009, passando rispettivamente dal 7,2% al 4,7%, principalmente come
conseguenza delle difficoltà economico-finanziarie dei paesi europei,
principali partner commerciali dell’Egitto. La ripresa della crescita economica,
che nel 2010 è stata del 5,1%, ha subito una battuta d’arresto nel 2011 come
conseguenza della crisi politica: secondo le previsioni del Fondo monetario
internazionale essa si attesterà all’1,2%, quattro punti percentuali in meno
rispetto all’anno precedente. Una ripresa dovrebbe verificarsi a partire dal
2012 (1,8%). I settori maggiormente colpiti dalle difficoltà economiche sono:
il manifatturiero e, soprattutto, il turismo. Quest’ultimo nel 2010 aveva
raggiunto un valore complessivo di 12 miliardi di dollari (il 5% circa del
Pil). Secondo le ultime stime, nel corso del 2011 il settore avrebbe subito una
contrazione di circa il 6% rispetto all’anno precedente.
·
La finanza pubblica. Le attuali difficoltà economiche stanno avendo
ripercussioni negative anche sul bilancio dello stato. Alla riduzione delle
entrate causata dalla contrazione economica si è aggiunto un aumento della
spesa pubblica. Il -governo di transizione, nel tentativo di guadagnare
consenso popolare, ha aumentato i salari dei dipendenti pubblici del 20%. Gli
analisti stimano che nel corso dello scorso anno il deficit sia aumentato di
quasi due punti percentuali: dal 8,1% del 2010 al 9,9% del 2011, per un valore
complessivo di circa 24 miliardi di dollari.
·
Il finanziamento del Fmi. Per
uscire dalla situazione di empasse, il governo egiziano tratta da mesi con il
Fmi la concessione di un finanziamento di 3,2 miliardi di dollari. La proposta
è arrivata direttamente dall’organismo internazionale già lo scorso giugno e
adesso si attende una decisione in merito da parte dei neoeletti rappresentanti
politici.
Egitto un anno dopo: rivoluzione continua -
Scenario
A un anno dalla caduta di Mubarak il futuro
politico ed economico dell’Egitto rimane incerto. L’ampia vittoria del -partito
Libertà e Giustizia (Fratelli Musulmani) nelle elezioni per l’Assemblea
nazionale del Popolo e il successo dei salafiti di Al-Nour costituiscono un
primo punto d’analisi nella definizione di alcuni scenari sull’Egitto di
domani.
Scenario 1 – Tra militari e Islam: la lunga
instabilità.
Le recenti elezioni parlamentari lasciano
pochi dubbi sul fatto che la guida del paese spetterà ai Fratelli Musulmani.
Tuttavia rimangono alquanto incerte le alleanze degli stessi – non hanno
ottenuto la maggioranza dei voti – e come questi si relazioneranno con i
militari, riluttanti a cedere potere e privilegi acquisiti in decenni. Allo
stesso modo restano un’incognita i futuri indirizzi politici ed economici del
paese. L’economia e la questione sociale non sembrano giocare a favore di un ritorno
alla stabilità del paese. Ma l’incertezza maggiore è probabilmente relativa a
come i Fratelli Musulmani gestiranno i rapporti con le forze salafite
(radicali), che hanno ottenuto ampi, e per certi versi inaspettati, consensi in
questa prima fase elettorale. Una possibile alleanza tra Fratelli Musulmani e
forze liberali (Partito Wafd) potrebbe offrire alle forze più radicali di
ottenere consenso se il paese non avrà la capacità economica di riprendersi.
Non è quindi possibile escludere il rischio di forti tensioni tra le forze
politiche, di nuove proteste popolari e del perdurare della situazione di
instabilità che il paese vive oggi, con conseguenze sulle già gravi condizioni
dell’economia del paese. L’atteggiamento dei militari, inoltre, rimane essenziale
per comprendere il futuro del paese. A questo proposito, gravi tensioni sociali
potrebbero scaturire dal possibile tentativo (come dimostra l’episodio del c.d.
Selmy Document) del Csfa di preservare la propria competenza esclusiva in
materia di budget della difesa e di mantenere il ruolo di garante ultimo
dell’interesse nazionale egiziano, al di sopra di qualunque possibilità di
supervisione da parte degli organi politici. E ancora, gravi motivi di
contrapposizione tra Csfa e formazioni politiche islamiste (vincitrici delle
elezioni) derivano dalla preoccupazione dei vertici militari che il risultato
delle urne possa incrinare il rapporto strategico con gli Stati Uniti
portandoli a sospendere o a ridurre sensibilmente l’assistenza militare fino ad
oggi garantita (il cui valore è di circa 1,3 miliardi di dollari l’anno). Se a
possibili nuove proteste e sommovimenti sociali i militari rispondessero con
una nuova fase di repressione, si potrebbero innescare nuove spirali di
violenza e verrebbe screditata l’istituzione dell’esercito che, in qualche
misura, ha cercato di avere un ruolo di garante dello stato nella fase di
transizione che ha preso avvio un anno fa. Il risultato, tutt’altro che
improbabile, sarebbe il procrastinarsi di una situazione di instabilità che,
teoricamente, potrebbe portare al collasso economico del paese. Il perdurare di
questa incertezza in Egitto avrebbe ripercussioni non solo a livello interno ma
anche sui fragili equilibri regionali e sulle relazioni con i paesi limitrofi.
Scenario 2 – Un Egitto moderato
Nonostante le incertezze precedentemente
esposte, altre motivazioni fanno presupporre che una linea moderata in Egitto
possa prevalere nel breve termine, rafforzando gli elementi di stabilità del
paese, anziché indebolirli, a lungo termine. Nonostante l’impronta del
wahabismo saudita nel salafismo egiziano, la grande autorità morale e religiosa
che ancora esercita il Grande Imam di Al Azhar, Ahmed Al Tayeb, potrebbe avere
influenze positive sulla stabilità sociale. L’Imam sembra infatti aver optato
per un atteggiamento misurato e improntato all’affermazione piena della libertà
religiosa e di espressione quali capisaldi del diritto di cittadinanza. La
linea di moderazione tenuta dal partito della fratellanza (Libertà e Giustizia
) e la futura alleanza con i liberali (penalizzati dai risultati elettorali)
che si profila sembra poter garantire che la via intrapresa da queste forze sia
quella di un moderno partito islamico, non troppo dissimile dal partito turco
del premier Erdoğan.
·
Inoltre, il frazionismo all’interno del movimento sunnita
é già una ragione di peso che dovrebbe indurre, almeno nel breve-medio periodo,
a non nutrire eccessivi timori per i possibili effetti della vittoria
islamista, visto che il partito Libertà e Giustizia ha escluso «puor cause» di associarsi con Al-Nour, il
partito salafita. Non saranno quindi gli islamisti a dominare in concreto le
scelte fondamentali del futuro governo egiziano, che saranno piuttosto il
risultato di un compromesso della verosimile coalizione di islamisti e partiti
laici, tra cui spicca il partito Wafd. Se, inoltre, alle prossime elezioni
parlamentari, prevalesse un candidato laico legato all’esercito, la linea di
moderazione del paese potrebbe uscirne rafforzata. Il nuovo Presidente della
Repubblica che sarà eletto nel mese di luglio tra candidati che non
apparterranno ai Fratelli Musulmani, come ha anticipato Mohamed Badie, leader
del movimento, assumerebbe di fatto il ruolo di grande mediatore. A ciò si
aggiunga che le forze politiche diffidenti nei confronti degli islamisti – il
Blocco egiziano, capeggiato dal tycoon della telefonia Sawiris, e Rivoluzione
continua che raggruppa i giovani di Piazza Tahrir – al momento non sembrano
avere i numeri e la capacità di influenza necessaria a sfidare i nuovi partiti
di governo. Infine, occorre considerare che i vertici del partito Libertà e
Giustizia , nel corso degli ultimi mesi, hanno dato prova tangibile del proprio
impegno per l’attuazione di una linea politica realmente moderata aprendo
subito un dialogo con gli Stati Uniti, incontrando gli emissari del Fondo
monetario internazionale (con cui è in corso una trattativa per ottenere aiuti
finanziari pari a circa 3,2 miliardi di dollari) e chiedendo aiuto ai
principali partner commerciali occidentali per far fronte alla spaventosa crisi
economica che in un anno e mezzo ha dimezzato le riserve di valuta (da 36 a 18
miliardi di dollari) e ridotto il turismo del 90%.

Published on Aspenia
online (http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online)
Hamas,
i Fratelli Musulmani, e il dilemma israeliano
Claudia De Martino - Mideast Flashpoints - 9/1/2012
Il
governo israeliano ha annunciato che intende intensificare i rapporti
diplomatici con i Fratelli Musulmani in Egitto, come anche con le altre forze
islamiste uscite vincenti dalle recenti elezioni parlamentari nel paese. Il
nuovo ambasciatore israeliano al Cairo, Jacob Amity, sarebbe stato incaricato
di avviare contatti perfino con i partiti salatiti – tra cui il partito al
Nour, oggi la seconda forza politica egiziana dopo il partito Libertà e
Giustizia (appunto, i Fratelli Musulmani). Per ufficializzare “il nuovo corso”
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi si dovrà attendere l’esito della
lunga maratona elettorale egiziana (fino alle elezioni presidenziali in estate)
ma è già chiaro che il governo Nethanyau sembra ispirarsi a una buona dose di
pragmatismo. Questa scelta pone tuttavia un problema specifico per Israele e il
rapporto con il mondo palestinese: il boicotaggio di Hamas, in vigore dal 2007.
Come potrà il governo israeliano continuare a spiegare alla sua stessa opinione
pubblica il mantenimento di un double standard rispetto ai Fratelli
Musulmani egiziani (e addirittura i gruppi salafiti) da un lato, e Hamas
dall’altro? I due partiti sono per molti versi espressione della stessa
ideologia politica.
Il
quesito è particolarmente urgente dato che Khaled Maashal, leader della fazione
armata del partito, ha annunciato in occasione del recente secondo round di
negoziati Hamas-Fatah (il cosiddetto Interim Leadership Forum) appena tenutosi
al Cairo, una potenziale svolta storica per l’organizzazione: Hamas sarebbe
disposto a stringere una tregua con Israele, passando dalla lotta armata a
quella “popolare”, e sarebbe pronto a riconoscere e sostenere l’istituzione di
uno stato palestinese entro i confini del ’67 (pur senza rinunciare al diritto
al ritorno dei profughi palestinesi). Non vi è stata alcuna menzione ufficiale
al riconoscimento di Israele, ma è indubbio che nessun leader del movimento si
era mai spinto tanto avanti sulla via delle concessioni in vista della
possibile riunificazione nazionale.
Hamas
ha molte e buone ragioni concrete per compiere questo passo: la sua base
strategica di appoggio in Siria è stata minata dalla repressione che Assad conduce
ai danni del suo popolo: la credibilità del regime di Damasco è ormai
pregiudicata nell’intero mondo arabo. Non a caso, sono circolate voci secondo
cui il braccio armato di Hamas starebbe cercando riparo in Giordania – cioè il
paese dal quale esso è stato espulso nel 2000, come del resto era accaduto
all’OLP nel 1970. Un portavoce del governo giordano si è preoccupato
immediatamente di smentire le indiscrezioni, ma resta il dato oggettivo di un
momento assai delicato per l’organizzazione che controlla la Striscia di Gaza.
E’
chiaro che Hamas sta cercando una nuova collocazione alla luce delle
transizioni arabe in atto, sia per evitare di finire come un “danno
collaterale” dell’isolamento internazionale della Siria, sia per sfruttare in
qualche modo la rinnovata popolarità dei Fratelli Musulmani. Per far ciò, ha
però bisogno di accreditarsi nuovamente come una grande forza politica
popolare, piuttosto che come un gruppo di resistenza armata: una forza che, in
continuità con i risultati del 2006, chiede che si tengano nuove elezioni in
Palestina – con la prospettiva di conquistare il potere anche in Cisgiordania,
alla luce del successo politico ottenuto con il rilascio di oltre un migliaio
di prigionieri palestinesi nello scambio con il Caporale israeliano Shalit.
Stiamo dunque assistendo a passi importanti verso la possibile trasformazione
di Hamas in un partito politico moderato, che naturalmente modifica il quadro
palestinese e pone una grande sfida per Fatah.
Su
questo sfondo, i legami con i Fratelli Musulmani egiziani sono cruciali, anche
per la continua valenza politica della questione palestinese in chiave
regionale: in occasione della visita di Haniyeh al quartier generale dei
Fratelli Musulmani al Cairo, lo scorso novembre, il suo omologo egiziano Mohammed
Badie dichiarò che la Palestina era sempre al centro delle preoccupazioni e
dell’impegno della Fratellanza. Il viaggio in Egitto, per Haniyeh, é stato del
resto solo la prima tappa di un tour che ha toccato molti dei centri vitali
della umma islamica, ovvero Sudan, Qatar, Bahrein, Tunisia e Turchia:
nella selezione delle mete si è voluto lanciare il messaggio che Hamas appoggia
le rivolte popolari e le rivoluzioni in corso, e guarda ai Paesi caratterizzati
da un islamismo moderato.
L’operazione
tentata da Hamas non è facile, ma si tratta comunque di una sfida nuova per
Israele, oltre che per il mondo palestinese. Una sfida che nasconde
un’opportunità, visto che le forze islamiste guidano oggi Paesi importanti
tuttora alla ricerca di un modello di democrazia che coniughi valori islamici e
rispetto dell’espressione della volontà popolare. Il governo Netanyahu ha per
una volta la possibilità di anticipare, piuttosto che subire, i cambiamenti in
atto nella regione, con scelte che andrebbero a beneficio di tutti.

Pubblicata su Equilibri (http://www.equilibri.net/nuovo)
Equilibri > Medio Oriente > Egitto > Egitto: Per i progressisti la nuova era inizia in salita
Egitto:
Per i progressisti la nuova era inizia in salita
Eugenio Dacrema
Creata il 01/18/2012 - 11:50
A
pochi giorni dalla conclusione del terzo ed ultimo turno di consultazioni in
Egitto, è possibile iniziare a tirare le somme di quella che per i liberali e
la sinistra egiziana è stata certamente una sonora sconfitta. Le forze
islamiste, guidate dal partito dei Fratelli Musulmani “Libertà e
Giustizia” che ha ottenuto quasi il 50% dei suffragi, si aggiudicherebbero più
dei due terzi dei seggi parlamentari.
Un
risultato parzialmente annunciato
Nonostante
le dimensioni di questa sconfitta siano certamente sorprendenti, fin
dall’inizio nessuno nel campo laico si aspettava realisticamente di poter
puntare ad una vittoria elettorale. Sin dal referendum costituzionale del 19
Marzo 2011 (che chiedeva agli egiziani di scegliere, tra le altre cose, se
tenere le elezioni entro l’anno, opzione benvoluta dai partiti islamisti, o
posticiparle per permettere alle nuove forze politiche di organizzasi e
consolidarsi, come chiedevano i movimenti più laici e progressisti), appariva
infatti chiaro il peso schiacciante che la consolidata presenza sul territorio
dei movimenti islamisti avrebbe avuto sugli sviluppi politici successivi.
Secondo
molti esponenti politici laici, che in questo momento sono impegnati nel dibattito
sull’analisi della sconfitta, a pesare più di tutti gli altri fattori sul
risultato elettorale è stata la grande differenza tra gli schieramenti in
termini di presenza stabile e radicata sul territorio. Non è un segreto,
infatti, che nonostante i decenni di repressione da parte dei diversi governi
dittatoriali che da Nasser a Mubarak si sono avvicendati in Egitto, i Fratelli
Musulmani siano stati in grado negli anni di sviluppare una fitta rete di
attività religiose, servizi sociali, sanitari, educativi, nonché una forte
presenza nelle organizzazioni professionali. Il fatto che questa tentacolare
organizzazione sia stata trasferita in blocco al servizio del nuovo partito
fondato dalla fratellanza in seguito alla caduta di Mubarak (a nessun membro
dei Fratelli Musulmani è stato permesso di iscriversi e fare propaganda per
partiti diversi da Libertà e Giustizia, pena l’espulsione senza appello dalla
fratellanza) ne ha certamente amplificato enormemente le potenzialità
elettorali.
Un
discorso leggermente diverso va fatto invece per quanto riguarda il grande
successo (circa il 24% dei suffragi) ottenuto dall’ala più oltranzista dello
schieramento, ovvero quella rappresentata principalmente dal partito di
ispirazione salafita al-Nur. Se da una parte, infatti, anche per i movimenti
salafiti come al-Dawaa (il movimento di cui al-Nur è emanazione) è corretto
affermare che godano di una tradizionale e consolidata presenza sul territorio
( o almeno in alcuni centri come Alessandria), bisogna anche dire che questa non
è neanche lontanamente comparabile alla presenza territoriale dei Fratelli
Musulmani, e che con ogni probabilità le ragioni del loro successo vanno
ricercate anche in altri fattori. A questo proposito gli esponenti politici
laici hanno in questi mesi avanzato ripetutamente forti sospetti riguardo
l’inspiegabile improvvisa capacità finanziaria dimostrata dai movimenti
salafiti, che sono stati in grado di articolare una campagna elettorale
efficace e molto costosa, pur avendo le proprie tradizionali roccaforti di
consenso in aree molto povere.
I
sospetti si concentrano sulla probabile, ma fin’ora non provata, presenza di
grossi aiuti economici provenienti dall’estero, e soprattutto dalle monarchie
del Golfo (Qatar e Arabia Saudita sono i principali sospettati), che vedrebbero
in al-Nur un possibile avamposto wahhabita (l’islam radicale applicato dalla
monarchia saudita) in Egitto. Una possibile forte influenza saudita all’ombra
delle piramidi non sarebbe malvista nemmeno da Washington, che infatti non si è
espressa in maniera particolarmente allarmata riguardo al notevolissimo espluà
elettorale delle forze islamiste più radicali.
Contrapposte
narrative della Rivoluzione
Questi
fattori più “concreti” non sono però gli unici da tenere in considerazione. Non
sono mancate infatti in questi mesi le battaglie propagandistiche incentrate
sul simbolismo della rivoluzione. Mentre infatti all’estero è passata
soprattutto la narrativa promossa dalle forze laiche e progressiste che pone al
centro del cambiamento rivoluzionario in primo luogo i giovani liberali e la
sinistra, protagonisti della “Rivoluzione di Internet” e veri motori del
movimento di Piazza Tahrir, la narrativa che ha prevalso all’interno
dell’Egitto è risultata piuttosto differente.
I
movimenti progressisti hanno infatti da un lato scontato la loro natura
intellettuale-elitaria (gran parte degli aderenti a movimenti come il 6 Aprile
proviene infatti da famiglie agiate) per quanto riguarda soprattutto
l’attivismo telematico, mentre dall’altra non hanno potuto sfruttare a pieno il
movimento sindacale di cui sono stati protagonisti all’interno delle aziende
private e pubbliche in un paese ancora privo, a parte alcune eccezioni, di una
base operaia e una cultura sindacale solide e radicate.
Tutto
questo ha dato la possibilità alle le forze islamiste, la maggioranza delle
quali inizialmente aveva rifiutato di aderire alle manifestazioni di Piazza
Tahrir, di far valere il peso degli anni di opposizione al regime che
soprattutto i Fratelli Musulmani possono vantare. Per l’egiziano medio,
infatti, è risultato molto più semplice associare la fratellanza al merito
della caduta di Mubarak, piuttosto che associarla ad una delle nuove
numerosissime sigle di partiti e di movimenti laici quasi completamente
sconosciuti alla maggior parte della popolazione.
Frammentazione
e polarizzazione
Non
risulta però sufficiente esaurire le spiegazioni per questa grave sconfitta
attribuendola solamente ad un contesto sociale e politico assai sfavorevole.
Non sono mancati, infatti, gli errori strategici, anche gravi, che le forze
laiche hanno commesso durante i mesi di preparazione alla campagna
elettorale. In primis, basta dare un’occhiata alla tabella dei risultati
delle elezioni che proponiamo di seguito per capire quanto frammentato fosse lo
schieramento laico.
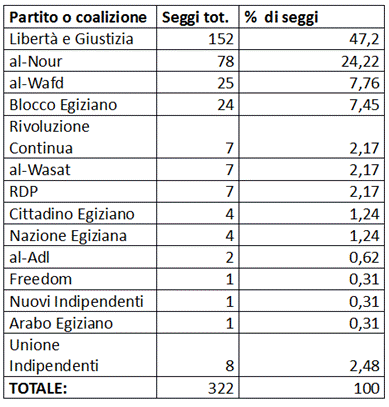
Mentre
infatti in cima alla lista possiamo facilmente riconoscere le liste di Libertà
e Giustizia e di al-Nour, per rintracciare lo schieramento laico dobbiamo
raggruppare tre liste diverse, al-Wafd (storico partito liberale egiziano
presente già nelle elezioni dell’era Mubarak), il Blocco Egiziano (una
coalizione che comprende sia forze liberali che forze socialiste, accomunate
sostanzialmente soltanto dalla contrapposizione ai movimenti islamisti) e
Rivoluzione Continua (coalizione formata da molti nuovi partiti progressisti
fondati soprattutto dai movimenti giovanili che hanno animato i giorni di
Piazza Tahrir).
A
loro volta il Bloco Egiziano e Rivoluzione Continua sono espressione di
numerosi partiti di medie e piccole dimensioni che durante la campagna
elettorale sono entrati spesso in contrasto. Questo clima di frammentazione e
spesso di litigiosità non ha certamente giovato alla capacità comunicativa
dello schieramento laico, che ha faticato non poco a far comprendere
soprattutto agli strati più popolari della società il proprio messaggio
politico e le differenze, spesso sottilissime, fra i vari partiti che lo compongono.
Ciò ha portato, al contrario, ad una fallimentare eccessiva semplificazione del
quadro politico, e spesso ridotto il dibattito alla semplice polarizzazione tra
laici e islamisti, identificati come migliori rappresentanti della società
tradizionale. Ne sono risultati trascurati quindi temi di fondamentale
importanza come quelli economici, riguardo ai quali le forze progressiste non
sono riuscite a far valere di fronte agli strati più poveri i loro programmi
assai più orientati all’equità delle retribuzione e alla salvaguardia dei
servizi sociali fondamentali.
Conlusioni
- Scenari e incognite del prossimo futuro
In un
contesto di elezioni democratiche normali, una sconfitta, seppur cocente, non è
mai una situazione irrecuperabile. Non sarebbe infatti la prima volta che un
partito, o una coalizione, pesantemente sconfitti in un confronto elettorale
risultino poi in grado di vincere quello successivo. E’ però assai ottimistico
pensare che il periodo post rivoluzionario egiziano possa già essere descritto
come un normale contesto democratico. Questo per due fattori principali, che
costituiscono gli elementi maggiori di incognita per il prossimo futuro.
Il
primo, e il più evidente al momento, è costituito dal clima di scontro tra gli
attivisti della sinistra politica e la giunta militare che si è nuovamente
esacerbato a partire da fine Novembre, con sanguinosi scontri soprattutto al
Cairo. Non è infatti da trascurare il fatto che al momento il potere in Egitto,
in quasi tutte le sue forme, sia ancora detenuto dai militari.
Quest’ultimi, forti della travolgente vittoria dei partiti islamisti, con
cui da mesi hanno sottoscritto una tacita ma piuttosto evidente alleanza di
mutuo rispetto e non belligeranza, potrebbero ora decidere di indurire il
proprio atteggiamento verso la sinistra progressista procedendo ad una
massiccia campagna di arresti e repressioni.
Questo
è certamente una scenario probabile, anche se non nella sua forma più estrema.
Non mancano, infatti, soprattutto all’interno dell’ala giovanile dei Fratelli
Musulmani, esponenti di rilievo che non vedono affatto benevolmente l’operato
della giunta militare e che sono molto sensibili ad alcuni ai temi economici e
sociali portati avanti dagli attivisti di sinistra. E’ pertanto improbabile che
ai militari venga data carta bianca per procedere ad una repressione veramente
feroce, anche se certamente lo spazio di manovra della giunta in questo senso
si è certamente allargato.
Il
secondo fattore, forse ancor più importante, riguarda lo scottante tema della
nuova costituzione. Il parlamento eletto a questa tornata elettorale sarà
chiamato infatti a redigere la nuova carta costituzionale del paese, stabilendo
i principi e le regole fondamentali anche per la libertà di culto, di
espressione e soprattutto le modalità in cui i prossimi confronti elettorali
verranno attuati.
In
passato la leadership di Libertà e Giustizia ha affermato che , qualunque fosse
stato l’esito del voto, avrebbe comunque optato per una alleanza con le forze
laiche per la nomina dell’assemblea costituente. Questo al fine di garantire
una nuova costituzione che fosse espressione di tutte le realtà politiche
e religiose del paese. Nonostante tale promessa, non sono però pochi coloro che
temono che soprattutto l’ala più conservatrice dei Fratelli Musulmani sia
tentata di spingere il movimento ad una comoda alleanza con le frange più
estremiste come i salafiti di al-Nur. Tale alleanza infatti avrebbe tutti i
numeri per poter garantire l’approvazione di una carta costituzionale
estremamente influenzata dalle dottrine islamiche e meno garantista rispetto ai
principi fondamentali come la libertà di culto e di espressione, nonché di
rappresentanza politica.
Questo
è certamente il pericolo maggiore che incombe sul futuro prossimo dei
progressisti egiziani, che sono ben consapevoli di non avere la forza
parlamentare per opporsi democraticamente ad uno scenario del genere. La
conseguenza potrebbe perciò essere il riaccendersi degli scontri di piazza,
questa volta non più contro la sola giunta militare, ma anche contro gli
avversari politici islamisti, portando il paese nuovamente in un caos
pericoloso, simile a quello immediatamente seguente la caduta di Hosni
Mubarak. Di tutto ciò sono pienamente consapevoli anche le leadership dei
partiti islamisti, dalle cui prossime decisioni, in ultima analisi, dipendono
in questo momento gli sviluppi politici dell’Egitto.
Published on Aspenia
online (http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online)
Il
quadro politico egiziano: un momento della verità per l’Islam politico
Azzurra Meringolo - Mideast Flashpoints -
18/1/2012
Dopo
la Tunisia, anche in Egitto sembra essere arrivato il momento dell’ascesa
dell’Islam politico. Per sapere l’esatta composizione del Maglis al-Shaab,
la camera bassa del primo parlamento dell’era post Mubarak, mancano solo i
risultati dell’ultimo ballottaggio tenutosi il 10 e 11 gennaio. A questi
dovranno inoltre sommarsi quelli di alcuni seggi che, in seguito alla decisione
della Commissione Elettorale, ripeteranno le operazioni di voto per garantirne
la legalità.
Anche
senza questi dati, comunque, il verdetto elettorale è già nitido. Le urne hanno
infatti consegnato la vittoria a Libertà e Giustizia, il partito
islamista della Fratellanza Musulmana che, dopo decenni di forzata
clandestinità, si appresta ora a governare il paese.
A
Libertà e Giustizia andranno circa il 45% dei seggi. Al secondo posto, con il
25% delle preferenze, si posizioneranno i salafiti del partito Al-Nour
(la Luce), un movimento islamista di emanazione wahabita su posizioni più
radicali. Anche se a prima vista l’alleanza tra questi due partiti sembra scontata,
i rapporti fra queste due formazioni dell’Islam politico sono sempre stati
altalenanti. Avendo radici comuni, momenti di vicinanza si sono alternati ad
altri di litigiosità e addirittura inimicizia. A confermarlo è stato quanto
accaduto lo scorso autunno, quando nel corso delle alleanze pre-elettorali
queste divisioni sono tornate a galla costringendo il blocco islamista a
correre in due coalizioni separate. Da una parte Al-Tahaluf al-Dimuqrati
(l’Alleanza Democratica) dominata dalla Fratellanza Musulmana), e
dall’altra Al-Tahaluf al-Islam, (l’Alleanza Islamista) guidata dal
Nour.
La
Fratellanza, che si è detta pronta ad includere nel suo governo tutte le
istanze politiche che vorranno cooperare, potrebbe infatti decidere di allearsi
con lo storico partito nazionalista Wafd (Delegazione), che ha ottenuto
circa il 9 % dei voti. In alternativa gli Ikhwan - i Fratelli -
potrebbero optare per il Blocco Egiziano, l’alleanza su posizioni più
liberali, guidata dal tycoon copto Naguid Sawiris che ha ottenuto poco più del
7%.
Oltre
alla questione delle alleanze, la dirigenza del partito e quella del movimento
islamista stanno ora discutendo sulla nomina dello speaker nel primo parlamento
dell’era post Mubarak. Tra i nomi dei candidati, i più probabili sono quello di
Saad El-Katatni, segretario generale di Libertà e Giustizia e già in passato
capo del blocco parlamentare della Fratellanza, e quello di Essam
El-Erian, vice presidente del partito.
Intanto
Mohammed Mursi, presidente di Libertà e Giustizia, ha annunciato quali saranno
le sfide alle quali il suo partito intende dare una risposta immediata – lo ha
fatto dalle colonne di Al-Sharq al-Wasat, un quotidiano panarabo
di proprietà saudita. Il partito della Fratellanza si propone in primis di
garantire a tutti i cittadini il principio di libertà e uguaglianza e al
contempo di ripristinare la sicurezza nazionale per rimettere in moto il paese.
Da un punta di vista economico, oltre allo sviluppo del turismo, Libertà e
Giustizia intende concentrarsi sul problema della disoccupazione e sostenere i
giovani nella creazione di piccole imprese. Per garantire maggiore giustizia
sociale e migliorare la qualità della vita dei cittadini, la Fratellanza punta
a una redistribuzione della ricchezza attraverso gli stipendi, a una più
efficiente assistenza medica, a combattere l’analfabetismo e destinare più
risorse alla ricerca scientifica. Si promettono anche interventi sul
sistema dei trasporti e sull’inquinamento ambientale.
Meno
chiara invece la politica estera che il movimento intende perseguire. Secondo
le dichiarazioni programmatiche di Mursi, Libertà e Giustizia cercherà di
incrementare l’integrazione con gli altri paesi arabi, ribadendo intanto il
diritto del popolo palestinese di liberare la sua terra e quello dei profughi
di ritornare in patria.
Secondo
quanto riportato dal quotidiano panarabo Al-Hayat il 1° gennaio,
affrontando anche la questione relativa alla relazione con lo stato ebraico,
Rashad Bayoumi, un membro della Fratellanza, sostiene che il suo movimento non
ha alcun obbligo a riconoscere il trattato di pace di Camp David firmato tra
Egitto e Israele nel 1979. Una posizione ribadita anche Ibrahim Mounir, membro
dell’esecutivo del movimento.
A
contraddirli è stata il 4 gennaio Victoria Nuland, portavoce del Dipartimento
di Stato americano, seconda la quale l’amministrazione americana avrebbero
ricevuto garanzie circa il rispetto di questo trattato direttamente da membri
della Fratellanza.
Oltre
a evidenziare l’indecisione degli islamisti sul futuro del trattato di pace con
Israele, questo dibattito suggerisce anche che può esistere un certo scarto tra
la dirigenza del movimento e quella del partito di Libertà e Giustizia, che
sono entrati in contraddizione anche su altre questioni.
Pochi
dubbi sembrano invece esserci sull’atteggiamento assunto dalla Casa Bianca, che
ha ufficialmente confermato di voler riconoscere i risultati delle elezioni,
tendendo la mano alla Fratellanza per istaurare rapporti diplomatici fattivi.
L’11 gennaio si è tenuto un incontro tra i leader di Libertà e Giustizia e
William Burns, numero due del Dipartimento di Stato; un passo ufficiale la cui
importanza è stata chiaramente percepita in Egitto. Questa è comunque una
novità solo parziale: per anni alcuni esponenti della Fratellanza hanno
avuto contatti con rappresentati del governo americano, ma questo sono stati
riservati o sono avvenuti tramite quei membri del movimento presenti in
parlamento che venivano ufficialemnte trattati come rappresentanti di questa
istituzione. Ora è il momento di un test più impegnativo per tutti.

Limes - rivista italiana di geopolitica
(25/01/2012)
Gattopardo o rivoluzione?
L’Egitto un anno dopo
di Azzurra Meringolo
Il 25 gennaio
2011 iniziava la rivolta che avrebbe portato alle dimissioni di Mubarak. Oggi
c'è un parlamento eletto, ma il vero potere è in mano ai militari dello Scaf. I
Fratelli musulmani di fronte a un bivio. Le richieste di piazza Tahrir non sono
ancora state ascoltate.
A poche ore
dall’inizio delle manifestazioni con le quali si celebrerà, il 25 gennaio, la prima ricorrenza dello scoppio
della rivoluzione di piazza Tahrir, quelli che molti accusano essere il vero
gattopardo del vecchio regime sembra essersi trasformato nel buon pastore.
“Ho preso la
decisione di porre fine allo stato di emergenza” ha detto ieri sera in un comunicato televisivo il
generale Hussein Tantawi, riservandosi comunque il diritto di farvi ricorso per
i casi di teppismo. Dichiarando la fine di questo stato in vigore dal giorno in
cui, nel 1981, il presidente Hosni Mubarak succedette ad Anwar Sadat
(assassinato), Tantawi sembra voler lanciare un messaggio di distensione a
quanti continuano ad accusare i militari di essere dei controrivoluzionari.
Ciononostante, pochi credono alle sue parole.
“È il solito
discorso che sentiamo da trent’anni” racconta un giovane. “Quando Tantawi ha sostituito
Mubarak alla guida del paese ha addirittura deciso di espandere il campo di
applicazione dello stato d’emergenza. Dallo scorso febbraio bastava uno
sciopero, un’interruzione del traffico o la diffusione di notizie ritenute
false dai militari per giustificarne il ricorso” aggiunge un altro. “Tantawi
non ha neanche definito cose intende con il termine teppismo” conclude un terzo
piuttosto titubante.
La dichiarazione
del capo del Consiglio supremo delle Forze armate (Scaf) arriva esattamente due giorni dopo che lo
stesso ha annunciato di concedere la grazia a 1959 detenuti la cui sorte era
appesa a sentenze militari. Tra i nomi dei rilasciati compare anche quello di
Maikel Nabil Sanad, il primo blogger dell’era post-Mubarak a finire dietro le
sbarre con l’accusa di aver insultato lo Scaf. Negando l’unità di intenti tra
popolazione ed Esercito, Nabil aveva scritto che i militari e i cittadini
egiziani non erano più una mano sola e per dimostrarlo aveva riempito il suo
diario virtuale di immagini e racconti che mettevano a nudo la violenza dei
militari giunti al potere dopo la caduta di Mubarak.
Neanche questa
mossa sembra aver convinto gli attivisti della rivoluzione; questi ultimi lunedì hanno partecipato a quattro
manifestazioni che cercavano di arrivare davanti al parlamento, dove si stava
tenendo la prima riunione del neoeletto Maglis al-Shaab, la camera bassa.
“Vogliamo solo far sapere ai nuovi deputati che devono fare il possibile per
realizzare le richieste rivoluzionare, e spingere i militari nelle caserme” ha
spiegato un manifestante costretto a tornare a casa senza aver raggiunto la
meta stabilita. Insieme ai militari, a difendere il parlamento sono stati
sostenitori di Libertà e Giustizia e di Al-Nour ("la luce"), i due
partiti islamisti che si sono spartiti più del 70% dei seggi.
Al primo,
emanazione della Fratellanza Musulmana, sono andati 235 seggi, il 46% del totale; Al-Nour,
partito salafita su posizioni più conservatrici, se ne è aggiudicati 124, il
26%. Sul terzo gradino del podio si trova Al-Wafd, lo storico partito
nazionalista che ha ottenuto il 7% delle preferenze, seguito a ruota dal Blocco
egiziano, l’alleanza su posizioni più laiche alla quale spetta il 6% dei seggi.
Non avendo una maggioranza assoluta, la Fratellanza si trova ora davanti a un
bivio. Potrebbe scegliere di allearsi con le forze liberali, mandando un chiaro
segno di cambiamento e innovazione all’intera regione in rivolta; oppure
potrebbe puntare sui meno pragmatici “cugini salafiti” , volgendo lo
sguardo al passato piuttosto che al futuro.
Mentre i vertici
di Libertà e Giustizia si interrogano sul da farsi, i sostenitori degli Ikhwan (i Fratelli musulmani)
si preparano a festeggiare oggi l’inizio di quella rivolta che ha spianato loro
la strada verso questo successo. “Non sono stati loro i protagonisti della
manifestazione del 25 gennaio 2011” spiega una giovane che si appresta a
partecipare a una delle manifestazioni alternative alle celebrazioni ufficiali
indette dai militari. “Il 25 gennaio non scenderemo in strada per festeggiare,
ma per lottare cercando di raggiungere quegli obbiettivi che non abbiamo ancora
realizzato dopo la caduta del vecchio raìs” spiegava a inizio settimana un
attivista del Movimento del 6 Aprile, uno dei gruppi protagonisti della rivoluzione che ha
organizzato per oggi manifestazioni contro i militari.
Quanti sono
insoddisfatti della condotta dell’Esercito chiedono infatti di accelerare il processo di
transizione, accorciando i tempi che portano alle elezioni presidenziali
previste a giugno. “La grande sfida di fronte alla quale si trova
l’Egitto", scrive sul quotidiano liberale Al-Masry al-Youm Roger Owen, docente ad Harvard, “consiste nel
trasformare il fervore rivoluzionario in qualcosa di simile a un nuovo ordine
costituzionale come quello creatosi dopo il 1919 [anno della prima rivolta
egiziana contro la Corona inglese, ndr], diverso da quello autoritario
comparso dopo il 1952 [anno della rivolta dei Liberi ufficiali di Nasser, ndr].
Solo allora il precedente spirito di liberazione dagli inglesi potrà evolversi
verso quella libertà di vivere la propria vita per la quale il popolo di Tahrir
ha lottato così coraggiosamente nel 2011”.
Islam
e Costituzione: l’Egitto sotto il segno della moderazione, Antonio Badini, 24 gennaio 2012
Egitto:
“Libertà e giustizia”, correnti di partito e alleanze di governo, Giuseppe Acconcia, 26 gennaio
2012
Egitto,
parola d'ordine: evitare default alla greca
Ugo Tramballi, 24 gennaio 2012
Where is Egypt Heading? Reasons Why
No One Really Knows ( new ) Sally Khalifa
Isaac
Limes - rivista italiana di geopolitica
(27/01/2012)
Il futuro economico
dell’Egitto: più populismo e meno crescita
di Giovanni Mafodda
A un anno
dall'esplosione della rivolta che ha destituito Mubarak, l'economia egiziana
continua a rimanere bloccata. Il ruolo dell'Fmi e l'impotenza del governo.
L'unica soluzione è un nuovo contratto sociale che riduca l'entità dei sussidi.
Con
l’insediamento del nuovo parlamento,
che le prime elezioni libere hanno dato per due terzi in mano a partiti
d’ispirazione islamica, prende il via una nuova fase politica in Egitto. Gli
accordi da raggiungere per la composizione della prevista Assemblea costituente
evidenzieranno le reali capacità di dialogo dell’attore politico con il
Consiglio superiore delle Forze armate - cui la piazza continua, inutilmente, a
chiedere un passo indietro.
Successivo e
ultimo passaggio per la formazione
del nuovo Egitto saranno poi le elezioni presidenziali. Molti osservatori
scommettono che i tempi si dilateranno ben oltre il prossimo luglio. Intanto, a
un anno dall’esplosione della rivolta che ha portato alla destituzione di Hosni
Mubarak, la crescita economica continua ad essere bloccata.
Le riserve
monetarie internazionali sono ridotte
a non più di 10 miliardi di dollari e secondo alcune stime dovrebbero esaurirsi
entro marzo. La disoccupazione giovanile è al 25%, cifra che mette spavento in
un paese dove solo tre cittadini su dieci hanno più di 30 anni. Declino del
turismo, blocco degli investimenti, inflazione crescente, forte indebitamento e
deficit statale alto completano il quadro.
La recente
richiesta di intervento del Fondo
monetario internazionale (Fmi), che il governo ha fatto partire alla volta di
Washington e che segue di qualche mese l’altezzoso rifiuto delle somme
stanziate per supportare l’Egitto, è il segno più chiaro ed allarmante della
sconfortante impotenza del governo del Cairo.
Sono in ballo 3,2
miliardi di dollari di possible
intervento, pochi a fronte della gravità della situazione, secondo alcuni
osservatori. I rappresentanti del Fondo sostengono che non è loro intenzione
vincolare la concessione dei prestiti a condizioni che l’Egitto non sarà in
grado di rispettare, ma pochi ci credono. Fmi da queste parti è sinonimo di
eccessivo condizionamento politico e di riforme troppo market-friendly:
un sigillo a stelle e strisce quasi sempre a tutto vantaggio della “cricca dei
compari” di Mubarak.
Sia Giustizia e
libertà, braccio
politico della Fratellanza musulmana e ora primo partito politico in Egitto,
sia al-Nour, guidato dai più radicali salafiti, seconda forza e vera sorpresa
elettorale, seppure con gradazioni molto diverse, hanno promesso che
proporranno riforme ispirate agli insegnamenti islamici. Ma non è detto che la
coalizione di governo che guiderà il paese alla fine della fase transitoria
sarà ad esclusiva composizione islamica.
Gli stessi poteri
del parlamento potrebbero
essere annacquati da un intervento correttivo dettato dai militari
all’Assemblea costituente. Sono in molti a ricordare che c’è più acrimonia tra
la Fratellanza e i salafiti di quanta ve ne sia tra i primi e il partito Wafd,
che pur nella nuova composizione è sempre espressione della borghesia
liberal-secolare. Nel caso di un’intesa con i salafiti, sarebbe probabile
l’applicazione in campo economico di principi che facciano diretto riferimento
alla Sharia.
Gli esempi del
Pakisan, dell’Iran e di altri
Stati, tuttavia, dimostrano che l’inserimento nella vita economica di principi
quali lo Zakat (contributo forzoso del 2% a favore dei piu’ bisognosi) e il
bando del pagamento di interessi sulle somme prestate - quest’ultimo per lo più
gestito soltanto come “formalmente conforme” - non ha provocato fondamentali
mutazioni al funzionamento dell’economia rispetto ai paesi che si ispirano a
concezioni più occidentali.
Piuttosto, è da
attendersi un sistema
governato con strumenti di crescente ispirazione populista; ma a ben guardare,
in un paese in cui il 40% della popolazione vive al di sotto o in prossimità
della soglia di povertà il “grado di laicità” dei prossimi governanti incide
presumibilmente poco, quantomeno nel breve periodo, sulle prime decisioni che
potranno essere prese in economia.
In considerazione
dell’esplosione del livello di
disoccupuazione, infatti, sarebbe difficile implementare politiche che si
preoccupino di spezzare le storture dei sussidi a pioggia, dell’aumento dei
posti di lavoro nel settore pubblico (per quanto i salari stenteranno a stare
dietro ai tassi di inflazione) e delle mille altre forme di trasferimenti non
produttivi che sono da tempo parte del vissuto economico dell’Egitto.
Un passaggio
quasi obbligato, insomma. Prima che, come
ha recentemente evidenziato Mohsin Kahan del Peterson institute of
international economy, “teste più sensibili non prevalgano e tornino indietro
dicendo che il solo modo per creare sviluppo è seguire modelli quali la
Turchia, la Malesia e l’Indonesia”.
Dalle colonne del
Financial Times, Ahmed Heikal
si è appellato agli imprenditori egiziani sostenendo che lo svilupppo e la
crescita economica non sono solo affare della politica, e che mediante lo
stabilimento di un “nuovo contratto sociale” è possibile e virtuoso rinunciare tout
court ai costosissimi sussidi che, soprattutto nel settore dell’energia,
vanno a favore dei più abbienti.
Questo
consentirebbe di liberare risorse
per ben 58 miliardi di dollari da reimpiegare, per una parte, nel welfare
per quelli che ne hanno realmente bisogno e per l’altra, più cospicua, in
programmi di assistenza sanitaria, educativi e a favore della creazione di
posti di lavoro nell’economia reale.

Published on Aspenia
online (http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online)
L’Egitto
e gli aiuti internazionali: dove la politica incontra l’economia
Azzurra Meringolo - Mideast Flashpoints -
23/2/2012
È
sfociata in una crisi diplomatica tra Egitto e Stati Uniti la campagna condotta
dalle autorità egiziane contro le ONG internazionali. Una crisi che, sotto il
profilo economico, rischia di aggravare l'instabilità dell'Egitto in questa
delicata fase di transizione e che potrebbe avere conseguenze anche sul piano
politico. Mentre i rapporti tra il Cairo e Washington si facevano più tesi nel
corso del mese di febbraio, Giustizia e Libertà, il partito islamista ispirato
alla Fratellanza Musulmana e vincitore delle ultime elezioni parlamentari, ha
chiamato in causa anche Tel Aviv, riportando al centro del dibattito politico
il trattato di pace tra Egitto e Israele firmato a Camp David nel 1979.
All'origine
della crisi c’è l'iniziativa del Ministro della cooperazione internazionale
egiziano, Fayza Abul Naga, che la scorsa primavera aveva avviato un’indagine
sulle attività e sui fondi delle Ong internazionali che operano nel paese. Alla
fine dello scorso dicembre, le autorità cairote hanno fatto irruzione nelle
sedi di diverse organizzazioni accusate di ricevere fondi da paesi stranieri e
di “voler dirottare la rivoluzione nell’interesse di Stati Uniti e Israele,
seminare il caos e minare la democrazia egiziana”. Tra le ONG che hanno subito
la confisca di documenti e apparecchiature compaiono i nomi di diverse
organizzazioni statunitensi. Proprio per questo, ribadendo l’importanza giocata
dalla società civile nel processo di transizione politica in corso, la Casa
Bianca ha minacciato di sospendere l’invio dei 3,1 miliardi di dollari che
assegna annualmente al Cairo. A complicare ulteriormente il quadro, è poi
intervenuta una corte egiziana che ha iniziato un procedimento contro
quarantatrè funzionari di Ong accusati di aver elargito illegalmente
finanziamenti a organizzazioni locali. Tra gli imputati, compaiono diciannove
statunitensi. Tra questi un nome illustre come quello di Tom Daschle, vice
presidente del National Democratic Institute ed ex leader democratico della
maggioranza al Senato statunitense, ma anche Sam LaHood, figlio del Segretario
ai trasporti degli Stati Uniti (e direttore del programma egiziano
dell’International Republican Institute - una Ong affiliata al partito
repubblicano).
A
metà febbraio, il Senatore democratico John Kerry e il suo collega repubblicano
Rand Paul hanno presentato due proposte di legge che chiedono la sospensione
dei sussidi egiziani, già inseriti nella proposta di budget per l'anno fiscale
2013 presentata dal presidente Obama al Congresso lo scorso 13 febbraio.
L'iniziativa
dei due senatori ha provocato una dura reazione da parte di Mohammed Mursi,
leader di Giustizia e Libertà. Mursi è giunto a dichiarare che un'eventuale
sospensione dei sussidi potrebbe perfino far "traballare il trattato di
Camp David”. Essam El-Erian, vice presidente del partito, ha ricordato che
"gli aiuti americani erano uno degli impegni sottoscritti dalle parti al
momento della firma del trattato. Se un contraente viola una clausola, gli
altri hanno diritto di chiedere una revisione dell’accordo”. Nonostante le dichiarazioni
dei vertici di Giustizia e Libertà, pochi credono che l’Egitto abbia realmente
intenzione di riaprire il fronte diplomatico-militare con lo stato ebraico. La
situazione economica del paese è particolarmente critica e la risoluzione delle
questioni interne appare senza dubbio prioritaria rispetto all'ipotesi di una
politica di tensione e confronto diretto con Israele.
Il
declino del settore turistico, il blocco degli investimenti e la crescente
inflazione contribuiscono, infatti, ad aumentare il deficit di un paese in cui
il tasso di disoccupazione giovanile potrebbe superare la soglia del 25%.
Secondo il Wall Street Journal le riserve valutarie sono precipitate dai
36,2 miliardi di dollari del 2010 ai 18,1 del 2011, e potrebbero esaurirsi nel
mese di marzo. Il debito estero ha superato i 35 miliardi di dollari, con un
incremento del 3,6 % rispetto all’anno passato. Anche il presidente Obama ha
invitato le autorità egiziane a riflettere sulla gravità della crisi economica,
lo scorso 20 gennaio, durante una conversazione telefonica con il capo del
Consiglio Supremo delle Forze Armate, il generale Hussein Tantawi. Il
presidente americano ha colto l’occasione per ricordare il ruolo decisivo
svolto dalle Ong e dai sussidi statunitensi per il buon esito della transizione
egiziana.
Pur
condannando pubblicamente l'ingerenza straniera nei suoi affari interni, il
Cairo continua a beneficiare di cospicui contributi finanziari internazionali.
La scorsa estate, dopo aver rifiutato gli aiuti della Banca Mondiale e del
Fondo Monetario Internazionale, l'Egitto è tornato sui suoi passi accettando un
prestito di 3,2 miliardi di dollari da parte dell’Fmi e un contributo biennale
di un miliardo di dollari dalla Banca Mondiale (oltre a 500 milioni per
l’assistenza immediata). Altri 650 milioni sono stati promessi al Cairo
dall’Unione Europea, anche se alcuni analisti temono che l’impegno sia a
rischio a causa della crisi dell’euro.
Anche
le monarchie del Golfo si sono dimostrate generose nei confronti del Cairo. Il
regno saudita ha promesso prestiti a lunga scadenza pari a 4 miliardi di
dollari e il Qatar ha annunciato di volerne investire altri 10. Certamente, i
rapporti con questi paesi dipendono anche dall’atteggiamento che i Fratelli
Musulmani adotteranno nei loro confronti. In un articolo pubblicato sul
quotidiano egiziano al-Masry al-Youm, l'editorialista Sultan al-Qassemi,
originario degli Emirati Arabi Uniti, ha spiegato che i nuovi protagonisti
della scena politica egiziana dovrebbero cercare di costruire relazioni con l’Arabia
Saudita e gli Emirati visto che queste sono le economie più forti della
regione. “I Fratelli Musulmani – spiega al-Qassemi – dovranno presto chiedersi
come fare per attrarre vitali investimenti da quei ricchi regimi che nutrono
sospetti nei confronti della loro agenda (...) I prossimi giorni sveleranno se
il pragmatismo della Fratellanza porterà l’Egitto a bussare alle porte degli
stati del Golfo.”
In
ultima analisi, l’Egitto si trova oggi in una situazione di forte dipendenza
dal flusso di aiuti – in varie forme – proveniente dall’estero. Ciò
condizionerà in qualche misura le sue scelte politiche e diplomatiche, pur non
garantendo in ogni caso una rapida ripresa e un miglioramento netto delle
condizioni di vita: l'ammontare degli aiuti internazionali finora promessi non
sarebbe comunque sufficiente a tenere a galla l'Egitto che, secondo l'opinione
dei suoi stessi economisti, avrebbe bisogno di 10 o 12 miliardi di dollari per
rimettere in sesto la sua economia.
|
Sicurezza energetica
Egitto e Israele alla battaglia
del gas
Chiara Proietti Silvestri
29/02/2012
|
Il clima di incertezza
e instabilità politica che caratterizza l’Egitto sta avendo implicazioni di
sicurezza energetica particolarmente controverse. La vulnerabilità delle
infrastrutture energetiche emerge chiaramente nei ripetuti attacchi all’Arab
Gas Pipeline, il gasdotto che, attraverso il Sinai, trasporta(va) il gas a
diversi paesi dell’area mediorientale. L’infrastruttura permette all’Egitto di
esportare circa cinque miliardi di metri cubi di gas all’anno, in particolare
verso Israele e Giordania. L’ennesimo attacco all’infrastruttura avvenuto a
inizio febbraio, ha nuovamente interrotto le forniture rendendo ancora più
urgente la ricerca di alternative più sicure e affidabili.
Fonte: Arab Fund for Economic & Social Development.
Alta tensione Al 2010, le riserve provate di gas dell’Egitto ammontavano a 2,2
migliaia di miliardi di metri cubi (mld mc); i mercati di destinazione delle
esportazioni egiziane erano Israele (2,10 mld mc), Giordania (2,52), Siria
(0,69) e Libano (0,15). Tuttavia, l'offerta di gas è stata interrotta ben dieci
volte nel corso del 2011, a causa dei numerosi sabotaggi che hanno reso il
gasdotto inutilizzabile per più di 200 giorni. I più colpiti dal blocco delle
forniture sono stati Israele, che importa dall’Egitto il 40 per cento del
consumo nazionale di gas, e la Giordania la cui dipendenza raggiunge l’80 per
cento.
Ad esacerbare
ulteriormente il quadro ha contribuito la decisione del governo egiziano di
rivedere al rialzo i prezzi del gas. Mentre la Giordania ha accettato la
rinegoziazione dei contratti, che ha determinato un sostanziale aumento da due
a oltre sei dollari per mille piedi cubi, Israele ha rifiutato di riconsiderare
i prezzi e, ad oggi, non ha in atto alcuna trattativa in tal senso.
La situazione,
tuttavia, non sembrerebbe essere particolarmente critica per Israele, che può
avvalersi delle scoperte di nuovi giacimenti ricchi di gas al largo delle sue
coste. Nonostante l’importanza di questi giacimenti, i danni conseguenti
all’interruzione del flusso di gas nel breve periodo sono inevitabili; secondo
fonti governative, il costo del sabotaggio potrebbe raggiungere i quattro
miliardi di dollari se le forniture non saranno totalmente ripristinate entro
l’entrata in produzione del primo campo.
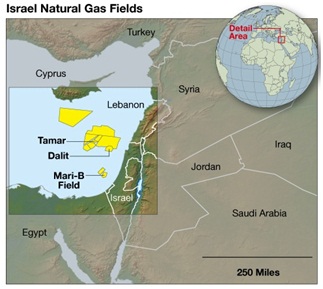
Fonte: Globes.
Il giacimento Tamar
dovrebbe diventare operativo a metà 2013 e fornire alla compagnia statale Israel
electric corporation (Iec) circa 3 miliardi di metri cubi all’anno per
almeno quindici anni. Considerate le riserve provate del sito, che ammontano a
circa 255 miliardi di metri cubi, sono in via di definizione anche opzioni per
esportare il gas, ma si dovrà attendere ancora un mese per conoscere quanto
deciso dall’apposito comitato governativo. In ogni caso, tra le proposte
papabili sembrano esserci il trasporto del gas nel porto di Eilat (Mar Rosso)
per esportarlo come Gnl, la costruzione di un terminal di liquefazione nel
Mediterraneo o il trasporto in Europa tramite la Grecia, ipotesi che per il
momento sembra però poco praticabile .
Una possibilità,
invece, più volte declamata è stata quella di esportare il gas, nell’ordine di
2-3 mld mc/anno, in Giordania, ma in tal senso non è stato ancora aperto alcun
negoziato. L’altro grande giacimento è Leviathan, che pur avendo riserve
provate di gas pari a 453 mld. mc, non sarà in funzione prima del 2017 e non
potrà perciò competere alla messa in sicurezza delle forniture, se non nel
medio periodo. Crisi giordana
Un recente rapporto
della Commissione per la regolazione elettrica giordana sottolinea che il paese
si trova in una grave crisi energetica; la continua inaffidabilità delle
forniture di gas dall’Egitto e la necessaria compensazione con materiali più
costosi, come il diesel o l’olio combustibile, determinerà un costo addizionale
per le casse statali di circa 2,4 mld. di dollari nel 2012. A questo si deve
aggiungere il salatissimo conto energetico dell’anno passato, che il calo
dell’offerta di gas (dai 6,2 mln. mc al giorno nel 2010 ai 2,2 mln. mc al
giorno nel 2011) ha fatto schizzare a 5,6 mld. di dollari.
Il paese stia pagando l’assenza di una politica di diversificazione che l’ha
reso del tutto dipendente dalle forniture egiziane. La strategia del governo, incentrata
sulla ricerca di vie alternative, non è tuttavia spendibile nel breve periodo a
causa della mancanza di infrastrutture.
Nonostante la disponibilità di Israele a fornire il proprio gas dalla metà del
2013, la soluzione più veloce sembra essere l’importazione di Gnl dal Qatar; il
governo ha recentemente costituito un comitato tecnico congiunto per valutare
la costruzione di un terminale di rigassificazione nel porto di Aqaba (Mar
Morto) che, in ogni caso, richiederà vari mesi prima di diventare operativo.
Intanto, il paese ha
iniziato a muoversi su progetti che riguardano la produzione di shale oil,
di cui la Giordania possiede riserve stimate intorno ai 500 mld. di barili di
petrolio equivalente (bpe), con l’obiettivo di raggiungere la quota del 14%
entro la fine del decennio. La Giordania, va ricordato, possiede anche notevoli
riserve di uranio, per oltre 140 mila tonnellate, e intende costruire il primo
impianto nucleare da mille MW entro la fine del decennio, con l’obiettivo di
produrre il 30 per cento dell’elettricità da energia nucleare entro il
2030-2040.
Dipendenza e
opportunità
Nonostante le
opportunità di investimento e le nuove vie di diversificazione, nel brevissimo
periodo permane l’emergenza e, nel caso della Giordania, una vera e propria
crisi. Al di là dell’uso di più costosi combustibili alternativi, i due paesi
mantengono una forte dipendenza dal gas egiziano. I progetti in ballo fanno ben
sperare per il futuro energetico giordano ma, come ha ricordato il responsabile
gas del governo, Marwan al-Bakain, “per i prossimi due anni la Giordania non ha
altra scelta che il gas egiziano”.sraele ha il potenziale per divenire, nei
prossimi anni, un importante esportatore di gas, ma resta la difficoltà nel
trovare, almeno fino all’entrata in produzione di Tamar, un’alternativa
affidabile ed economicamente sostenibile.
A complicare il quadro
si aggiunge lo stallo nelle relazioni tra il governo egiziano e i beduini del
Sinai, considerati i responsabili degli attacchi ai gasdotti. Il 13 gennaio, durante
un incontro tra le parti, i beduini hanno dichiarato di non riconoscere un
parlamento senza una loro rappresentanza e hanno minacciato il ricorso alle
armi contro il Consiglio supremo delle forze armate egiziano.
Il governo non sembra
tuttavia disposto a scendere a patti con questa riottosa minoranza, lasciando
il campo aperto a nuove rivendicazioni e attentati. Prospettiva certamente non
auspicabile per Israele e Giordania, ma poco confortante anche per l’Egitto
che, senza gli introiti delle esportazioni di gas e in vista della revisione al
rialzo dei prezzi, perde una fondamentale fonte di guadagno per il rilancio di
un'economia instabile, con un alto debito pubblico e un’industria turistica che
fatica a riprendere quota.
Chiara Proietti Silvestri è analista di Relazioni internazionali. Collabora
con il Rie di Bologna.

Pubblicata su Equilibri (http://www.equilibri.net/nuovo)
Equilibri > Medio Oriente > Egitto > Egitto: una panoramica sul prima e dopo Mubarak
Egitto:
una panoramica sul prima e dopo Mubarak
Da admin
Creata il 02/13/2012 - 10:52
L’attuale
transizione egiziana guidata dai militari non riverbera segni positivi e,
l’insurrezione che ha abbattuto il trentennale regime di Hosni Mubarak, continua
a debilitare la gestione amministrativa dell’intera società.
Il
clima d’incertezza politica accresce le titubanze dei consumatori, i mercati
sono paralizzati, il tasso di disoccupazione sfiora il 25% e i costi delle
derrate subiscono continui rincari. Le vicende politiche, cadenzate da gravi
recrudescenze per la sicurezza interna e, per le riottose agitazioni sociali,
hanno cagionato un congelamento dei programmi d’investimento.
La
Banca Mondiale stima che il 40% della popolazione locale vive al di sotto della
soglia della povertà, con un tasso di sopravvivenza che dipende esclusivamente
dalle sovvenzioni governative. In tutto questo si aggiunge il paradosso
energetico che coinvolge il Paese, ovvero, un Egitto costretto a ricomprare il
gas prodotto dalle compagnie straniere, a sovvenzionarlo e poi rivenderlo
sul mercato interno. Se con il nuovo regime dei colonnelli sembra che a
cambiare siano solo le etichette, si ripresenta “l’epitome di Mubarak”. Come in
molti hanno già detto: si ripresenta un Egitto senza né Panem né Circenses.
Economia,
prima e dopo Mubarak
L’Egitto
di Mubarak ha sostenuto un programma di riforme economiche a lungo termine con
l’obiettivo di migliorare il tenore di vita dei cittadini. Se da un lato,
l’aumento del livello di crescita ha permesso d’attutire gli effetti negativi
della globalizzazione, dall’altro, la distribuzione dei giovamenti si è
rivelata sempre più discrepante con forti sperequazioni nella distribuzione
della ricchezza. Inoltre, la crescente instabilità finanziaria mondiale ha
colpito con più intensità i ceti bassi, provocando le già note tensioni
socio-politiche che hanno portato ai cambiamenti istituzionali in auge.
Agli
inizi degli anni Novanta, sull'onda dello slogan “Top Economic Reformer” e,
sotto l’insistenza di organizzazioni come la World Bank e il FMI, lo Stato
aveva deciso di realizzare la privatizzazione di oltre 300 aziende pubbliche.
Ma, dal 1991 ad oggi ne sono state vendute solo 164. Se nel 1990 il Paese
cresceva del 2%, nel 1996 il PIL arrivò al 5%. Nei primi anni del millennio
l’inflazione è aumentata vertiginosamente, passando dal 4% nel 2000, al 18,3%
nel 2009, al 11,9% nel 2010 e al 12,8% nel 2011. Dal 2000 a 2008, la
povertà sia urbana e rurale è passata dal 21% al 30%. E, nello stesso periodo
si contano quasi 2000 scioperi. E’ chiaro che “La tigre del Nilo” già prima
delle sommosse, era in preda a un vortice endemico dagli effetti smisurati.
L’impatto
che l’Arab Awakening ha avuto sull’economia mostra effetti in negativo.
Nell’anno in corso il PIL ha registrato una contrazione del 4%, il tasso di
crescita è sceso dal 7% al 2%, gli investimenti esteri sono calati del 26% e il
debito pubblico è cresciuto fino al 30%. Le riserve di valuta straniera sono in
caduta libera, la bilancia dei pagamenti registra un saldo sfavorevole che
supera i 9,8 miliardi di dollari. Nel climax della rivolta, l’economia egiziana
perdeva almeno 310 milioni di dollari al giorno. I settori maggiormente colpiti
sono stati il turismo, con un calo del 33%, seguono l'industria e le
costruzioni. Sono invece positivi gli andamenti del Canale di Suez e il settore
agricolo.
Entro
la fine del 2011 gli esperti prevedono una diminuzione degli investimenti
diretti dall'estero (IDE) del 92%. I 6,4 miliardi di dollari che le aziende straniere
hanno vincolato nel mercato egiziano nel 2010, sono scesi drammaticamente. Per
attenersi al suo debito, da un miliardo di dollari, il Cairo dovrebbe iniziare
a massimizzare ogni entrata. Cosa alquanto difficile, se si prendono in
considerazione i miliardi destinati alla difesa e, al fatto che quasi il 40%
dell’economia è controllato dagli uomini in divisa che non pagano le tasse e
usano i soldati come forza lavoro. Anche nella nota di accompagnamento alla
decisione di Standard&Poor’s di abbassare il rating del deficit sovrano
egiziano, si sottolinea il “rischio endemico rappresentato dalle sfide
istituzionali e i possibili ulteriori conflitti sociali”.
La
fine del regime di Mubarak ha dato alle forze armate l'autorità di implementare
direttive incentrate più sul pubblico che sul privato. Recentemente, il
Ministro delle Finanze Hazem El-Beblawi ha affermato che la società egiziana
non si oppone al libero mercato ma, non tollererà più la corruzione e la
mancanza di trasparenza. La maggior parte degli analisti concordano ,
invece, col fatto che siano principalmente i militari a dimostrarsi
recalcitranti verso il processo di liberalizzazione, in quanto, vedono
nel libero mercato una minaccia alla loro posizione privilegiata. Lo scorso febbraio
Francia, Germania e Gran Bretagna hanno annunciato che l’Egitto ha chiesto loro
di cristallizzare i beni degli ex alti responsabili egiziani. Parigi ha anche
precisato che la domanda non includeva Mubarak.
Le
risorse energetiche
L’Egitto
ha iniziato a essere un produttore di gas grazie all’Italia: è stata proprio
l’AGIP che, alla fine degli anni ‘80 l’ha scoperto. Ma, il Paese non riesce a
produrre tutto il gas necessario al consumo interno. Il fabbisogno di
elettricità diventa sempre più vorace, a seguito di un aumento demografico
annuo, pari all’8%, e non postula diminuzioni. All’Egitto non può essere dato
l’epiteto di produttore di rilievo. Nel 2010 è diventato importatore di
greggio, anche se continua a venderlo in modeste quantità all’Europa e a
lavorare combustibili altrui trasformandoli in prodotti petroliferi. A seguito
delle scoperte nel Deserto occidentale e nell’offshore del Delta, le sue
aspettative sono in estensione, ma a oggi il Paese continua ad importare
combustibili, usando i proventi che derivano dalla rendita gasifera.
Il
commercio internazionale vede un Egitto costretto a ricomprare il gas prodotto
dalle compagnie straniere situate in loco e, ha iniettare sovvenzioni per
rivenderlo sul mercato interno. Oltretutto l’Egitto paga il gas in valuta straniera
alle compagnie e ciò crea una vera e propria fallacia, in quanto, porta il
Cairo a indebitarsi sul mercato internazionale. L’amministrazione è arrivata a
chiedere un prestito alle grandi banche d’investimento per riuscire pagare il
debito alle società straniere che estraggono il gas egiziano.
L’Egitto
ha cominciato a esportare gas naturale, in particolare liquefatto (GNL) dopo il
2000 con la produzione dei giacimenti del Delta del Nilo e del Golfo di Suez,
venduti all’estero in gran parte attraverso i terminali di Idku e Damietta
(complessivamente, circa 15 miliardi di metri cubi l’anno, di cui quasi 10
attraverso tecnologia GNL). Ma, già nel 2008 i fabbisogni interni imponevano di
ridurre i ritmi di esportazione di gas liquido. Mubarak ha chiesto alle grandi
produttrici di limitare lo sfruttamento dei giacimenti per ridurre la
produzione a discapito del mercato estero e dedicare invece una parte degli
investimenti allo sviluppo del mercato locale, proponendo prezzi
inferiori. Come era facile dedurre, poche società, come l’americana
Apache e l’emiratina Dana Gas hanno in parte accettato. L’Egitto, ha così
dovuto continuare a coprire con lauti sussidi i prezzi al consumo, per poi
annunciare una temporanea moratoria ai nuovi contratti d’esportazione.
È
chiaro che il Paese può diventare un importante protagonista nella regione
mediterranea, tenuto conto non solo delle riserve provate ma, soprattutto delle
grandi risorse dell’offshore del Delta del Nilo. Secondo le grandi compagnie,
nei bacini egiziani si celano circa 6.300 miliardi di metri cubi di gas. Gli
analisti pensano che insieme alla Libia, l’Egitto potrebbe diventare un vero e
proprio hub nel Nord Africa. Creare un centro di energia in questa zona sarebbe
fondamentale, poiché è prevista un’impennata di domanda di energia elettrica,
ed è paradossale sapere che questi paesi capaci di produrre siano costretti a
subire continui black out.
Il
gas
Tutti
i Paesi rivieraschi hanno problemi di approvvigionamento energetico, a causa
dei loro crescenti bisogni interni. Inoltre, non va dimenticato che le
ambizioni di dotarsi di una rendita petrolifera per sopperire alle difficoltà
economiche, sono nelle prime note dell’agenda politica di ogni amministrazione
araba. Il bacino marittimo del levante, che si estende dalla costa del Sinai
fino alla costa siriana, ritorna ad essere al centro dell’attenzione dei
geologi grazie alle nuove tecniche di sviluppo. Nel marzo 2010 il rapporto del
US Geological Survey sul bacino del Mashreq ha stimato la sua potenzialità
in 1,7 miliardi di barili di petrolio e circa 3.000 miliardi di metri cubi di
gas naturale.
Per
l’Egitto, agli inizi del 2009, le proiezioni puntavano ad aprire nuovi
giacimenti con gli accordi di production sharing, della BP e della RWE tedesca.
Ma queste hanno rifiutato di impegnarsi con investimenti capaci di implementare
il mercato locale. Era noto a tutti che il Cairo non aveva la disponibilità
monetaria per coprire la sua quota d’investimenti nei progetti di sviluppo
dell’offshore. Mubarak ha così prorogato la moratoria sui progetti di
esportazione. L’anno successivo, la soluzione contrattuale proposta da BP e
RWE, porta le due companies ad auto-spianarsi la strada approfittando della
debolezza finanziaria del Paese. Si sono assicurate il 100% di concessioni
ventennali nei bacini dell’offshore del Delta del Nilo e del Mediterraneo
Occidentale. Se all’Egitto si riconoscono le royalties, le società si
assicurano, dal 2014, il diretto monopolio del gas.
Un’altra
difficile questione riguarda la fornitura di gas a Israele, negoziata fin dal
2005 e intrapresa nel 2008. La condotta, che prevedeva rifornimenti a un
circuito integrato tra Israele e la Palestina, è stata depennata e sostituita
da una pipeline da al-Arish ad Ashkelon che porta 1,7 miliardi di metri cubi
annui, pari al 40% dei fabbisogni israeliani, per un periodo di 15 anni.
L’operazione in causa ha acceso non pochi dibattiti, non solo perché defalca
gas al Paese in crisi, ma, perché legittima l’emissione di un prezzo troppo
basso. A fine dicembre 2010 è stata presentata una revisione del contratto dove
i prezzi erano comunque al di sotto del 40% rispetto al mercato
internazionale. L’approvvigionamento è stato interrotto con il sabotaggio del 5
febbraio alla stazione di Al Arish e, con la primavera araba, la commedia di
Mubarak, che prometteva gas a basso prezzo, ha avuto fine.
Ma
la questione del gas lascia apre molti altri interrogativi:
-
L’“espansionismo” israeliano lascia che la texana Noble Energy punti tutte le
sue risorse sull’offshore situato tra Cipro e la costa israeliana.
Secondo le stime, nel giacimento del Leviathan, ci sarebbero quasi 450 miliardi
di metri cubi di gas, mentre il capitale complessivo del bacino del
Mediterraneo Orientale ne conterebbe più di 3.000 miliardi di metri cubi.
La convenzione del mare prevede accordi tripartiti tra Israele Libano ed
Egitto, ma, ciò non sembra preoccupare Israele il quale è intenzionato a
spartirsi le risorse del sottosuolo in esclusiva con Cipro.
-
Ankara, invece, non riconosce le frontiere marittime che Cipro e Israele hanno
siglato e cerca di aprire una crisi che coinvolge tutti i Paesi rivieraschi.
Erdogan, che vuole mettere Israele in secondo piano, sta rafforzando la
cooperazione economica con l’Egitto proprio per creare un’opposizione alla
collaborazione Israele-Cipro.
L’Egitto
può sostituire Israele nei commerci turchi e diventare il primo fornitore di
gas di Ankara. La Turchia a sua volta, nella collaborazione con l’Egitto
potrebbe ricavare profitti strategici e, con l’obiettivo di disturbare
i piani di Israele, potrebbe aprire collegamenti con il Libano, la Siria e
l’offshore di Gaza.
Turismo
L’industria
del turismo è un asset portante dell’economia egiziana, crea posti di lavoro e
sostiene circa il 10% della popolazione. È una delle principali voci del
bilancio nazionale e fornisce un’occupazione diretta o indiretta a circa un
lavoratore su sette. Importante notare che attorno al settore turistico si
muovono anche quello dei trasporti e quello alberghiero.
Secondo
i dati forniti dal ministro del turismo egiziano, da quando l’Egitto è passato
da celebre meta turistica a teatro di rivolte, i ricavi sono calati del 30%
raggiungendo i 9 miliardi di dollari del 2011 contro i 12,5 miliardi del 2010.
I dati ufficiali mostrano chiaramente la gravità del problema. Nel 2010 il
Paese ha ospitato 14,2 milioni di visitatori stranieri per un giro d'affari di
circa 13 miliardi di dollari, mentre nell’anno appena trascorso si contano 10,2
milioni di turisti. I ricavi di luglio evidenziano una perdita degli arrivi
pari al 28% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Quindi quasi 4
miliardi di dollari in meno a causa dei movimenti rivoluzionati che hanno
portato al rovesciamento di Mubarak.
Il
crollo è stato verticale, con un calo del 60% nelle località del Mar Rosso.
Secondo le stime del United Nations World Tourism Organization, nell’estate del
2011 il mercato ha ripreso punti ma oscillando sempre in una contrazione
negativa del 42-43% rispetto al trend del anno precedente. Il ministero del
turismo egiziano ha comunicato che la diminuzione di turisti più consistente
riguarda gli emiratini (-58%), kuwaitiani (-52%) e sauditi (-48%). A trarre i
migliori profitti da questa situazione è, sicuramente, la Turchia indicata come
meta alternativa da gran parte dei tour operator.
È
indubbio che il turismo sia il settore più colpito dalle Primavere arabe.
C’è stata una rivoluzione, il dittatore è stato cacciato e ora,
l’amministrazione deve pensare al futuro. Ora che sembra arrivata la quiete, il
governo tecnico ha l’obbligo di rilanciare il settore e rassicurare i turisti
in arrivo.
Conclusioni
Le
questioni fin qui sciorinate inducono a riflettere sulle complessità delle
dinamiche che interessano il futuro dell’Egitto. Il modello governativo
proposto dai militari in carica sembra avere le sembianze di una conduzione
acefala. Si ripropone la triste cantilena di un paese che, non regge alle
sperequazioni sociali e, non riesce a soffocare il confronto (imposto) con
un’incommensurabile numero di indigenti costretti a tener vive le
proteste per non insabbiare di nuovo la realtà. È indubbio che l’Egitto resta
al centro dell’attenzione di grande e medie potenze che cercano di contendersi
il controllo del Mediterraneo.
L’instabilità
politica dello stato diventa elemento funzionale agli obiettivi delle
companies, poiché permette loro di inserirsi nei bacini e accaparrarsi le
risorse del sottosuolo, mettendo il Cairo in una posizione di sudditanza. Il
nuovo processo di ridefinizione politica e istituzionale deve puntare su
progetto democratico che collimi con il consolidamento del potere centrale e
con la formazione di un governo pienamente rappresentativo, al cui interno vi
siano elementi moderati delle diverse identità.

Pubblicata su Equilibri (http://www.equilibri.net/nuovo)
Equilibri > Medio Oriente > Marocco > Marocco – Tunisia - Egitto: la transizione amara di chi ha fatto
le rivolte
Marocco
– Tunisia - Egitto: la transizione amara di chi ha fatto le rivolte
Eleonora Ardemagni
Creata il 02/27/2012 - 09:03
Liberali,
progressisti, riformatori, modernisti, laici: queste sono solo alcune delle
tante etichette attribuite ai movimenti che hanno innescato le rivolte nelle
piazze arabe di Tunisi, Il Cairo, Rabat. In un mondo ormai post-ideologico,
sorprende che la questione definitoria si riveli un’ineludibile priorità
d’analisi. E invece essa diviene essenziale, paradossalmente, per provare a
comprendere le cause che hanno portato questi movimenti e partiti a raccogliere
così pochi voti nelle recenti consultazioni elettorali. E interrogarsi su quale
ruolo gli animatori delle piazze nordafricane possano giocare ora, nella
decisiva fase di ricostruzione socio-politica dei loro paesi, resa ancora più ardua
ma necessaria da una crisi economico-occupazionale fortissima. In una scena
pubblica “saturata” dagli islamisti, dai militari (nel caso egiziano), dalla
monarchia (è l’esempio marocchino), l’effettiva trasformazione delle rivolte in
rivoluzioni sistemiche -o in genuini processi di autoriforma- potrebbe
dipendere soprattutto da una variabile. La capacità di coping –gestione attiva
della crisi- ovvero dall’abilità di chi ha alimentato le sollevazioni di
produrre e incanalare risorse politiche in un processo di transizione ancora in
salita.
Dentro
la sconfitta: decostruire e ricomporre
In
Tunisia e in Egitto, il carattere popolare, fluido, dinamico e non-strutturato
delle proteste è riuscito a far implodere sistemi politici indeboliti perché
disfunzionali e corrotti; in Marocco, le manifestazioni hanno indotto il re
Mohammed VI a pianificare d’urgenza un percorso di revisione costituzionale,
nonché ad anticipare di un anno le elezioni legislative. Tuttavia, i suddetti
punti di forza dei movimenti, così efficaci nella fase di scardinamento
dell’esistente, si sono trasformati in punti di debolezza nel successivo
periodo di competizione per la costruzione. Infatti, la mancanza di una
forma-partito definita e il conseguente deficit di radicamento territoriale
hanno indebolito la forza propulsiva di questi gruppi, impedendo loro di
proporsi come forze di governo identificabili e solide, soprattutto se
paragonati alle formazioni islamiste già abituate al gioco politico, nonostante
operassero in condizioni di illegalità durante i regimi (come Ennahda in
Tunisia e i Fratelli Musulmani in Egitto). In più i non-islamisti, bloccati da
liti e particolarismi, non sono riusciti a dar vita a coalizioni compatte e
rappresentative, disperdendosi in numerosissime liste dal bacino elettorale
davvero ridotto. La frammentazione ha dunque prevalso sull’individuazione di
una piattaforma d’azione comune, forse incoraggiata anche da leggi elettorali
di tipo proporzionale. E dalla tendenza, rintracciabile in tutti i sistemi che
tornano ad aprirsi dopo lunghe esperienze autoritarie, alla moltiplicazione
degli attori partitici.
D’altra
parte, occorre riflettere sul fatto che sono intercorsi solo pochi mesi fra
l’inizio delle proteste e gli appuntamenti elettorali: ciò ha senza dubbio ostacolato
il processo di organizzazione dei movimenti e di consolidamento dei partiti,
nonché il fisiologico approfondimento delle dinamiche di negoziazione politica
fra le parti. Inoltre, i finanziamenti per la campagna elettorale hanno
contribuito a divaricare ancora di più il peso delle forze in campo a favore
degli islamisti, a causa del probabile supporto economico ricevuto da soggetti
esterni, soprattutto in Egitto (probabilmente da parte dell’Arabia Saudita e
delle monarchie del Golfo). Forse, la chiave di volta del ragionamento va però
cercata nel contenuto dei messaggi politici lanciati dalle parti durante la
competizione elettorale. Ed è su questo terreno, che avrebbe dovuto vederli in
netto vantaggio, che coloro che hanno innescato e condotto le rivolte non hanno
saputo giocare le loro carte, lasciando slogan, temi programmatici e spazio
mediatico ai più scaltri islamisti. I quali, paradossalmente, sono riusciti a
farsi percepire come gli attori del cambiamento, ri-definendosi e ricalibrando
la propria retorica sugli umori e le richieste popolari.
Mentre
all’inizio delle proteste (è il caso dei Fratelli Musulmani e dei salafiti di
al-Nour in Egitto) non esitarono a definire i manifestanti “anti-islamici”.
Così in Marocco, gli islamisti del Parti de la Justice et du Développement
(PJD) si propongono di mitigare il tratto autoritario della monarchia facendosi
portatori del concetto di responsabilità democratica all’interno delle
istituzioni: proprio una delle espressioni più scandite durante le manifestazioni
organizzate nel Paese da attivisti di sinistra ed esponenti sindacali, non solo
in questi mesi ma, con crescente vigore, già dal 2007. In Egitto, il braccio
politico dell’organizzazione dei Fratelli Musulmani, Freedom and Justice Party
(FJP) presenta un programma elettorale incentrato su contenuti molto simili a
quelli delle forze considerate più riformiste: sui temi economici, l’attenzione
alla giustizia sociale, da garantire mediante l’intervento statale, è
addirittura più marcata nelle proposte di questi ultimi, piuttosto che
nell’idea di “liberalismo competitivo” sostenuta dagli islamisti. È il “gioco
delle parti” fra chi, come i movimenti ritenuti più progressisti, tenta di
disegnare un progetto maturo di società perché inclusivo e chi, come i Fratelli,
cerca di mostrare un volto moderno pur nella tradizione, rassicurante e al
tempo stesso attrattivo per gli investitori occidentali. In questo senso vanno
lette pure le ricorrenti lodi nei confronti dell’AKP di Erdogan, erto a fonte
d’ispirazione soprattutto dopo il viaggio del premier turco a Tunisi e Il
Cairo, nel settembre scorso. Senza però sottovalutare i distinguo in merito
alla questione della laicità dello stato, profondamente kemalista e dunque
inscritta nella storia politica di Ankara.
Al di
là delle tattiche elettorali, il principale handicap dei gruppi che per primi
si sono ribellati allo status quo va forse ricercato nella storia culturale dei
rispettivi Paesi e risiede nella loro natura elitaria. Infatti questi
movimenti, da sempre affascinati dal confronto con il pensiero liberale
occidentale e impegnati a rielaborarlo in chiave islamica, sono espressione
della parte più aperta e colta della società, quella numericamente più esigua.
Potremmo dunque essere di fronte al rinnovarsi dell’antica borghesia elitaria:
essa si riaffaccia nel discorso pubblico arabo-musulmano ogni volta che i
sistemi politici si dibattono fra opportunità di riforma e tendenze
all’irrigidimento. Citare le esperienze dei nazionalisti del Destur in Tunisia
(anni Venti) e il periodo del Wafd liberale (dal 1922 a 1952) in Egitto può
essere utile per comprendere l’orizzonte storico e insieme il ricorrere
temporale dei medesimi problemi di percezione politica dei gruppi elitari; ma
l’analogia non deve esaurire lo spazio dell’analisi né distogliere dalle
possibili novità della contemporaneità. È vero che molti dei giovani
manifestanti delle piazze arabe proviene proprio da famiglie più benestanti
della media (come il Movimento egiziano 6 aprile), con un livello d’istruzione maggiormente
elevato rispetto al resto dei cittadini. Ma non può sfuggire che le formazioni
dell’Islam politico hanno negli anni attirato a sé l’attenzione e il consenso
di segmenti di classe media e mondo delle professioni, capitalizzando in
percentuali di voto le ricadute sociali dell’odierna crisi economica. Il
rischio, già tramutatosi in realtà, è che i messaggi politici più innovativi e
meno radicati, come quelli improntati a una riforma liberale dello Stato,
risultino ostici e persino preoccupanti per una larga parte di cittadini, anche
perché propagandati con un linguaggio troppo complicato e oscuro. E
contribuiscano invece ad alimentare i consensi degli islamisti, portatori
di una visione tradizionale e comprensibile della società perché incentrata
sull’Islam, “din wa dawla”, ovvero religione e Stato, quindi di per sé garante
di giustizia sociale.
A
questo proposito, l’esempio del Polo democratico modernista in Tunisia (e del
partito Ettajdid al suo interno) pare sintomatico. La coalizione del Pôle Démocratique
moderniste (PDM) ha conquistato solo 5 seggi alle recenti elezioni per
l’Assemblea costituente tunisina (rispetto ai 90 del primo partito Ennahda): il
rassemblement della sinistra laica, nove formazioni organizzate intorno
all’Ettajdid, plasmatosi alla scuola francese e più incline all’uso di
quest’ultimo invece che all’arabo, paga una campagna elettorale fondata proprio
sul tema della laicità dello stato. Dall’altro lato, il concetto di giustizia
sociale, architrave dei programmi degli islamisti, è in grado di intercettare
un alto e diffuso consenso popolare, in particolare in una fase di esplosione
delle diseguaglianze sociali come questa. In più, i partiti islamisti
dispongono di una rete fitta e capillare di organizzazioni caritatevoli, sul modello
dei Fratelli musulmani, capace di supplire in molte aree all’assenza del
welfare statale: così, la quotidiana assistenza locale produce affiliazione
partitica, radicando l’Islam politico sia da un punto di vista territoriale che
culturale. Ciò spiega la fatica dei movimenti più liberali e laici di
raccogliere voti al di fuori dei centri urbani, specie nelle campagne più
isolate, meno raggiunte dagli echi mediatici delle rivolte. E questa
“componente assistenziale” della strategia riduce lo spazio della competizione,
costringendo gli altri gruppi a un continuo “gioco di rimessa”.
Dopo
la sconfitta: la costruzione dell’identità politica
C’è
chi, come Olivier Roy, ha definito le rivolte nordafricane “post-islamiste”:
alle manifestazioni, prive di connotazione religiosa, hanno invece fatto
seguito vittorie elettorali nette dei partiti islamisti, che tuttavia non
possono governare da soli perché privi della maggioranza assoluta dei seggi
parlamentari. Alcune componenti d’ispirazione liberale e laica, non a caso già
presenti da tempo sulla scena pubblica nazionale, partecipano così a governi di
coalizione. In Tunisia, l’esecutivo chiamato a traghettare il paese fino
all’approvazione della nuova Costituzione è guidato da Ennahda (che ha ottenuto
il 41% dei voti) insieme a due partiti del centro-sinistra liberale, Congrès
pour la République (CPR 14%) e Ettakatol (FDLL 10%). In Marocco, il PJD (107
seggi) governa con i nazionalisti dell’Istiqlal (60 seggi) e due formazioni
minori, i berberi del Movimento popolare (32 seggi) e il Partito del progresso
e del socialismo (18 seggi). Gli equilibri politici egiziani sono ancora in
divenire: Giustizia e Libertà, il partito dei Fratelli musulmani che ha vinto
le elezioni con il 47% dei suffragi, sembra orientarsi verso un’alleanza con i
liberali storici di al-Wafd (8% dei voti), rinunciando a un accordo con
al-Nour, il partito salafita arrivato secondo con il 24% dei consensi.
D’altronde, il fronte islamista egiziano presenta al suo interno divergenze non
trascurabili: il pragmatismo astuto degli Ikhwan (i Fratelli) si scontra con la
rigidità ideologica dei salafiti, protesi a un’azione di riforma morale, prima
che politica, della società, ponendo così in contrasto le due formazioni
proprio sul piano degli obiettivi strategici. La situazione resta però molto
incerta, anche perché il ruolo del potente Consiglio Supremo delle Forze Armate
si fa di ora in ora più ingombrante.
Nella
costruzione dell’identità politica, i movimenti che hanno dato vita alle
rivolte di Tunisia, Egitto, Marocco non sono stati finora capaci di darsi un
profilo culturale e politico definito nonché riconoscibile, ma si sono
soprattutto presentati come forze di opposizione (all’autoritarismo esistente)
e forze in opposizione (agli islamisti e al loro progetto di società). Mentre
in maniera speculare, le formazioni che afferiscono all’Islam politico sono
chiamate ad affrontare il problema di un’immagine di sé stereotipata e carica
di pregiudizio, proprio in virtù delle loro radici ideologiche, in primo luogo
agli occhi della comunità internazionale. Pertanto, il compito primo e
necessario dei gruppi politici che hanno accelerato la “decomposizione” degli
equilibri interni ai loro Paesi è affrontare con determinazione la questione
identitaria. Un processo interno essenziale perché mirato a individuare la
propria essenza, magari trascendendo dall’uso aprioristico di etichette
occidentali, con l’obiettivo di rendere efficace la comunicazione politica
anche in termini elettorali e quindi l’incisività della stessa azione pubblica.
Costruendosi una definizione “in positivo”, che non sia più elaborata “per
negazione e per sottrazione” delle altre. A riguardo, lo scrittore Faraj Fuda
(1945-1992), una delle voci più originali del liberalismo egiziano, osservava
che “[…] pazienza e tempo sono richiesti non solo nella competizione contro gli
islamisti, ma anche per raggiungere una piena democrazia”.
Conclusioni
Da un
punto di vista comparato e nel medio periodo, il ruolo dei non-islamisti nella
transizione politica appare potenzialmente più incisivo in Tunisia, poiché essa
è chiamata a riformare la Costituzione ora, a consultazioni già avvenute e
dunque con la partecipazione certa di alcune, seppur poche, componenti
liberali. A un primo sguardo, l’Egitto dovrebbe essere destinato allo stesso
percorso. Invece, oltre all’incognita dei militari, nel marzo 2011 sono stati
approvati via referendaria dei “principi sopracostituzionali”, tra i quali ve
n’è uno che disciplina i criteri di composizione dell’Assemblea costituente: il
Parlamento può dunque nominare solo venti dei cento membri dell’organismo,
poiché i restanti ottanta vengono scelti dal Consiglio Supremo delle Forze
Armate tra i rappresentanti della società civile egiziana. In Marocco, il
processo di riforma interna è stato gestito con prontezza, ma somiglia troppo a
una concessione del makhzen –il cuore del potere della Corte- al popolo. Il Re
ha delegato la stesura degli emendamenti -approvati poi tramite referendum nel
giugno 2011- alla Commissione consultiva per la revisione della Costituzione,
presieduta da un suo consigliere. Quindi, non vi è stato né coinvolgimento
delle opposizioni e dei gruppi che hanno organizzato le rivolte, né il nuovo
Parlamento (eletto solo nel novembre successivo) ha potuto esprimere la commissione.
Fino
a questo momento, gli islamisti hanno dimostrato una capacità camaleontica di
riposizionarsi sulla scena pubblica, dando luogo a una vera operazione di
rebranding politico, anche se non vanno trascurate le differenze ideologiche
all’interno del fronte, tutt’altro che granitico, dell’Islam politico.
All’opposto, i gruppi animatori delle rivolte hanno difettato di pragmatismo,
in certi casi fino a boicottare l’appuntamento elettorale -come la Coalizione
marocchina del 20 febbraio- rimanendo quindi intrappolati nella difesa
intransigente di principi e metodi dell’azione politica. La prova del governo e
quella dell’opposizione potrebbe perciò aiutare la maturazione di entrambe le
parti; mettendo gli islamisti a confronto con l’esercizio quotidiano del potere
e le scelte che ne derivano
-per ora abbottonatissimi nelle dichiarazioni sul tema “caldo” della
politica estera e dei rapporti con Israele- e convincendo i gruppi nati con le
rivolte che “sporcarsi le mani” dentro le istituzioni è l’unico modo per
tentare di modellare il sistema politico del futuro, agendo mediante nuove e
migliori pratiche pubbliche.
Oltre all’Egitto, Algeria, Israele,
Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità palestinese. Dal
6 novembre 2007 partecipano a pieno titolo al Processo di Barcellona anche
Albania e Mauritania.
Allo stato attuale sono in vigore gli
accordi con Tunisia (1° marzo 1998),
Marocco (1° marzo 2000), Israele (1° giugno 2000), Giordania (1° maggio 2002), Egitto (1° giugno 2004), Algeria (1° settembre 2005), Libano (1° aprile 2006) e l’accordo interinale d’associazione sugli
scambi e la cooperazione con l’Organizzazione per la liberazione della
Palestina a vantaggio dell’Autorità palestinese (1° luglio 1997). Con la Turchia è in vigore dal 1964 un accordo di
associazione, cosiddetto di prima generazione, superato dallo status di paese
candidato della Turchia. Il negoziato con la Siria è stato concluso il 19
ottobre 2004; il 17 dicembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo (COM (2004) 808) che è
ancora in attesa di esame.

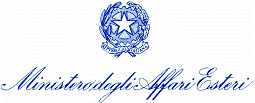
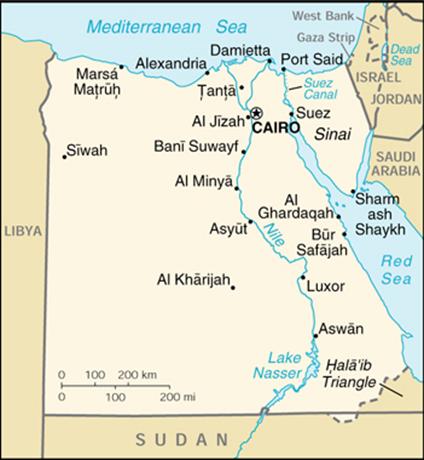
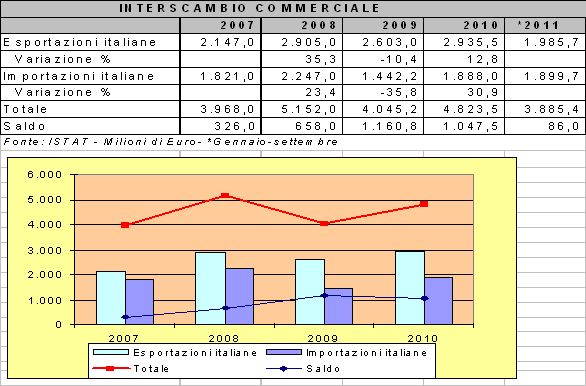






![[Al-Sayed Al-Badawi. Image from bp.blogspot.com]](Es1063_file/image021.jpg)