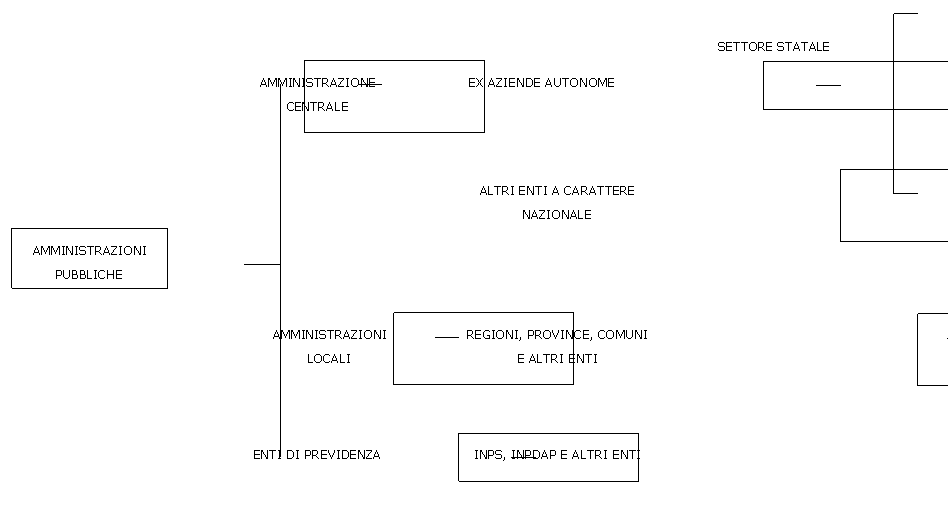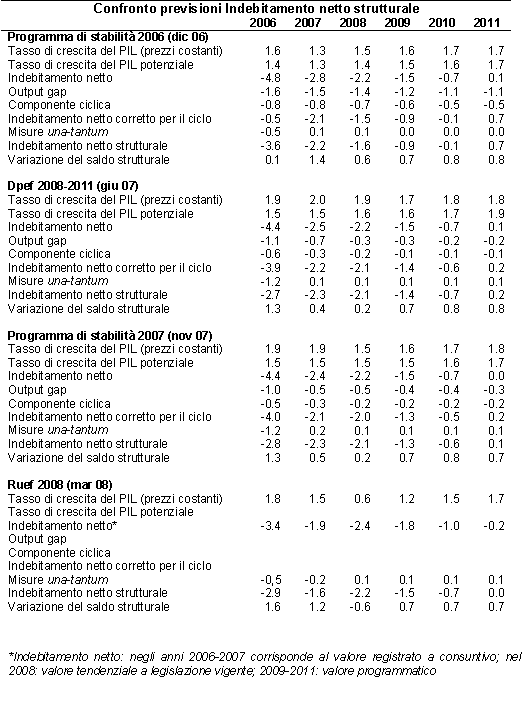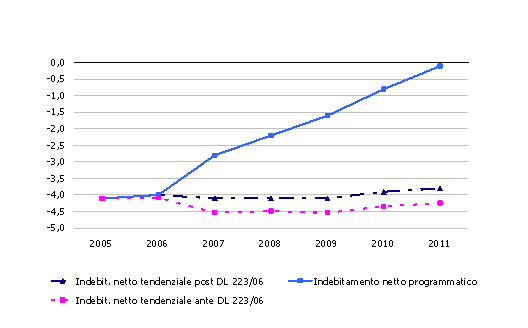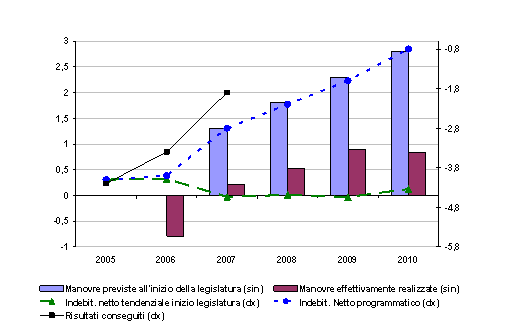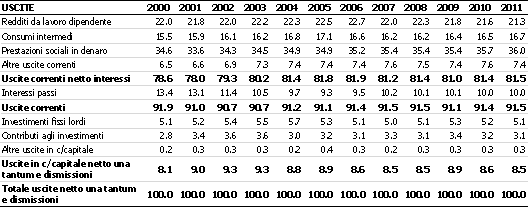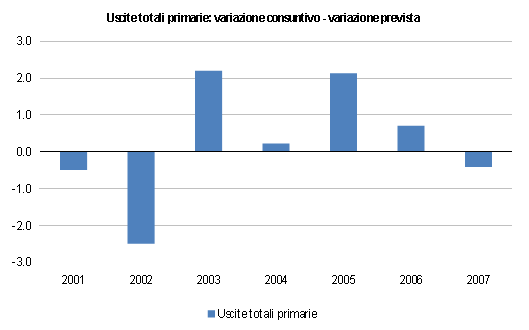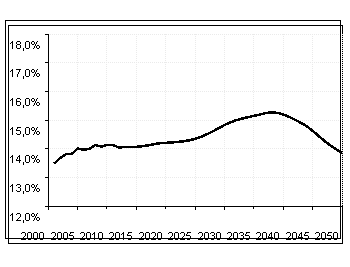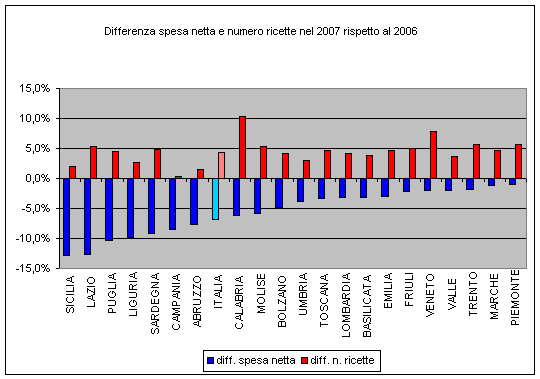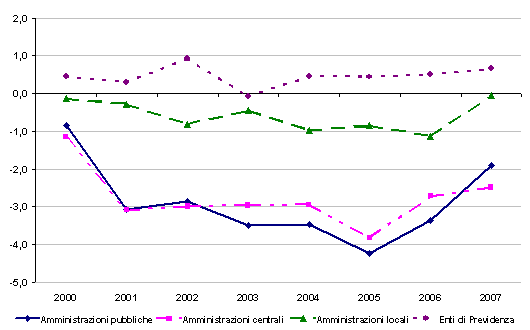PARTE I5
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE NORME. 5
IL PROCEDIMENTO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI. 7
Il vincolo di copertura finanziaria delle leggi ed il
procedimento di quantificazione. 7
La relazione tecnica. 10
La verifica parlamentare delle quantificazioni13
L’attività del Servizio Bilancio dello Stato. 16
La condivisione dei metodi di quantificazione. 19
La verifica delle quantificazioni riferite ai saldi di
rilievo europeo. 21
PROFILI METODOLOGICI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLE
QUANTIFICAZIONI. 23
L’analisi normativa: corrispondenza tra norme ed
effetti quantificati nella relazione tecnica.23
L’analisi dei dati sottostanti la quantificazione. 27
- La disponibilità dei dati28
- La rettifica dei dati29
Profili temporali delle quantificazioni: previsioni ultratriennali ed incidenza di
fattori demografici nella spesa sociale 31
Aspetti problematici connessi alle clausole di non
onerosità. 40
Effetti finanziari riferiti ad una pluralità di atti
normativi52
- La neutralità finanziaria del procedimento di
riorganizzazione dei Ministeri53
- I risparmi ascritti alla ridefinizione delle
posizioni dirigenziali57
Meccanismi automatici per il controllo della spesa ed
il conseguimento di risparmi59
- Clausole di salvaguardia definite mediante
meccanismi automatici di controllo della spesa. 59
- Meccanismi automatici a presidio di risparmi di
spesa. 64
La revisione delle quantificazioni nella fase di
attuazione delle leggi67
- Rifinanziamento e definanziamento di norme di spesa. 67
- Le eccedenze di spesa. 72
La quantificazione degli effetti delle norme sui saldi
di fabbisogno e di indebitamento. 86
- La conoscenza dei criteri di quantificazione. 88
- La compensazione degli effetti peggiorativi sui
saldi96
Il mantenimento in bilancio e la riassegnazione alla
spesa di somme non utilizzate. 100
- Effetti finanziari connessi all’impiego in esercizi
successivi di somme non utilizzate. 100
- Un’indiretta conferma degli effetti sui saldi : i
risparmi connessi alla riduzione del periodo di perenzione dei residui107
- Principali problematiche emerse in sede di verifica
delle quantificazioni107
Coperture finanziarie a valere su maggiori entrate non
previste. 113
- L’utilizzo di maggiori entrate accertate in corso
d’anno. 115
- Utilizzo di maggior gettito connesso all’andamento
dei prezzi di determinati prodotti125
- L’utilizzo di effetti fiscali indotti127
Devoluzione di entrate per il finanziamento di
funzioni locali131
La copertura degli oneri correnti nelle leggi
finanziarie. 139
- Coerenza temporale tra oneri e mezzi di copertura. 140
- Utilizzo tra i mezzi di copertura di risparmi di
spesa. 141
- Utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico. 142
PARTE II145
ANALISI DEI PRINCIPALI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA.. 145
La verifica degli andamenti di finanza pubblicA.. 147
Il Patto di stabilità e crescita e il conto economico delle
P.A.151
Il Patto di stabilità e crescita. 151
- La procedura di disavanzo eccessivo nei confronti
dell’Italia. 153
Il conto economico delle P.A. ed il Sistema europeo
dei conti156
I principali saldi di finanza pubblica.. 161
I saldi del conto economico delle Pubbliche
amministrazioni163
- L’indebitamento netto. 163
- Il saldo primario. 167
I saldi strutturali171
- Il saldo corretto per il ciclo e l’output gap. 171
- Le misure una tantum.. 172
- L’indebitamento netto strutturale nel periodo
2006-2011. 176
Le manovre di finanza pubblica. 180
- Fase restrittiva. 181
- Fase espansiva. 184
- Valutazione d’insieme del contributo delle manovre
al risanamento. 187
Il fabbisogno ed il debito. 191
- Il fabbisogno. 191
- Il debito delle Amministrazioni pubbliche. 197
APPROFONDIMENTI SETTORIALI. 207
Le entrate. 207
- Le entrate nel conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche. 207
- La pressione fiscale. 210
- La dinamica delle entrate della P.A. nel 2006 – 2007. 212
- Le entrate del Bilancio dello Stato: analisi degli
incassi tributari214
- Entrate degli enti territoriali: incassi tributari218
- Le previsioni per il 2008 e per il triennio 2009 -
2011. 219
Le uscite delle pubbliche amministrazioni222
- La spesa per interessi227
- La spesa primaria. 229
- I risultati 2007 e le previsioni per il 2008. 230
Il pubblico impiego. 234
- L'occupazione nel settore pubblico. 234
- La spesa per redditi da lavoro dipendente nella P.A.238
- Le previsioni per il 2008. 240
- Il rinnovo contrattuale 2008-2009. 241
- Pubblico impiego: i problemi aperti244
I consumi intermedi249
- La regola del 2 per cento, i tagli lineari e gli
accantonamenti degli stanziamenti del bilancio dello Stato 252
La spesa sociale. 256
- La spesa previdenziale e assistenziale. 256
- Le prestazioni sociali in denaro e la spesa
previdenziale. 256
- La spesa assistenziale. 265
La spesa sanitaria. 269
- La dinamica della spesa. 270
- La composizione della spesa sanitaria. 271
- Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa
sanitaria pubblica. 277
- Il finanziamento della spesa sanitaria. 277
- Il disavanzo del SSN.. 281
- I Piani di rientro delle regioni in disavanzo
strutturale negli anni 2001-2005. 285
La spesa per l’istruzione. 290
- La spesa per l’istruzione delle Amministrazioni
pubbliche. 290
- La spesa per l’istruzione scolastica: confronti
internazionali295
La spesa in conto capitale. 303
- Gli investimenti delle Pubbliche amministrazioni306
- I contributi agli investimenti308
- Le previsioni per il 2008 relative alla spesa in
conto capitale. 310
La spesa per ricerca e sviluppo. 312
- La spesa per ricerca e sviluppo negli anni
2000-2005.313
- La spesa per la R&S nel contesto internazionale. 316
La spesa ambientale. 318
- La spesa per la protezione dell’ambiente (anni
2000-2006)320
- Confronti internazionali321
- La fiscalità ambientale. 325
La finanza locale. 330
- Evoluzione dei saldi nel periodo 2000-2005. 331
- Il 2006. 332
- Il 2007. 333
- Il 2008. 337
- Attuazione del federalismo fiscale. 339
Il
vincolo di copertura finanziaria delle leggi ed il procedimento di
quantificazione
L’articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, dispone che ogni legge che determini nuove o
maggiori spese “deve indicare i mezzi per farvi fronte”, includendo in tal modo
la copertura finanziaria tra i requisiti di costituzionalità delle leggi.
Il vincolo
costituzionale implica che la copertura sia commisurata all’onere – inteso sia
come incremento di spesa sia come riduzione di entrate – effettivamente
derivante dalle norme. Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del
requisito indicato dall’art. 81, quarto comma, Cost., assumono rilievo la
corretta determinazione degli effetti di maggior spesa o di minore entrata
derivanti dalle norme proposte nonché la coerenza, rispetto a tali oneri, dei
mezzi di copertura apprestati.
Tale coerenza va
accertata sia sotto il profilo quantitativo – riferito all’equivalenza tra
oneri e mezzi di copertura - sia sotto il profilo temporale, per la necessaria
sincronia richiesta tra il determinarsi degli effetti onerosi e l’acquisizione
delle risorse con le quali farvi fronte.
In attuazione del
disposto costituzionale dell’art. 81, quarto comma, Cost., la legge n. 362 del
1988 ha apportato importanti innovazioni alla normativa in materia di
contabilità generale dello Stato recata dalla legge n. 468 del 1978 ,
introducendo, tra l’altro, l’art. 11-ter,
che individua, con carattere di tassatività, le tipologie di copertura ammissibili.
L’articolo 11-ter
della legge n. 468/1978 dispone infatti che alla copertura degli oneri possa
provvedersi mediante:
·
utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi
speciali previsti dalla legge finanziaria (tabelle A e B);
·
riduzioni di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa;
·
modifiche legislative che comportino nuove o
maggiori entrate.
Con lo stesso art.
11-ter è stato disciplinato un
procedimento preordinato alla corretta determinazione degli oneri e dei
relativi mezzi di copertura: quantificazione e copertura dell’onere
costituiscono in tal modo il risultato di specifici adempimenti, i cui esiti
sono suscettibili di verifica parlamentare.
Il procedimento di quantificazione è
essenzialmente incentrato sulla relazione
tecnica, ossia su un documento, predisposto dal Governo e sottoposto a
verifica da parte dei competenti organi parlamentari, con il quale si dà
conto degli oneri e delle coperture che scaturiscono dalle normative proposte
nonché dei dati e dei metodi utilizzati per la loro quantificazione.
L’articolo 11-ter, infatti:
• dispone
l'obbligo di presentazione della relazione
tecnica per tutti i disegni di legge del Governo, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
"conseguenze finanziarie";
• prevede
che le Commissioni parlamentari competenti possano richiedere al Governo la
relazione tecnica anche sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare;
• precisa
che la relazione tecnica deve essere
verificata in sede parlamentare secondo le norme dei regolamenti delle due
Camere. Tale verifica assume specifica evidenza nel quadro del procedimento
legislativo, in quanto finalizzata alla formulazione – secondo modalità e con
gli effetti disciplinati dai regolamenti parlamentari - dei pareri che le
Commissioni Bilancio di Camera e Senato sono chiamate ad esprimere sui progetti
di legge e sulle proposte emendative aventi conseguenze di carattere
finanziario.
La funzione di
controllo finanziario si esplica peraltro anche sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare sprovviste di relazione
tecnica. In tali casi la Commissione Bilancio può procedere all’espressione
di un parere sulla base dell’analisi tecnica del progetto di legge, svolta con
il supporto dei competenti uffici, e sulla base degli ulteriori elementi
forniti dai rappresentanti del Governo. Non è tuttavia infrequente il caso in
cui la Commissione stessa, qualora ritenga che i dati e gli elementi in suo
possesso non siano sufficienti per un esauriente esame dei profili finanziari
del provvedimento, richieda espressamente al Governo la predisposizione di
un’apposita relazione tecnica. A seguito dell’acquisizione della relazione, il
procedimento di verifica delle quantificazioni prosegue secondo le medesime
modalità previste per l’esame delle iniziative governative corredate di tale
strumento.
Procedimento di quantificazione
In sintesi, il procedimento di quantificazione può essere così
rappresentato:
• predisposizione
da parte dei competenti Ministeri di una relazione tecnica a corredo di
un’iniziativa legislativa o di un emendamento governativi o, su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti, a corredo di una proposta legislativa di
iniziativa parlamentare;
• prima
verifica di coerenza delle quantificazioni e di conformità della relazione
tecnica alla normativa contabile da parte Ministero dell’economia e delle
finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), che appone un
visto, con il quale si attesta che la relazione tecnica è stata verificata
positivamente ovvero negativamente: la verifica negativa può riguardare i
profili di copertura e/o di quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento,
cui la relazione tecnica si riferisce;
• trasmissione
della relazione tecnica al Parlamento, in allegato all’iniziativa legislativa o
all’emendamento del Governo ovvero in risposta alla richiesta formulata da una
Commissione parlamentare con riferimento ad iniziative legislative parlamentari;
• esame
della relazione tecnica e del testo normativo cui la stessa si riferisce da
parte della Commissione avente competenza nella specifica materia su cui verte
l’iniziativa;
• elaborazione
di un testo e trasmissione dello stesso alla V Commissione (Bilancio) per
l’espressione del parere prescritto dal regolamento;
• esame
del testo e della relazione tecnica da parte della Commissione Bilancio, previa
istruttoria tecnica degli uffici competenti;
• eventuale
richiesta da parte della medesima Commissione, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria, di un’integrazione della relazione tecnica ovvero di
ulteriori elementi e chiarimenti;
• espressione
del parere da parte della Commissione Bilancio;
• esame
ed eventuale recepimento del parere da parte della Commissione destinataria,
secondo le modalità e con gli effetti previsti dai regolamenti parlamentari.
Va precisato che la verifica delle quantificazioni si
esplica, secondo un procedimento che ricalca sostanzialmente lo schema
illustrato, anche sugli schemi di atti
normativi del Governo trasmessi alle Camere per il parere parlamentare,
che, qualora implichino entrate o spese, sono sottoposti, ai sensi dell’art.
96-ter del Regolamento della Camera,
alla Commissione Bilancio, chiamata ad esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario.
La
relazione tecnica
L’articolo 11-ter della legge n. 468/1978 configura,
quindi, la relazione tecnica come lo strumento mediante il quale il Governo, da
un lato, individua gli effetti finanziari delle normative proposte e fornisce
una stima, il più possibile attendibile, degli oneri da esse derivanti e dei
mezzi di copertura previsti, dall’altro, rende espliciti - e, pertanto,
verificabili nell’ambito del procedimento di approvazione delle leggi - tutti
gli elementi, le valutazioni nonché la sequenza dei passaggi di tipo
logico-matematico, attraverso i quali si è pervenuti alla definizione delle
medesime stime.
Lo stesso articolo 11-ter individua
un contenuto necessario delle relazioni tecniche, disponendo che le stesse debbano
indicare i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e
ogni altro elemento utile per la
verifica tecnica in sede parlamentare: ciò con l’intento di rendere possibile,
nell’ambito del procedimento legislativo, la ricostruzione esaustiva del
procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e
di attendibilità dei dati e delle ipotesi sui quali esso si fonda.
Infine, la relazione
tecnica deve indicare i risultati del procedimento di quantificazione, ossia
gli effetti finanziari che ciascuna disposizione è suscettibile di determinare.
Completano la definizione del contenuto necessario delle relazioni tecniche
ulteriori prescrizioni recate dall’art. 11-ter,
alcune delle quali presentano una valenza di carattere generale, mentre altre sono
riferite a specifiche tipologie di spese.
Si dispone infatti
che la quantificazione debba dar conto anche della proiezione temporale dell’onere con riferimento ad un arco che
generalmente coincide con quello del bilancio pluriennale, almeno per quanto
riguarda la spesa in conto capitale, per la quale è richiesta anche
un’indicazione dell’onere complessivo, in relazione agli obiettivi fisici
previsti. Per la spesa corrente e per le minori entrate, la relazione
tecnica deve considerare tutti gli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle norme.
Sono inoltre
previste specifiche prescrizioni,
con riferimento ai progetti di legge vertenti su particolari materie.
In particolare, si prevede che:
·
per le norme in materia di pensioni, sia fornito
un quadro analitico di proiezioni, almeno decennali, riferite all'andamento
delle variabili collegate ai soggetti beneficiari;
·
per le misure concernenti il pubblico impiego,
siano indicati i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che conseguono dalle norme fino alla loro
completa attuazione, nonché sulle correlazioni con lo stato giuridico ed
economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili;
·
per gli interventi che comportino oneri a carico
di enti del settore pubblico la relazione tecnica riporti le valutazioni
espresse dagli enti interessati, fermo restando l’obbligo di prevedere la
copertura degli oneri a carico degli enti, ai sensi dell’art. 27 della legge n.
468/1978.
Dalla descrizione fornita emerge come il legislatore abbia finora
optato per un modello flessibile, che presuppone, accanto da una comune
struttura di base, contenuti delle relazioni tecniche differenziati in ragione
della natura e delle finalità delle norme oggetto di esame. Negli ultimi anni è
emersa peraltro la necessità di porre rimedio a carenze e disomogeneità
riscontrate nella predisposizione delle relazioni tecniche, individuando contenuti
minimi essenziali che le stesse devono presentare, sulla base delle
prescrizioni del più volte citato art. 11-ter
della legge n. 468/1978 e modelli standardizzati di redazione delle relazioni
stesse.
Tali elementi sono
stati ribaditi - con ulteriori precisazioni di carattere applicativo - dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, che
ha inoltre stabilito le caratteristiche e le modalità di redazione della
relazione tecnica secondo un modello standardizzato (cosiddetto “manuale per la
predisposizione della relazione tecnica standard”). Nel quadro della
definizione di tale modello sono state anche fornite indicazioni di dettaglio
circa i contenuti che, in attuazione della vigente normativa, le relazioni tecniche devono
presentare.
Si dispone, tra l’altro, che:
• le variabili relative al quadro macroeconomico utilizzate ai fini
delle quantificazioni siano quelle riportate nei più recenti documenti di
finanza pubblica; eventuali eccezioni dovranno essere espressamente indicate;
• siano altresì indicati tutti “i passi logico-matematici” che
hanno portato alla definizione degli effetti finanziari diretti ed indiretti;
• l’onere sia indicato, in applicazione della legge n. 246/2002,
come limite massimo di spesa, ovvero come previsione di spesa.
Viene tuttavia precisato che, anche qualora sia la norma stessa ad indicare la
dimensione finanziaria dell’intervento (c.d. “limite di spesa”), la relazione
tecnica debba fornire tutte le indicazioni e gli elementi necessari a valutare
la congruità delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi assegnati. Nel
caso in cui si tratti invece di una previsione di spesa, deve essere sempre
indicata una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione
degli effetti che eccedano le previsioni medesime;
• per le misure che comportino oneri di carattere permanente o con
proiezione oltre il triennio, particolare attenzione sia dedicata all’individuazione
del cosiddetto onere a regime e alle relative forme di finanziamento;
• per le disposizioni in materia di entrata, gli effetti sul
gettito siano esplicitati anche rispetto alle Regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e Bolzano;
• siano sempre quantificati gli oneri riferiti ad interventi che
riguardano amministrazioni diverse dallo Stato (Enti territoriali e
previdenziali, Aziende sanitarie, ecc.), indicando la relativa copertura in una
specifica sezione della relazione tecnica; la copertura potrà essere
rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, da nuove o
maggiori entrate per l’ente interessato o da minori spese per il bilancio del
medesimo ente;
• siano individuati gli effetti finanziari indotti del provvedimento;
• in apposita sezione sia indicato l’impatto della normativa
introdotta sui diversi saldi di finanza pubblica (saldo netto da
finanziare; fabbisogno di cassa del settore statale; indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche); qualora si riscontrino differenze tra i tre
aggregati, vanno indicate le ragioni di tali discrasie, “tenuto conto degli
effetti della gestione di tesoreria e delle regole del SEC 95”.
Si tratta di
indirizzi recepiti, mediante rinvio alla citata direttiva del 2004, anche dalla
recente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2006,
che ha altresì stabilito, nel quadro della definizione di indirizzi per il
coordinamento dell’azione di Governo, il divieto di prendere in considerazione
iniziative legislative prive di relazione tecnica o con relazione redatta in
difformità dal prescritto modello standard.
Va tuttavia segnalato
che il modello standard per la
predisposizione delle relazioni tecniche non ha finora trovato una sistematica
applicazione e che, anche a prescindere dall’utilizzo di una modulistica
predefinita, i contenuti delle relazioni tecniche non sempre corrispondono in
modo omogeneo e ricorrente a quelli indicati dalle due direttive sopra
richiamate.
La
verifica parlamentare delle quantificazioni
Come già
evidenziato, il procedimento di quantificazione è articolato tra i vari
portatori dell’interesse finanziario (principalmente le Amministrazioni di
settore ed il Ministero dell’economia e delle finanze, sul versante
governativo, le Commissioni di merito e la Commissione Bilancio, sul versante
parlamentare): la quantificazione non rappresenta infatti il frutto
dell’elaborazione di un unico centro dotato di competenze tecniche, ma il
risultato di un processo dialettico tra i diversi soggetti del comparto
finanziario istituzionalmente coinvolti nella formazione degli atti normativi.
Il procedimento presuppone quindi un confronto tra organi governativi
(responsabili delle quantificazioni e dei dati ad esse sottostanti) ed organi
parlamentari, in primis le
Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, (impegnate nella fase della
verifica delle quantificazioni).
Come già accennato,
la verifica delle quantificazioni in sede parlamentare assume una specifica
evidenza nel quadro dell’attività consultiva svolta dalle Commissioni Bilancio
di Camera e Senato: i pareri resi dalle due Commissioni in merito agli effetti
finanziari delle iniziative legislative ed i rilievi formulati sulle
conseguenze finanziarie degli schemi di atti normativi del Governo
rappresentano infatti l’esito di procedimenti di verifica delle quantificazioni
degli effetti finanziari dei provvedimenti e, qualora questi abbiano natura
onerosa, delle corrispondenti coperture finanziarie.
Sono sottoposte a
verifica in primo luogo le quantificazioni operate dalla relazione tecnica, al
fine di valutarne la coerenza sul piano del procedimento logico-matematico,
dell’attendibilità delle ipotesi e della validità dei metodi adottati,
dell’affidabilità dei dati utilizzati, della rispondenza delle stime al
contenuto delle norme. A tali fini gli organi parlamentari si avvalgono del
supporto delle strutture amministrative competenti e dell’istruttoria tecnica svolta
dagli stessi. Gli esiti di tale esame costituiscono la base del dibattito che
si sviluppa nel corso delle sedute della Commissione Bilancio e può diventare
il presupposto per la richiesta al rappresentante del Governo – avanzata nel
corso dell’esame svolto presso la Commissione stessa - di dati ed elementi
ulteriori, di un’integrazione della relazione tecnica ovvero di approfondimenti
o maggiori chiarimenti su singoli profili.
Gli elementi
richiesti sono generalmente forniti, nel corso delle sedute, dal rappresentante
del Governo che, a sua volta, si avvale dell’attività svolta dai competenti
uffici governativi (uffici dell’amministrazione avente competenza nella
specifica materia trattata dall’iniziativa legislativa, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze, ecc.).
Sulla base
dell’esame tecnico svolto e del confronto con i rappresentanti del Governo,
viene a maturare un orientamento della Commissione sui profili finanziari dei
provvedimenti al suo esame, fondato sull’istruttoria tecnica effettuata e sui
dati raccolti: tale giudizio si esprime in un parere, adottato mediante una votazione.
Il parere
costituisce quindi oggetto di una pronuncia, assunta al termine di una
discussione politica, condotta sulla base di un’approfondita istruttoria
tecnica e di un confronto con i rappresentanti del Governo.
Il parere può essere favorevole e, quindi, confermare le
quantificazioni operate dalla relazione tecnica, oppure può essere contrario in
quanto considera non fondate le stime riportate oppure non adeguate o non
disponibili le risorse utilizzate a copertura.
I casi più frequenti sono tuttavia quelli in cui la
Commissione esprime un parere favorevole, corredandolo di osservazioni (di
carattere non vincolante) ovvero di condizioni (vincolanti), volte ad adeguare
il dettato normativo alle esigenze di rispetto del vincolo di copertura
finanziaria.
Non è infrequente il caso in cui le condizioni poste con il
parere approvato dalla Commissione siano tali da imporre una rideterminazione delle stime indicate nella relazione tecnica, alla luce di
eventuali errori o di una inidoneità dei dati e delle ipotesi utilizzati,
acclarati nel corso della verifica parlamentare.
Qualora manchi invece
una relazione tecnica, come già accennato, il progetto di legge viene comunque
esaminato dalla Commissione Bilancio, che, qualora ritenga insufficienti gli
elementi forniti dal rappresentante del Governo nel corso della seduta ovvero
ravvisi possibili profili problematici o la necessità di approfondimenti, può
richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.
Gli effetti dei
pareri espressi dalla Commissione Bilancio sono disciplinati dai regolamenti
parlamentari e variano a seconda della sede (referente, legislativa, redigente)
di esame dei provvedimenti.
Nell’ipotesi di esame, in sede referente sussiste
l’obbligo, per la Commissione che non abbia recepito il parere espresso dalla
Commissione bilancio, di indicarne le ragioni nella relazione per l’Assemblea
(art. 74 Reg. Camera).
Il carattere vincolante dei pareri espressi dalla
Commissione Bilancio si manifesta con conseguenze procedurali di particolare
rilievo nelle ipotesi di adozione della cosiddetta procedura decentrata di
esame dei progetti di legge, presso le Commissioni competenti, in sede
legislativa o in sede redigente: infatti, la conseguenza del mancato
rispetto delle parti vincolanti dei predetti pareri si sostanzia, nel caso del
procedimento in sede legislativa, nella rimessione all’Assemblea del progetto
di legge (ai sensi dell’art. 94 Reg.) e, nel caso dell’esame in sede redigente,
nell’instaurarsi di una procedura che può concludersi con l’approvazione da
parte dell’Assemblea di un ordine del giorno, che obblighi la Commissione che
ha proceduto all’elaborazione del testo a modificarlo per adeguarlo alle
condizioni imposte dalla Commissione Bilancio (art. 96 Reg.).
In ogni caso,
nell’ipotesi di conflitto tra la Commissione Bilancio e le competenti
Commissioni di settore riguardo alla copertura finanziaria dei provvedimenti,
il giudizio, in ultima istanza, è rimesso all’Assemblea, che può esprimersi
anche in difformità ai pareri resi dalla V Commissione sui profili di copertura
finanziaria. Il parere della Commissione Bilancio ha infatti funzione istruttoria rispetto alle
determinazioni assunte dall’Assemblea. Le norme regolamentari mirano a rendere
comunque palese, in ogni fase della decisione di Assemblea, la pronuncia
adottata, per i profili di competenza, dalla Commissione Bilancio sul testo
legislativo e sulle proposte emendative ad esso riferite.
Particolare rilievo
assumono, a tal riguardo, le modifiche regolamentari apportate con
l’introduzione, all’articolo 86, del comma 4-bis, che annette peculiari effetti ai pareri della Commissione Bilancio, che risultino espressamente motivati con riferimento
all’osservanza dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti,
qualora la Commissione che procede in sede referente non adegui il testo
legislativo a siffatte indicazioni, la norma regolamentare introdotta dispone
che le corrispondenti proposte di modifica o di soppressione, volte a recepire
le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio, assumono un autonomo e ben
individuato rilievo procedurale: tali proposte si intendono infatti presentate
come emendamenti e sottoposte alla votazione dell’Assemblea. Non è ammessa la
presentazione di subemendamenti né la votazione per parti separate.
Infine, i rilievi formulati dalla Commissione
Bilancio, ai sensi dell’articolo 96-ter
del Regolamento, sugli schemi di atti
normativi del Governo che implichino entrate o spese, sono trasmessi al
Governo unitamente al parere della Commissione competente per il merito.
Resta in tali casi impregiudicata la facoltà del Governo di
discostarsi dal parere parlamentare nell’emanazione degli atti normativi, ma il
giudizio parlamentare sui profili finanziari assume un rilievo specifico, determinando
quasi sempre una coerente pronuncia finale del Governo, diretta a recepire le
indicazioni formulate.
L’attività
del Servizio Bilancio dello Stato
La verifica delle quantificazioni effettuata in sede parlamentare viene
espressamente qualificata dall’art. 11-ter
come di carattere tecnico: essa si
avvale pertanto, come già segnalato, di un’istruttoria tecnica svolta dalle
strutture amministrative competenti.
A seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 362/1988, sono state pertanto costituite,
presso i due rami del Parlamento, apposite strutture (i Servizi Bilancio) che
hanno iniziato ad operare a partire dal 1989. Alla Camera, il Servizio Bilancio
dello Stato svolge una disamina dei testi legislativi e delle relative
relazioni tecniche, all’esame della Commissione Bilancio, e sottopone a
verifica tecnica le quantificazioni riguardanti gli oneri derivanti da tali
testi nonché i mezzi di copertura, qualora anche questi ultimi siano oggetto di
stima, come nel caso dell’utilizzo, a fini di copertura finanziaria, di
maggiori entrate derivanti da nuove normative proposte.
La verifica tecnica
svolta dal Servizio Bilancio dello Stato ha per oggetto, in primo luogo, la rispondenza
della relazione tecnica alle norme proposte: a tal fine è importante controllare
che tutti gli effetti onerosi che il testo normativo è suscettibile di produrre
siano correttamente individuati e sottoposti a quantificazione. Sono quindi
soggetti a verifica i dati utilizzati dalla relazione tecnica, allo
scopo di riscontrane l’attendibilità ed il grado di aggiornamento: a tale scopo
sono effettuate ricerche volte, tra l’altro, ad accertare che i dati utilizzati
per la quantificazione siano in linea con quelli forniti da altre fonti
ufficiali e che siano state utilizzate le più aggiornate basi di dati
disponibili.
Sono quindi oggetto
di verifica: i metodi di quantificazione, che devono consentire
l’individuazione di tutti i possibili effetti, diretti ed indiretti, derivanti
dalle nuove normative; il procedimento di calcolo utilizzato, le
ipotesi e le metodologie di stima - che devono fondarsi su adeguati
supporti statistici - ed ogni altro elemento su cui si fonda la
quantificazione.
All’analisi svolta
dal Servizio Bilancio dello Stato si affianca quella della Segreteria della Commissione Bilancio, che effettua un esame volto
a controllare la correttezza e la conformità alla normativa contabile delle
clausole di copertura finanziaria utilizzate e a verificare inoltre,
mediante apposite banche dati, la disponibilità effettiva dei mezzi di
copertura rinvenuti a valere su fondi speciali o derivanti da riduzioni di
autorizzazioni legislative preesistenti.
I contributi del Servizio Bilancio dello Stato e della Segreteria
della Commissione Bilancio confluiscono in un’unica nota di verifica delle quantificazioni, riferita a ciascun
provvedimento corredato di relazione tecnica, sottoposto all’esame della
Commissione Bilancio.
La nota predisposta dagli uffici, nel dar conto delle
risultanze della verifica effettuata, potrà evidenziare che la quantificazione
è correttamente svolta ovvero segnalare eventuali lacune nei dati riportati nelle relazioni tecniche ovvero profili problematici o passaggi
logico-matematici non del tutto esplicitati, che necessitano pertanto di chiarimenti e/o approfondimenti. In
alcuni casi potrà essere segnalata l’opportunità di acquisire dal Governo ulteriori elementi o un’integrazione della
relazione tecnica. Infine, la verifica tecnica potrà evidenziare veri e
propri errori nelle quantificazioni ovvero
l’utilizzo di criteri scarsamente
prudenziali nelle stime.
Tali rilievi, generalmente recepiti nel dibattito svolto
presso la Commissione Bilancio, possono indurre il relatore o la stessa
Commissione ad avanzare richieste o a formulare osservazioni di analogo tenore.
Infine, a seguito di un confronto dialettico con i rappresentanti del Governo,
la Commissione perviene alla formulazione del parere che, in base
all’istruttoria tecnica svolta dagli uffici e degli ulteriori elementi
acquisiti, può anche indicare, mediante apposite condizioni, la necessità di
una revisione delle quantificazioni
e, quindi, di una riformulazione delle
clausole di copertura finanziaria contenute nei progetti di legge.
In ogni caso, la valutazione finale della relazione tecnica e degli
effetti finanziari dei provvedimenti rientra nella sfera decisionale propria
dell'organo parlamentare. L’esito della verifica tecnica compiuta dagli uffici
competenti non ha infatti un proprio rilievo procedimentale, ma dà luogo ad una
documentazione nella piena disponibilità degli organi parlamentari e, in
particolare, della Commissione Bilancio. L’attività del Servizio Bilancio dello
Stato (unitamente a quella della Segreteria della Commissione Bilancio) si delinea
quindi come uno specifico supporto tecnico nell’ambito del complessivo
procedimento di valutazione degli oneri e degli altri effetti finanziari, con
funzione meramente istruttoria rispetto alle determinazioni adottate dalla Commissione Bilancio.
Va ancora evidenziato
che il controllo degli effetti finanziari viene avviato dalle competenti
strutture anche sui provvedimenti – sottoposti al parere della Commissione
Bilancio – privi di relazione tecnica. In tali casi viene predisposta da parte
del Servizio Bilancio dello Stato una scheda
di analisi degli effetti finanziari del provvedimento, che include le
valutazioni sulla copertura finanziaria formulate dalla Segreteria della
Commissione Bilancio. Qualora, nel corso dell’esame, sia richiesta la
predisposizione di una relazione tecnica, alla predetta “scheda di analisi”
farà seguito una “nota di verifica” delle quantificazioni riportate nelle
stessa relazione.
La
condivisione dei metodi di quantificazione
Come emerge dalla
precedente illustrazione, la legge n. 362 del 1988, modificando la legge n.
468, ha procedimentalizzato l'attività di quantificazione preventiva di oneri e
mezzi di copertura, per garantire una coerente pronuncia sui profili finanziari
dei progetti di legge. Tale procedimento si giova del contributo di una
pluralità di attori, nel quadro di un confronto dialettico tra Governo e
Parlamento.
Attraverso tale
confronto sono state analizzate, e spesso risolte, numerose questioni
metodologiche relative alla stima degli effetti delle disposizioni esaminate.
L’interazione tra i diversi protagonisti del procedimento (organi governativi
interessati e relative strutture amministrative, Commissioni Bilancio delle due
Camere e competenti uffici parlamentari) ha consentito la definizione di una
base comune di regole condivise, con
conseguente, progressivo affinamento delle metodologie di analisi e di determinazione
degli effetti finanziari dei progetti normativi.
Ulteriori soggetti
istituzionali concorrono poi, con le loro decisioni, a convalidare o a
sottoporre a rilievi critici gli esiti del procedimento di quantificazione,
attraverso un controllo che si esercita sia nella fase della formazione delle
leggi sia successivamente all’entrata in vigore delle stesse.
Si fa riferimento
essenzialmente, per quanto attiene al primo profilo, al controllo esercitato, ai
fini dell’esercizio dei poteri di rinvio ai sensi dell’art. 74 della
Costituzione, dal Presidente della Repubblica nella fase della promulgazione
delle leggi.
Successivamente
all’entrata in vigore delle leggi, i risultati del procedimento di quantificazione
trovano ancora un momento importante di valutazione e di riscontro nelle
pronunce della Corte costituzionale, motivate dal rispetto del vincolo
costituzionale di copertura finanziaria, ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Le motivazioni
addotte a sostegno delle decisioni di rinvio alle Camere dei progetti di legge
da parte del Presidente della Repubblica, così come le pronunce della Corte
costituzionale spesso costituiscono il presupposto per l’adeguamento o la
radicale modifica di regole, anche convenzionali, e metodologie di
quantificazione, contribuendo quindi al sistematico perfezionamento dei criteri
utilizzati nelle stime.
Si pensi ad esempio al problema della determinazione degli
oneri previsti oltre la durata del bilancio pluriennale e di quelli recati “a
regime” dalle leggi di spesa pluriennali.
I consolidati indirizzi interpretativi dell’articolo 81
della Costituzione, stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, impongono di
individuare l’onere recato dalle norme per tutto il periodo di effettiva durata
della legge di spesa, indicando adeguati mezzi di copertura. In particolare, a
giudizio della Corte, la ragionevolezza della copertura va valutata facendo
riferimento alla coerenza tra onere coperto nel triennio ed onere a regime.
Pertanto, la previsione di copertura può ritenersi idonea soltanto se non si
determina un apprezzabile scostamento tra l’onere massimo indicato nel bilancio
pluriennale e gli oneri previsti per gli esercizi successivi.
Tali orientamenti sono stati recepiti nell’attività di
verifica parlamentare delle quantificazioni e di controllo delle coperture
finanziarie: risulta infatti ormai consolidato il criterio in base al quale
deve essere oggetto di attenta valutazione il rapporto tra onere “a regime”
ed onere previsto per l’ultimo esercizio considerato nella clausola di
copertura finanziaria. Pertanto, per ragioni di carattere prudenziale, la
copertura necessaria a far fronte all’onere massimo, che si produce oltre il
triennio, viene normalmente anticipata all’ultimo anno del triennio di
riferimento. L’applicazione di questo criterio è suscettibile quindi di
produrre economie di bilancio, anche consistenti, in quegli esercizi in cui
l’onere stimato si colloca ad un livello inferiore al picco, corrispondente all’anno
di massimo impatto della norma sul bilancio dello Stato. Al fine di evitare
tale eventualità e di assicurare nel contempo il rispetto del principio sancito
dalla giurisprudenza costituzionale, in alcuni casi è stato seguito un diverso
criterio, riferendo la copertura non già all’onere massimo previsto oltre il
triennio, ma all’onere medio ultratriennale .
Su tali profili si confronti anche il successivo capitolo
relativo ai profili temporali delle quantificazioni, con particolare
riferimento alla spesa sociale.
I risultati del
procedimento di quantificazione trovano infine un importante momento di
valutazione tecnica nell’attività della Corte dei conti: il citato articolo 11-ter della legge n. 468 ha infatti
affidato alla Corte la redazione di una relazione
quadrimestrale sulle tipologie di copertura delle leggi e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri, che viene trasmessa al Parlamento.
In tal modo le
valutazioni della Corte, pur intervenendo su una decisione legislativa ormai
definitiva, segnalano a Governo e Parlamento i possibili profili problematici
sia delle quantificazioni che delle coperture, contribuendo in tal modo al
consolidamento delle metodologie e delle tecniche adottate.
La
verifica delle quantificazioni riferite ai saldi di rilievo europeo
La ricostruzione
degli effetti delle norme contenuta nelle relazioni tecniche è preordinata
essenzialmente alla verifica del rispetto dell’obbligo di copertura
finanziaria: pertanto essa è formulata considerando soprattutto l’impatto della
normativa proposta sul bilancio dello Stato e sul relativo saldo (saldo netto da
finanziare). Fanno eccezione le quantificazioni riferite alle disposizioni
della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati a manovre di finanza
pubblica, che espongono anche, attraverso appositi allegati, gli effetti delle
normative introdotte sui saldi rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli
europei (l’indebitamento netto della p.a. e, per i riflessi sul debito
pubblico, il fabbisogno di cassa del settore statale).
Tali parametri fanno infatti riferimento ad aggregati
contabili più ampi del bilancio dello Stato, che riguardano l’intero comparto
della pubblica amministrazione.
Inoltre, le operazioni che ne influenzano l’andamento sono
per lo più contabilizzate secondo criteri diversi da quelli che presiedono alla
registrazione delle operazioni nel bilancio dello Stato. Per quanto riguarda
l’indebitamento, si fa infatti riferimento alle convenzioni contabili del
sistema “SEC 95”, basato sul criterio della competenza economica e,
quindi, su modalità di contabilizzazione profondamente diverse da quelle che
presiedono alla redazione del bilancio dello Stato e dei bilanci della maggior
parte degli enti pubblici (basati per lo più sui criteri della competenza
giuridica e della cassa).
D’altro canto, i saldi rilevanti per il rispetto dei vincoli europei
costituiscono informazioni finali di sintesi sullo stato complessivo della
finanza pubblica di ciascun Paese, elaborate ai fini della comparabilità dei
dati in ambito europeo e della verifica del rispetto dei parametri di stabilità
e di convergenza. La definizione preventiva dell’impatto delle normative
proposte su tali saldi e la disponibilità delle relative informazioni fin dalla
fase dell’iter parlamentare delle
norme assumono quindi un rilievo sempre meno eludibile.
Pertanto, recenti
indirizzi emersi nell’ambito dell’attività istituzionale di quantificazione
evidenziano la necessità di estendere la valutazione dell’impatto delle norme
in termini di fabbisogno e di indebitamento anche ai provvedimenti non
direttamente inquadrabili nell’ambito di manovre economico-finanziarie. Ciò al
fine di rendere possibile, tendenzialmente per tutte le iniziative legislative,
un controllo che non si limiti ai profili di copertura finanziaria in senso
stretto (equivalenza tra oneri e mezzi di copertura ai fini del saldo netto da
finanziare), ma che si estenda anche alla valutazione dell’equilibrio
finanziario (compensazione) rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento
netto.
In proposito vanno richiamate soprattutto le già citate
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 e del
6 giugno 2006, che disciplinano le modalità di predisposizione delle relazioni
tecniche ed evidenziano come “le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti
devono essere idonee a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione,
nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli
impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine (…) nelle relazioni tecniche
va dimostrato l’equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da
finanziare, al fabbisogno e all’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni”.
Tali profili sono
peraltro più dettagliatamente trattati in un apposito paragrafo del successivo
capitolo, dedicato all’analisi di questioni metodologiche, emerse anche nel
corso della XV legislatura, con specifico riferimento alla quantificazione
degli effetti di nuove normative sui saldi di fabbisogno del settore pubblico e
di indebitamento netto della p.a.
L’analisi normativa:
corrispondenza tra norme ed effetti quantificati nella relazione tecnica.
Il comma 2
dell’articolo 11-ter della legge n.
468 del 1978 prescrive che la relazione tecnica contenga un’esaustiva
quantificazione degli oneri e delle entrate recati da ciascuna disposizione
rispetto alla normativa vigente. Pertanto, uno degli aspetti indefettibili del
procedimento di verifica delle quantificazioni consiste in un’approfondita
analisi del testo della proposta normativa e nel raffronto del medesimo con le
indicazioni della relazione tecnica.
Tale analisi è volta a riscontrare la corrispondenza tra le norme
suscettibili di determinare effetti finanziari e quelle considerate dalla
relazione tecnica, nonché la piena coincidenza tra il tenore letterale delle
norme aventi profili di carattere finanziario ed i contenuti normativi assunti
alla base delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
L’individuazione iniziale delle norme suscettibili di
determinare effetti finanziari riveste, peraltro, particolare rilievo anche nell’esame
dei progetti di legge di origine parlamentare, in genere non corredati di
relazione tecnica, in relazione ai quali il Servizio Bilancio dello Stato predispone,
come segnalato nel paragrafo iniziale, specifiche schede di analisi degli
effetti finanziari. In questi casi, infatti, l’individuazione di disposizioni
di potenziale impatto finanziario – nelle schede predisposte dal Servizio - può
costituire il presupposto, non soltanto per l’eventuale richiesta di una
relazione tecnica da parte della Commissione Bilancio, ai sensi del comma 3 del
citato articolo 11-ter, ma anche per
la definizione del contenuto minimo che la stessa RT deve presentare, sulla
base dell’analisi svolta in sede parlamentare.
L’esperienza
maturata nell’analisi dei progetti normativi evidenzia, con una certa frequenza,
casi di incoerenza tra relazioni tecniche e testo delle iniziative legislative
cui le stesse si riferiscono, per la mancata considerazione nella relazione
stessa di tutte le norme suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario.
Nell’ambito del procedimento di verifica, tale carenza determina generalmente
richieste al Governo di chiarimenti o di una integrazione della relazione
tecnica presentata.
- Ad esempio, nel corso dell’esame del disegno di legge
di conversione del decreto legge n. 223 del 2006
(C. 1475), ora legge n. 248 del 2006, il Servizio Bilancio dello Stato ha
segnalato la necessità di quantificare gli effetti delle disposizioni contenute
nell’articolo 36, comma 29, riguardante nuove modalità di
determinazione del reddito di lavoro autonomo, al quale non risultavano ascritti
effetti finanziari nella relazione tecnica originaria.
Infatti, il comma – recante modifica dell’articolo 54 del
TUIR - conteneva misure che, singolarmente considerate, apparivano suscettibili
di determinare effetti di segno opposto sul gettito IRPEF. Occorreva, pertanto,
disporre di un’ analitica quantificazione dei singoli interventi operati sulla
base imponibile IRPEF, anche ai fini dell’eventuale verifica di una compensatività
dei predetti effetti.
In particolare, le norme sulla concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro autonomo delle plusvalenze e delle minusvalenze di beni
strumentali e dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione della
clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o
professionale, avrebbero presumibilmente determinato un recupero di gettito,
mentre l’applicazione della norma relativa alla integrale deduzione delle spese
per prestazioni alberghiere e di ristorazione, sostenute dal committente per
conto del professionista ed addebitate in fattura, avrebbe determinato una
perdita di gettito.
Il rilievo del Servizio Bilancio dello Stato, fatto proprio
dalla Commissione Bilancio, ha trovato riscontro nella Nota di documentazione
depositata dal Governo presso la medesima Commissione, in risposta alle
osservazioni emerse nel corso dell’esame svolto in sede consultiva. Nel
documento veniva infatti condivisa l’analisi degli effetti derivanti
dall’applicazione delle singole misure, ma si assicurava che l’impatto complessivo
di competenza e di cassa, ascrivibile al complesso delle norme, poteva ritenersi
neutrale dato il carattere sostanzialmente compensativo dei predetti effetti.
- Con riferimento, invece, alle disposizioni contenute nel disegno
di legge finanziaria per il 2007[4],
riguardanti detrazioni IRPEF per l’acquisto di apparecchi e motori ad alta
efficienza, il Servizio Bilancio dello Stato ha rilevato l’esigenza di un’integrazione
della relazione tecnica originaria, in quanto, oltre ad una discrasia tra i
parametri quantitativi presenti nella disposizione e quelli utilizzati per la
stima, dal raffronto tra la relazione tecnica ed il testo delle norme emergeva,
in particolare, la mancata quantificazione dell’effetto di perdita di gettito
connesso alla concessione, disposta dalle medesime norme, di una detrazione per
l’acquisto e l’istallazione di variatori di velocità su impianti di una
determinata potenza elettrica[5].
La relazione tecnica integrativa, trasmessa successivamente
dal Governo, ha fornito, in assenza di dati sui volumi effettivi di vendita,
una stima presuntiva della perdita di gettito derivante da tale agevolazione.
In altri casi,
l’individuazione, nell’ambito dell’attività di verifica, di discrasie tra il
contenuto delle norme ed i parametri posti alla base della quantificazione ha
determinato la richiesta di chiarimenti al Governo e talvolta, anche in base
agli elementi di risposta forniti, la rettifica delle stime contenute nella
relazione tecnica con il conseguente adeguamento della copertura finanziaria.
- Nell’ambito dell’esame del disegno di legge di
conversione del decreto legge n. 262 del 2006[6] (C.
1750), il Servizio Bilancio dello Stato ha evidenziato la necessità di
acquisire dal Governo chiarimenti sulla quantificazione riguardanti gli effetti
delle disposizioni sugli incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti.
Infatti, mentre le norme limitavano la concessione dei contributi (finalizzati
all’acquisto di autocarri meno inquinanti
ed autovetture a metano) ai veicoli acquistati o immatricolati dalla
data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2007, gli effetti di spesa
per la concessione dell’incentivo e di maggior gettito IVA, conseguenti alla
maggiore domanda indotta, erano ascritti a ciascuno degli anni del triennio di
competenza 2007-2009.
Nella Nota trasmessa dal Governo, in risposta alle
osservazioni formulate nell’ambito dell’esame della Commissione, veniva,
pertanto, fornita - per le norme oggetto del rilievo - una nuova versione della
relazione tecnica, allineando i relativi parametri di stima al disposto
normativo. Tale nuova stima, peraltro, evidenziava, a fronte di un leggero
effetto di ripresa di gettito, per ciascuno degli anni del triennio di
riferimento, registrato per il complesso degli incentivi nella relazione
tecnica iniziale, l’emersione di un profilo di onerosità per gli esercizi 2008
e 2009, a causa
del venir meno del cospicuo gettito IVA indotto, erroneamente stimato dalla
relazione tecnica originaria per tali anni.
L’analisi
dei dati sottostanti la quantificazione
Molte questioni
emerse nel corso dell’attività di verifica delle quantificazioni hanno avuto ad
oggetto i dati esposti nelle relazioni tecniche, posti a fondamento delle stime
elaborate. Il lavoro svolto dal Servizio Bilancio dello Stato, riguardo a tali
profili, ha il fine precipuo di verificare l’attendibilità e il grado di
aggiornamento dei dati utilizzati nonché la rispondenza degli stessi alle
specifiche procedure di quantificazione cui si riferiscono.
L’attività di
analisi dei dati si esplica attraverso metodologie, ormai consolidate, i cui
passaggi essenziali possono essere così sintetizzati:
-
controllo
sui criteri di rilevazione e di elaborazione dei dati contenuti nella relazione
tecnica, per valutarne la completezza e il grado di corrispondenza alle
fattispecie esaminate;
-
eventuale
raffronto con dati riportati in relazioni tecniche riferite a norme o
fattispecie analoghe;
-
confronto
con dati tratti da altre fonti governative (relazioni di settore, documenti del
Ministero dell’economia, interventi del Governo presso le Assemblee
parlamentari, ecc.), da pubblicazioni di altre istituzioni pubbliche (quali, ad
esempio, Banca d’Italia, Istat, Corte dei Conti) e da documenti di istituti di
ricerca di rilievo nazionale o internazionale (per esempio, l’OCSE);
-
ricerche
effettuate via internet, presso
banche dati o siti istituzionali;
-
spesso,
infine, può risultare necessario reperire, presso fonti specializzate, anche se
di carattere non istituzionale, dati più analitici o più aderenti alla
fattispecie esaminata. Ad esempio, costituiscono utili parametri di confronto i
dati elaborati periodicamente dalle associazioni di categoria, da istituti ed
enti privati.
Si espongono, di
seguito, due tra le principali problematiche affrontate nel corso della XV
legislatura, nell’ambito dell’analisi dei dati esposti nelle relazioni
tecniche. I casi riportati riguardano, in particolare, situazioni in cui è
stata lamentata la non disponibilità dei dati, alla base delle
quantificazioni riportate nelle relazioni tecniche ed altre in cui l’attività
di verifica dei dati, svolta dal Servizio Bilancio dello Stato, ha consentito
di rilevare incongruenze nei dati utilizzati, dando luogo a rettifiche
degli stessi e alla conseguente rideterminazione delle stime finali.
L’attività di
verifica delle quantificazioni riportate nelle relazioni tecniche è fortemente
condizionata dall’effettiva disponibilità dei dati e delle informazioni
sottostanti le quantificazioni.
Tuttavia in molti casi, soprattutto con riferimento a norme
di carattere fiscale, le relazioni tecniche si limitano essenzialmente a
fornire il risultato finale delle quantificazioni, spesso ottenuto attraverso
l’applicazione di modelli di micro-simulazione, di cui dispongono le
amministrazioni di settore interessate. Non assumono quindi un’esplicita
evidenza, nella documentazione che dà conto dell’attività di quantificazione,
parametri e valori di carattere intermedio, in quanto impliciti ovvero non
considerati nel modello di simulazione utilizzato.
La mancanza di tali indicazioni non consente peraltro, in
sede di verifica delle quantificazioni, di procedere ad un’esaustiva
ricostruzione dell’intero procedimento e, quindi, di disporre di elementi
idonei a convalidare i risultati finali
esposti nelle relazioni tecniche.
- Queste considerazioni sono emerse anche nel corso della XV
legislatura, in particolare durante l’esame del ddl finanziaria per il 2008 , che recava numerose
norme di carattere fiscale, le cui relazioni tecniche evidenziavano
esclusivamente le stime finali degli effetti finanziari ascritti alle diverse disposizioni
– calcolati, secondo le informazioni espressamente riportate, sulla base di
appositi modelli di microsimulazione - senza esplicitare quindi un complesso
di dati e di elementi (riferiti ad esempio alle basi imponibili, al numero di
contribuenti, alle aliquote utilizzate, ecc.), che avrebbero consentito, in
sede di verifica parlamentare, una puntuale ricostruzione del procedimento di
quantificazione e, quindi, un riscontro dell’efficacia dei risultati ottenuti.
In molti casi, nella documentazione governativa veniva
segnalato come la mancanza di un’informazione sistematica sui predetti elementi
fosse da imputare alla circostanza che i modelli di micro-simulazione
utilizzati non richiedevano l’inserimento di tali variabili in quanto il
risultato veniva calcolato a partire dalla situazione individuale effettiva
di ciascun contribuente.
Nondimeno il Servizio
Bilancio dello Stato ha sottolineato, in diverse occasioni, la necessità che
fossero fornite informazioni relative a dati aggregati e a talune variabili di
carattere intermedio, idonee a consentire una verifica dei dati e quindi a suffragare,
attraverso un opportuno riscontro sulla correttezza delle stime finali, anche l’efficacia
del modello utilizzato.
Infatti, la carenza di informazioni di carattere intermedio
a corredo dei risultati tratti dal modello fa sì che la verifica delle stime,
in ambito parlamentare, non possa basarsi che su ricostruzioni induttive, a
partire da informazioni parziali o di carattere metodologico.
E’ stato altresì evidenziato che la conoscenza dei dati
sottostanti le stime – quali ad esempio, per le norme di carattere fiscale, le
basi imponibili, le aliquote e il numero di soggetti interessati dalle singole
imposte oggetto di intervento, nonché ulteriori informazioni riferibili alle
diverse quantificazioni (detrazioni, deduzioni, ipotesi adottate, ecc.) – assicurerebbe
anche la comparabilità, nel tempo, degli elementi addotti a corredo di
quantificazioni riferite a fattispecie analoghe.
Inoltre, con particolare riferimento al disegno di legge
finanziaria ed ai provvedimenti ad esso collegati, si rileva come la
carenza di dette informazioni impedisca anche una corretta analisi degli
effetti finanziari delle proposte emendative presentate nel corso dell’esame
parlamentare e, quindi, una verifica della compensatività delle stesse,
necessaria ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte stesse.
Come già accennato,
l’analisi dei dati indicati nelle relazioni tecniche è diretta, tra l’altro, a
verificarne l’aderenza al dettato delle norme cui essi si riferiscono.
Il molti casi il
Servizio Bilancio dello Stato ha evidenziato l’opportunità di procedere ad
aggiornamenti dei dati forniti nella relazione tecnica governativa, ritenuti
non in linea con altre informazioni, più aggiornate, a disposizione del
Servizio. In altre circostanze, è stato segnalato come le stime dei potenziali
beneficiari delle norme, indicate nelle relazioni tecniche, non risultassero
coerenti con il contenuto delle norme stesse: ciò ha indotto talvolta il
Governo a procedere ad una revisione dei dati e delle quantificazioni riportati
nelle relazioni tecniche ed al conseguente adeguamento delle norme di copertura.
- Con riferimento alle disposizioni contenute nel disegno
di legge finanziaria per il 2008, riguardanti l’esenzione dal pagamento
della tassa di concessione governativa per i telefoni cellulari utilizzati da
soggetti sordi, il Servizio Bilancio ha rilevato l’esigenza di un’integrazione
della relazione tecnica originaria, in quanto, mentre la norma si riferiva in
via generale a tutti i soggetti affetti da sordità, la relazione tecnica
quantificava gli effetti di gettito con esclusivo riferimento ai soggetti
sordomuti. La quantificazione risultava, pertanto, sottostimata.
Il Governo ha convenuto sulla necessità di rettificare i
dati e ha quindi rivisto la propria stima, modificando gli effetti imputati
alla norma rispetto ai saldi di finanza pubblica.
Profili
temporali delle quantificazioni: previsioni
ultratriennali ed incidenza di fattori demografici nella spesa sociale
Per effetto del processo di invecchiamento
demografico, che caratterizza la struttura e l’evoluzione della popolazione del
nostro Paese e di buona parte dei Paesi dell’Unione europea, va assumendo
sempre maggiore rilevanza la valutazione degli andamenti di medio-lungo periodo
della spesa sociale, con particolare riferimento alla componente cosiddetta age-related. L’attenzione prestata deriva
anche dalla necessità di verificare che i predetti andamenti siano congruenti
con il percorso di medio-lungo termine di convergenza ai parametri europei,
soprattutto con riferimento ai livelli del debito pubblico. Infatti,
particolare rilievo assume la predetta analisi rispetto alla valutazione della
sostenibilità nel lungo periodo delle finanze pubbliche: a tal fine nell’Aggiornamento
annuale del programma di stabilità che i Paesi membri trasmettono alle autorità
europee è prevista un’ apposita sezione dedicata a tale profilo.
Per fare fronte a questo obbligo, nel tempo, il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato modelli di
previsione, continuamente aggiornati anche sulla base di scenari definiti a
livello europeo, che permettono di simulare gli andamenti della spesa sociale age-related lungo un arco di tempo anche
di lungo periodo.
Per quanto attiene agli aspetti connessi all’attività
di quantificazione degli effetti delle norme, particolare rilievo assume, nelle
predette materie, il profilo evolutivo, nel medio-lungo periodo, degli oneri
stimati.
Si ricorda che l’articolo 11-ter della legge n. 468/1978, relativamente
alle disposizioni in materia pensionistica, dispone che la relazione
tecnica debba contenere anche un quadro analitico di proiezioni finanziarie
almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai
soggetti beneficiari.
Ciò in relazione al
fatto che l’importo e la durata dei benefici di natura pensionistica e, di
conseguenza, dei relativi oneri a carico della finanza pubblica, dipendono
strettamente dalle caratteristiche soggettive dei beneficiari, quali, ad
esempio, l’età di accesso al trattamento economico, il periodo medio di
godimento del beneficio in relazione alla speranza di vita, l’anzianità
lavorativa che determina l’ammontare del trattamento stesso, i profili
retributivi afferenti al percorso lavorativo.
Si tratta, pertanto, di una previsione di
medio periodo in cui entrano in gioco numerose variabili, sia di natura
propriamente demografica sia di natura macroeconomica sia, infine, di carattere
normativo.
Le risultanze di
tali simulazioni, che tengono conto di continui aggiornamenti, e la descrizione
della struttura e delle variabili incorporate nei modelli sono pubblicate
annualmente dalla Ragioneria Generale dello Stato, in un Rapporto[8] che reca anche una dettagliata analisi
metodologica dei modelli stessi. Tale Rapporto, come verrà precisato nel
seguito del presente paragrafo, contiene i singoli approfondimenti in relazione
alla spesa pensionistica, sanitaria e alla spesa per assistenza (Long Term Care - LTC).
Pertanto, riguardo alle singole disposizioni
di spesa in materia pensionistica[9], la
quantificazione degli oneri recata dalla relazione tecnica, riferita agli
esercizi oltre il triennio di competenza del bilancio, utilizza le elaborazioni
fornite dai modelli previsionali di cui dispone il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
- Ad esempio, la
relazione tecnica alla legge n. 247/2007, di attuazione del Protocollo del
23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività (c.d. “Protocollo Welfare”), ha evidenziato, in relazione
ad ogni misura anche non strettamente pensionistica, gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica per il periodo 2008-2013, mentre per quelle a
carattere pensionistico, con particolare riferimento alle modifiche nei
requisiti di accesso al pensionamento, gli effetti finanziari sono stati evidenziati
per il decennio 2008-2017. Inoltre, in apposita appendice, è stata rappresentata
l’incidenza degli interventi del Protocollo sull’andamento a legislazione
vigente della spesa pensionistica in rapporto al PIL per il periodo 2008-2050,
sulla base delle ipotesi dello scenario nazionale base.
Proiezioni
decennali degli effetti finanziari sono state riportate anche dalla relazione
tecnica relativa agli interventi in materia
di TFR disposti dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).
Con riferimento ai profili di quantificazione
attinenti alle norme di copertura degli oneri, la giurisprudenza
costituzionale[11],
ripresa e confermata dalla Corte dei conti, ha sancito - come già accennato nel
capitolo iniziale del presente dossier - che, fatta salva la necessità di una
puntuale indicazione delle risorse finanziarie previste a fini di copertura per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio triennale, per quelli successivi
la previsione delle risorse destinate a fare fronte ai relativi oneri deve
risultare in modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza si
intende realizzata allorquando si ravvisi una coerenza tra onere
massimo coperto nel triennio ed onere previsto negli
esercizi successivi.
In applicazione di tale principio, pertanto,
la copertura dell’onere a regime è generalmente assicurata imputando al terzo
anno del bilancio triennale di competenza l’onere annuo corrispondente a quello
di massima esposizione, nel periodo di applicazione delle norme.
- La relazione
tecnica riferita agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, previsti dalla legge finanziaria 2008[13], reca i dati e i parametri alla base della
quantificazione degli oneri per ciascun anno fino all’entrata a regime delle
disposizioni, che si realizzerà nell’arco di dieci anni. Nel prospetto
riepilogativo degli effetti delle disposizioni sui saldi[14], in corrispondenza del terzo anno del bilancio
triennale di competenza, viene contabilizzato l’effetto massimo delle
disposizioni, previsto a regime, commisurando allo stesso anche la copertura
della disposizione, introdotta per emendamento.
Nel corso della XV
legislatura, è emersa spesso l’opportunità di corredare la relazione tecnica di
proiezioni ultratriennali anche con riferimento agli effetti finanziari di disposizioni
riguardanti interventi che, pur non rientrando nella materia strettamente
pensionistica, per loro natura appaiono comunque fortemente influenzati da
dinamiche demografiche di medio e lungo periodo, connesse all’evoluzione
della struttura della popolazione e all’incidenza di flussi migratori.
Infatti, per tali
interventi che interessano prevalentemente voci di spesa di carattere
assistenziale, a fronte dell’estensione a nuovi soggetti di benefici di carattere
sociale, non sempre le relazioni tecniche hanno esplicitato se e in quale
misura la quantificazione dei relativi oneri tenesse conto dell’incidenza del
fattore demografico e del suo probabile sviluppo in un arco di tempo di
medio-lungo periodo. E’ stato quindi evidenziato come la mancanza di tali dati
non consentisse una puntuale verifica della sostenibilità nel tempo degli
interventi.
- Ad esempio, in
occasione dell’esame del disegno di legge recante modifiche alla normativa in
materia di cittadinanza, il Servizio Bilancio dello Stato ha
osservato che, sulla base del già citato disposto dell’art. 11-ter della legge n. 468/1978, la
relazione tecnica avrebbe dovuto fornire, in relazione alle implicazioni di
natura pensionistica, un prospetto almeno decennale degli effetti delle
disposizioni in discussione. Il Servizio ha inoltre rilevato la necessità
che fossero fornite valutazioni di carattere previsionale relative all’incidenza
di andamenti di carattere demografico, trattandosi di provvedimenti
riguardanti la condizione dello straniero e suscettibili di determinare un
incremento dei beneficiari degli istituti assistenziali e previdenziali. Tale
richiesta, fatta propria dal relatore del provvedimento presso la Commissione
bilancio, ha trovato riscontro nel seguito della
discussione dal momento che il Ministero dell’interno ha prodotto una
documentazione con la quale si dava conto delle modalità di calcolo dei flussi
migratori, considerati ai fini della quantificazione.
La richiesta di tali informazioni nasce,
peraltro, dalla considerazione che, come illustrato in precedenza, la
Ragioneria Generale dello Stato dispone di modelli di previsione di
medio-lungo periodo riguardante il più generale aggregato della spesa sociale
pubblica.
Di seguito si fornisce un’illustrazione
sommaria di tali modelli, con riferimento alle componenti della spesa
pensionistica, della spesa sanitaria e della spesa assistenziale.
I
modelli della Ragioneria Generale dello Stato per le previsioni di medio e
lungo periodo della spesa sociale
Come già precisato, la constatazione che
il processo di invecchiamento demografico ha assunto sempre più rilevanza negli
andamenti di medio-lungo periodo della spesa sociale, con particolare
riferimento alla componente c.d. age-related, ha indotto i Paesi europei ad
elaborare modelli di previsione compatibili in ambito UE. Ciò con una duplice
finalità: da un lato, tenere sotto controllo tali aggregati di spesa che, in
rapporto al PIL, costituiscono una componente importante della spesa pubblica,
anche con riferimento ai diversi sistemi di welfare adottati, e, dall’altro,
verificare che i loro andamenti siano congruenti con il percorso di convergenza
ai parametri di Maastricht. Per fare fronte a tali impegni, il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato ha elaborato modelli di previsione, continuamente aggiornati anche sulla
base di scenari definiti a livello europeo, che permettono di simulare gli andamenti
della spesa sociale age-related lungo un arco di tempo anche di lungo
periodo. Le risultanze di tali simulazioni nonché le metodologie adottate sono
annualmente descritte nel Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del
sistema pensionistico e socio-sanitario[18].
Con riferimento alla spesa pubblica
per pensioni rispetto al PIL, le previsioni fino al 2050 sono effettuate
sulla base di tre diversi scenari, di cui due (scenario nazionale base e
scenario nazionale programmatico) definiti in ambito nazionale e il
terzo (scenario EPC-WGA baseline) definito in ambito europeo dal Gruppo
di lavoro sull’invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di
Politica Economica del Consiglio Ecofin[19]. Le previsioni elaborate sulla base di
ipotesi di scenario definite a livello europeo sono riportate nell’Aggiornamento
del Programma di Stabilità, mentre quelle coerenti con le ipotesi dello
scenario nazionale base, per il 2007, sono state pubblicate nell’ultimo DPEF
2008-2011 e riprese anche nell’ultimo Rapporto del Nucleo di Valutazione della
Spesa Previdenziale.Tali scenari, come si legge nel Rapporto
della RGS, sono costituiti da una componente demografica e da una componente
macroeconomica[21].
Le previsioni, inoltre, sono elaborate anche
sulla base dell’assetto normativo vigente, ma aggiornato con le misure che si
prevede di adottare nell’anno. Più in particolare, esse recepiscono anche gli
effetti delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria e negli
eventuali provvedimenti collegati, come approvati dal Consiglio dei ministri e
recepiti nei documenti programmatici di finanza pubblica (RPP e documento di
aggiornamento del Programma di Stabilità). Con riferimento alle previsioni
nazionali, lo scenario nazionale programmatico differisce dallo scenario
nazionale base per il fatto di recepire integralmente le indicazioni del quadro
macroeconomico sottostante la RPP[22]. Il quadro demografico dei due modelli
recepisce le ipotesi sottostanti l’ultima previsione della popolazione prodotta
dall’Istat, con base 2005. Le ipotesi sono determinate dal tasso di fecondità,
dalla speranza di vita, distinta per maschi e per femmine, e dal saldo
migratorio[23]. Il quadro macroeconomico incorpora, tra
l’altro, il tasso di crescita della produttività, le ipotesi relative ai
mutamenti del mercato del lavoro (tasso di disoccupazione, tasso di attività
della fascia di età 15-64 e tasso di occupazione) nonché il tasso di crescita
reale del PIL[24].
Anche per la spesa sanitaria e la
spesa assistenziale, ambedue fortemente influenzate dal fattore
demografico, a livello europeo è stata evidenziata la necessità di elaborare
modelli previsionali che permettano di seguirne l’evoluzione in rapporto al PIL
nel medio-lungo periodo. Anche in questo caso, pertanto, tali previsioni sono
state effettuate sulla base delle indicazioni metodologiche concordate in
ambito EPG-WGA.
Con riferimento alla spesa sanitaria,
come si legge nel Rapporto n. 9, l’ipotesi di base, adottata fin dal 2001,
assume che la struttura dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di
prestazione resti costante nell’intero periodo di previsione[25] e che il costo unitario si agganci al PIL
pro capite[26]. Tale metodologia, denominata “pure
ageing scenario”, rende le variazioni del rapporto spesa sanitaria/PIL
dipendenti esclusivamente dalla modificazione della struttura della
popolazione. Con riferimento allo scenario nazionale base, tale metodologia si
applica a partire dall’anno successivo al quadriennio di riferimento
dell’ultimo DPEF. Per il periodo precedente, infatti, la previsione
dell’andamento della spesa è effettuata per singola funzione di costo[27], tramite modelli di breve periodo. Tuttavia,
per tenere conto di altri fattori, diversi da quello demografico, che incidono
sull’evolversi dei consumi sanitari, sono state elaborate ipotesi alternative
che riflettono il miglioramento delle condizioni di salute correlato con l’aumento
della speranza di vita, i differenziali inflazionistici tra prodotti sanitari e
prodotti non sanitari, anche in dipendenza del diverso contenuto tecnologico,
l’effetto trainante sui costi sanitari derivante dalla remunerazione del
fattore lavoro. La combinazione di tali ipotesi alternative ad integrazione del
pure ageing scenario prende il nome di “reference scenario”. Le ipotesi
demografiche e macroeconomiche dello scenario nazionale base utilizzato ai fini
della previsione della spesa sanitaria sono le stesse impiegate nell’ambito
della spesa pensionistica. Ciò rende i risultati previsionali omogenei e
aggregabili.
Anche per la spesa sanitaria, le
previsioni incorporano il quadro normativo vigente nonché gli interventi
previsti nel disegno di legge finanziaria, come approvato dal Consiglio dei
ministri e recepiti nei documenti programmatici di finanza pubblica (RPP e
Programma di Stabilità)[28].
La spesa assistenziale age-related,
rivolta agli anziani e ai disabili non autosufficienti (spesa pubblica per Long
Term Care), è composta da tre aggregati: la componente sanitaria della spesa
per LTC (che è riconducibile al più grande aggregato della spesa sanitaria
pubblica[29]), le indennità di accompagnamento e gli
interventi socio-assistenziali rivolti ai disabili e agli anziani non
autosufficienti erogati a livello locale. Sulla base delle medesime metodologie
illustrate in precedenza, la Ragioneria Generale dello Stato elabora le
previsioni di medio-lungo periodo per la spesa per LTC sia separatamente, per
ciascuna componente, sia per l’aggregato complessivo, secondo lo scenario
nazionale base, lo scenario nazionale programmatico e, infine, secondo lo
scenario EPC-WGA baseline. Tali esercizi previsionali si basano sulle ipotesi
di evoluzione del consumo di prestazioni per LTC adottate nella definizione del
pure ageing scenario, che scontano i soli effetti diretti imputabili alle
dinamiche demografiche. Tuttavia, dal momento che, come già precisato per la
spesa sanitaria, altri fattori possono incidere significativamente sulla
dinamica della spesa per LTC, la Ragioneria Generale dello Stato, sempre in
accordo con quanto concordato in ambito EPC-WGA, elabora simulazioni sulla base
del cosiddetto reference scenario. La componente sanitaria comprende l’insieme
delle prestazioni sanitarie erogate a persone non autosufficienti che necessitano
di assistenza continuativa. Più in particolare, con riferimento all’Italia, la
componente sanitaria della spesa per LTC include: l’assistenza territoriale
agli anziani e ai disabili (a sua volta comprendente l’assistenza ambulatoriale
e domiciliare, l’assistenza semi-residenziale e l’assistenza residenziale);
l’assistenza integrativa protesica, psichiatrica e quella rivolta agli
alcolisti e ai tossicodipendenti.
Per ciascuna di queste prestazioni, il
modello stima i profili del consumo sanitario[30], anch’essi aggragabili in tre componenti
principali a seconda dei destinatari e delle modalità di erogazione della
prestazione: l’assistenza residenziale agli anziani e ai disabili; l’assistenza
non residenziale agli anziani e ai disabili; l’assistenza, in qualunque forma
erogata, ai soggetti affetti da dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti) o
patologie psichiatriche. La spesa per indennità di accompagnamento e di
comunicazione sono costituite da prestazioni monetarie erogate ad invalidi
civili, ciechi e sordomuti, esclusivamente in dipendenza delle condizioni
psicofisiche del soggetto. Dai modelli della RGS emerge che, mentre per le
indennità erogate ai sordomuti non vi è un sostanziale legame con l’età dei
percettori[31], le indennità di accompagnamento erogate
ad invalidi civili ed ai ciechi sono fortemente correlate con l’età[32].
La spesa per altre prestazioni LTC
comprende un insieme di prestazioni, prevalentemente in natura, erogate a
livello locale per finalità socio-assistenziali. Risulta estremamente difficile
ricostruire tale aggregato per le notevoli carenze informative che
caratterizzano il settore, sia con riferimento alla platea dei beneficiari sia
con riferimento alla numerosità degli interventi. Pur considerando tali
limitazioni, la RGS ha elaborato le previsioni di medio-lungo termine seguendo
il medesimo approccio adottato per la componente sanitaria, secondo il quale il
parametro fondamentale è rappresentato dal profilo della spesa pro capite per
sesso e per età corrispondente alle diverse tipologie di prestazione[33]. Dalle previsioni in tale modo
elaborate, che recepiscono le indicazioni dello scenario nazionale base, emerge
che, dato che questo genere di prestazioni si rivolge prevalentemente agli
anziani, i valori corrispondenti alle età elevate sono decisamente alti.
Inoltre, le femmine presentano un consumo più alto dei maschi, soprattutto in
relazione all’assistenza residenziale ed alle prestazioni in denaro.
Aspetti problematici
connessi alle clausole di non onerosità
La Commissione Bilancio
durante la XV legislatura è stata di frequente chiamata ad esaminare norme,
soprattutto relative agli assetti organizzativi o ad adempimenti delle
pubbliche amministrazioni, sprovviste di risorse finanziarie in quanto
considerate attuabili nell’ambito delle risorse già previste, per analoghe
finalità, sulla base della vigente legislazione.
La necessità di escludere,
comunque, che tali norme potessero dar luogo, nel corso della loro applicazione,
ad oneri privi di copertura, ha spesso indotto - secondo una prassi che aveva
ricevuto impulso già nelle precedenti legislature
- ad inserire nei testi legislativi le c.d.
clausole di non onerosità.
Tali clausole in
alcuni casi sono state inserite nel testo originario dell’iniziativa
legislativa, mentre, in altre circostanze, sono state introdotte su richiesta della
Commissione Bilancio, che, con apposita condizione riportata nel proprio
parere sui profili finanziari del provvedimento, ha ravvisato la necessità di
prevedere espressamente che all’attuazione delle norme si dovesse provvedere
senza nuovi o maggiori oneri.
In alcuni casi, ancora, il testo non è stato espressamente
corredato di una clausola di non onerosità, ma la relazione tecnica o la
relazione illustrativa hanno evidenziato come dal medesimo non derivassero
nuovi o maggiori oneri.
Nei casi di inserimento
delle clausole di non onerosità nei testi originari delle iniziative
legislative trasmessi alla Commissione Bilancio per l’espressione del parere,
il Servizio Bilancio dello Stato, in sede di verifica degli effetti finanziari,
ha solitamente richiesto che le relazioni tecniche ovvero la documentazione
allegata alle stesse iniziative fossero corredate di tutti gli elementi idonei
a suffragare la neutralità finanziaria e, quindi, l’effettiva possibilità di
dare attuazione alla normativa proposta senza ricorrere a nuove risorse.
Tale orientamento appare peraltro in linea con i recenti
indirizzi governativi in tema di redazione delle relazioni tecniche, in base ai
quali “per le disposizioni che non comportano nuovi oneri finanziari è
necessario dimostrarne la neutralità”.
Gli elementi forniti dalla relazione tecnica dovrebbero
essere idonei a dimostrare, in ragione del tipo di disciplina introdotta,
l’effettiva possibilità di dare attuazione alle norme stesse senza nuovi oneri,
in modo particolare allorquando la successiva attuazione del provvedimento, da
parte delle amministrazioni competenti, sia caratterizzata da limitati margini
di discrezionalità. In tali casi, ad esempio, sarà importante verificare se
effettivamente le amministrazioni interessate dispongano degli strumenti, anche
di carattere tecnico, delle competenze e delle risorse necessarie per far
fronte all’attuazione delle norme.
Qualora, invece, la
clausola di non onerosità sia posta a presidio di misure caratterizzate da un
certo grado di discrezionalità (soprattutto per quanto attiene alle modalità di
attuazione), la funzione di garanzia svolta dalla clausola, potrebbe
configurarsi come introduzione di un principio di carattere interpretativo
ai fini dell’attuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, del
provvedimento.
In tali casi, infatti, premessa la necessità che la clausola
sia espressamente riportata nella norma, non essendo sufficiente una mera
indicazione nella relazione tecnica o nella relazione illustrativa, le
pubbliche amministrazioni dovrebbero sempre valutare alla luce del criterio della
non onerosità in quale misura e secondo quali modalità dare attuazione alle
medesime norme. Ciò dovrebbe quindi emergere chiaramente sia dalle relazioni
tecniche, sia dal disposto normativo, utilizzando, ad esempio, formule che
“impongano” di dare attuazione alle norme senza nuovi o maggiori oneri.
Le clausole di non
onerosità possono essere riferite all’aggregato del bilancio dello Stato
o all’aggregato della finanza pubblica
e sono, di norma, espresse mediante una o più delle seguenti formulazioni,
ossia disponendo che:
·
dalla
norma non derivino/o non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato/finanza pubblica;
·
agli
adempimenti previsti dalla nuova normativa si faccia fronte a carico degli
ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate;
·
ai nuovi
adempimenti si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie
già previste a legislazione vigente.
In tutti i casi in cui la relazione tecnica non esclude espressamente
che dall’applicazione della nuova disciplina possano discendere nuove spese, ma
assume che a tali esigenze possa comunque farsi fronte con l’utilizzo di
risorse già previste dalla vigente normativa e, quindi, senza nuovi oneri, il
Servizio Bilancio dello Stato – pur in presenza di una clausola di non
onerosità - ha di norma evidenziato la necessità di elementi puntuali di
valutazione circa l’effettiva sostenibilità finanziaria degli interventi in
mancanza di risorse aggiuntive.
Ciò in quanto l’utilizzo
di una non canonica forma di “copertura”, quale quella che rinvia a risorse
esistenti, non esclude di per sé che possa riscontrarsi ex post,
contrariamente all’originaria previsione, l’insorgere di effetti finanziari
negativi a carico di uno dei due aggregati (bilancio dello Stato/finanza
pubblica) cui la clausola stessa può essere riferita.
In sede d’attuazione
delle disposizioni, infatti, si possono precostituire le condizioni per futuri
interventi di “finanziamento” delle leggi provviste di clausole di non
onerosità. In tali casi, qualora non risulti possibile un intervento in via amministrativa,
occorrerà assumere un’opportuna iniziativa in via legislativa, intervenendo con
una specifica norma di finanziamento o con legge di assestamento ovvero ancora
mediante inclusione degli interventi nell’elenco delle “eccedenze di spesa” allegato
alla legge finanziaria.
- Un caso di finanziamento per via legislativa di una norma
originariamente corredata di clausola di non onerosità è quello disposto dall’art
12 della legge 48/2008, che ha previsto,
tra l’altro, per le esigenze connesse al funzionamento del “Centro nazionale
per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET”, di cui all'articolo
14-bis della legge n. 269/1998, l’istituzione, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione
di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, laddove la norma originaria
(comma 2 del citato art. 14-bis)
prevedeva che il Centro si avvalesse delle risorse umane, strumentali e
finanziarie esistenti e che dall'istituzione e dal funzionamento dello stesso
non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Pertanto, nell’ambito della verifica degli effetti finanziari dei
provvedimenti legislativi, nel caso in cui sia presente una clausola di non
onerosità, si impone una valutazione, caso per caso - da parte della
Commissione Bilancio, che potrà avvalersi dell’istruttoria tecnica dei competenti
uffici - della “effettività” della previsione di assenza di nuovi o maggiori
oneri ovvero della concreta sostenibilità dei nuovi interventi mediante
utilizzo di risorse già esistenti, ai fini del rispetto del principio di neutralità
finanziaria.
Tale valutazione
assume una particolare valenza soprattutto nel caso di creazione di nuovi
organismi o di attribuzione ad organi esistenti di nuove competenze.
Nella prima ipotesi
è importante escludere che possano determinarsi occorrenze finanziarie sia per gli
aspetti logistici ed organizzativi, sia per l’eventuale corresponsione ai
componenti dei nuovi organismi di compensi o emolumenti, anche di natura non
retributiva (rimborsi ed altro). Tale possibilità andrebbe quindi espressamente
esclusa con apposita previsione legislativa.
Nel secondo caso, la
verifica della non onerosità delle norme richiede l’acquisizione dal Governo di
elementi volti a dimostrare che ai nuovi adempimenti le amministrazioni
interessate possano effettivamente far fronte con i mezzi e le risorse già in
dotazione.
Gli elementi forniti dovranno essere idonei a suffragare l’ipotesi di
invarianza finanziaria con riferimento al peculiare rilievo, anche tecnico, dei
nuovi compiti assegnati, e alla strumentazione nonché alle competenze conseguentemente
necessarie per l’espletamento degli
stessi.
- Si riportano di seguito due esempi riferibili alle
fattispecie citate:
a) Lo
schema di regolamento - relativo all’organizzazione
del Ministero delle infrastrutture, - emanato in attuazione dell’art. 1, comma
4, del DL 181/2006, ha, tra l’altro,
previsto, all’art. 6, l’istituzione - senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato - della “Conferenza permanente dei Provveditori interregionali” con
funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di
competenza. Nel corso dell’esame dello schema di regolamento presso la
Commissione Bilancio, con riferimento precipuo all’istituenda Conferenza, è
stato richiesto al Governo di modificare la formula della clausola al fine
prevedere, come da prassi consolidata in casi analoghi, l’esclusione di nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e di riformulare, invece, con
riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica, la clausola
d’invarianza finanziaria generale, riferita all’intero provvedimento, prevista
dall’art. 11. Il Governo nella medesima sede ha affermato di concordare
sull’opportunità di integrare con apposita clausola d’invarianza le
disposizioni relative all’istituzione della suddetta Conferenza nonché di
riformulare la clausola generale nei termini indicati.
b) Lo
schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/7/CE, (gestione della qualità
delle acque di balneazione) in materia, ha previsto, tra l’altro,
l’individuazione di nuove competenze per Stato, Regioni e Comuni, con
particolare riferimento alle attività di monitoraggio, classificazione della
qualità idrica, gestione di registri ed informazione al pubblico con mezzi e
tecnologie di comunicazione adeguati. All’art. 18 è stato inoltre prevista un
espressa clausola d’invarianza. A tale riguardo in sede
di esame del provvedimento, anche sulla base dell’istruttoria effettuata dagli
uffici, il relatore del provvedimento presso la Commissione Bilancio ha
richiesto al Governo di fornire dati ed elementi volti a accreditare l’effettiva
possibilità, da parte delle amministrazioni interessate, di far fronte ai nuovi
compiti con le risorse finanziarie, strumentali ed umane già previste a
legislazione vigente e, quindi, senza o nuovi maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, in considerazione anche del peculiare rilievo tecnico
dei compiti assegnati alle amministrazioni interessate, che avrebbe richiesto
presumibilmente strumenti e competenze adeguate. Il Governo, a tale riguardo,
nella stessa sede ha affermato che la riduzione del numero dei parametri
microbiologici per la valutazione della balneabilità delle acque da 19 a 2,
comporterà ingenti riduzioni dei costi ed eviterà duplicazioni, assicurando
pertanto che dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Dal punto di vista
metodologico è opportuno attribuire un autonomo rilievo ad un’ulteriore
tipologia di clausola di non onerosità, che potrebbe essere più propriamente
definita clausola di invarianza finanziaria. L’ipotesi ricorre nel caso in cui non
si presuppone un’assenza di oneri in senso stretto, ma si assume che a tali possibili
effetti possa farsi fronte con risorse
derivanti dalle stesse norme introdotte, garantendo quindi la complessiva neutralità
finanziaria dell’intera disciplina.
In tali casi, nella
documentazione prodotta dal Servizio Bilancio dello Stato, è stata in genere evidenziata
la necessità che fossero forniti gli elementi atti a quantificare sia le voci
di costo sia le corrispondenti voci di entrata e/o di risparmio,
dimostrando in tal modo la compensatività tra le une e le altre, sia per quanto
attiene all’aspetto quantitativo sia sotto il profilo della corrispondenza
temporale.
- In relazione alla necessità di
dare dimostrazione, nella relazione tecnica, della compensazione tra le voci di
costo e di entrata, a) dal punto di vista quantitativo e b) con riguardo alla
contestualità tra effetti onerosi e corrispondenti effetti compensativi, si
riportano di seguito due esempi di casi verificatisi nel corso della
legislatura appena conclusa.
a) L’art.
16 della legge 34/2008 - Legge
comunitaria 2007 – ha disposto, in materia di controlli sulle importazioni di
legname nella Comunità europea, la delega al Governo per l’adozione di un
sistema di licenze FLEGT, prevedendo, quali
principi direttivi per l’esercizio della stessa, tra gli altri, l’individuazione
delle autorità nazionali competenti per la verifica delle licenze, mediante le
risorse già previste a legislazione vigente, la determinazione dell'importo di
una tassa
e la sua destinazione ad integrale copertura delle spese delle autorità
competenti in materia di controlli. Durante l’esame parlamentare del
provvedimento, sulla base dell’istruttoria degli uffici, la Commissione
Bilancio ha richiesto chiarimenti al Governo in merito alla possibilità di fare
fronte agli oneri connessi alla verifica delle licenze FLEGT con le risorse
disponibili a legislazione vigente, nonché in ordine alle finalità e alle forme
di utilizzo della tassa che, stando al tenore letterale delle disposizioni,
sembrava piuttosto presentare natura di tariffa. In tal caso, infatti, essendo
la stessa deducibile dal reddito imponibile, avrebbe potuto
determinare riflessi negativi in termini di gettito tributario e quindi
l’impossibilità di rispettare il vincolo d’invarianza. Il Governo nella stessa
sede ha affermato che la clausola d’invarianza è stata prevista per evitare
effetti negativi a carico della finanza pubblica. In merito alle possibili
conseguenze finanziarie della norma, ha rilevato che soltanto in sede di
attuazione della delega sarebbe stato possibile valutare le eventuali
implicazioni onerose. Inoltre, anche in base ad una documentazione trasmessa
dal Ministero delle Politiche agricole,riferita
alla gestione del sistema FLEGT da parte del Corpo forestale dello Stato, è
stato escluso qualsiasi onere aggiuntivo mentre lo strumento della tassa
introdotto è stato ritenuto idoneo a coprire integralmente le spese necessarie.
b) L’art.
9 del DL 7/2007
ha disposto, tra l’altro, che, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa,
l'interessato presenti all'ufficio del registro delle imprese, per via
telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli
adempimenti previsti dalla disposizione. In merito alle modalità di attuazione
della norma e al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, in sostituzione delle domande in formato cartaceo,
la disposizione ha inoltre demandato ad un decreto ministeriale la
rideterminazione della misura dell’imposta di bollo disponendo a riguardo,
comunque, l’invarianza del gettito. Nel corso dell’esame del provvedimento in
Commissione, sulla base dei rilievi evidenziati dal Servizio Bilancio dello
Stato, sono stati richiesti chiarimenti al Governo in merito all’eventuale
insorgenza di maggiori oneri di carattere amministrativo connessi al periodo di
transizione fra il sistema attuale e quello previsto dalla disposizione e circa
le modalità con le quali assicurare l’invarianza di gettito, con riferimento
alla rideterminazione delle tariffe dell’imposta di bollo: tenuto conto che
l’unico criterio fissato dalla disposizione risultava quello di carattere
agevolativo - mirante ad incentivare le domande presentate per via informatica
- risultava necessario chiarire a carico di quali voci della tariffa sarebbero
state compensate le minori entrate derivanti dall’agevolazione stessa. Il
Governo nella stessa sede ha, tra l’altro,
affermato come nessun onere fosse ravvisabile nella disciplina transitoria,
poiché la nuova procedura avrebbe utilizzato più razionalmente le medesime
strutture, procedure e risorse, mentre la rideterminazione delle tariffe
sarebbe stata effettuata tenendo in considerazione il gettito attuale, relativo
alla quasi totalità delle domande presentate in formato cartaceo, in modo da
garantire l’invarianza indicata dalla norma.
La Corte dei conti, in merito alla norma in
esame, in termini in parte analoghi ai rilievi sopra richiamati, ha anch’essa evidenziato
che non appariva chiaro come potesse essere realizzata l’invarianza del
gettito, considerato che gli oneri derivanti dall’agevolazione risultavano
plausibilmente destinati ad accrescersi nel tempo per effetto della progressiva
riduzione delle domande in formato cartaceo; inoltre nello stesso periodo di
coesistenza dei due sistemi, avrebbero potuto sorgere oneri aggiuntivi di
carattere amministrativo per l’introduzione dei nuovi procedimenti operativi a
fianco di quelli esistenti. Sul punto – ha proseguito la Corte - la relazione
tecnica non forniva elementi di chiarimento, limitandosi ad affermare che la
nuova normativa non comportava alcun onere aggiuntivo della finanza pubblica,
consentendo invece una razionalizzazione ed un risparmio per i privati e le
amministrazioni.
Nei casi in cui l’effetto
compensativo dei nuovi oneri, idoneo a garantire la complessiva neutralità
finanziaria del provvedimento, sia ascritto a risparmi derivanti dalle stesse
norme introdotte, si richiede altresì che le riduzioni di spesa ipotizzate,
oltre ad essere quantificate, siano sempre riferibili ad importi iscritti nei
conti pubblici. E’ possibile infatti ravvisare potenziali risparmi soltanto
rispetto ad importi già “scontati” nei tendenziali di spesa.
- Si segnalano in proposito, le disposizioni dell’art. 13,
commi da 8-quinquiesdecies a 8-undevicies, del citato D.L. n. 7/2007:
pur non essendo espressamente dettata, per tali disposizioni, una clausola di
non onerosità, il caso assume rilievo - ai fini della presente analisi - in
quanto la relazione tecnica a corredo del D.L. prefigurava un’invarianza
complessiva di effetti per la finanza pubblica. Ciò soprattutto in
considerazione del rilevante risparmio per l’amministrazione derivante dal
confronto tra gli oneri dovuti ai general
contractors (in relazione alla revoca disposta dal D.L) ed i costi che
sarebbe stato necessario sostenere per la realizzazione dell’opera da parte dei
medesimi. Il Servizio Bilancio dello Stato, nella nota predisposta sul
provvedimento, ha peraltro rilevato che la relazione tecnica si limitava a
prevedere la realizzazione di risparmi, non quantificati, connessi al minor
costo di realizzazione delle opere in conseguenza del loro affidamento tramite
procedure di gara. Quanto all’eventuale carattere compensativo di tali risparmi,
il Servizio evidenziava altresì la necessità che fosse chiarito quali fossero
le spese iscritte nei conti pubblici con riferimento alle opere in questione,
sottolineando come soltanto in relazione ad una riduzione di importi già
iscritti nei tendenziali della P.A. si sarebbe potuto configurare un
risparmio, suscettibile di essere portato a compensazione di nuovi possibili
oneri.
Tale orientamento è stato condiviso anche dalla Corte dei
conti, che ha richiamato, sul punto, i rilievi formulati dal Servizio Bilancio
della Camera.
Le clausole di non
onerosità possono essere, inoltre, inserite, quali criteri direttivi,
all’interno di leggi di delega legislativa: si pone in tal caso il
problema del loro effettivo riscontro soprattutto con riferimento alla
successiva normativa delegata
In diverse circostanze il Servizio Bilancio dello Stato ha evidenziato
l’opportunità che, già in occasione dell’esame nella norma di delega, fossero forniti
elementi di valutazione ed adeguatamente esplicitate le ipotesi e i presupposti
che, sia pur in base a stime di carattere presuntivo, potevano indurre a
ritenere effettivamente possibile un’attuazione della delega senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, in tali
casi, soprattutto negli ultimi anni, nei pareri espressi dalla Commissione
Bilancio è stata generalmente imposta una procedura per la verifica della
neutralità finanziaria degli schemi di decreti legislativi adottati in
attuazione della delega, incentrata sull’obbligo di predisposizione della
relazione tecnica e sulla sottoposizione dei predetti provvedimenti ai pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per la materia trattata e per
le conseguenze di carattere finanziario.
- A questo riguardo si richiama la legge n. 247/2007 (c.d.
“Protocollo welfare”) che ha conferito, tra
l’altro, deleghe al Governo, rispettivamente, in materia di ammortizzatori
sociali, mercato del lavoro ed occupazione femminile (art. 1, commi 28, 30 e
81). In relazione all’esercizio di tali deleghe, con una clausola di carattere
generale, l’articolo 1, comma 93, ha escluso espressamente
l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Durante
l’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio, sulla base dell’istruttoria
svolta dagli uffici, è stata evidenziata
l’opportunità che, già in sede di definizione delle norme di delega, tale
supposta invarianza fosse suffragata da idonei elementi di valutazione. Sono
stati richiesti quindi ulteriori elementi informativi al Governo in merito
all’effettiva praticabilità dell’esercizio delle predette deleghe nel rispetto
del prescritto principio di neutralità finanziaria. Sul punto, inoltre, la
Commissione, al momento dell’espressione di un parere favorevole sul provvedimento, ha
rilevato, in via generale, l’opportunità “di rafforzare, sotto il profilo
procedurale, la verifica della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti che
saranno adottati in attuazione delle deleghe conferite al Governo (…),
attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere nuovamente gli schemi di
decreti al Parlamento, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni
competenti, qualora il Governo non intendesse adeguarsi alle condizioni
espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione”.
Clausole di non onerosità possono, infine, essere previste
in alcuni provvedimenti normativi che rinviano, quanto alla loro attuazione, ad
una successiva disciplina di natura regolamentare, da sottoporre, prima
della sua adozione, al parere della Commissione Bilancio.
- Durante la XV legislatura sono stati sottoposti al parere
della V Commissione, tra gli altri,
gli schemi di regolamenti in materia di organizzazione dei Ministeri e di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione di Ministri, adottati in conseguenza del
riordino delle attribuzioni ministeriali disciplinato dal decreto legge 18
maggio 2006, n. 181. Data la peculiarità di tale procedimento, per lo
svolgimento del quale la norma di riferimento introdotta dal decreto legge dettava
un principio generale di invarianza finanziaria, prevedendo inoltre una serie
di misure
a garanzia della stessa, si rinvia al successivo capitolo, riguardante
l’analisi di effetti finanziari riferiti ad una pluralità di atti normativi,
con specifico riferimento al caso del procedimento di riorganizzazione dei
Ministeri.
Effetti
finanziari riferiti ad una pluralità di atti normativi
Una recente evoluzione della prassi riferita ai processi di
quantificazione ha comportato l’imputazione di un unico effetto finanziario,
individuato da una norma primaria, ad una pluralità di atti di normazione
secondaria.
In questi casi, la norma di rango primario definisce generalmente
la cornice operativa del processo, ossia i criteri normativi ed il procedimento
da utilizzare, nonché l’obiettivo
finanziario complessivo, il cui conseguimento è demandato a successivi atti
di normazione secondaria: tale obiettivo può consistere in una mera invarianza di effetti finanziari ovvero
nel conseguimento di un risparmio di
ammontare predeterminato.
In molti casi, soprattutto allorquando l’obiettivo
complessivo di risparmio è fissato nell’ambito di manovre di finanza pubblica,
il relativo effetto finanziario è spesso immediatamente scontato ai fini dei
saldi di finanza pubblica, anche se l’effettivo conseguimento del risultato è
condizionato all’emanazione di una serie di provvedimenti attuativi.
Nelle ipotesi
indicate sono peraltro emersi profili di particolare criticità, per quanto
attiene alla verifica degli aspetti di carattere finanziario, sia nella fase del
controllo preventivo - ossia
in sede di esame da parte della Commissione Bilancio del progetto di legge che
ha dato avvio all’intero procedimento – sia nella fase attuativa, ossia
nel corso dell’esame da parte della medesima Commissione degli atti di
normazione secondaria, ai quali risultava affidato il conseguimento del
predetto effetto finanziario complessivo.
In ordine al
primo aspetto, sono emersi
problemi legati alla difficoltà di disporre di elementi idonei per una verifica
preventiva dell’impatto dell’intero procedimento prefigurato dalla norma
primaria, dovendo tale valutazione necessariamente essere rinviata al momento
dell’adozione degli atti di normazione secondaria, recanti la definizione della
disciplina di dettaglio.
Pertanto, in sede di
verifica del disegno di legge che ha avviato il processo di normazione
secondaria, le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno richiesto
che fosse definita una procedura di controllo parlamentare ad hoc sugli atti normativi da emanare, disponendo che questi
fossero corredati anche di relazione tecnica.
Tuttavia anche il riscontro – al momento dell’esame parlamentare degli
schemi di atti normativi adottati dal Governo - dell’effettiva possibilità di
conseguimento degli obiettivi finanziari indicati dalla norma legislativa ha
presentato profili particolarmente critici: ciò soprattutto in considerazione
del fatto che l’emanazione dei provvedimenti, e la corrispondente verifica da
parte dei competenti organi parlamentari, ha seguito uno sviluppo sequenziale,
scandito dalla predisposizione, in tempi successivi, dei diversi schemi di provvedimenti
attuativi. E’ quindi mancata una sede di esame contestuale di tali atti,
l’unica in grado di assicurare la verifica in via preventiva del risultato
complessivo imputato all’intero procedimento.
In tali circostanze
si è spesso preso atto che - nonostante le modalità di controllo finanziario
delle norme, prefigurate dal nostro ordinamento, e la connessa verifica
parlamentare delle quantificazioni siano sostanzialmente incentrati su una valutazione
preventiva degli effetti finanziari imputabili alle norme – nei casi in esame,
soltanto a conclusione dell’intero procedimento, sarebbe risultato possibile
accertare l’effettivo conseguimento del risultato finanziario complessivamente ascritto
alle misure legislative introdotte e ai relativi provvedimenti di attuazione.
Non di meno, in sede di valutazione delle relazioni tecniche allegate a tali
provvedimenti, il Servizio Bilancio dello Stato ha spesso richiesto chiarimenti
ed elementi ulteriori di analisi pur nella consapevolezza del carattere
necessariamente parziale, per le ragioni già dette, della verifica che
risultava possibile effettuare sui singoli atti.
Di seguito sono
descritti due casi rappresentativi delle specifiche procedure di controllo
adottate e delle problematiche di carattere metodologico affrontate.
Il decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181,
emanato all’inizio della XV legislatura, ha disposto il riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. La
nuova organizzazione prefigurata si sostanziava nell’incremento delle strutture
ministeriali, spesso in conseguenza della suddivisione delle competenze di un
solo Ministero tra due dicasteri di nuova istituzione[63]. Il testo originariamente
emanato dal Governo, dopo aver delineato la nuova articolazione dei Ministeri,
recava una generica e non articolata clausola di invarianza, riferita non ai
singoli provvedimenti attuativi - che avrebbero quindi potuto, in teoria,
recare oneri - ma all’intero procedimento di riordino.
Quindi, per un
verso, non risultava possibile conoscere in anticipo l’effettiva strutturazione
amministrativa dei Ministeri, essendo la stessa concretamente demandata ai regolamenti
attuativi e, per altro verso, la relazione tecnica, che accompagnava il
decreto-legge, non presentava alcuna ipotesi di quantificazione degli effetti
finanziari del provvedimento, limitandosi a richiamare il rispetto del
principio dell’invarianza della spesa, da assicurare mediante la riallocazione
delle risorse già assegnate ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio[64].
In sede di
approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge, furono
introdotte alcune norme al fine di consentire il controllo, al momento della
presentazione degli schemi di provvedimenti attuativi, del rispetto del vincolo
di invarianza, nella consapevolezza che, prima della emanazione delle norme di
attuazione, non
sarebbe stato possibile procedere ad un’efficace verifica in tal senso.
In particolare fu
stabilito che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM), attuativi del riordino, fossero corredati di relazione tecnica e
sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per la materia
trattata e per i profili di carattere finanziario.
In esito al dibattito parlamentare, furono inoltre introdotte
norme volte a potenziare l’effettività della clausola di invarianza ed a
consentire il controllo parlamentare sul rispetto della stessa. In particolare,
fu stabilito che:
·
la clausola di invarianza dovesse riferirsi alle
risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione
vigente e stanziate in bilancio;
·
fosse posto un esplicito divieto di revisione
dei trattamenti economici complessivi;
·
l'onere relativo ai contingenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei
Sottosegretari di Stato non dovesse essere superiore al limite di spesa
complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del
decreto[66].
Costituì un notevole elemento di novità procedurale la
previsione di una tale procedura di controllo parlamentare anche rispetto ad atti
avente natura prevalentemente amministrativa (schemi di DPCM). Inoltre, con
un ordine del giorno presentato durante l’esame del D.L. n. 181 presso
la Camera, sottoscritto dai componenti della Commissione Bilancio ed accolto
dal Governo, fu formulato l’impegno per il Governo stesso di procedere alla riarticolazione
del bilancio dello Stato in relazione al riassetto delle amministrazioni, possibilmente
in occasione dell’esame del disegno di legge di assestamento, dandone evidenza,
eventualmente mediante un’apposita nota di variazione, in modo da consentire al
Parlamento una valutazione compiuta del complesso delle modifiche apportate.
Tuttavia la
procedura adottata, pur segnando un indubbio miglioramento rispetto a quanto
previsto dal testo originario del decreto legge n. 181, non ha consentito di
effettuare un puntuale riscontro preventivo del rispetto del vincolo di
invarianza complessiva della spesa, atteso che il riordino è stato attuato
mediante una serie di provvedimenti successivi, emanati in un arco temporale
che va dal luglio 2006[67] al
gennaio 2008[68].
Le relazioni
tecniche predisposte a corredo dei singoli atti spesso si sono pertanto
limitate a fornire una generica assicurazione circa l’invarianza finanziaria
dell’intero processo di riordino, in ottemperanza al disposto della norma
legislativa di base, precisando comunque che dati di dettaglio a sostegno di
tale neutralità complessiva sarebbero stati disponibili soltanto al termine del
complessivo procedimento.
In tali circostanze, il Servizio Bilancio della Camera, nel
rilevare la difficoltà di effettuare una compiuta verifica in mancanza del
quadro complessivo di redistribuzione delle attribuzioni, ha peraltro
evidenziato l’opportunità che, in occasione dell’adozione dei singoli
provvedimenti, le relazioni tecniche dessero comunque conto:
·
dello stato di avanzamento del processo di riordino;
·
delle ipotesi nonché di tutti gli elementi,
anche di tipo quantitativo, sebbene a carattere parziale, idonei a
suffragare la ragionevole previsione del Governo di poter rispettare, alla
conclusione dell’intero processo, il vincolo di invarianza complessiva della
spesa rispetto a quella sostenuta nell’ambito del quadro organizzativo di
partenza.
Inoltre, la Commissione
Bilancio, preso atto del problema sollevato, ha talvolta espresso sui singoli
provvedimenti parere favorevole nel presupposto che “anche in occasione dei
futuri provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 181/2006, le modalità di
effettiva attuazione siano determinate secondo meccanismi atti a garantire
comunque l'invarianza degli oneri e quindi la neutralità finanziaria
complessiva del processo di riordino.
Nei fatti, l’invarianza
si è rivelata difficilmente verificabile in termini strettamente numerici, con
riferimento ai singoli provvedimenti, anche per la circostanza che talvolta la
garanzia di tale neutralità non discendeva dal tenore letterale delle
disposizioni bensì dall’assicurazione, fornita dal Governo, che la concreta
attuazione amministrativa dei DPCM, una volta approvati, sarebbe stata disposta
nell’ambito delle risorse concretamente disponibili.
- A tal proposito si rammenta che alcuni provvedimenti
attuativi sono stati emanati prevedendo un incremento numerico delle posizioni
dirigenziali e, quindi, con profili di possibile onerosità[71]. Tale
fattispecie si è verificata, ad esempio, in sede di riorganizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, il cui organico è stato suddiviso tra il Ministero della
pubblica istruzione ed il Ministero dell’università e della ricerca istituiti a
norma del citato decreto legge n. 181/2006. All’atto dell’esame dello schema di
regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’università e della ricerca si è riscontrato che il numero dei
responsabili degli uffici di tale Ministero da solo corrispondeva alla
dotazione già prevista per il preesistente Ministero della istruzione, della
università e della ricerca. Non residuava, pertanto, alcuna dotazione
disponibile da utilizzare per l’emanando regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione. Con
riferimento a tale aspetto problematico, il Governo ha affermato che il
parametro da considerare, a presidio dell’invarianza della spesa, non doveva
essere considerato la dimensione della pianta organica di diritto bensì lo
stanziamento di spesa iscritto a bilancio in conformità di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 25-quater del
decreto legge n. 181/2006.
La legge 296/2006
(legge finanziaria 2007) ha introdotto una serie di misure di razionalizzazione
e di riorganizzazione dei Ministeri e delle amministrazioni pubbliche,
finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento. In particolare
l’articolo 1, comma 404, lettere a), ha previsto l’obbligo di disporre la riduzione
del 10% degli uffici dirigenziali generali e del 5% degli uffici di livello
dirigenziale non generale. L’applicazione della disposizione avrebbe dovuto
comportare la riduzione di 40 unità del numero degli uffici dirigenziali
generali con un effetto di risparmio stimato pari a4 milioni di euro per il 2007, 8 milioni di euro per il 2008 e di
10 milioni a decorrere dal 2009, scontati nei saldi complessivi della manovra
di finanza pubblica per il triennio 2007-2009.
La stessa legge
finanziaria 2007 ha previsto che le amministrazioni dovessero dare concreta
attuazione alle misure di razionalizzazione della spesa mediante schemi di
regolamento corredati di una dettagliata relazione tecnica e di un analitico
piano operativo, asseverati dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in
essere e dei relativi tempi e termini. Nel periodo trascorso dall’entrata in
vigore delle norme, le misure di razionalizzazione non hanno ancora trovato la
loro piena applicazione[73]. Nell’arco
di tale periodo sono stati comunque emanati numerosi decreti attuativi riferiti
alle singole strutture ministeriali: tali schemi di decreti sono stati
sottoposti all’esame delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per i
profili di carattere finanziario.
L’esame degli atti
in questione non ha peraltro consentito un riscontro oggettivo circa il conseguimento
degli obiettivi di risparmio posti dalla norma primaria. Il Servizio Bilancio
dello Stato, a tale proposito, ha rilevato che – poiché non si può procedere
ad un esame contestuale delle varie misure di attuazione – non risulta
possibile verificare l’effettivo, integrale conseguimento dei risparmi
quantificati dalla legge finanziaria. Con
riguardo a tale profilo problematico la Commissione Bilancio ha preso tuttavia
atto delle assicurazioni fornite dal Governo.
Analogamente a quanto
osservato per il procedimento di riordino dei Ministeri, anche dal caso ora
esaminato emerge che l’imputazione di un unico effetto finanziario ad una pluralità
di atti normativi secondari può conciliarsi con la logica della verifica
preventiva di tali effetti soltanto qualora il controllo finanziario, sia
pur differito alla fase successiva all’approvazione della legge, possa
esplicarsi contestualmente sul complesso dei provvedimenti di rango secondario
da adottare in attuazione della legge medesima.
In mancanza di tale presupposto, la verifica dei profili di
carattere finanziario non può giovarsi di elementi di riscontro oggettivo ed
esaustivo se non una volta definito l’intero procedimento delineato dalla norma
legislativa.
Meccanismi
automatici per il controllo della spesa ed il conseguimento di risparmi
Il tema del
controllo della spesa pubblica è divenuto elemento centrale del dibattito
politico nel corso degli ultimi anni. Tale centralità ha indotto il legislatore
a prestare particolare attenzione all’effettivo conseguimento di obiettivi
di controllo della spesa e/o ad obiettivi programmatici di riduzione della
stessa, collegati a misure di razionalizzazione.
In tale prospettiva,
sono stati talvolta previsti, in via legislativa, meccanismi suscettibili di
essere attivati automaticamente - ossia senza un successivo intervento del
legislatore, in corrispondenza di andamenti della spesa non in linea con le
previsioni formulate – e diretti a ricondurre i flussi effettivi entro i limiti
predefiniti.
Questi meccanismi
hanno trovato talvolta una loro definizione nell’ambito delle procedure
previste dal D.L. n. 194/2002 (c.d. “decreto taglia-spese”), con
particolare riferimento all’introduzione delle cosiddette “clausole di
salvaguardia”.
In altre occasioni,
i meccanismi automatici di riduzione della spesa hanno costituito presidi volti
ad assicurare il conseguimento di risparmi, previsti per lo più nel quadro di
manovre di finanza pubblica e scontati nei relativi saldi.
Procedure di carattere generale per il controllo della spesa
sono state introdotte, nel corso della XIV legislatura, con il citato D.L. n.
194/2002.
Tale decreto-legge, modificando l’articolo 11-ter della legge 468/1978, ha individuato
alcuni meccanismi volti a correggere in via automatica eventuali effetti di
maggiore spesa rispetto a quelli previsti, derivanti da specifiche norme.
In linea generale, le disposizioni introdotte all’art. 11-ter dal citato D.L. n. 194 prevedono che
ogni legge, che comporti nuove o maggiori spese, debba indicare espressamente,
per ciascun anno e per ogni intervento da essa disposto, la spesa
autorizzata, configurata come limite massimo di spesa, ovvero la relativa previsione
di spesa. Al fine di mantenere nel tempo la coerenza tra onere e copertura,
in relazione a tali due tipologie di spesa, il legislatore ha individuato
meccanismi che intervengono nel caso di andamenti anomali della spesa stessa.
Più in particolare, in relazione a norme configurate come
“autorizzazioni di spesa”, che recano quindi limiti di spesa, sono
stabilite procedure che, con notevole grado di automaticità, prevedono la disapplicazione
in via amministrativa delle disposizioni, nel caso di accertato superamento
delle risorse autorizzate.
In altri casi, allorquando la norma è suscettibile di
configurare, in capo ai beneficiari, veri e propri diritti soggettivi,
la relativa copertura finanziaria va formulata come previsione di spesa e deve
essere prevista un’apposita “clausola di salvaguardia”, per la
compensazione di eventuali effetti che eccedano le previsioni stesse. Il
decreto n. 194 non indica peraltro un contenuto tipico della clausola di
salvaguardia.
Il rinvio a procedure definite, di volta in volta, mediante
la clausola di salvaguardia è apparso necessario in considerazione della
difficoltà di stabilire, anche nel caso di norme che attribuiscono diritti
soggettivi o prevedono comunque spese a carattere obbligatorio, l’applicazione
di meccanismi automatici di cessazione dell’efficacia delle norme stesse, quali
quelli previsti, dallo stesso decreto “taglia-spese”, per le cosiddette
autorizzazioni di spesa (cosiddetti limiti di spesa).
La prassi applicativa delle disposizioni richiamate ha
consentito peraltro di elaborare un modello alquanto standardizzato di
clausola di salvaguardia, che, in linea di massima, è riconducibile al
seguente schema: a) monitoraggio degli oneri da parte del Ministero
dell’economia; b) attivazione delle procedure per l’adozione dei necessari
provvedimenti correttivi, consistenti nella presentazione di una relazione e di
un’apposita iniziativa legislativa e/o
nel rinvio alla legge finanziaria delle misure correttive; c)
inoltre, in considerazione della specifica tipologia di intervento, è previsto
la possibilità che il Ministro dell’economia attinga al Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d’ordine, in
attesa dell’adozione dei necessari provvedimenti correttivi.
Tuttavia, in taluni casi, la
formulazione della clausola di salvaguardia si è discostata dal modello
consolidato, prevedendo procedure caratterizzate da un certo automatismo: si
tratta infatti di procedure dirette a correggere andamenti delle erogazioni non
in linea con le previsioni, mediante misure di rimodulazione della spesa che
non necessitano di un nuovo intervento legislativo e che appaiono, quindi,
potenzialmente idonee a ripristinare, in via immediata ed automatica, la
coerenza tra oneri effettivi e risorse stanziate.
Particolare rilievo, nella XV legislatura, ha assunto il
caso della delega legislativa volta a consentire l’accesso anticipato al
pensionamento ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti. La
peculiarità di tale intervento merita di essere segnalata sotto diversi
aspetti:
·
in primo luogo, a fronte del riconoscimento, al
raggiungimento di determinati requisiti, del diritto all’accesso
anticipato al pensionamento, l’onere veniva configurato come limite di spesa
(anziché come previsione di spesa, secondo la classificazione indicata dal “decreto
legge taglia-spese”);
·
l’onere veniva tuttavia corredato di una
clausola di salvaguardia (normalmente annessa, come già evidenziato, alle
previsioni e non ai limiti di spesa);
·
infine, mentre il legislatore delegante aveva
introdotto, a fronte del predetto limite di spesa, una clausola di salvaguardia
configurata secondo il modello consolidato, generalmente adottato per le c.d.
“previsioni di spesa”, il
legislatore delegato ha ritenuto di sostanziare tale clausola in un meccanismo
diverso, di carattere automatico, diretto a garantire in modo immediato e
certo il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge delega.
Ai fini della presente analisi,
si intende peraltro porre in evidenza soprattutto l’ultimo profilo rilevato,
ossia la peculiarità della clausola di salvaguardia contenuta nello schema di
decreto legislativo predisposto nell’esercizio della delega, che ha previsto meccanismi automatici diretti a
garantire il rispetto del limite di spesa fissato anche nell’eventualità in
cui, in sede di accertamento dei requisiti, il numero dei soggetti aventi
diritto al beneficio dovesse rivelarsi superiore a quello stimato nella
relazione tecnica annessa allo stesso schema di decreto.
- Più in particolare, lo schema di decreto legislativo in
materia di accesso anticipato al pensionamento per alcune categorie di
lavoratori impiegati in mansioni particolarmente usuranti (doc. 238/XV legislatura)
- che, al momento, non ha ancora concluso il suo formale iter di emanazione – ha dettato una particolare
clausola di salvaguardia degli effetti finanziari.
La peculiarità di tale clausola discende dalla necessità di
contemperare esigenze diverse, evidenziate già nel corso dell’esame della legge
delega (legge n. 247/2007 – Attuazione del Protocollo welfare). Infatti, tra i
principi e criteri direttivi della delega, oltre ai parametri per
l’individuazione dei soggetti aventi diritto al pensionamento anticipato,
veniva indicato il rispetto, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefìci, della coerenza con il limite delle risorse
finanziarie di un apposito Fondo. Peraltro, pur prevedendo la legge tale
limite di spesa, vertendo la stessa in materia di diritti soggettivi, è apparsa
non congrua la mera applicazione delle procedure ordinarie che avrebbe
provocato – secondo la disciplina generale dettata per i limiti di spesa - la
mera disapplicazione delle disposizioni in caso di superamento del limite
stesso.
La legge di delega, come già accennato, ha quindi previsto
una clausola di salvaguardia - elaborata sulla base del tradizionale modello
stabilito per le cosiddette “previsioni di spesa” - disponendo che, in caso di
scostamenti, in base alle richieste degli aventi diritto, rispetto alle risorse
finanziarie previste, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne avrebbe
dovuto dar notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze ai
fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 11-ter, comma 7,
della legge n. 468/1978. Tuttavia, nella stessa relazione tecnica allegata al disegno
di legge di delega, veniva espressa una riserva circa tale clausola di
salvaguardia, segnalandosi che la clausola non avrebbe comunque consentito, a
fronte dell’automaticità che caratterizza la spesa pensionistica, di operare in
via altrettanto immediata all’interno del sistema pensionistico stesso.
Pertanto, in caso di scostamenti, la copertura dei maggiori oneri sarebbe stata
di fatto rinviata a provvedimenti successivi, per i quali sarebbe stato
necessario apprestare nuove risorse, a carico della fiscalità generale.
La compensazione all’interno del sistema pensionistico
stesso, secondo la relazione tecnica, appariva invece presupposto necessario
per non alterare in modo sostanziale gli andamenti di breve e medio-lungo
periodo della spesa pensionistica e la sostenibilità della finanza pubblica in
relazione, in particolare, al percorso di rientro dal debito pubblico.
Per superare tale riserva, il legislatore delegato ha
pertanto introdotto una procedura di controllo della spesa più aderente alle
esigenze sopra evidenziate, denominata sempre “clausola di salvaguardia”
(articolo 5), ma caratterizzata da elementi di automatismo. La disposizione
prevede che, qualora nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle domande
presentate agli enti previdenziali interessati ed accolte emergano scostamenti
rispetto alle risorse finanziare previste, si proceda al differimento, in
ragione della maturazione dei requisiti, della decorrenza dei trattamenti (le
cosiddette finestre), al fine di garantire un numero di accessi al
pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione
alle risorse finanziarie disponibili. Ciò al fine di assicurare l’automaticità
del rientro nei limiti previsti dell’eventuale maggiore spesa, senza
pregiudizio dei diritti soggettivi in gioco, facendo ricorso alla flessibilità
in tema di decorrenza del pensionamento prevista per la generalità dei lavoratori e mantenendo inoltre sotto
controllo l’intero aggregato ai fini del rispetto del Patto di stabilità e
crescita.
Come risulta evidente da quanto esposto, i caratteri
fortemente innovativi che la fattispecie presenta rispetto alla disciplina
generale vanno ricondotti alla necessità di contemperare l’esigenza di rendere
effettivo il riconoscimento del diritto con quella di rispettare comunque il
limite costituito dalle risorse assegnate all’apposito Fondo, pur
nell’impossibilità di disporre degli elementi idonei a consentire una compiuta
ricognizione, in via preventiva, dei potenziali beneficiari e, quindi, dei
relativi oneri.
La soluzione individuata è stata pertanto quella di
configurare l’onere quale limite di spesa, pur in presenza di diritti soggettivi,
prevedendo comunque un meccanismo di salvaguardia - diverso da quello
contemplato dalla legge delega - per ricondurre in via automatica, in caso di
scostamenti, la spesa effettiva a quella fissata dalla legge delega, attraverso
una procedura di rinvio delle decorrenze dei trattamenti, finalizzata al non
superamento del numero di pensionamenti programmato.
L’efficacia del meccanismo
rimane sostanzialmente da verificare alla luce della concreta attuazione delle
procedure prefigurate dalla normativa delegata.
Il Servizio Bilancio dello Stato, tenuto conto che i criteri di
priorità saranno individuati con decreto ministeriale, ha comunque sottolineato
l’esigenza di valutare tutte le possibili implicazioni nell’applicazione del
meccanismo prefigurato con la clausola di salvaguardia, ivi compresi eventuali
profili di contenzioso. In risposta a tali considerazioni, nel corso della
seduta della Commissione Bilancio della Camera del 9 aprile 2008, il
rappresentante del Governo ha rilevato che eventuali profili di contenzioso non
dovrebbero sussistere, dal momento che la medesima clausola di salvaguardia
opera, qualora necessario, con applicazione del criterio, ordinariamente adottato
in ambito previdenziale, di priorità in ragione della maturazione dei requisiti
agevolati.
Nel corso della
legislatura è emersa anche la necessità di elaborare strumenti che assicurino
in via automatica il conseguimento di obiettivi di risparmio,
soprattutto nei casi in cui i relativi effetti siano preventivamente
contabilizzati ed utilizzati a copertura di nuove spese, secondo quanto accade,
ad esempio, per i risparmi “scontati” nel quadro complessivo delle manovre di
finanza pubblica.
Le considerazioni di
seguito riportate - pur non presentando diretta attinenza con la tematica prima
esaminata, riferita alla clausola di salvaguardia annessa alle previsioni di
nuove spese – vengono svolte in questa sede in quanto anch’esse fanno
riferimento a meccanismi di controllo connotati da accentuate caratteristiche
di automaticità.
Gli interventi
normativi che si intende evidenziare, introdotti nel corso della XV
legislatura, presentano infatti i seguenti caratteri:
·
definizione
di un obiettivo programmatico di contenimento della spesa o in termini di riduzione percentuale o in valore
assoluto;
·
individuazione
degli strumenti normativi da utilizzare per il conseguimento dell’obiettivo;
·
previsione,
in caso di inefficacia o di non piena efficacia dei predetti strumenti, di meccanismi
automatici di salvaguardia, diretti comunque a conseguire l’effetto di
risparmio ascritto alla disciplina.
-Un esempio del meccanismo descritto può riscontrarsi
nell’art. 1, comma 621, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007),
che ha imposto che, in caso di mancato conseguimento dei risparmi previsti dai
commi 483 (in materia di riordino di enti pubblici) e 620 (misure per
la scuola), di ridurre corrispondentemente le dotazioni di bilancio delle
amministrazioni interessate all’attuazione degli interventi previsti (in
particolare delle amministrazioni vigilanti sugli enti pubblici, nel caso del
comma 483, e del Ministero della pubblica istruzione, per il comma 620).
La disposizione recata dal comma 621 costituiva pertanto lo
strumento utile a garantire comunque il conseguimento dei risparmi di spesa ascritti
alle disposizioni dei commi 483 e 620 della legge finanziaria, risparmi che,
rientrando nel quadro della manovra di finanza pubblica per il 2007,
contribuivano a definire il complessivo effetto della stessa in vista del
raggiungimento dell’obiettivo di deficit fissato
dal documento di programmazione economico-finanziaria.
Nei casi citati,
l’introduzione di un meccanismo automatico di controllo sembra motivato anche
dalla necessità di garantire il conseguimento di risparmi già computati nel
quadro degli effetti finanziari necessari per conseguire gli obiettivi
programmatici fissati con la manovra di finanza pubblica. In assenza del
predetto meccanismo, l’adozione di ordinari criteri di prudenzialità avrebbe
forse suggerito – come avvenuto in precedenti occasioni - di non utilizzare in
via preventiva, per il conseguimento di obiettivi di riduzione del deficit,
risparmi demandati ad una serie di provvedimenti successivi e caratterizzati da
possibili margini di incertezza.
La successiva esperienza applicativa e le difficoltà riscontrate
nella realizzazione dei risparmi previsti hanno convalidato l’opportunità di
prevedere, nel caso illustrato, un meccanismo automatico a garanzia del
conseguimento dell’effetto atteso di riduzione della spesa.
Le misure previste dalla legge finanziaria 2007 per la
scuola (quali l’aumento del rapporto alunni/classe, la certificazione
all’insegnamento della lingua inglese dei docenti della scuola primaria, la
riduzione dei quadri orari degli istituti professionali e la riconversione
professionale del personale docente in soprannumero) avrebbero dovuto
assicurare il conseguimento di economie di spesa per un importo complessivo non
inferiore a 448,20 milioni di euro per l’anno 2007, 1.324,50 milioni di euro
per l’anno 2008 e 1.402,20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. In
realtà, le economie previste non sono state poi conseguite nella misura
preventivata. Pertanto, al fine di evitare che operasse il meccanismo
automatico sopra prefigurato, l’obiettivo di risparmio è stato rimodulato a
decorrere dal 2008[83]
e, per il 2007, è stato necessario provvedere alla sospensione della clausola di
salvaguardia prima descritta, predisponendo la necessaria copertura
finanziaria.
Più recentemente, nella legge finanziaria 2008, l’art. 2,
comma 593, ha introdotto tale meccanismo di controllo della spesa in relazione
agli obiettivi di risparmio connessi all’adozione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, delle misure di contenimento delle spese postali e
telefoniche. La disposizione stabilisce che le pubbliche amministrazioni
dovranno adottare misure di contenimento delle suddette spese in modo tale da conseguire
risparmi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro
per l’anno 2008, 128 milioni di euro per l’anno 2009 e 272 milioni di euro per
l’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento di tali obiettivi indicati,
è stabilito che, in caso di accertamento di minori economie, si dovrà provvedere
alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle
pubbliche amministrazioni inadempienti.
La
revisione delle quantificazioni nella fase di attuazione delle leggi
Una procedura per la correzione degli scostamenti che si
verifichino nella fase di attuazione delle leggi, rispetto alle originarie
previsioni di spesa è delineata, in via ordinaria, come in precedenza accennato,
dall’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 468/1978. Tale norma prevede la presentazione, da parte del Ministro
dell'economia e delle finanze, di un’apposita relazione al Parlamento che individui
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione dei relativi oneri. Contestualmente,
l’articolo 11-ter prevede che siano
assunte, da parte del Governo, le conseguenti iniziative legislative.
Tale procedura, benché quasi costantemente richiamata
nell’ambito delle clausole di salvaguardia che accompagnano, ai sensi del D.L.
n. 194/2002, le previsioni di spesa, non ha mai trovato attuazione dall’entrata
in vigore del medesimo decreto legge.
Nel corso della XV legislatura, invece, per rettificare -
con riferimento a leggi già in vigore – le quantificazioni di effetti
finanziari che risultavano non più rispondenti al reale andamento degli oneri
rilevati nella fase di attuazione, le Camere hanno fatto ricorso ad altri
strumenti: l’introduzione di nuove norme legislative recanti una
rideterminazione degli stanziamenti originariamente previsti (rifinanziamento e/o
definanziamento di disposizioni vigenti); l’approvazione di misure correttive
delle “eccedenze di spesa”, riportate nelle leggi finanziarie annuali.
L’esigenza di ridefinire la quantificazione degli effetti
finanziari derivanti da norme legislative può presentarsi nella fase di
attuazione delle leggi allorché si manifestino effetti finanziari
originariamente non previsti: tale evenienza può richiedere l’approvazione di
nuove norme di legge contenenti quantificazioni aggiornate, volte per esempio a
disporre una riduzione di stanziamenti risultanti sovradimensionati rispetto
alle finalità di spesa
ovvero, più di frequente, ad approntare la necessaria copertura finanziaria di
spese risultate sottostimate. Anche in questo caso – trattandosi della
rettifica di stime formulate in precedenza – la procedura di quantificazione
prevede la presentazione, la verifica e la valutazione parlamentare di una
nuova relazione tecnica, rispetto alla quale il Servizio Bilancio fornisce le
proprie analisi con finalità istruttorie. Va segnalato tuttavia che
frequentemente – come di seguito illustrato con riferimento a casi specifici di
revisione delle quantificazioni – non sono risultate sufficientemente suffragate,
nell’ambito delle relazioni tecniche, le ragioni della revisione delle originarie quantificazioni.
Fra gli esempi di revisione delle quantificazioni, che si
sono presentati nella XV legislatura in connessione all’emergere, in fase di
attuazione delle norme, di condizioni o di elementi originariamente non
previsti, si segnalano: a) le norme in materia di detraibilità dell’IVA per i
veicoli aziendali; b) le disposizioni per la destinazione del 5 per mille
dell’imposta sui redditi alla ricerca e al volontariato; c) le agevolazioni
fiscali per gli investimenti nelle aree svantaggiate (cd. “Visco Sud”) e per le
spese in ricerca.
a) Con sentenza della Corte di Giustizia
europea in data 14 settembre 2006, è stata sancita la piena detraibilità
dell’IVA sui veicoli per uso aziendale. Gli effetti finanziari della sentenza
sono stati quantificati, in parte, dal decreto legge 262/2006 (che ha stimato in
circa 5,2 miliardi di euro a decorrere dal 2007 le minori entrate riferibili
alle operazioni poste in essere dopo la sentenza) e, per la restante parte,
dalla Nota di aggiornamento del DPEF 2007-2011 (che, ai fini dell’indebitamento
netto, ha individuato in 17,1 miliardi di euro, originariamente imputati al 2006
e solo successivamente rimodulati, l’onere dei rimborsi per
l’IVA indebitamente versata negli anni precedenti alla sentenza()).
Quest’ultimo onere ha trovato evidenza contabile, ai fini del bilancio dello
Stato, tra le regolazioni debitorie (accantonamento in tabella B nella legge
finanziaria 296/2006, pari a 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009). Tale spesa (liquidazione dei rimborsi) è stata quindi
formalmente autorizzata con l’articolo 15-bis, commi 12 e 13, del decreto legge
81/2007 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), il quale ha confermato
la predetta quantificazione.
Successivamente, dopo un
comunicato dell’Agenzia delle entrate che rendeva noto che era
stato acquisito un numero ancora esiguo di istanze di rimborso (il che avrebbe
potuto determinare una diversa distribuzione dell’onere sul triennio 2007-2009,
con un possibile incremento della spesa negli esercizi successivi), sono
intervenuti due definanziamenti della predetta autorizzazione di spesa:
l’articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 244/2007, che l’ha ridotta di 2 miliardi di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009; l’articolo 8, comma 1, del decreto legge
248/2007 (Proroga di termini), che ha operato un’ulteriore riduzione di 250
milioni di euro per l’anno 2008().
Poiché le allegate relazioni
tecniche non hanno fornito i dati posti alla base di tale revisione degli
oneri, i Servizi Bilancio di Camera e Senato hanno richiesto chiarimenti sia in ordine al
presumibile ammontare dei rimborsi da erogare negli esercizi successivi, alla
luce degli elementi emersi nel 2007, sia in ordine alla coerenza fra tali oneri
(la cui riduzione veniva utilizzata a copertura di nuove spese) e le nuove
finalizzazioni che si intendeva finanziare. Infatti, come detto, con
riferimento all'autorizzazione per i rimborsi IVA non erano stati
originariamente scontati effetti sull’indebitamento netto per gli anni
successivi al 2006; inoltre gli effetti sul fabbisogno risultavano largamente inferiori
a quelli sul saldo netto da finanziare.
b) La legge finanziaria 266/2005 (articolo 1, comma 337) ha introdotto a
titolo sperimentale per l'anno 2006 la possibilità, per i contribuenti, di destinare una quota
pari al 5 per mille dell'IRPEF al sostegno del volontariato o al finanziamento
dell'università, della ricerca scientifica o della ricerca sanitaria. L’onere,
pari a 270 milioni di euro per competenza, era stato stimato in base alla
percentuale di contribuenti che negli anni precedenti aveva operato la propria
scelta in relazione all’8 per mille (=41% del totale dei contribuenti). La
spesa per competenza era stata riferita all’esercizio 2007(),
con una dinamica ridotta per i saldi di fabbisogno e di indebitamento.
Successivamente sono intervenute,
oltre alla riproposizione di anno in anno del medesimo istituto, numerose
rettifiche dell’onere originariamente previsto.
In particolare, l’articolo 1,
comma 1234, della legge finanziaria 296/2006 ha rinnovato la facoltà di
opzione per il 2007, fissando l’onere a 250 milioni di euro per il 2008.
L’articolo 20 del decreto legge 159/2007 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria) ha integrato l’originario stanziamento 2007()
per un ammontare di 150 milioni; ha inoltre ammesso al riparto
anche le associazioni sportive dilettantistiche. L’articolo 3, comma 4, della legge
finanziaria 244/2007 ha rinnovato per il 2008 la facoltà di opzione (con
una spesa pari a 380 milioni per il 2009) ed al contempo ha incrementato
l’autorizzazione di spesa di cui alla precedente legge 296/2006, portandola a
400 milioni; ha inoltre previsto – senza tuttavia modificare l’onere – che la
predetta autorizzazione di spesa (legge 296/2006) fosse utilizzabile anche per
la liquidazione agli aventi diritto delle quote relative agli anni precedenti.
Infine, il decreto legge 248/2007 (Proroga di termini) ha ammesso al
riparto anche le fondazioni di carattere culturale, con un contestuale
incremento di 5 milioni dell’autorizzazione di spesa per gli anni 2008 e 2009.
In proposito i Servizi Bilancio
di Camera e Senato hanno rilevato la carenza di dati e di informazioni in
ordine alle stime ed alle rettifiche che si sono succedute, segnalando fra
l’altro: l’insufficienza delle indicazioni circa i parametri posti alla base
delle predette revisioni; l’impossibilità di limitare la spesa all’entità degli
stanziamenti autorizzati (tenuto conto che le erogazioni variano con il
modificarsi delle percentuali di adesione dei contribuenti); l’incoerenza, da
un anno all’altro, delle stime relative a fabbisogno e indebitamento (e quindi
dei tempi di volta in volta ritenuti necessari per l’espletamento delle
procedure di erogazione delle risorse).
c) La legge finanziaria 296/2006 ha
introdotto due tipologie di agevolazioni fiscali: un credito d’imposta in
favore delle imprese che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate negli anni compresi fra
il 2007 e il 2013();
un secondo credito d’imposta, per il
periodo dal 2007 al 2009, in relazione ai costi sostenuti per attività di
ricerca industriale, con un limite ai costi
ammissibili al beneficio (15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta). L’efficacia di
ambedue le agevolazioni era espressamente subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea.
Tali meccanismi agevolativi
hanno successivamente subito ripetute modifiche, che hanno di volta in volta
esteso o ridotto la loro portata e, conseguentemente, il loro costo per la
finanza pubblica.
Da ultimo, l’articolo 29, commi
10-bis e 10-ter, del decreto legge 248/2007 (Proroga di termini) ha quantificato maggiori entrate nette nell’anno
2008 - pari a 96,9 milioni di euro - in relazione all’effettivo utilizzo di
ambedue le agevolazioni fiscali: infatti, come precisato dalla relazione
tecnica, poiché l’autorizzazione della Commissione europea alla quale era stata
subordinata l’efficacia di tali agevolazioni non era stata accordata nel corso
del 2007, si poteva presumere che, per effetto dell’incertezza normativa, le
imprese non avessero effettuato gli investimenti inizialmente previsti. Considerando l’effetto
disincentivante connesso all’incertezza normativa nel 2007(), si prevedeva una riduzione del 30 per cento
degli investimenti originariamente stimati, con un conseguente risparmio per
l’erario.
Anche in questo caso il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che la
relazione tecnica non aveva fornito informazioni circa i presupposti alla base
della considerazione che nel 2007 l’incertezza normativa circa l’applicabilità
dei benefici avesse comportato una flessione degli investimenti. Pertanto la
quantificazione dei risparmi proposta nella RT avrebbe potuto determinare, ove
fosse stata confermata la fondatezza di tali presupposti, una sovrastima dei
risparmi previsti per il 2008.
Fra i meccanismi di
controllo della spesa introdotti con il decreto legge 194/2002rivestono
particolare rilievo le misure correttive degli effetti finanziari delle leggi
che presentino andamenti di spesa eccedenti le corrispondenti coperture
(cosiddette “eccedenze di spesa”). Tali
correzioni, pur riguardando leggi già in vigore (e quindi operando nella fase
di attuazione delle leggi), richiedono l’approvazione parlamentare e possono
pertanto essere assimilate, dal punto di vista procedurale, a nuove decisioni
di spesa.
Norme e
procedure
Come già ricordato, la
procedura di correzione delle eccedenze di spesa è stata introdotta dall’articolo
11-ter della legge 468/1978(),
il quale ha distinto le norme legislative di spesa in due categorie:
autorizzazioni costituenti limiti massimi di spesa (che cessano di avere
efficacia all’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti); previsioni di spesa
(che devono essere accompagnate da una clausola di salvaguardia per la
compensazione degli effetti che eccedano tali previsioni). Le misure correttive
delle eccedenze di spesa rientrano, in linea generale, nella procedura
stabilita per questa seconda categoria, ossia per le previsioni di spesa.
Tale meccanismo ha trovato applicazione essenzialmente per
le spese obbligatorie o vincolate a vario titolo (per es. spese attinenti a
diritti soggettivi o derivanti da impegni internazionali), in relazione alle
quali non sarebbe stato possibile disporre la cessazione automatica
dell’efficacia delle norme in presenza di disallineamenti fra oneri e
stanziamenti.
In particolare, come detto in precedenza, con l’articolo
11-ter, comma 7, è stata delineata una procedura di
intervento, in caso di scostamenti fra previsioni di spesa e fabbisogno
effettivo, basata sul monitoraggio del Ministro dell'economia e finalizzata
all’assunzione delle “conseguenti iniziative legislative”.
Inoltre, con l’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater),
il contenuto tipico delle leggi finanziarie annuali è stato esteso per
ricomprendervi le misure correttive di eccedenze di spesa. Tale norma, infatti,
elencando le misure che integrano il contenuto proprio delle leggi finanziarie
annuali, ha incluso fra queste anche le “norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7”.
Dal punto di vista
procedurale le norme richiamate - pur essendo poste fra loro in correlazione
dal testo della legge n. 468 – possono essere considerate
come costitutive di due distinte possibilità di intervento, entrambe volte alla
correzione degli effetti finanziari non previsti: da una parte, l’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 11-ter,
comma 7 (“conseguenti iniziative legislative”), dall’altra l’inserimento nella
legge finanziaria annuale di misure destinate a coprire le eccedenze di spesa
(ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater).
In sostanza, sulla base di tale interpretazione, l’attività
di monitoraggio effettuata dal Ministro dell’economia può tradursi sia nell’adozione
di provvedimenti correttivi ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, sia nell’approvazione di misure correttive in sede di
legge finanziaria a norma dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater).
In linea di
principio quindi ambedue le opzioni, in presenza di scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa, potrebbero essere utilizzate sia per modificare le norme
sostanziali da cui le eccedenze derivano sia per disporre la copertura delle
maggiori occorrenze assumendo una nuova decisione di spesa: per prassi costante,
le eccedenze di spesa approvate in legge finanziaria hanno assunto quest’ultima
forma, ossia si sono configurate come stanziamenti aggiuntivi - indicati dal Governo in un apposito
allegato nella legge finanziaria annuale e deliberati dalle Camere - ad
incremento della copertura finanziaria di norme legislative previgenti.
Tale modalità è considerata dalla Corte dei conti meno rigorosa e, almeno
in teoria, meno tempestiva rispetto a quella che prevede – a valle del
monitoraggio dell’attuazione delle norme finanziarie - l’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7.
In ordine ad alcuni esempi di modifica delle norme
sostanziali all’origine delle eccedenze di spesa si veda il successivo
paragrafo “Riduzione dell’impatto finanziario delle misure correttive delle
eccedenze di spesa”.
Le misure
correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa negli anni 2004-2008
Il nuovo istituto è
stato applicato per la prima volta nella legge finanziaria 2004 a seguito di
quanto emerso nell’ambito del disegno di legge di assestamento per il 2003.
Nell’assestamento
di bilancio, infatti, non erano stati inseriti una serie di oneri evidenziatisi
nel corso dell’esercizio, ma in base alla nuova disciplina essi erano stati
rinviati – in ragione della loro natura, definita di “spese eccedenti la
relativa previsione normativa” - alla
decisione legislativa da assumere in
sede di legge finanziaria per il 2004. Confermando tale indicazione, l’articolo 4, comma 246, della
legge 350/2003 è stata corredata di un apposito allegato recante il
rifinanziamento delle eccedenze di spesa.
Analogamente si è proceduto nelle quattro successive leggi
finanziarie, come si riepiloga nella tabella che segue.
La tabella riporta l’ammontare delle
eccedenze di spesa previsto nelle leggi finanziarie al netto della quota
attribuita alle regolazioni debitorie (riportata per ogni anno nell’ultimo
rigo). In grassetto è indicato, per il solo saldo netto da finanziare,
l’importo delle eccedenze di spesa approvato per il primo esercizio di
riferimento di ciascuna legge finanziaria.
Importi
complessivamente autorizzati per gli anni 2004-2010a titolo di correzione degli
effetti finanziari delle leggi
|
|
|
Legge
350/03
|
Legge
311/04
|
Legge
266/05
|
Legge
296/06
|
Legge
244/07
|
|
TOTALE
importi autorizzati
|
|
2004
|
SNF
|
2,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
SNF
|
2,8
|
|
Fabb.
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fabb.
|
0,3
|
|
Ind. PA
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ind. PA
|
0,3
|
|
Regolaz.
debitorie
|
1,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Regol.
debitorie.
|
1,8
|
|
2005
|
SNF
|
2,7
|
2,1
|
-
|
-
|
-
|
SNF
|
4,8
|
|
Fabb.
|
0,3
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
Fabb.
|
0,8
|
|
Ind. PA
|
0,3
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
Ind. PA
|
0,8
|
|
Regolaz.
debitorie
|
-
|
1,1
|
-
|
-
|
-
|
Regol.
debitorie
|
1,1
|
|
2006
|
SNF
|
2,9
|
0,2
|
2,3
|
-
|
-
|
SNF
|
5,4
|
|
Fabb.
|
0,3
|
0,2
|
0,6
|
-
|
-
|
Fabb.
|
1,1
|
|
Ind. PA
|
0,3
|
0,2
|
0,6
|
-
|
-
|
Ind. PA
|
1,1
|
|
Regolaz.
debitorie
|
-
|
|
0,4
|
-
|
-
|
Regolaz. debitorie.
|
0,4
|
|
2007
|
SNF
|
-
|
0,2
|
0,7
|
2,0
|
-
|
SNF
|
2,9
|
|
Fabb.
|
-
|
0,2
|
0,4
|
-
|
-
|
Fabb.
|
0,6
|
|
Ind. PA
|
-
|
0,2
|
0,4
|
-
|
-
|
Ind. PA
|
0,6
|
|
Regolaz.
debitorie
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Regolaz.
debitorie
|
-
|
|
2008
|
SNF
|
-
|
-
|
0,8
|
0,2
|
0,6
|
SNF
|
1,6
|
|
Fabb.
|
-
|
-
|
0,4
|
-
|
0,2
|
Fabb.
|
0,6
|
|
Ind. PA
|
-
|
-
|
0,4
|
-
|
0,2
|
Ind. PA
|
0,6
|
|
Regolaz
debitorie
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,03
|
Regol.
debitorie
|
0,03
|
|
2009
|
SNF
|
-
|
-
|
-
|
0,1
|
0,2
|
SNF
|
0,3
|
|
Fabb.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,2
|
Fabb.
|
0,2
|
|
Ind. PA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,2
|
Ind. PA
|
0,2
|
|
Regolaz.
debitorie
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Regolaz
debitorie
|
-
|
|
2010
|
SNF
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,2
|
|
0,2
|
|
Fabb.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,2
|
|
0,2
|
|
Ind. PA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,2
|
|
0,2
|
|
Regolaz.
debitorie
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Regolaz.
debitorie.
|
-
|
(miliardi
di euro – importi arrotondati)
Riduzione
dell’impatto finanziario delle misure correttive delle eccedenze di spesa
Dal punto di vista quantitativo, la tabella indica una
marcata rilevanza del ricorso alle eccedenze di spesa nei primi quattro anni di
applicazione ed un ridimensionamento del fenomeno nell’ultimo anno (2008), con
una significativa riduzione degli importi autorizzati con la legge 244/2007.
La tabella che segue riporta sinteticamente gli effetti complessivi
delle misure correttive approvate per il primo esercizio di riferimento di
ciascuna legge finanziaria. Nella prima riga è riportato il solo effetto sul
saldo netto da finanziare, nella terza riga sono state sommate, per ciascun
anno, la spesa registrata sul saldo netto da finanziare e le regolazioni debitorie:
(miliardi di euro – importi arrotondati)
|
|
L. 350/2003
anno 2004
|
L. 311/2004
anno 2005
|
L. 266/2005
anno 2006
|
L. 296/2006
anno 2007
|
L. 244/2007
anno 2008
|
TOTALE
|
|
SNF
|
2,8
|
2,1
|
2,3
|
2,0
|
0,6
|
9,8
|
|
RD
|
1,8
|
1,1
|
0,4
|
-
|
-
|
3,3
|
|
SNF+RD
|
4,6
|
3,2
|
2,7
|
2,0
|
0,6
|
13,1
|
Non si dispone di informazioni sufficienti per ricostruire
le ragioni che sono alla base di tale ridimensionamento. Alcune cause possono
essere tuttavia ricercate:
a)
sotto il profilo quantitativo, nella progressiva
riduzione delle occorrenze dovute ad annualità pregresse, nonché nel carattere
permanente di parte delle correzioni apportate nel corso degli anni;
b)
sotto il profilo sostanziale, nella modifica,
per alcuni degli scostamenti riscontrati, del meccanismo che aveva determinato
le eccedenze stesse.
a) In
particolare, sotto il primo profilo si osserva che, in presenza di una
sostanziale omogeneità nella natura degli interventi oggetto dei
rifinanziamenti in esame, l’approvazione
di finanziamenti aggiuntivi per le eccedenze di spesa potrebbe aver determinato
un effetto di contenimento degli scostamenti nel corso del tempo, via via che
si riducevano le occorrenze per gli anni pregressi. Inoltre, aver provveduto a
integrare le autorizzazioni di spesa originarie con nuovi finanziamenti di
carattere permanente ha consentito un parziale ridimensionamento del fenomeno.
Va sottolineato tuttavia che tale limitazione è avvenuta attraverso
aggiustamenti successivi: infatti, dopo la prima sperimentazione dello strumento
delle eccedenze (legge 350/2003), nella quale i valori autorizzati erano stati
pressoché uniformi per tutto il triennio, nelle tre successive leggi
finanziarie
la parte prevalente degli stanziamenti aggiuntivi ha riguardato il primo
esercizio del triennio, con una drastica diminuzione nel secondo e nel terzo
anno. Con la legge 244/2007 si è ristabilito infine un sostanziale equilibrio
delle somme autorizzate nel triennio, in quanto l’intero ammontare che
costituisce la differenza fra il primo esercizio e gli altri due riguarda
un’unica voce di spesa (oneri previdenziali pregressi).
Nello specifico si osserva che sul totale di 9,8 miliardi
di maggiore spesa contabilizzata negli anni 2004-2008 sul SNF, circa 3,8
miliardi di euro hanno riguardato aumenti di carattere permanente e in
particolare: 2,5 miliardi di euro per spese previdenziali e assistenziali; 0,5
miliardi di euro per spese di giustizia; 0,4 miliardi di euro per impegni
internazionali; 0,15 miliardi di euro per oneri nel settore tributario; 0,3 miliardi di euro per
finanziamenti, agevolazioni o sovvenzioni all’economia.
b)
Riguardo agli altri strumenti adottati per
conseguire un riallineamento fra gli stanziamenti originari e le maggiori
occorrenze di spesa emerse in sede di attuazione, si osserva che attualmente
non sono disponibili informazioni sistematiche circa l’impatto finanziario
degli interventi normativi che sono stati approvati specificamente al fine di
correggere i meccanismi che hanno generato le eccedenze. Peraltro nel corso della XV legislatura, in
alcuni settori che si erano caratterizzati per il ripetersi degli scostamenti
rispetto alle previsioni, oltre al mero rifinanziamento delle eccedenze sono
state introdotte anche misure di razionalizzazione finalizzate a ridimensionare
tale fenomeno.
- Si segnalano, a titolo esemplificativo, le correzioni
normative apportate nei settori dell’editoria e della giustizia.
·
Con il decreto
legge 223/2006 (Rilancio economico e sociale, contenimento della spesa
pubblica) sono state introdotte modifiche alla
disciplina sul pagamento delle spese di giustizia, che in base alla
legislazione previgente venivano in prevalenza anticipate dagli uffici postali
e poi rimborsate dallo Stato a Poste italiane SpA. Poiché Poste italiane SpA
provvedeva al pagamento delle somme indipendentemente dalla presenza di
disponibilità in bilancio, tale meccanismo tendeva a far emergere
successivamente maggiori occorrenze di spesa, che venivano finanziate con la
procedura di cui alla lettera i-quater) (eccedenze di spesa). Il decreto
legge 223/2006 ha quindi disposto che il pagamento delle spese di giustizia possa
avvenire esclusivamente – tranne alcune eccezioni - attraverso le ordinarie
procedure di contabilità generale dello Stato, eliminando così il ricorso all’anticipazione
da parte degli uffici postali. Tale innovazione, pur non incidendo sul volume
assoluto delle spese di giustizia, è intervenuta sul fenomeno del
disallineamento temporale fra il pagamento delle somme e la loro imputazione al
bilancio dello Stato. Il Servizio Bilancio ha ritenuto pertanto non
giustificata la previsione di un effetto di risparmio ascritto alle modifiche
introdotte,
considerato che l’unica voce effettiva di risparmio avrebbe dovuto essere
costituita dal venir meno del costo del servizio di Poste italiane SpA (mentre la spesa
complessiva avrebbe dovuto presumibilmente mantenere il medesimo livello registrato
negli anni precedenti).
·
Con il decreto legge 262/2006 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria) sono state introdotte misure di razionalizzazione dei
contributi all’editoria finalizzate: a rendere
più severi i requisiti di accesso alle provvidenze (per esempio, definizione
delle agenzie di stampa a diffusione nazionale); a ridurre i rimborsi per
talune voci di spesa (costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi,
costi per copie di carta stampata); a limitare alcuni pagamenti (rateizzazione
del debito dello Stato verso Poste italiane SpA). Poiché, tuttavia, a tali
misure di contenimento non sono stati ascritti effetti finanziari, non sono disponibili
dati circa il loro impatto sugli andamenti di spesa in atto (si segnala
tuttavia che nella legge finanziaria per il 2008 la voce “provvidenze
all’editoria” non è stata rifinanziata fra le eccedenze di spesa).
In un caso, invece, l’intervento
correttivo è consistito non in una riduzione dell’eccedenza, ma solo in una sua
diversa collocazione formale nel testo: infatti l’eccedenza, inizialmente
inserita nell’allegato i-quater), è stata riposizionata nell’ambito
dell’articolato della legge finanziaria. Le nuove misure, pertanto, non hanno
riguardato una revisione del meccanismo che aveva generato le eccedenze, ma
soltanto lo strumento tecnico della rettifica degli stanziamenti.
- Nelle ultime tre leggi finanziarie
[legge 266/2005(),legge
296/2006()
e legge 244/2007()]
è stato disposto l’utilizzo di risorse, per un ingente ammontare (fra i 400 e i
700 milioni circa ogni anno), per il finanziamento dei maggiori oneri emersi a
carico della gestione per le pensioni agli invalidi civili (GIAS). Nella
precedente legge finanziaria 311/2004, invece, tali oneri erano stati inseriti
fra le eccedenze di spesa di cui alla lettera i-quater). In particolare
le leggi finanziarie per il 2006, per il 2007 e per il 2008 hanno disposto, per
il finanziamento dei predetti maggiori oneri, l’utilizzo di somme già
trasferite alla Gestione degli interventi assistenziali (GIAS) e all’INPS
risultanti ancora disponibili nelle casse dell’Istituto. Come precisato dalle
relazioni tecniche, tali norme non determinavano alcun onere né sul bilancio
dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni, trattandosi di
regolazioni contabili riguardanti somme già trasferite all’INPS e non
utilizzate.
Sul punto il Servizio Bilancio ha richiesto chiarimenti in ordine alla natura
delle maggiori spese, rispetto a quelle preventivate, tenuto conto della
ripetitività dei finanziamenti aggiuntivi disposti.
Profili
metodologici relativi alla quantificazione delle eccedenze
Rispetto alla fase di avvio della procedura di correzione
delle eccedenze di spesa (negli anni fra il 2003 e il 2005), con le leggi
finanziarie approvate nel corso della XV legislatura si sono registrate alcune
significative evoluzioni.
Innanzitutto, come sopra
illustrato, si è verificata una riduzione - in termini di quantità complessiva
dei finanziamenti correttivi autorizzati - delle eccedenze incluse nel
cosiddetto allegato i-quater). In secondo luogo si è
pervenuti, con l’ultima legge finanziaria approvata (legge 244/2007), ad un
tendenziale riequilibrio nel triennio dell’impatto finanziario delle misure
correttive,
presumibilmente soprattutto a causa del ridursi dell’incidenza, sul primo anno,
del fabbisogno per oneri pregressi.
Come detto, è possibile che - nel tempo - l’approvazione di
finanziamenti aggiuntivi contribuisca di per sé al contenimento degli
scostamenti.
Altro fenomeno che sembrerebbe garantire una maggiore
trasparenza delle quantificazioni è l’evidenziazione – contenuta nella legge
finanziaria 244/2007 (a differenza delle precedenti) - di effetti comparabili
sui tre saldi di finanza pubblica e non solo sul saldo del bilancio dello Stato.
- Tale evidenziazione risulta invece assente nella legge
finanziaria 296/2006, che riporta effetti solo sul saldo netto da finanziare:
ciò potrebbe derivare da una differenziazione, fra il bilancio dello Stato e il
conto della PA, dei criteri di costruzione delle previsioni tendenziali (che
per i saldi di fabbisogno e di indebitamento già scontavano le maggiori spese
incluse fra le eccedenze). Si osserva in proposito che l’applicazione di
criteri non omogenei di contabilizzazione riduce necessariamente il grado di
significatività e di confrontabilità delle previsioni di spesa.
Infine, nella legge finanziaria 244/2007 (che, come detto,
ha mostrato un significativo contenimento delle eccedenze in termini quantitativi)
la quota di regolazioni debitorie si è notevolmente ridotta, garantendo
così una maggiore rispondenza delle stime rispetto agli obiettivi di
monitoraggio e di contenimento della spesa.
Si ricorda infatti che nei primi anni di applicazione della
nuova procedura delle eccedenze di spesa, l’iscrizione di significativi importi
a titolo di regolazioni debitorie -
dovuta, tra l’altro, alla necessità di sanare situazioni pregresse di rilevante
ammontare - aveva comportato anche la non evidenza di somme considerevoli nelle
risultanze contabili della manovra finanziaria, sulle quali era destinata ad
incidere la decisione parlamentare . Nelle
leggi finanziarie approvate nel corso della XV legislatura si è invece
registrata – presumibilmente anche in ragione dei precedenti interventi sulle
occorrenze pregresse - una significativa riduzione delle regolazioni debitorie
fra le eccedenze di spesa: conseguentemente le somme sono state incluse quasi
integralmente nei prospetti di copertura degli oneri correnti delle leggi
finanziarie.
Tale riduzione delle regolazioni debitorie è particolarmente
significativa con riferimento ad una voce frequentemente inclusa fra le
eccedenze di spesa e presente anche nella legge finanziaria 244/2007: i
maggiori trasferimenti all’INPS per la copertura di occorrenze pregresse.
Infatti l’importo, pur essendo stato
individuato sulla base del rendiconto
2005 dell’INPS e indicato come regolazione contabile, è stato tuttavia
contabilizzato per intero nel saldo netto da finanziare e sottoposto al vincolo
di copertura degli oneri correnti.
Profili
problematici riscontrati nel corso della
XV legislatura
L’attività di verifica delle quantificazioni in ordine alle
misure correttive delle eccedenze di spesa è finalizzata, da una parte, a
chiarire le cause di ordine legislativo che sono alla base della formazione
delle predette occorrenze e, dall’altra, a identificare eventuali elementi che
rendano necessaria la rettifica delle originarie quantificazioni. In ordine a
tali fattori, si è spesso constatata una carenza di informazione nelle
relazioni tecniche di corredo alle leggi finanziarie.
Ciò premesso, le opzioni di intervento delineate dal decreto
legge 194/2002 in presenza di
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa includono – come in precedenza
ricordato - anche la modifica delle norme sostanziali da cui le eccedenze
derivano. Tale possibilità non è stata tuttavia messa in atto nella XV
legislatura, se non in poche circostanze delle quali si è dato conto nella
parte precedente della presente esposizione.
Nella XV legislatura è stata
confermata la prassi di utilizzare lo strumento delle misure correttive in
legge finanziaria esclusivamente per disporre la copertura di maggiori
occorrenze e non per rimuovere i fattori da cui tali maggiori oneri sono
generati. Ciò è confermato dalla circostanza che una parte delle esigenze di
correzione tende a riproporsi di anno in anno (è il caso delle spese nei
settori della previdenza, dell’assistenza, della giustizia e degli adempimenti
internazionali).
Nel corso della XV legislatura si è inoltre constatato un
ricorso alla procedura di cui alla lettera i-quater) anche per il rifinanziamento di voci originariamente
classificate come limiti di spesa, utilizzo che non appare appropriato alla
luce della disciplina vigente.
Quest’ultima infatti, come in precedenza illustrato, è
finalizzata essenzialmente a mantenere nel tempo la coerenza fra onere e
copertura attraverso meccanismi di intervento volti alla correzione degli
scostamenti. Per le autorizzazioni di spesa sono previste procedure automatiche
di disapplicazione delle norme in via amministrativa nel caso di superamento
delle risorse autorizzate, tenuto conto che tali oneri non sono di natura
obbligatoria e possono quindi essere sottoposti al limite di spesa previsto
dalla legge. Al contrario, per le spese obbligatorie connesse a diritti
soggettivi o ad impegni inderogabili (per esempio gli adempimenti
internazionali) è prevista un’articolata procedura di monitoraggio e di
attivazione delle misure correttive (fra cui le eccedenze di spesa), con la
possibilità di attingere – ove previsto – al Fondo di riserva per le spese
obbligatorie: tale procedura va collegata alla circostanza che queste spese non
possono essere sospese mediante meccanismi automatici.
Il ricorso alle misure correttive delle eccedenze in
presenza di oneri qualificati come limiti massimi di spesa rappresenta una
deroga rispetto ai vincoli sopra descritti, posti a presidio della
corrispondenza, nel tempo, fra oneri e copertura.
-Tale utilizzo della procedura di cui alla lettera i-quater) per il rifinanziamento di voci
originariamente classificate come limiti di spesa si è verificato nell’ambito
della legge finanziaria 296/2006. In particolare, l’allegato contenente
l’elenco delle eccedenze di spesa e la relazione tecnica hanno dato conto di
misure correttive riguardanti agevolazioni tariffarie riconosciute per legge
alle imprese editrici (che lo Stato è tenuto a rifondere ai gestori telefonici
e a Poste Italiane SpA): tali agevolazioni – come enunciato anche dalla RT
- costituiscono limiti di spesa. Lo
stesso Governo aveva in proposito confermato che il ricorso alla procedura
dell’eccedenza di spesa era finalizzato proprio ad evitare l’emanazione del
decreto di accertamento dell’avvenuto raggiungimento del limite di spesa
autorizzato.
Altri casi di eccedenze di spesa occorsi nella XV
legislatura sembrano evidenziare, infine, una certa incoerenza nella prassi
applicativa della disciplina introdotta dal DL 194/2002. Si segnalano, in
particolare le norme previdenziali per il personale degli enti disciolti.
-La legge finanziaria 244/2007 ha previsto il
rifinanziamento, nell’ambito delle eccedenze di spesa, delle norme in materia di ricongiunzione
dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo
di previdenza per il personale degli enti disciolti. La RT affermava che era
necessario procedere ad una prima assegnazione di risorse alle gestioni
previdenziali interessate, al fine di attivare la procedura di estinzione del
debito delle corrispondenti gestioni liquidatorie. In sede di esame
parlamentare, il Governo precisava che l’ammontare complessivo delle operazioni
finanziarie concernenti le norme oggetto di rifinanziamento avrebbe potuto essere
definito solo al termine del negoziato con l’INPS e l’INPDAP: tale difficoltà
di calcolo, d’altra parte, aveva già impedito - in sede di
formulazione della norma originaria - la quantificazione, anche in
via presuntiva, degli oneri relativi ai capitali di copertura. Pertanto,
secondo quanto affermato dal Governo, l’appostazione aggiuntiva di risorse in
esame costituiva un’eccedenza di spesa in rapporto alla previsione dei capitali
di copertura necessari, non quantificati nel 2007 a causa della completa
assenza di informazioni in merito.
In proposito il Servizio Bilancio dello Stato ha segnalato
che non apparivano condivisibili le motivazioni, indicate dal Governo, che
avevano indotto a definire il finanziamento – dal punto di vista contabile –
come eccedenza di spesa, atteso che a tale norma (considerata dal Governo di
carattere essenzialmente procedurale) non erano stati a suo tempo ascritti
effetti finanziari: al contrario, alla disciplina generale in materia di
liquidazione degli enti disciolti erano stati ascritti effetti di risparmio.
Pertanto, in assenza di una specifica base normativa a fondamento degli impegni
e delle obbligazioni genericamente richiamati dalla RT e dalla successiva documentazione
trasmessa dal Governo, il finanziamento in esame avrebbe assunto di fatto la
natura di una nuova autorizzazione di spesa (sostanzialmente qualificata dal
Governo come anticipazione). Qualora, invece, all’attuazione delle norme
interessate dalla procedura di correzione fossero stati ascritti effetti
onerosi in precedenza non previsti, sarebbe stato necessario correggere le
stime iniziali (ossia la previsione di un onere nullo) motivandone le ragioni e
prospettando una ricostruzione, almeno di larga massima, dei possibili effetti
finanziari proiettabili nel decennio.
La
quantificazione degli effetti delle norme sui saldi di fabbisogno e di indebitamento
Come anticipato nel capitolo iniziale del presente dossier,
la quantificazione degli oneri relativi ai nuovi provvedimenti viene
effettuata, di norma, stimando l’impatto sul saldo netto da finanziare, ossia gli effetti, espressi in termini
di competenza giuridica, delle norme introdotte sul bilancio dello
Stato.
Non viene invece sistematicamente fornita anche l’indicazione
degli effetti sul fabbisogno del
settore statale - ossia sul saldo, espresso in termini di cassa,
riferito ad un aggregato più ampio del bilancio dello Stato, in quanto
comprensivo della gestione di tesoreria e dei bilanci delle ex amministrazioni
autonome - nonché sull’indebitamento
netto della p.a., che rappresenta il
saldo rilevante ai fini della procedura europea sui disavanzi eccessivi,
espresso in termini di competenza economica,
secondo il sistema contabile europeo (SEC 95) e riferito all’intero comparto
delle amministrazioni pubbliche, individuate secondo il medesimo sistema di
contabilità.
Un’eccezione è costituita dalle leggi finanziarie e dai
provvedimenti collegati alle manovre annuali di finanza pubblica, che, essendo
finalizzati anche al conseguimento di obiettivi di disavanzo, individuati
secondo le definizioni contabili europei, sono necessariamente corredati di
prospetti che riportano la quantificazione degli effetti finanziari delle norme
in essi contenuti su ciascuno dei tre saldi sopra indicati.
E’ emersa peraltro, nel quadro dell’attività di verifica
delle quantificazioni, l’esigenza - più volte segnalata anche dal Servizio
Bilancio dello Stato – che la quantificazione degli effetti delle disposizioni
anche sui saldi di fabbisogno e di indebitamento sia effettuata non solo nel
corso dell’esame delle manovre (leggi finanziarie e provvedimenti collegati),
ma anche per tutti gli altri provvedimenti adottati nel corso dell’esercizio
finanziario, tenuto conto della necessità di non vanificare gli obiettivi di
finanza pubblica, fissati nell’ambito delle manovre, con i successivi
provvedimenti legislativi adottati in corso d’anno.
Va quindi affermandosi un
indirizzo in base al quale la verifica delle quantificazioni in sede
parlamentare, finalizzata precipuamente al controllo del requisito della copertura
finanziaria (ossia dell’equivalenza tra effetti positivi ed effetti
negativi delle norme rispetto al saldo netto da finanziare), debba considerare
anche la corrispondenza tra effetti di segno opposto prodotti dalle norme sugli
altri saldi di finanza pubblica e, quindi, la complessiva compensatività
di tali effetti anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
della p.a.
Un’ulteriore esigenza
emersa nel corso delle ultime due legislature riguarda la necessaria
trasparenza che – proprio al fine di consentire una esaustiva verifica in
sede parlamentare – deve essere accordata ai criteri in base ai quali
vengono stimati gli effetti delle nuove norme in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto della p.a., nei casi in cui tali conseguenze
finanziarie assumono autonoma evidenza nell’ambito delle relazioni tecniche.
Entrambe le considerazioni hanno trovato conferma, sul
versante governativo, in due importanti atti di indirizzo. Si intende far
riferimento, in primo luogo, alla già citata direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 2004, che ha introdotto la c.d.
“relazione tecnica standard” da allegare
a tutti i provvedimenti che comportano effetti finanziari. Tale modello di
relazione tecnica prevede, tra l’altro, che gli effetti finanziari siano
valutati non solo in termini di saldo netto da finanziare, ma anche ai fini del
fabbisogno e dell’indebitamento e che, qualora vi siano differenze degli effetti
stimati rispetto ai tre aggregati, siano adeguatamente esplicitate le relative
motivazioni.
La necessità della valutazione degli effetti finanziari sui
tre saldi trova riscontro anche nella più recente direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottata nel corso della XV legislatura,
che, richiamando anche la precedente Direttiva del 2004, ha precisato che le
coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire
il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, nonché degli obiettivi
contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di
finanza pubblica.
A tale scopo nella relazione tecnica va dimostrato
l’equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del
bilancio statale, al fabbisogno e all’indebitamento. La direttiva ha quindi
sostanzialmente equiparato gli obblighi di quantificazione riferiti ai tre
diversi saldi di finanza pubblica, facendo emergere con chiarezza la necessità
della trasparenza e, quindi, della verificabilità, dei relativi criteri di
stima.
I predetti indirizzi non hanno peraltro trovato finora
compiuta attuazione. Infatti, per quanto attiene ai profili di
quantificazione, attualmente, le relazioni tecniche riferite a
provvedimenti non inseriti in manovre di finanza pubblica sono in genere
carenti di dati riguardanti l’impatto sui saldi di fabbisogno e di
indebitamento, mentre nei casi (finanziarie e provvedimenti collegati alle
manovre) in cui tali dati sono forniti, non sempre risultano sufficientemente esplicitati
i criteri ed i parametri di quantificazione utilizzati.
Quanto alla possibilità di un’equiparazione degli effetti
delle norme sui diversi saldi anche sotto il profilo dell’obbligo
costituzionale di copertura, nel corso della legislatura conclusa, sono
emersi orientamenti non del tutto univoci.
Si esaminano, nei successivi paragrafi, le principali
questioni emerse, nel corso della XV legislatura, in ordine ai due profili
metodologici sopra enunciati.
Una specifica questione emersa nel corso della legislatura
appena conclusa attiene alla individuazione
di criteri univoci e trasparenti di quantificazione degli effetti delle
norme sui diversi saldi di finanza pubblica. In mancanza di un’esplicitazione,
nelle relazioni tecniche, dei predetti criteri, si possono determinare
situazioni di oggettiva incertezza nell’interpretazione e nella valutazione
delle quantificazioni soprattutto nei casi in cui, a fronte di disposizioni di
contenuto sostanzialmente analogo, sono fornite stime del tutto diverse riguardo
all’impatto previsto sui diversi saldi.
A titolo esemplificativo si possono analizzare i contributi
pluriennali di finanziamento per spese infrastrutturali.
Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo degli
effetti sui tre saldi attribuiti a taluni contributi autorizzati dall’ultima
legge finanziaria:
(milioni di euro)
|
|
SNF
|
Fabbisogno
|
Indebitamento p.a.
|
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2008
|
2009
|
2010
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
Art. 2, legge
finanziaria 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAGGIORI SPESE
C/CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marche e Umbria (comma 107) : tre contributi per 15
ann, decorrenti da 2008-2009-2010
|
5,0
|
10,0
|
15,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
Sisma Basilicata (comma 115): contributo per 10
anni da 2008
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
Legge obiettivo (comma 257): contributi per 15 anni
decorrenti da 2008-2009-2010
|
99,6
|
199,2
|
298,8
|
50,0
|
200,0
|
400,0
|
50,0
|
200,0
|
400,0
|
|
Giochi Mediterraneo (comma 263): contributo per 14
anni da 2009
|
(0,4)
|
0,7
|
0,7
|
(0,4)
|
2,0
|
3,0
|
(0,4)
|
2,0
|
3,0
|
|
Campionati del mondo di nuoto Roma (comma 271):
contributo per 14 anni da 2008
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
1,0
|
2,0
|
0,4
|
1,0
|
2,0
|
|
Mondiali ciclismo (comma 272): contributo per 15
anni da 2008
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
5,0
|
8,0
|
2,0
|
5,0
|
8,0
|
|
Interventi per Venezia (comma 291): contributo per
15 anni da 2008
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La differenza che emerge nella tabella, fra gli effetti
quantificati in termini di SNF e quelli imputati agli altri due saldi, discende
dal fatto che il primo importo indica la spesa a carico del bilancio dello
Stato autorizzata annualmente per l’attivazione di mutui finanziari, mentre gli
altri due saldi indicano, di norma, l’effettivo utilizzo dei mutui per la
realizzazione di interventi in conto capitale. Il rapporto tra l’utilizzo
effettivo delle somme (importo iscritto ai fini del fabbisogno e
dell’indebitamento netto nei diversi esercizi) e l’ammontare complessivo del
mutuo attivabile è quindi indicativo
della tempistica con la quale si prevede di spendere effettivamente le suddette
somme.
Come emerge dai dati sopra esposti, la tempistica per
l’attivazione dei mutui varia con una certa ampiezza. Nel caso degli interventi
connessi ad eventi sismici, l’attivazione integrale coincide con l’annualità in
cui è previsto l’inizio del finanziamento (Umbria e Marche) o con quella
successiva (Basilicata). Nel caso degli impianti sportivi, per l’attivazione
integrale sembrerebbe necessario circa un triennio. In relazione alla “legge
obiettivo” l’attivazione complessiva nel primo triennio sembra essere inferiore
ad un quarto di quanto complessivamente attivabile.
Una considerazione a parte merita il caso degli interventi
per Venezia. La norma autorizza un contributo quindicennale di 4 milioni di
euro, a decorrere dal 2008. Gli importi iscritti ai fini dei saldi di
fabbisogno e indebitamento netto sembrano indicare che il contributo in esame
non sia utilizzabile per l’attivazione di un mutuo per il finanziamento delle
opere relative alla salvaguardia di Venezia, bensì esclusivamente in forma
diretta, per l’effettuazione di spese in conto capitale nella misura di 4
milioni annui. Ciò in quanto una disposizione della legge finanziaria per il
2007 - illustrata più
diffusamente, di seguito, nel presente paragrafo - prevede che l’attivazione di
mutui derivanti da contributi pluriennali a carico di enti della p.a. sia
sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, che è tenuto a negare l’autorizzazione stessa
nel caso in cui si accerti che la stessa determini effetti negativi, ai fini
del saldo dell’indebitamento netto, non contabilizzati e non coperti.
Pertanto, nel caso in esame, poiché la quantificazione
dell’incidenza annua sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, riportata nel
prospetto riepilogativo degli effetti della legge finanziaria 2008 (allegato
7), non tiene conto della spesa rapportata all’effettivo utilizzo del mutuo
attivabile con il contributo (corrispondente all’incirca all’importo
attualizzato del contributo stesso) non sembrerebbe possibile tale attivazione
a valere sulle somme stanziate dalla norma in questione.
Dalle considerazioni
finora svolte si deduce che le modalità effettive per l’utilizzazione di
contributi pluriennali, autorizzati mediante disposizioni dal contenuto
apparentemente analogo, possono variare notevolmente in relazione all’impatto
stimato in termini di fabbisogno e di indebitamento e, quindi, determinare
valutazioni differenti per quanto attiene all’entità delle misure compensative
da adottare al fine di evitare un peggioramento dei saldi di fabbisogno e di
indebitamento.
Si possono pertanto verificare difficoltà nell’interpretare
la portata di disposizioni normative i cui riflessi in termini di effettivo
incremento della spesa in conto capitale (calcolata ai fini dei predetti saldi)
potrebbero non essere pienamente conosciuti al momento dell’approvazione di
nuove discipline o di modifiche alle normative già esistenti.
Va inoltre considerato il notevole rilievo che tali
tematiche presentano per la valutazione della compensatività di proposte
emendative presentate nel corso dell’esame parlamentare dei provvedimenti; la
questione assume aspetti di particolare importanza per gli emendamenti riferiti
ai disegni di legge finanziaria ed ai provvedimenti ad essi collegati, che sono
soggetti ad un vaglio di ammissibilità, sotto il profilo della compensazione,
il cui esito condiziona la stessa possibilità di esame e di messa in votazione
delle proposte emendative.
Infatti, emendamenti volti a sostituire spese già previste nel
disegno di legge finanziaria con altre di importo equivalente, ma destinate a
differenti finalità, potrebbero non risultare perfettamente compensati rispetto
ai saldi di fabbisogno e di indebitamento e, quindi, essere ritenuti
inammissibili, nel caso in cui la destinazione delle somme alle nuove finalità
determini, ad esempio, un profilo di cassa più sostenuto rispetto alla finalità
iniziale e, quindi, un impatto più rilevante sui saldi di fabbisogno e di
indebitamento.
Il Servizio Bilancio dello
Stato ha sempre richiesto che fossero chiaramente esplicitati i criteri di
stima utilizzati per definire l’impatto di nuove disposizioni sui saldi di
fabbisogno e di indebitamento. Tale esigenza assume particolare rilievo al fine
di :
- consentire una verifica
dei predetti criteri di quantificazione nel corso dell’esame parlamentare
dei progetti di legge ai quali si riferiscono;
- applicare i medesimi
parametri alle proposte emendative presentate nel corso dell’esame degli
stessi progetti;
- assicurare la coerenza,
nel tempo, dei criteri di quantificazione utilizzati in occasione
dell’introduzione di norme riferite a fattispecie analoghe o, in una certa
misura, assimilabili.
I criteri sottostanti le predette stime possono variare infatti notevolmente in relazione alle diverse
tipologie di spese di volta in volta considerate.
Si è già fatto cenno alle disposizioni della legge
finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512) che disciplinano
una procedura autorizzatoria per l’erogazione dei contributi pluriennali. Le
disposizioni citate subordinano l’utilizzo di tali contributi – finalizzati ad
operazioni finanziarie con onere di ammortamento a totale carico dello Stato –
alla previa verifica, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, della mancanza di effetti negativi in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Laddove tali effetti siano
riscontrati, si rende necessaria la quantificazione dell’importo
attualizzato del contributo e la compensazione del medesimo a valere su un
apposito Fondo. In mancanza di disponibilità del Fondo, l’utilizzo dei
contributi non potrebbe essere autorizzato.
Pertanto, in base alla norma citata, in molti casi la
garanzia dell’utilizzo dei contributi, sia pur autorizzati con norma
legislativa, è condizionata alla sussistenza di un’adeguata compensazione – in
termini di fabbisogno e di indebitamento – commisurata in linea di massima all’importo
attualizzato dei contributi stessi.
Come si evince da un’apposita circolare,
fanno eccezione alcune fattispecie, tra cui anche quelle i cui effetti
finanziari risultano già considerati negli andamenti tendenziali, ossia nei
flussi di entrata e di spesa previsti in base alla vigente legislazione e
che non necessitano quindi di specifica copertura in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto.
Va peraltro considerato
che - sia per la mancanza di note tecniche esplicative riferite alle modalità
di costruzione degli andamenti tendenziali a legislazione vigente sia per la
mancata indicazione, nelle relazioni tecniche riferite a singole iniziative
legislative, delle ragioni in base alle quali determinate spese possano
considerarsi già ricomprese nei predetti andamenti - si determina spesso
un’oggettiva incertezza in merito alla valutazione dell’effettiva portata di
specifiche disposizioni sui tre diversi saldi di finanza pubblica. La questione
assume peculiare rilievo allorquando si tratta di verificare l’idoneità di
specifiche norme di copertura a fornire adeguata compensazione a determinate
spese, il cui impatto sui saldi della p.a. può variare in relazione a
circostanze, che non sempre appaiono di immediata evidenza.
A tali difficoltà vanno ad aggiungersi quelle derivanti dal
fatto che spesso non risultano adeguatamente evidenziate, nell’ambito delle
relazioni tecniche, le modalità con le quali, anche mediante il ricorso a
convenzioni contabili, vengono adattate alle singole fattispecie le regole del
sistema contabile europeo (SEC 95), regole alla stregua delle quali va valutato
l’impatto delle singole disposizioni sul saldo di indebitamento netto della
p.a.
Le regole del sistema SEC 95 –
basate sul cosiddetto criterio della “competenza economica” - sono riportate in
specifici regolamenti europei ed i relativi profili applicativi sono in parte
definiti in apposito “Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico”. Peraltro
l’adeguamento delle regole europee alle specificità insite nelle diverse
normative presuppone l’adozione di criteri, anche convenzionali, finalizzati ad
ottenere un’approssimazione
il più possibile soddisfacente al criterio della contabilità economica. Tali
principi e convenzioni – in base ai quali vengono quantificati gli effetti
delle nuove disposizioni rispetto al saldo di indebitamento netto – non sempre
emergono con chiarezza dalle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti.
Il Servizio Bilancio dello Stato, nella documentazione
predisposta per l’esame delle iniziative legislative sottoposte al parere della
Commissione Bilancio - in particolar modo di quelle presentate nel quadro delle
manovre di finanza pubblica – ha quindi più volte segnalato la necessità che,
nella fase della verifica parlamentare delle quantificazioni, sia attribuita adeguata evidenza ai criteri
utilizzati per stimare gli effetti delle norme sui diversi saldi, con
particolare riguardo al saldo di indebitamento netto della p.a.
L’esplicitazione dei
predetti criteri consentirebbe infatti il consolidamento - attraverso
l’interlocuzione tra i diversi soggetti interessati – di principi comuni e di metodologie di
analisi condivise, sul modello di quanto accaduto nell’ambito dell’attività di
quantificazione degli effetti delle norme sul saldo netto da finanziare, ai
fini del controllo della copertura finanziaria delle norme.
- Casi emblematici di entrambe le problematiche sopra
evidenziate sono le stime finanziarie riferite ai commi da 179 a 181 dell’art.
2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), che hanno previsto
contributi quindicennali ed una spesa pluriennale per programmi, ad alto
contenuto tecnologico, nel settore della difesa. Nel corso dell’esame di
tali disposizioni sono infatti emerse, da un lato, la necessità di acquisire
elementi di valutazione ulteriori, rispetto a quelli riportati nella RT, alla
base delle differenze riscontrate nella definizione degli effetti delle
disposizioni sui tre diversi saldi di finanza pubblica, dall’altro, l’esigenza
di una più puntuale definizione dei criteri che, in applicazione del SEC 95 e
delle decisioni di Eurostat, avevano portato a stimare in una certa misura
l’impatto delle disposizioni sul saldo di indebitamento netto della p.a.
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica
venivano così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo, allegato alla RT
(Allegato 7):
(milioni di euro)
|
|
SNF
|
Fabbisogno
|
Indebitamento p.a.
|
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2008
|
2009
|
2010
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
Art. 2 legge
finanziaria 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPESE
C/CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
comma 179
(contributi per 15 anni)
|
20
|
45
|
70
|
24
|
110
|
210
|
0
|
0
|
0
|
|
Comma 180
(spesa pluriennale)
|
318
|
468
|
918
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Comma 181
(contributi per 15 anni)
|
20
|
45
|
70
|
60
|
25
|
62
|
0
|
0
|
27
|
In merito ai criteri sottostanti la quantificazione dei
predetti effetti, la RT richiamava essenzialmente, per quanto attiene al
fabbisogno, il parametro quantitativo rapportato ai previsti “tiraggi” di
tesoreria rispetto all’importo (netto ricavo dei mutui) ottenuto con
l’operazione finanziata mediante i contributi pluriennali. Per quanto
riguarda l’indebitamento, si faceva invece riferimento ai criteri stabiliti
da Eurostat per il trattamento contabile delle spese militari e alla
circostanza che, per talune spese, l’impatto stimato era considerato nullo
perché le spese in questione erano state già incluse nelle stime tendenziali
di spesa a legislazione vigente e non necessitavano quindi, su tale versante,
di un’apposita compensazione.
Nella nota di verifica predisposta, il Servizio Bilancio
dello Stato ha peraltro rilevato che la mera enunciazione dei predetti criteri
non appariva sufficiente ai fini di una ricostruzione del procedimento di
quantificazione che aveva condotto all’elaborazione delle stime.
In particolare, con riguardo alle stime di impatto sul
deficit, veniva osservato che la stessa decisione di Eurostat, concernente i
criteri di contabilizzazione delle spese militari, adottata il 9 marzo 2006,
fissava taluni principi metodologici per la registrazione della spesa sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche per forniture della difesa, diversificandoli in
ragione della tipologia di contratto nonché dei prodotti e dei servizi
acquisiti. Ai fini della verifica delle stime indicate, risultava quindi
necessario disporre anche dei dati e dei parametri in base ai quali, in
attuazione dei predetti criteri, si era concretamente pervenuti al calcolo
degli specifici effetti imputati alle norme.
Le medesime considerazioni venivano svolte con riguardo alla
verifica delle stime degli effetti di cassa.
In risposta a tali rilievi, una nota del Ministero
dell’economia e delle finanze, del 26 ottobre 2007, ha chiarito, tra l’altro,
che:
·
riguardo ai commi 179 e 181, l’impatto sugli
andamenti di finanza pubblica, relativamente al deficit erano stati calcolati
facendo riferimento alle effettive consegne dei beni e dei servizi
oggetto dei contratti stipulati, sulla base dei criteri stabiliti nella
decisione di Eurostat;
·
riguardo al comma 180, nella nota si è ribadito
che la quantificazione del predetto deficit era stata effettuata sulla base
della data di effettiva consegna o disponibilità operativa del bene;
veniva evidenziato inoltre che, per quanto concerne il programma Eurofighter,
esso era già stato considerato nelle linee tendenziali della finanza pubblica
recepita dal DPEF 2007-2008: per tale ragione, l’impatto stimato sul saldo di
indebitamento risultava nullo.
Va considerato che, nei
casi in cui si ravvisi un’incertezza circa i criteri sottostanti la
quantificazione degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento di specifici
stanziamenti, più difficile appare la valutazione dell’idoneità dell’utilizzo
delle stesse risorse per il finanziamento di nuove finalità di spesa (secondo
quanto avviene nel caso di riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa per
il finanziamento di nuovi interventi). In tali ipotesi, infatti, non sempre
risulta agevole individuare l’effettiva portata di tale modalità di copertura
ai fini dei tre diversi saldi.
Specifici profili problematici,
relativi alla quantificazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di
indebitamento, sono poi emersi con riguardo alle norme che, in deroga alla
disciplina generale in materia di contabilità, hanno consentito il mantenimento
di somme in bilancio ed il loro utilizzo in esercizi successivi alla scadenza
dei termini ordinari. Tali aspetti sono esaminati più in dettaglio nel successivo
capitolo - al quale si rinvia - riferito al mantenimento di somme in bilancio e
alla riassegnazione delle stesse alla spesa, contenuto sempre in questa prima
parte del dossier.
Un’autonoma considerazione ha assunto, soprattutto nel corso
delle ultime due legislature, la questione riferita alla possibilità di
equiparare i tre saldi di finanza pubblica con riguardo non solo alle
esigenze di quantificazione, ma anche al profilo dell’obbligo di copertura.
La problematica affrontata ha riguardato, tra l’altro, la
possibilità o meno di prevedere coperture
suscettibili di produrre effetti compensativi esclusivamente sul saldo netto da
finanziare e non anche sugli altri saldi.
In alcuni casi, la
mancata individuazione di una specifica compensazione degli effetti su
fabbisogno e indebitamento netto della p.a. è stata espressamente giustificata
dalla previsione di un più favorevole andamento dei saldi di finanza
pubblica, rispetto a quelli precedentemente stimati, tale quindi da “riassorbire”
gli effetti peggiorativi delle nuove norme, sprovvisti di adeguata
compensazione, senza compromettere il conseguimento degli obiettivi
programmati. La tematica si intreccia, in questo caso, con le questioni
inerenti all’utilizzo dell’extra-gettito (c.d. “copertura su tendenziale”),
oggetto di uno specifico paragrafo all’interno del presente dossier, cui si
rinvia per considerazioni ed elementi di carattere integrativo.
-Si segnala, in particolare, la norma del decreto –legge
“mille proroghe”, concernente la
soppressione dell’obbligo per gli agenti della riscossione di versare
un’anticipazione sulle riscossioni erariali, che ha determinato, sulla base
delle stime riportate nella relazione tecnica iniziale, un effetto di
peggioramento dell’indebitamento netto per circa 4,6 miliardi di euro
relativamente all’anno 2007. Dall’allegato conoscitivo degli effetti finanziari
risultava che la minore entrata era compensata solo con riferimento al saldo
netto da finanziare, mentre sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto
veniva riportato un effetto complessivo di peggioramento pari all’onere in
questione. Dalla relazione tecnica emergeva tuttavia che i riflessi negativi su
detti saldi sarebbero stati riassorbiti nell’ambito del quadro di finanza
pubblica per l’anno 2007, senza compromettere il rispetto degli obiettivi
programmati per l’anno medesimo nell’ambito del patto di stabilità e crescita.
Il Servizio Bilancio della Camera ha evidenziato come, in
mancanza di dati di preconsuntivo sull’esercizio 2007, il supposto
riassorbimento dei maggiori oneri, recati dalla soppressione dell’obbligo di
versamento in acconto, per effetto di un miglioramento del saldo tendenziale
per il 2007 dovesse essere suffragato da indicazioni di maggior dettaglio,
atte a confermare un complessivo andamento dei conti di finanza pubblica tale
da offrire adeguata compensazione agli effetti peggiorativi ascritti alla
predetta norma.
Al Senato, nel parere espresso sul provvedimento dalla
Commissione Bilancio[142],
è stato evidenziato come una previsione di più favorevole andamento dei saldi,
avulsa da un contesto di revisione complessiva del quadro macroeconomico e di
finanza pubblica, non sembrasse in grado di fornire una garanzia di adeguata
tutela degli obiettivi di saldo complessivo della p.a.
In altre circostanze, pur
in presenza di quantificazioni che evidenziavano effetti di peggioramento dei
saldi di fabbisogno e di indebitamento, prodotti da proposte normative
all’esame del Parlamento, si è ritenuto che la mancata adozione di specifiche
misure di compensazione, benché costituisse un elemento essenziale nell’analisi
dell’impatto finanziario delle norme esaminate, non incidesse sui profili
relativi all’obbligo di copertura finanziaria in senso stretto.
-
Un primo caso riguarda la norma, introdotta, con
emendamento approvato presso il Senato, nel disegno di legge finanziaria 2008,
che ha disposto, limitatamente al 2008, l’abolizione della quota di
partecipazione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per
gli assistiti non esentati. A tale fine, il livello
del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è stato incrementato per l’anno
2008 per un importo pari alle minori entrate stimate (pari a circa 834 milioni
di euro). A parziale copertura degli oneri derivanti dall’abolizione dei
ticket, è stata disposta una riduzione, per un importo di 326 milioni di euro
per l’anno 2008, della dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie. La relazione tecnica precisava che l’utilizzo
delle risorse del Fondo poteva ritenersi idoneo ad incidere sul saldo netto da
finanziare per l’intero importo degli oneri da coprire, mentre, ai fini delle
compensazioni degli effetti delle disposizioni onerose sul saldo di indebitamento
netto, la copertura utilizzata poteva essere contabilizzata nella misura di circa
il 50 per cento. Ciò in quanto la dinamica delle erogazioni a carico del fondo
- e, quindi, il profilo considerato per la stima del “peso” delle relative
risorse sul saldo di indebitamento – teneva conto del tempo, intercorrente tra
il momento dell’impegno contabile e quello dell’effettiva erogazione dei fondi,
necessario per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.
-
Un altro caso di particolare rilevanza è emerso
nel corso dell’esame parlamentare del già citato D.L. n. 248/2007 (cosiddetto “decreto
mille proroghe”). Si è già detto che il provvedimento reca una disposizione
(art. 36) i cui effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento sono stati
ritenuti, in base alla RT, sono stati considerati “riassorbiti” a valere sul
più favorevole andamento, rispetto alle previsioni, del quadro di finanza
pubblica per l’esercizio 2007.
Nel corso dell’esame del
provvedimento presso il Senato è stato peraltro consegnato dal Governo un
prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sui tre diversi saldi,
che, alla luce delle modifiche apportate dalla Camera, evidenziava un
complessivo squilibrio degli effetti del provvedimento rispetto ai saldi di
fabbisogno e di indebitamento anche per l’esercizio 2008, per un importo di
931 mln.
La Commissione Bilancio del
Senato, a conclusione dell’esame, ha espresso parere contrario sul provvedimento
nel suo complesso, non motivandolo tuttavia con riferimento al rispetto
dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.
La Commissione Bilancio
del Senato, nel parere espresso sul decreto-legge, ha in primo luogo ribadito
“l’opportunità che nella valutazione della copertura delle singole leggi di
spesa sia assicurata la compensazione anche degli effetti in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto della p.a., in quanto si può ritenere
che l’attuale sistema di regole (anche conformemente a quanto indicato nella
Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006) non consenta di
prescindere dalla valutazione e dalla compensazione di tali effetti”. Tuttavia,
poiché la pronuncia di contrarietà sul provvedimento non è stata espressamente
motivata con riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., deve desumersi
che il profilo di carenza di compensazione sui predetti saldi non sia stato
ritenuto suscettibile di incidere sulla valutazione relativa alla sussistenza
del requisito della copertura finanziaria in senso stretto.
Il
mantenimento in bilancio e la riassegnazione alla spesa di somme non utilizzate
Nel corso della XV legislatura sono state frequentemente
prese in esame dal Parlamento norme volte a consentire, in deroga alla
disciplina generale di contabilità, il riutilizzo di risorse finanziarie
risultate disponibili alla conclusione dell’esercizio di competenza, in quanto
non utilizzate entro i termini originariamente previsti. A tal fine queste
risorse, altrimenti destinate ad andare in economia, sono state mantenute in
bilancio, in conto residui, ovvero riversate all’entrata di esercizi successivi
per la riassegnazione a capitoli di spesa (per scopi analoghi o difformi da
quelli originari).
Tale fenomeno, collegato essenzialmente ai tempi di impegno
e di erogazione delle risorse iscritte in bilancio, tende impropriamente a
tradursi in una forma di copertura finanziaria (aggiuntiva rispetto a quelle
previste dalla disciplina contabile) e presenta una serie di profili
problematici che sono stati evidenziati sia nel corso dell’esame delle norme
presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato sia dalla Corte dei conti,
nell’ambito delle sue relazioni al Parlamento sulle tipologie di coperture
adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
In particolare la Corte dei conti ha ripetutamente eccepito, per un verso, il
mancato rispetto del principio di annualità di bilancio, per altro verso la
mancata compensazione degli effetti delle predette disposizioni derogatorie in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto della p.a. In taluni casi,
inoltre, la Corte ha eccepito anche la dequalificazione della spesa, nei casi
di nuova finalizzazione a spese di parte corrente, di risorse originariamente
classificate come di conto capitale.
La vigente disciplina contabile, sulla base della quale
vengono costruite di anno in anno le previsioni del bilancio dello Stato,
prevede termini differenziati di mantenimento in bilancio delle somme non
utilizzate, a seconda della fattispecie di spesa considerata: a) spese correnti
non impegnate e non erogate; b) spese correnti impegnate, ma non erogate; c)
spese in conto capitale non impegnate e non erogate; d) spese in conto capitale
impegnate, ma non erogate.
I termini generalmente applicati sono i seguenti:
a) le
somme relative a spese correnti non impegnate e non erogate nell’esercizio
finanziario di competenza non costituiscono residui passivi: infatti, di norma
non è consentito il loro mantenimento in bilancio, in quanto trova applicazione
il principio di cui all’articolo 20 della legge n. 468/1978 che ne esclude l’impegno
nell’esercizio successivo;
b) le
somme relative a spese correnti impegnate, ma non erogate, costituiscono residui propri e possono essere
mantenute in bilancio per un periodo di due anni, esteso a tre anni qualora si
tratti di residui concernenti spese per lavori, forniture e servizi; successivamente
interviene la perenzione amministrativa;
c) le
somme relative a spese in conto capitale non impegnate e non erogate possono essere
conservate in bilancio come residui (residui
di stanziamento) per un solo anno, ad eccezione degli stanziamenti iscritti
in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio finanziario, per i quali il periodo di conservazione previsto è di
due anni;
d) per
le spese in conto capitale che risultano impegnate, ma non erogate, è previsto
il mantenimento in bilancio dei relativi residui per tre esercizi successivi a
quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento.
Lo schema di massima
ricavabile dai predetti termini è riportato sinteticamente nella tabella che
segue (“+” = finanziamento iscritto in conto competenza o in conto residui; “-” = finanziamento non più iscritto né in conto
competenza né in conto residui).
|
|
|
somme
|
anno
di iscrizione dello stanziamento
(T)
|
T+1
|
T+2
|
T+3
|
T+4
|
|
SPESA CORRENTE
|
A
|
Non impegnate e non erogate(*)
|
+
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
B
|
Impegnate ma non erogate(*)
|
+
|
+
|
+
|
-/+(**)
|
-
|
|
SPESA
C. CAPIT.
|
C
|
Non impegnate e non erogate(*)
|
+
|
+
|
-/+(***)
|
-
|
-
|
|
D
|
Non impegnate e non erogate(*)
|
+
|
+
|
+
|
+
|
-
|
(*) Entro l’esercizio nel quale è iscritto lo stanziamento.
(**) Possono essere mantenute in conto residui
fino a tre esercizi dopo l’iscrizione dello stanziamento solo le spese per
lavori forniture e servizi.
(***) Possono essere mantenute in conto residui
fino a due esercizi dopo l’iscrizione dello stanziamento solo le spese iscritte
in bilancio sulla base di norme di legge entrate in vigore nell’ultimo
quadrimestre dell’anno T-1.
La vigente normativa prevede peraltro deroghe ed eccezioni
ai predetti termini, sia di portata generale (stabilite dalla stessa disciplina
contabile) sia di portata specifica (in quanto riferite soltanto a talune
tipologie di spesa).
Nella prima categoria rientrano le eccezioni previste
dalle stesse norme di contabilità: riassegnazioni alla spesa di somme versate
all’entrata nell’ultimo bimestre dell’anno precedente;
iscrizione in bilancio delle quote dei fondi speciali relative ad esercizi
precedenti per la copertura di nuove leggi di spesa; assegnazione della
cassa necessaria al pagamento dei titoli rimasti inestinti alla chiusura
dell’esercizio e trasportati all’esercizio successivo.
Nella seconda categoria rientrano determinate
tipologie di interventi finanziari per i quali è stata disposta, con legge, una
disciplina che diverge, “in via permanente” o per determinate categorie di
operazioni, rispetto alla disciplina generale. E’ il caso – per esempio –
dell’articolo 15, comma 9, della legge 49/1987()che,
per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, prevede in via generale che
le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possano essere impegnate
nell’esercizio successivo. Tale normativa è stata
applicata anche agli interventi di cooperazione e sviluppo previsti all’interno
di provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie
e internazionali: ad esempio, l’articolo
1, comma 1, del DL 8/2008(),
nell’autorizzare per l’anno 2008 la spesa di 94 milioni di euro per interventi
di cooperazione, ha disposto che le somme non impegnate nell'esercizio di
competenza possano essere impegnate nell'esercizio successivo.
Poiché, come detto, le norme richiamate incidono sui criteri
per la costruzione delle previsioni a legislazione vigente, la deroga ai predetti
termini può influire sulla dinamica delle spese, determinando un impatto
finanziario pari all’entità delle risorse che si decide di riutilizzare negli
esercizi successivi.
Per valutare i possibili effetti del mantenimento di somme
in bilancio e della riassegnazione alla spesa occorre considerare i tre saldi
di finanza pubblica.
In linea di massima il rinvio di una spesa da un esercizio a
quello successivo può risultare neutrale con riferimento al saldo netto da
finanziare.
Ciò si determina, nel caso di mero mantenimento di residui
in bilancio, in quanto i relativi effetti vanno da incidere essenzialmente sul conto
residui, e, nel caso di riversamento all’entrata e successiva riassegnazione
alla spesa, per la compensazione che si determina tra effetto di entrata (riversamento dall’anno
precedente) ed effetto di spesa (nuovo utilizzo).
Tale neutralità può, invece, non verificarsi con riferimento
ai saldi relativi al più ampio perimetro della pubblica amministrazione (e
quindi ai saldi di fabbisogno e di indebitamento).
Infatti, la somma trasportata da un anno all’altro,
provenendo dal bilancio dello Stato, non costituisce un’entrata aggiuntiva per
il comparto della p.a., ma
la spesa che ne deriva è suscettibile di incrementare gli esborsi complessivi
del medesimo settore, effettuati nel nuovo esercizio verso altri settori.
Per valutare gli effetti finanziari della riassegnazione o
del mantenimento di somme in bilancio occorre, inoltre, conoscere la fase in
cui tali decisioni intervengono (sussistenza o meno dell’impegno di spesa;
tempistica di acquisizione delle entrate).
A. In
particolare, dal lato della spesa, nel caso delle somme non ancora impegnate,
il prolungamento del termine per il mantenimento in bilancio può consentire di
impiegare risorse che sarebbero altrimenti andate in economia.
Tale prolungamento è suscettibile, quindi,
di determinare un impatto sia sotto il profilo degli impegni adottati in corso
di esercizio (competenza giuridica) sia sul versante della cassa
(in quanto l’esborso graverebbe, in aumento, sull’esercizio di effettiva
erogazione, incrementando gli effetti di cassa per tale esercizio rispetto a
quelli incorporati nelle previsioni tendenziali). In particolare, sul versante
della spesa di cassa, andrebbe considerato l’effetto corrispondente all’importo
delle erogazioni e la connessa spesa corrispondente al costo della relativa provvista
finanziaria (spesa per interessi).
Di conseguenza, un’estensione dei termini
di utilizzo di somme non impegnate è suscettibile di determinare effetti
finanziari sia sul saldo di fabbisogno sia sull’indebitamento netto tenuto
conto che, per conseguire una soddisfacente approssimazione al criterio della
competenza economica – in base al quale viene computato il saldo di indebitamento
- si fa ricorso, con opportuni
adattamenti, al dato riferito alla competenza giuridica o a quello di cassa,
entrambi interessati dal rinvio dei termini per l’impegno delle somme.
B. Nel caso,
invece, delle somme impegnate ma non spese, occorre distinguere fra la
spesa corrente e la spesa in conto capitale.
·
Per la spesa corrente, il prolungamento dei
termini ordinari non incide sulla sussistenza dell’obbligazione in capo alla
pubblica amministrazione (in quanto il titolo giuridico dell’intervento da
finanziare risulta ormai acquisito in base alla norma di legge e al conseguente
atto di impegno). Tale prolungamento può tuttavia determinare una diversa
distribuzione della spesa per i successivi esercizi finanziari. In altre
parole, il prolungamento non modifica gli effetti giuridici dell’originario
impegno di spesa, ma può incrementare la distribuzione tra i diversi esercizi
delle erogazioni di cassa.
Di conseguenza, per le somme di
spesa corrente già impegnate, un’estensione dei termini di utilizzo dovrebbe
essere accompagnata - al fine di evitare un impatto finanziario negativo - da
una compensazione degli effetti finanziari per il saldo di fabbisogno e,
per quelle spese per le quali il criterio di cassa sia ritenuto più congruo ad
approssimare l’impatto in termini di competenza economica, anche ai fini del
saldo di indebitamento netto della p.a.
·
Per la parte in conto capitale, anche se il titolo
giuridico della spesa risulta ormai acquisito (in base alla norma di legge e
all’atto di impegno), il rinvio delle somme a successivi esercizi finanziari
determinerà comunque un impatto, oltre che sul fabbisogno, sull’indebitamento
netto, in quanto - in base ai criteri che, sulla scorta dei principi contabili
europei, presiedono al calcolo di tale parametro – la contabilizzazione delle
spese in conto capitale ai fini del conto economico della p.a. è effettuata
prevalentemente tenendo conto del momento di effettivo esborso delle somme
(criterio di cassa).
Conseguentemente, per
le somme in conto capitale già impegnate, l’estensione dei termini di utilizzo
dovrebbe essere accompagnata da una
compensazione degli effetti finanziari per ambedue i saldi di fabbisogno e di
indebitamento netto.
L’esigenza di compensare gli effetti in termini di
fabbisogno e di indebitamento va poi sempre considerata anche alla luce delle
disposizioni della legge finanziaria per il 2006, con la quale è stata
introdotta una norma che ha posto un limite alla riassegnazione in bilancio di
entrate destinate alle singole amministrazioni, collegando a tale limite
significativi risparmi di spesa.
Si tratta dell’articolo 1, comma 46, della legge
266/2005. La norma ha stabilito che, con decorrenza dal 2006, le riassegnazioni
di entrate destinate alle singole amministrazioni non avrebbero dovuto superare
l'ammontare di quelle effettuate nel 2005. Alla disposizione sono stati
ascritti effetti di risparmio sui saldi di fabbisogno e indebitamento, con
importi crescenti nel triennio dal 2006 al 2008, anno a decorrere dal quale si
determina l’effetto “a regime”.
Tenuto conto di questa restrizione ulteriore dei margini di
riutilizzo delle somme disponibili provenienti da precedenti esercizi, in caso
di riassegnazione di somme si dovrebbe quindi sempre tener conto del possibile
impatto peggiorativo rispetto agli andamenti generali di spesa, in
considerazione dell’effetto di risparmio ascritto alla disciplina restrittiva
in materia di riassegnazioni, sopra illustrata (infatti i tendenziali di spesa
incorporano - a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 46 –
effetti di risparmio suscettibili di essere ridotti nei casi di deroga, non
prevista dalla norma originaria, all’applicazione dei limiti ivi stabiliti).
-In determinate condizioni, peraltro, tale compensazione può
essere considerata non necessaria. Ciò vale per esempio per l’articolo 10 del
DL 253/2006 (Partecipazione italiana alla missione internazionale in Libano),
in quanto l’esclusione – ivi prevista -
dei rimborsi ONU dal limite alla
riassegnazione delle entrate stabilito dalla legge 266/2005 non appare
suscettibile di ridurre i risparmi ascritti al predetto limite: infatti non
sembra presumibile che, nella quantificazione di tali risparmi, siano state
ricomprese anche le entrate derivanti dai rimborsi ONU.
Le considerazioni finora svolte trovano un’indiretta
conferma negli effetti ascritti dalla relazione tecnica alle modifiche alla
normativa sui residui apportate nella XV legislatura, in particolare
dalla legge finanziaria 2008: l’articolo 3, comma 36, della legge 244/2007 ha
infatti ridotto da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui in
conto capitale, relativi a somme impegnate e non erogate.
Detta modifica, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, comporta
l’eliminazione di un ammontare di residui passivi tale da determinare un
effetto positivo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, stimato in
1.530 milioni nel 2008, 1.340 milioni nel 2009 e 1.310 milioni nel 2010.
La medesima norma ha inoltre definito una articolata
procedura di valutazione e di monitoraggio dei residui di parte capitale,
finalizzata alla loro eliminazione (con conseguente riversamento delle somme
all’entrata del bilancio dello Stato).
L’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 36, della legge n. 244/2007 conferma – pertanto – la necessità
che, in via generale, ciascuna deroga tendente a prolungare il mantenimento in
bilancio delle somme in conto capitale già impegnate sia accompagnata da
un’apposita compensazione (come sopra indicato) degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento.
Nonostante i criteri sopra enunciati, nella legislatura
appena conclusasi, così come nelle precedenti, l’estensione dei termini di
utilizzo di somme originariamente destinate all’impiego in precedenti esercizi
ha fatto emergere, in sede di esame parlamentare, alcuni profili critici
connessi alle questioni prima descritte.
Si tratta, in particolare, delle seguenti problematiche:
a)
possibile attenuazione del principio di
annualità del bilancio, con conseguenti effetti di ridotta significatività
delle risultanze della gestione riferita ai singoli esercizi.
- Tale aspetto è stato più volte
rilevato, in primo luogo dalla Corte dei conti nelle sue Relazioni
quadrimestrali sulle coperture e sulle quantificazioni degli oneri relative
alle leggi approvate. Il Servizio Bilancio ha
evidenziato tale problematica, per esempio, con riferimento all’articolo 1,
comma 376, della legge finanziaria 296/2006 (recante una nuova destinazione,
per il 2007, delle risorse originariamente destinate al Progetto sperimentale
“bioetanolo” non utilizzate negli anni 2005 e 2006);
b) mancata
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento.
- Tale
profilo è stata riscontrato, per esempio, in sede di esame dell’articolo
6, comma 5, del decreto legge 300/2006 (proroga di termini), il quale ha
previsto che le somme stanziate per la costituzione di
sportelli unici all'estero, non impegnate al 31 dicembre 2006, fossero
mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all’entrata nell’anno
successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero del commercio internazionale in favore dell’Istituto per il commercio
estero.
Come evidenziato in precedenza, il versamento
delle somme all’entrata dell’esercizio successivo può garantire la neutralità
finanziaria con riferimento al solo saldo di bilancio dello Stato, ma non per i
saldi relativi al perimetro, più ampio, delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, come richiesto dal Servizio Bilancio dello Stato, per i saldi di
fabbisogno e di indebitamento avrebbe dovuto essere predisposta un’idonea
compensazione.
Analoga problematica è stata rilevata dal Servizio
Bilancio dello Stato con riferimento all’articolo 2, comma 304, della legge
finanziaria 244/2007 (riutilizzo nel 2008, per una nuova finalità, di somme
2007 originariamente destinate agli sportelli unici all'estero).
c) mancata
valutazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento con specifico riferimento ai limiti previsti per la
riassegnazione delle entrate disposto con l’articolo 1, comma 46, della legge
266/2005.
- L’articolo 6,comma 8, del decreto legge 300/2006 (Proroga di termini) ha previsto che le
somme stanziate per il Fondo per l’autotrasporto non impegnate entro il
31 dicembre 2006 fossero mantenute in bilancio nel conto residui per essere
versate in entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti. Nel caso specifico, constatato
– con apposita verifica della Commissione Bilancio della Camera – che le somme
2006 risultavano ancora disponibili, a fine esercizio, per il loro intero
ammontare, è stata richiesta la compensazione ai fini del fabbisogno e
dell’indebitamento per il mancato risparmio connesso alla deroga al limite alle
riassegnazioni fissato dalla legge 266/2005;
d) incompatibilità
fra l’originaria natura delle risorse da riassegnare (per esempio,
finanziamenti in conto capitale) e le nuove finalizzazioni (per esempio, spesa
corrente).
- Con
riferimento all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 300/2006 (Proroga
di termini), sopra citato, il Servizio Bilancio ha evidenziato la necessità che
le somme di cui si prevedeva la riutilizzazione avessero una (nuova)
finalizzazione conforme alla natura di conto capitale degli stanziamenti
originari. Diversamente si sarebbe infatti
verificata una dequalificazione della spesa, suscettibile di tradursi in
un peggioramento del saldo corrente.
Analoga considerazione – in ordine alla
disomogeneità fra i meccanismi di spesa previsti originariamente e quelli
introdotti con la nuova finalizzazione - è stata formulata con riferimento
all’articolo 2, comma 305, della legge finanziaria 244/2007, che ha disposto,
per l’anno 2008, la riassegnazione al Fondo per il credito all'esportazione di
una quota delle disponibilità del Fondo rotativo per i finanziamenti agevolati
alle imprese esportatrici. Sul punto il Servizio Bilancio dello Stato ha
segnalato la necessità di una compensazione anche in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, considerato che si prevedeva l’utilizzo di risorse di un fondo
rotativo a beneficio di un fondo non dotato di analoghe caratteristiche;
e) non
univocità dei criteri in base ai quali sono contabilizzati gli effetti derivanti
dall’utilizzo di somme stanziate negli esercizi precedenti; in particolare la
ridotta trasparenza di tali criteri di contabilizzazione comporta che, in casi
riferiti a fattispecie del tutto analoghe può essere talvolta prevista la
compensazione rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento e in altri
casi omessa. Spesso tale difformità di orientamento è motivata sulla base
della considerazione che, in determinati casi, il rinvio della spesa in
questione non è suscettibile di determinare impatti sul fabbisogno e
sull’indebitamento in quanto già considerato nella definizione delle linee tendenziali
di evoluzione della spesa in base alla vigente legislazione: si tratta peraltro
di un assunto difficilmente verificabile in base a dati testuali, in quanto la
definizione dei tendenziali di finanza pubblica non viene in genere corredata
di relazioni illustrative, volte ad esplicitare in dettaglio i criteri di
costruzione delle medesime previsioni.
-Si vedano a titolo esemplificativo le reiterate
disposizioni in materia di progetti sperimentali per i biocarburanti,
che hanno di volta in volta previsto la possibilità di utilizzare gli
stanziamenti disposti da leggi finanziarie precedenti, non utilizzati negli
anni di competenza. Nel corso dell’esame parlamentare dell’ultima manovra
finanziaria, con riferimento ad una disposizione in materia, introdotta dal
Senato
e sprovvista di compensazione, è pervenuta una relazione tecnica che
sottolineava la necessità di tener conto degli effetti negativi della
disposizione in termini di indebitamento netto.
Al contrario in numerosi casi – fra cui quelli
esposti in precedenza - tale orientamento contabile non è stato seguito. Lo
dimostra l’esempio dell’articolo 6, comma 5, del decreto legge 300/2006
(mantenimento in bilancio delle somme stanziate per la costituzione di
sportelli unici all'estero e loro versamento all’entrata nell’anno successivo a
favore dell’Istituto per il commercio estero): in occasione dell’esame di tale
norme, in risposta al rilievo del Servizio Bilancio dello Stato circa la
necessità di predisporre apposita compensazione in termini di fabbisogno e di
indebitamento, il Governo ha infatti precisato che la conservazione in
bilancio dei fondi predetti non recava effetti negativi per i saldi di finanza
pubblica “essendo stata già considerata nel tendenziale e riguardando
residui in conto capitale, per i quali la deroga si sostanzia solo
nell’allungamento di un anno dei termini di conservazione”.
Sono ascrivibili al medesimo ordine di
considerazioni le difficoltà incontrate nel valutare l’impatto finanziario di
una norma, come l’articolo 21-bis del
decreto legge 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l’equità sociale), che ha destinato al finanziamento di
programmi di recupero e riqualificazione urbana (“Contratti di quartiere
II”) risorse originariamente stanziate per altri programmi di edilizia
residenziale e non impegnate entro il 31 dicembre 2007. La relazione tecnica
indicava una stima delle risorse residue giacenti e utilizzabili per tali nuove
finalità.
Sul punto il Servizio Bilancio dello Stato, stante l’assenza di informazioni
circa i criteri di costruzione dei tendenziali di spesa per il 2008, ha chiesto
al Governo di chiarire se le previsioni tendenziali già scontassero,
nonostante il termine del 31 dicembre 2007 previsto dalla legislazione vigente,
il differimento agli esercizi 2008 e seguenti dell’utilizzo effettivo delle
risorse disponibili; in caso contrario, infatti, la norma avrebbe
determinato effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto;
f) necessità
di verificare sia l’ammontare sia l’effettiva disponibilità per i nuovi
impieghi, ove previsti, delle somme di cui si dispone il riutilizzo.
- Con l’articolo 2 della legge 9/2007 (Interventi per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) sono stati
riconosciuti benefici fiscali a favore dei proprietari degli immobili locati a
conduttori che si trovino in condizioni disagiate. La copertura delle minori
entrate
conseguenti all’agevolazione fiscale veniva disposta a valere su una precedente
autorizzazione di spesa, concernente il premio di concentrazione,
ed effettuata mediante un meccanismo di mantenimento delle somme in conto
residui e di riversamento all’entrata del bilancio dello Stato nelle misure
necessarie a far fronte, negli anni successivi, alle minori entrate fiscali.
In proposito la Commissione Bilancio ha evidenziato, fra l’altro, la necessità
di chiarire se l’utilizzo di risorse originariamente destinate ad altre
finalità potesse pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a
legislazione vigente (tenuto conto che le risorse utilizzate a copertura risultavano
iscritte in un capitolo nel quale confluiscono anche risorse di fonte
differente)
.
Coperture
finanziarie a valere su maggiori entrate non previste
Il comma 1, lett. d), dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 enumera,
tra le modalità esclusive di copertura finanziaria delle leggi, le modificazioni
legislative che comportino nuove o maggiori entrate.
L’utilizzo di tale criterio di copertura presuppone, quindi, l’adozione
di un intervento legislativo che, mediante l’introduzione di nuovi strumenti
impositivi, ovvero mediante l’inasprimento di quelli esistenti, garantisca la
realizzazione di maggiori entrate, a margine di quelle previste in base alla normativa
vigente.
Si tratta di una modalità di copertura che presenta, sotto il profilo
della quantificazione, maggiori elementi di aleatorietà rispetto alle altre
enumerate dall’articolo 11-ter della
legge n. 468 del 1978, che fanno riferimento a risorse già individuate con
esattezza nel loro ammontare.
Infatti, in caso di ricorso a mezzi di copertura derivanti
da disposizioni suscettibili di produrre maggior gettito, particolare
attenzione deve essere dedicata alla corrispondenza tra previsioni di entrata e
nuovi oneri effettivi recati dalle norme. Pertanto, la relazione tecnica deve
fornire tutti gli elementi idonei a verificare tale perfetta coincidenza, sia
sotto il profilo della certezza della realizzazione, sia per quanto attiene
alla coincidenza degli importi stimati e della corrispondenza della relativa dinamica
temporale.
Questi profili di complessità appaiono accentuarsi con
riferimento a taluni provvedimenti, adottati nel corso della legislatura appena
conclusasi, che, discostandosi in parte delle modalità di copertura
tassativamente indicate dalla citata legge n. 468/1978, hanno dispostola compensazione di nuovi oneri a valere su maggiori
entrate fiscali non riconducibili all’introduzione di specifiche disposizioni,
suscettibili di produrre maggior gettito, ma ad una revisione delle stime di
bilancio già formulate in base alla vigente normativa ovvero ad andamenti
congiunturali di mercato oppure ancora a modifiche dei comportamenti dei
consumatori indotte dall’introduzione di specifiche disposizioni, aventi
effetti diretti di carattere oneroso.
La caratteristica comune degli effetti di maggior gettito di cui si è
disposto l’utilizzo con i predetti provvedimenti è quella di determinarsi a
legislazione vigente, in assenza di una specifica innovazione normativa,
ovvero a seguito dell’operare di fattori che solo in via indiretta sono
riconducibili all’introduzione di specifici interventi normativi.
In base all’analisi delle determinanti e dell’ origine
delle maggiori entrate utilizzate, può essere formulata una schematica
classificazione delle predette forme di copertura in base alle seguenti
tipologie:
·
utilizzo
di maggiori entrate derivanti dalla fiscalità generale emerse in corso d’anno,
rispetto al complesso delle entrate previste nelle stime di finanza pubblica
(c.d. “extra- gettito”);
·
utilizzo
di effetti di maggiore entrata, riferibili ad una singola imposta indiretta
(e.s. “maggiori entrate IVA”) e connessi all’andamento congiunturale di
particolari mercati;
·
sono
altresì analizzati quei casi nei quali si prevede l’utilizzo, a fini di
copertura, di effetti di maggior gettito che derivano, quali conseguenze
indotte, dall’introduzione di norme il cui effetto principale è di natura
onerosa: è questa l’ipotesi che ricorre allorquando si prevede che, a seguito dell’introduzione
di misure di incentivo settoriale, possano determinarsi, oltre ad effetti di carattere oneroso, effetti di maggior
gettito (c.d. “effetti fiscali indotti”), in parte compensativi dei
primi, dovuti a modifiche nel comportamento dei consumatori interessati.
Come di seguito illustrato, con riferimento ai medesimi provvedimenti,
in sede di verifica parlamentare delle quantificazioni, insieme ai tradizionali
criteri di verifica preventiva della corrispondenza tra oneri e relative
coperture, è stata considerata necessaria l’indicazione di ulteriori condizioni,
volte ad assicurare il rispetto del vincolo costituzionale della copertura.
Nei paragrafi successivi, sono quindi esaminati
sinteticamente, richiamando i singoli provvedimenti nei quali si è fatto ricorso
a tali forme di compensazione, gli specifici profili metodologici emersi
nell’ambito delle relative procedure parlamentari di verifica delle
quantificazioni.
Nel corso del 2007,
lo scenario di finanza pubblica esposto nei documenti di finanza pubblica, via
via presentati, ha evidenziato un progressivo miglioramento del quadro
tendenziale macroeconomico e finanziario, dovuto ad una più sostenuta crescita
del PIL ed al consolidarsi di una dinamica positiva delle entrate tributarie, caratterizzata
da tassi di crescita ben superiori a quelli dell’economia e ritenuta quindi in
parte di carattere strutturale, soprattutto per la parte connessa alla politica
di lotta all’evasione ed erosione delle basi imponibili.
Il Governo, pur nel
sostanziale rispetto degli obiettivi programmatici di saldo imposti dal
percorso di risanamento dei conti pubblici, ha deciso in diverse occasioni di
utilizzare tale miglioramento per compensare nuove misure di spesa.
La forma di copertura utilizzata, pur non risultando
pienamente riconducibile alla classificazione delle modalità di finanziamento
di nuovi oneri indicate, in via tassativa, dall’art. 11-ter della legge n. 468/1978, ha riconosciuto, per espressa
previsione contenuta nei medesimi provvedimenti legislativi in questione, il
proprio presupposto giuridico nella disposizione della legge finanziaria 2007
(art. 1, comma 4) che – ricalcando analoghe disposizioni contenute in
precedenti leggi finanziarie - ha previsto che le eventuali maggiori entrate
derivanti dalla lotta all’evasione, in quanto eccedenti rispetto all’obiettivo
di saldo programmato, fossero destinate, se di natura permanente, alla
riduzione della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi
di sviluppo e di equità sociale.
La premessa per l’utilizzo delle maggiori risorse emerse dalle
dinamiche spontanee rilevate nei flussi di entrata, è stata, in genere,
individuata in una procedura contabile (accertamento del maggior gettito e
conseguente variazione di bilancio, registrata, anche mediante emendamento, nel
disegno di legge di assestamento), volta ad assicurare l’avvenuta acquisizione delle
risorse stesse al bilancio, quale presupposto necessario per la loro utilizzazione
ai fini di copertura.
Tale criterio ha assunto formale rilievo giuridico in sede
di definizione, da parte della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art.
1, comma 4), della procedura per l’utilizzo delle eventuali maggiori entrate realizzate
nell’esercizio 2008: la citata disposizione prevede, in analogia con le
precedenti leggi finanziarie, la destinazione dell’eventuale extra-gettito ad
obiettivi di riduzione della pressione fiscale, ma, a differenza di precedenti
norme di analogo tenore, dispone espressamente che tale utilizzo sia realizzato
nei limiti delle risorse accertate in sede di provvedimento di assestamento del
bilancio dello Stato.
Inoltre, sono state
evidenziate alcune problematiche di carattere ricorrente, attinenti alla
verifica delle quantificazioni. Molte hanno trovato espressione in rilievi contenuti
nella documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera e/o del
Senato, ampiamente ripresi nel corso dell’esame parlamentare dei singoli
provvedimenti,
In primo luogo, sono
emerse esigenze riferite all’analisi della struttura e delle diverse componenti
del maggior gettito utilizzato nonché dell’incidenza di tale imprevisto
andamento rispetto agli equilibri complessivi di finanza pubblica e al
conseguimento degli obiettivi programmati.
Particolare rilievo è stato annesso – nella documentazione istruttoria
predisposta e nel dibattito svolto presso la Commissione Bilancio –
all’acquisizione di elementi di analisi dei possibili fattori determinanti del
maggior gettito registrato, al fine di individuare e valutare la consistenza
delle componenti di maggior entrata che potevano ritenersi caratterizzate
effettivamente dai requisiti di stabilità e di strutturalità, ritenuti
necessari.
Ciò ai fini del
rispetto sia degli indirizzi dettati in sede europea[182], sia di criteri di correttezza
della copertura, che impongono di verificare - in caso di destinazione di
incrementi di gettito determinatisi in corso di esercizio al finanziamento di
misure di carattere espansivo - che gli incrementi stessi possano ritenersi
stabili e, quindi, suscettibili di proiettarsi sull’intero esercizio, nonché
sugli esercizi successivi, nei casi in cui essi siano destinati a finanziare
anche interventi di spesa che si protraggono oltre l’esercizio di riferimento.
Gli elementi emersi nell’ambito del dibattito parlamentare e
la successiva analisi svolta dal Governo nella Relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all’evasione
fiscale hanno consentito
di individuare i fattori determinanti del maggior gettito emerso in corso
d’anno soprattutto:
·
in una più sostenuta dinamica delle variabili
macroeconomiche cui sono correlate le entrate, rispetto al quadro programmatico
adottato in sede di previsione;
·
in una più incisiva azione legislativa ed amministrativa
volta a contrastare comportamenti di evasione ed elusione degli obblighi
impositivi vigenti, con conseguente avvicinamento delle basi imponibili
effettive alle basi imponibili potenziali, desumibili dai dati di contabilità
nazionale;
·
nei migliori risultati di gettito derivanti
dall’applicazione di misure di entrata già adottate, rispetto a quelli stimati
in sede di previsione;
·
nei possibili cambiamenti strutturali nelle
relazioni tra gettito e contesto macroeconomico.
Più in generale,
poiché gli andamenti rilevanti per il conseguimento degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica non riguardano esclusivamente i flussi di
entrata, ma gli equilibri complessivi di bilancio, è stata evidenziata la
necessità di considerare condizione inderogabile per l’utilizzo delle predette eccedenze
di entrata la garanzia del rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati.
Come evidenziato nelle Note predisposte dal Servizio
Bilancio dello Stato sui provvedimenti in esame, il vincolo di rispetto dei
saldi impone particolare cautela nella valutazione di eccedenze di entrate utilizzate
per il finanziamento di nuovi interventi, rendendo necessaria un’analisi delle
stesse anche alla luce delle dinamiche in essere sul lato della spesa. Ciò al
fine di accertare che gli incrementi di gettito registrati siano tali da
comportare un miglioramento del saldo complessivo di bilancio e che l’utilizzo
in corso d’anno di tale miglioramento non comprometta la realizzazione degli
obiettivi di saldo fissati per l’intero esercizio.
Poiché l’utilizzo dei predetti miglioramenti a compensazione di oneri
comporta la rinuncia ad un maggior margine di certezza nel raggiungimento degli
obiettivi programmati di saldo - tenuto conto dell’incidenza di ineliminabili
elementi di rischio, connessi a fattori esogeni o ad errori di stima - tale
scelta esige una verifica della tenuta complessiva del quadro delle
previsioni, sia macroeconomiche che di finanza pubblica
Ciò al fine di:
·
garantire
che le sopravvenienze di segno positivo emerse, sul lato delle entrate, in
riferimento ad alcune poste di bilancio abbiano carattere di continuità;
·
escludere
che si possano determinare inattesi andamenti di segno opposto su altre poste
di bilancio, sia dal lato delle entrate che dal lato delle spese, in misura
tale da compromettere il raggiungimento, per l’esercizio o gli esercizi
interessati, degli obiettivi programmati di saldo.
Il livello di affidabilità dei risultati di tale analisi è
direttamente correlato al grado di stabilità dei dati sugli aggregati di
entrata e di spesa disponibili nel corso dell’esercizio. Tale circostanza
riveste particolare rilievo per la componente di entrata, in quanto una quota
cospicua del gettito delle imposte dirette è acquisito all’erario nella seconda
metà dell’esercizio. Pertanto, previsioni di gettito complessive formulate in
assenza di indicazioni relative a tali versamenti potrebbero presentare un
certo grado di rischio, anche in considerazione delle continue modifiche normative
che hanno recentemente interessato la disciplina di tali imposte.
Il vincolo dell’invarianza dei saldi programmati comporta, pertanto, che
i provvedimenti che utilizzino in corso d’anno, come fonte di copertura, extra-gettiti
emergenti siano adottati nell’ambito di una fase di verifica e di revisione del
quadro complessivo delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica.
Come si vedrà nell’esame dei singoli provvedimenti, tale
condizione pare essere stata rispettata nel caso dei decreti legge n. 81 e 159,
emanati rispettivamente nel luglio e nell’ottobre del 2007,
(riguardanti, specificamente, gli utilizzi degli extragettiti), che hanno
finanziato, con maggiori entrate emerse in corso d’anno, interventi onerosi
adottati in concomitanza di momenti di complessiva revisione degli andamenti
macroeconomici e di finanza pubblica propedeutici alla presentazione del DPEF
2008-2011 e della successiva Nota di aggiornamento a tale documento
programmatico.
La predetta condizione non appare, invece, ricorrere con
riferimento al già citato decreto-legge n. 248 del 2007 (c.d. “decreto
mille-proroghe”), adottato nel dicembre 2007. Tale provvedimento, infatti, nel
testo originario, ha previsto, di fatto, l’utilizzo di parte dell’ulteriore
miglioramento dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno – emerso successivamente
alla revisione del quadro di finanza pubblica operata con la Nota di
aggiornamento al DPEF - a compensazione di un intervento di soppressione
dell’anticipazione a carico degli agenti incaricati del servizio di
riscossione, con effetti limitati al solo esercizio 2007. In tale circostanza, tuttavia,
non è stata formalmente fornita una revisione aggiornata degli andamenti di
finanza pubblica volta a dimostrare l’effettiva possibilità, nonostante gli
effetti peggiorativi del predetto intervento, di conseguimento a fine anno dell’obiettivo
di saldo programmato.
Nel corso della procedura parlamentare di verifica delle
quantificazioni riferite ai predetti provvedimenti, sono stati, ancora,
evidenziati i seguenti profili di criticità:
·
l’adozione episodica delle predette misure di
utilizzo di extra-gettiti non ne permette la valutazione nell’ambito di un
quadro integrato di finanza pubblica, che consenta di considerare anche gli
effetti indotti di retroazione ed interazione;
·
il ricorso a provvedimenti a carattere
frammentario può aumentare il rischio di instabilità, connesso anche alla
possibile introduzione di ulteriori interventi espansivi in sede di esame
parlamentare dei provvedimenti .
Va infine considerato che l’adozione di misure di spesa nel
corso dell’esercizio con effetti finanziari circoscritti all’esercizio medesimo
non sempre garantisce i tempi necessari per la realizzazione di tali effetti, e
quindi, il reale utilizzo dell’extra-gettito nei limiti temporali prescritti.
Tale circostanza può comportare, pertanto, il rischio di uno slittamento di spese
anche all’esercizio successivo.
Nonostante le
valutazioni espresse, va considerato che l’esperienza realizzata nel 2007,
attraverso l’emersione e l’utilizzo di extra-gettiti, ha consentito l’adozione
di misure espansive nei limiti delle risorse emerse, garantendo comunque,
almeno in base ai dati di pre-consuntivo disponibili,
il raggiungimento degli obiettivi programmati per il medesimo esercizio.
Ciò nonostante,
nell’esame parlamentare sono emersi alcuni elementi di riflessione critica
concernenti il grado di affidabilità delle stime relative agli andamenti
tendenziali, tenuto conto delle frequenti revisioni intervenute rispetto alle
previsioni effettuate sia in sede di manovra iniziale sia in occasione dei successivi
documenti di revisione del quadro complessivo di finanza pubblica.
Il reiterato
accertamento, nell’arco di un esercizio, di eccedenze di entrate nette,
rispetto ai valori precedentemente stimati, può infatti anche significare una
limitata capacità dei modelli di previsione a cogliere nel breve periodo
l’effetto di modifiche di natura strutturale delle basi imponibili ovvero un’eccessiva
prudenzialità nel valutare i sintomi indiretti di tali modifiche.
Dal dibattito è emersa quindi la necessità di un’attenta valutazione
dell’efficacia di tali strumenti di previsione: tale esigenza non può
prescindere da una maggiore trasparenza, nei documenti di finanza pubblica, dei
dati e delle ipotesi poste a fondamento dell’attività di previsione e delle
conseguenti stime tendenziali circa l’evoluzione del quadro di finanza pubblica.
-Alla luce delle considerazioni espresse, appare opportuno
fornire, di seguito, una descrizione di sintesi dei procedimenti
parlamentari di esame e verifica delle quantificazioni riferiti ai provvedimenti
che, nel corso del 2007, hanno provveduto all’utilizzo di “extra-gettiti”.
Nel settembre 2007, la RPP e la Nota di aggiornamento al
DPEF 2007-2008 hanno confermato l’obiettivo di indebitamento netto per il 2007
al 2,8 per cento del Pil, obiettivo poi riconfermato, in dicembre,
nell’Aggiornamento del Programma di stabilità e crescita.
1) Nel marzo
2007, la Relazione unificata per l’economia e la finanza, a seguito dei
positivi risultati conseguiti nel 2006 ed in presenza di prospettive di
crescita significativamente migliori per l’anno 2007, collocava la previsione
di indebitamento netto al 2,3 per cento del Pil. Tale miglioramento era la
risultante di un ulteriore incremento delle entrate totali, trainato dal gettito
tributario, e di un lieve rialzo delle previsioni di spesa, causato
essenzialmente dai maggiori oneri per interessi.
Il nuovo quadro delineato in luglio in sede di DPEF
consentiva di collocare la stima di indebitamento tendenziale al 2,1 per cento
del Pil, a seguito di un ulteriore incremento delle entrate nette. Analogo
miglioramento era stimato per il 2008 ed in misura più accentuata nel 2009.
In tale contesto il Governo ha deciso di adottare il decreto legge n. 81 del 2007, recante “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria”[185], che sviluppava effetti di spesa pari
a 0,4 punti percentuali di Pil nel 2007 e 0,1 per quelli successivi. La nuova
stima tendenziale di indebitamento netto, integrata con gli effetti del decreto
legge, si collocava al 2,5 per cento del Pil nel 2007, saldo in linea con
l’obiettivo programmatico iniziale. Peraltro, gli ultimi indirizzi allora
emersi in sede europea invitavano il Governo ad utilizzare tutto il
miglioramento dei conti emerso nel 2007
a riduzione del disavanzo, come emergeva dal Documento di programmazione
economico-finanziaria[186].
A livello di saldo netto da finanziare le maggiori entrate
nette, acquisite al bilancio dello Stato per il 2007 mediante contestuali
modifiche emendative al disegno di legge di assestamento ed utilizzate a
copertura delle misure contenute nel provvedimento, venivano quantificate in
circa 4,1 miliardi di euro nel 2007 ed in circa 1,5 miliardi di euro annui dal
2008.
La relazione tecnica indicava esclusivamente, a livello di
saldo netto da finanziare, le componenti aggregate del saldo che ne
giustificavano il miglioramento netto.
Nel corso del procedimento di verifica, in presenza di
oneri di natura permanente recati dal decreto, i rilievi espressi si sono
concentrati sulla necessità di elementi integrativi di valutazione volti a
comprovare il carattere di strutturalità delle maggiori entrate nette poste a
compensazione di tali oneri. In particolare, con riguardo agli effetti
finanziari sul bilancio dello Stato, nella documentazione predisposta dal
Servizio Bilancio dello Stato, richiamata nel corso del dibattito in
Commissione, si è chiesto di disporre dei seguenti elementi:
·
le previsioni sull’andamento delle componenti di
spesa per gli anni 2008 e 2009 e, quindi, sui prevedibili effetti netti di
miglioramento del saldo netto da finanziare, atti a consentire la copertura dei
maggiori oneri recati dal decreto per tali anni;
·
più dettagliate indicazioni sui capitoli di
entrata e di spesa in relazione ai quali si riscontravano le variazioni,
apportate in sede di assestamento, rispetto alla legge di bilancio iniziale, e
sulle relative determinanti. Ciò al fine di valutare il carattere di
strutturalità o meno delle dinamiche sottostanti tali variazioni.
Sono stati, inoltre, segnalati i possibili rischi connessi
ai risultati dell’autotassazione, non ancora acquisiti al bilancio, con
particolare riguardo alle incertezze gravanti sulla prima applicazione delle
novità normative contenute nella legge finanziaria 2007 in materia di studi di
settore.
Con riguardo agli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, si è chiesto di acquisire un quadro
aggiornato delle variazioni intervenute, rispetto alle previsioni iniziali,
negli andamenti tendenziali, come integrati dagli effetti della manovra
finanziaria 2007 approvata.
E’ stato, infine, osservato che, fermo restando l’obiettivo
di medio termine di un saldo prossimo al pareggio, il cui conseguimento era
previsto dal DPEF per il 2011, la rinuncia ad un tendenziale miglioramento
dell’indebitamento netto negli anni successivi al 2007, per effetto del
provvedimento adottato, avrebbe comportato un incremento della complessiva
manovra di correzione, da realizzare in anni caratterizzati da previsioni di
crescita più contenute rispetto al 2007.
Negli elementi di risposta a tali rilievi, il Governo ha
fornito gran parte delle informazioni integrative richieste, garantendo in tal
modo un più articolato supporto conoscitivo alla decisione parlamentare.
2) A fine
settembre 2007, con la Nota di aggiornamento al DPEF, è stato ridisegnato il
quadro delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. Le aspettative
di minore crescita dell’economia americana hanno indotto a rivedere verso il
basso le previsioni di evoluzione del Pil per il 2007 e per gli anni
successivi. Tuttavia, la perdurante dinamica positiva delle entrate tributarie
ha consentito di collocare la nuova stima dell’indebitamento netto per il 2007
all’1,9 per cento del Pil.
In tale contesto, il Governo è intervenuto nuovamente per
sostenere lo sviluppo dell’economia, attraverso l’adozione del decreto legge n 159 del 2007, recanteInterventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale[187]. Il
provvedimento anticipava al 2007 alcune spese necessarie a fronteggiare
emergenze produttive, finanziava investimenti in infrastrutture (Ferrovie e
Anas), recava agevolazioni alle famiglie disagiate e risorse per il
finanziamento degli impegni assunti nell’ambito della cooperazione e dello
sviluppo economico. A seguito dell’adozione del decreto, l’indebitamento netto
per il 2007 si collocava al 2,4 per cento del Pil, un decimo di punto in meno
rispetto a quanto indicato nel DPEF.
Il testo iniziale del decreto recava, a livello di saldo
netto da finanziare, oneri per oltre 8 miliardi di euro nel 2007 e marginali
effetti di spesa negli anni successivi. A livello di fabbisogno ed
indebitamento netto gli oneri si cifravano in circa 7,6 miliardi di euro nel
2007, mentre negli anni successivi si determinava un effetto di miglioramento
dei saldi[188].
A parziale copertura degli oneri recati nel 2007, il
provvedimento utilizzava maggiori entrate nette per circa 6 miliardi di euro,
di cui 900 milioni ulteriori rispetto a quelle accertate in sede di Nota di
aggiornamento al DPEF, a seguito di una integrazione delle previsioni di
gettito IRES. Le maggiori entrate risultavano incluse in bilancio a seguito
della presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento, non
ancora pervenuto ad approvazione definitiva. Con i medesimi emendamenti
venivano proposte anche variazioni in diminuzione di alcune poste di spesa, per
un importo netto di circa 2 miliardi di euro, anch’esso parzialmente
utilizzato a copertura degli oneri del
decreto.
Anche in questa circostanza, in sede di verifica delle
quantificazioni, si è rilevata la necessità di una maggiore trasparenza in
riferimento ai criteri di stima adottati nelle previsioni, sia delle maggiori
entrate nette, sia delle minori spese nette, utilizzate a copertura degli
interventi di spesa recati dal provvedimento, al fine di valutare l’effettiva
realizzabilità, in sede di consuntivo per l’esercizio 2007, degli obiettivi di
saldo prefissati.
In particolare, con riferimento alla stima delle maggiori
entrate nette, si è rilevato che, confrontando a livello di singoli tributi le
stime formulate in giugno e quelle formulate a tutto settembre, si
riscontravano, per talune imposte, notevoli differenze nella valutazione del
gettito atteso, sia a causa di fattori imprevisti, sia per il verificarsi di
circostanze non correttamente valutate in sede di quantificazione iniziale.
Tale analisi consigliava, pertanto, un’estrema cautela nell’utilizzo di surplus di bilancio emersi in base a
previsioni formulate in corso d’anno.
Si sottolineava, infine, la necessità di ulteriori elementi
di valutazione in merito al carattere strutturale delle maggiori entrate
accertate. Tale profilo, infatti, nonostante l’utilizzo delle maggiori entrate
fosse limitato al solo esercizio 2007, assumeva rilievo in considerazione degli
indirizzi dettati in sede europea.
3) Nell’ambito
della problematica in esame, si segnala, infine, ilcitato decreto legge n.
248 del 2007,
adottato a fine dicembre, concernente la proroga dei termini previsti da
disposizioni vigenti. Tale provvedimento recava, all’articolo 36, la
soppressione, a decorrere dall’esercizio 2007, dell’obbligo per gli agenti
della riscossione, di versare entro il 30 dicembre di ciascun anno
un’anticipazione delle riscossioni erariali. La soppressione comportava un effetto
di peggioramento dei saldi, stimato in circa 4,6 milioni di euro nel 2007.
A livello di saldo netto da finanziare, l’onere, pur non
risultando formalmente corredato di autonoma clausola di copertura, risultava,
come successivamente indicato dal Governo a seguito di rilievo del Servizio
Bilancio dello Stato, compensato dall’effetto positivo di altre norme del
provvedimento.
A livello di fabbisogno ed indebitamento netto, in base a quanto affermato
dalla relazione tecnica, gli effetti finanziari negativi potevano essere
assorbiti nel quadro di finanza pubblica per l’anno 2007, senza compromettere il
rispetto degli obiettivi programmati.
Nell’ambito del procedimento di verifica si è osservato che
i dati di preconsuntivo relativi al conto delle Amministrazioni pubbliche per
il 2007, sarebbero stati disponibili solo nel marzo 2008 e che, pertanto, il
supposto riassorbimento dei maggiori oneri, recati dalla soppressione
dell’obbligo di versamento in acconto, nell’ambito di un ulteriore
miglioramento del saldo tendenziale per il 2007 doveva essere suffragato da
indicazioni statistiche di maggior dettaglio, atte a confermare un complessivo
andamento dei conti di finanza pubblica conforme agli obiettivi programmati per
il predetto esercizio.
Alla Camera, la Commissione Bilancio ha esaminato il
provvedimento in sede referente, congiuntamente alla Commissione Affari
costituzionali. Al Senato, la Commissione Bilancio ha invece esaminato il
provvedimento in sede consultiva. La Commissione Bilancio del Senato ha
quindi espresso parere contrario sul provvedimento nel suo complesso, pur non
motivandolo con riferimento al rispetto dell’art. 81, quarto comma, della
Costituzione[193].
In particolare, con riferimento alla mancata compensazione,
nell’ambito del provvedimento, degli effetti finanziari della norma in esame su
fabbisogno ed indebitamento netto per l’esercizio 2007, in quanto
riassorbiti nel più favorevole andamento per tale anno dei saldi di finanza
pubblica, la Commissione ha osservato che tale forma di compensazione, essendo
avulsa da un contesto di revisione formale e complessiva del quadro
macroeconomico e di finanza pubblica, non sembrava in grado di fornire una
garanzia della tutela degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
In altri casi, norme
introdotte nel corso della XV legislatura hanno previsto l’utilizzo di maggior
gettito, non derivante dall’andamento complessivo dei flussi di entrata, ma
dall’incremento del gettito di una singola imposta, determinatosi in corso
d’anno per effetto dell’evoluzione dei prezzi di determinati prodotti.
L’andamento crescente di alcune variabili economiche
rispetto ai valori di riferimento, posti alla base delle previsioni contenute
nei documenti di programmazione, può infatti determinare effetti di maggior
gettito per determinate imposte indirette, non scontati nelle previsioni di
finanza pubblica. Ci si riferisce, in particolare, al prezzo dei prodotti
petroliferi, il cui andamento crescente degli ultimi anni, superiore ai valori
di riferimento previsti nei documenti di programmazione, ha determinato un
corrispondente incremento del gettito relativo all’IVA, non scontato nei saldi
tendenziali.
Tenuto conto di tale
fenomeno, nell’ultima manovra di bilancio (legge finanziaria 2008) sono state
inserite disposizioni volte ad utilizzare il maggior gettito a titolo di
imposta sul valore aggiunto, derivante da un incremento dei prezzi del petrolio
greggio superiore al valore preso come riferimento nelle previsioni dei DPEF
annuali, per compensare riduzioni delle accise sui carburanti e sui
combustibili.
- In particolare, i commi da 290 a 293 dell’articolo 1 della
legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) prevedono che con decreto ministeriale
si provveda alla riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti usati come
carburanti o come combustibili per usi civili, nei casi in cui il prezzo del
petrolio aumenti in misura pari o superiore, con riferimento alla media del
periodo, a due punti percentuali rispetto al valore indicato nel DPEF e a
condizione che il valore medio del semestre precedente non registri una
riduzione rispetto a quello indicato nel DPEF. Viene altresì prevista la
possibilità, con cadenza trimestrale, di variare le aliquote di accisa, qualora
il prezzo del greggio comporti una diminuzione rispetto al valore di
riferimento indicato nel DPEF. Le norme prevedono una clausola (comma 292) di
esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per
effetto del citato decreto.
La normativa illustrata ha trovato applicazione con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 marzo 2008, che ha
disposto, a decorrere dalla sua entrata in vigore (20 marzo 2008) e fino al 30
aprile 2008, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, oli da gas o
gasolio usato come carburante e GPL e gas naturale per autotrazione, prevedendo
che alle relative minori entrate si facesse fronte con il maggior gettito
conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 2008, in relazione ai
versamenti periodici dell’IVA, valutato in 162,03 mln. di euro.
Finalità del
meccanismo descritto è quella di contenere l’impatto sui prezzi finali dei
prodotti energetici degli incrementi del prezzo del petrolio ed il conseguente
effetto di amplificazione dovuto all’applicazione dell’IVA ad un prezzo più
elevato.
Infatti, l’imposta sul valore aggiunto, essendo una imposta
proporzionale,
oltre a determinare un incremento del gettito atteso, qualora applicata ad un
prezzo dei prodotti petroliferi superiore a quello di riferimento, tende ad
amplificare l’impatto delle variazioni di prezzo intervenute.
La documentazione dei competenti uffici parlamentari,
riferita alla verifica degli effetti finanziari delle citate disposizioni, ha
segnalato talune problematiche metodologiche riconducibili all’utilizzazione di
maggiori entrate collegate all’andamento di determinate variabili, non in linea
con i parametri incorporati nelle stime generali di finanza pubblica.
Il caso in esame ha assunto un peculiare rilievo anche in
quanto riferito a risultati di maggior gettito riguardanti singole imposte e
specifici mercati.
In tale circostanza – in analogia con le considerazioni
formulate riguardo ai provvedimenti di utilizzo dei cosiddetti “extra-gettiti”
- è stato preliminarmente osservato che, a fini cautelativi, l’utilizzo di maggiori
entrate IVA a compensazione di nuovi oneri, dovrebbe essere subordinato alla
previa verifica che gli andamenti di finanza pubblica risultino comunque coerenti,
nonostante il predetto utilizzo, con il raggiungimento degli obiettivi
complessivi prefissati.
Infatti, soltanto
all’interno di una nuova valutazione complessiva del quadro macroeconomico e
dei generali andamenti di finanza pubblica può trovare giustificazione l’ipotesi
di neutralità finanziaria del meccanismo legislativo, mentre non sembrerebbe
sufficiente, ai predetti fini, la mera previsione di una clausola di non
onerosità, quale quella dettata dalle norme in esame.
Inoltre, poiché il meccanismo prefigurato dalle norme in
esame è caratterizzato da un certo automatismo, sembrerebbe opportuno prevedere
l’applicazione di forme di compensazione alternative per i casi in cui si
riscontrino esiti negativi rispetto agli andamenti complessivi.
La norma non prevede tale condizione, ma dispone che il
meccanismo operi allorquando si verifichino determinati incrementi del prezzo internazionale
del greggio: tale presupposto potrebbe, di per sé, non garantire l’invarianza
dei saldi rispetto alle previsioni, in quanto, a fronte dell’aumento del
gettito IVA conseguente al suddetto aumento del prezzo, potrebbero verificarsi fattori
di segno opposto (ad esempio una riduzione delle quantità vendute di altri
prodotti, con conseguente flessione del gettito IVA riferito ai medesimi,
ovvero riduzioni del gettito di altre imposte erariali).
Un’altra modalità di
copertura a valere su maggiori entrate, cui si è fatto ricorso anche durante la
scorsa legislatura, è quella che prevede l’utilizzo, a parziale compensazione
di oneri recati da misure di agevolazione volte ad orientare il comportamento
di spesa dei consumatori per la realizzazione di determinate politiche
settoriali, delle maggiori entrate a titolo di IVA (e di altre imposte
indirette) che si realizzino a causa dei maggiori consumi, indotti dall’effetto
incentivante delle stesse misure di sostegno adottate (“auto copertura”, anche
parziale, di misure di incentivazione mediante effetti fiscali indotti).
- A titolo esemplificativo della fattispecie in esame
possono richiamarsi le misure, adottate con le ultime due leggi finanziarie e
in parte prorogate dal D.L. n. 248/2007 (c.d. “decreto mille proroghe”), che hanno
previsto incentivi alla sostituzione, mediante rottamazione, di veicoli inquinanti
nonché quelle che hanno disposto agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e
le riqualificazioni energetiche degli edifici.
Con riferimento al primo esempio, le misure in questione
hanno previsto incentivi alla sostituzione, tramite demolizione, di automezzi
immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, con autoveicoli nuovi, immatricolati
come “euro 4” o “euro 5”, che emettano meno di 140 grammi di CO2.
Gli incentivi concessi sono costituiti da un contributo in denaro nonché dall’esenzione
dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Con riferimento al secondo esempio, le agevolazioni in
questione hanno previsto:
·
la detrazione ai fini IRPEF di una quota pari al
36 per cento delle spese rimaste a carico del contribuente, per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, da ripartire in dieci quote annuali nel
limite di un plafond massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare;
·
l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del
10 per cento sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio realizzati su fabbricati
a prevalente destinazione abitativa privata.
In entrambi i casi descritti le relazioni tecniche hanno
scontato, a parziale compensazione degli oneri dovuti all’agevolazione, le
maggiori entrate derivanti dall’effetto incentivante prodotto dalle
agevolazioni stesse.
Nell’ambito della
procedura di verifica si è evidenziato che il ricorso a tale forma di copertura
presenta profili di problematicità in merito:
·
alla
certezza dell’effetto indotto di maggiore entrata, la cui realizzazione è
subordinata ad una modifica nel comportamento di spesa del consumatore, dettata
da valutazioni di convenienza individuale;
·
alla
certezza che l’effetto indotto dia effettivamente luogo ad un incremento netto
di entrate, e non sia invece compensato da riduzioni di gettito conseguenti a “effetti
di sostituzione”, ossia a minori acquisti di altri beni di consumo;
·
alla
necessità di escludere, nel caso di proroga di incentivi in vigore da molto
tempo, quali quelli relativi alle ristrutturazioni edilizie, che l’effetto
incentivante indotto dalla disposizione sia in realtà già scontato negli
andamenti tendenziali.
Infatti, qualora tali andamenti dovessero
risultare costruiti, sotto il profilo macroeconomico, sulla base delle risultanze
degli esercizi pregressi, senza dare autonoma quantificazione agli effetti
recessivi derivanti dal venire a scadenza delle singole agevolazioni in corso,
l’elemento aggiuntivo derivante dalla proroga di queste ultime sarebbe unicamente
rappresentato dal costo dell’incentivo stesso, il cui onere non potrebbe quindi,
per definizione, essere incluso nelle previsioni tendenziali, costruite sulla
base della legislazione vigente.
Pertanto, anche in relazione alle fattispecie in esame, è stata rilevata
la necessità, a fini cautelativi, di subordinare il ricorso a forme, anche
parziali, di compensazione a valere su effetti fiscali indotti ad una
valutazione complessiva degli andamenti di finanza pubblica e della conformità
del predetto utilizzo agli obiettivi di saldo programmati.
Tale criterio è
stato da ultimo ribadito in occasione dell’esame parlamentare del D.L. n.
248/2007, recante disposizioni di proroga di talune delle agevolazioni prima
descritte, in relazione al quale la predetta condizione non è apparsa invece
soddisfatta[200].
- Si segnala che, nell’ambito delle
manovre annuali di finanza pubblica, è ricorrente la considerazione, a
compensazione di oneri, di taluni effetti indotti di maggior gettito, che
possono trovare anche separata evidenza nel quadro di copertura degli oneri
correnti recati dalle leggi finanziarie annuali. Si tratta peraltro
generalmente di effetti (ad esempio collegati ad aumenti di retribuzioni nel
pubblico impiego) caratterizzati da un elevato grado di certezza, in quanto
suscettibili di determinarsi in via automatica, come conseguenza
indiretta delle misure di carattere espansivo adottate e per l’operare della
normativa fiscale in vigore. In altri casi (ad esempio, incentivi per la
rottamazione adottati nel corso delle manovre di finanza pubblica e misure
fiscali per interventi di ristrutturazione del tipo di quelli prima descritti),
gli effetti indotti portati a compensazione di maggiori oneri nell’ambito delle
manovre finanziarie possono presentare caratteri meno automatici in
quanto il presupposto del loro realizzarsi è rinvenuto in modifiche nel
comportamento dei consumatori. Tuttavia, nei casi indicati, è risultato
comunque possibile – a differenza di quanto accaduto nel caso del D.L. n.
248/2007, prima descritto - valutare tali effetti fiscali indotti
nell’ambito della fase di complessiva ridefinizione e verifica del quadro degli
andamenti macroeconomici e di finanza pubblica, che si accompagna all’adozione
delle manovre annuali.
Devoluzione
di entrate per il finanziamento di funzioni locali
Nella legislatura appena conclusa è proseguito un lavoro di
analisi e di proposta in tema di federalismo fiscale, anche se non è stato
portato a termine un provvedimento di riassetto organico della finanza
territoriale. In attesa di tale intervento, si è peraltro assistito
all’approvazione di numerose disposizioni che incidono sul sistema dei rapporti
finanziari fra lo Stato e le amministrazioni locali, seppure con riferimento ad
aspetti circoscritti e non inseriti in una cornice di carattere generale.
In particolare, sono state approvate alcune disposizioni
che, in prospettiva di un assetto caratterizzato da più accentuati elementi di
federalismo, hanno previsto l’introduzione in favore degli enti territoriali di
compartecipazioni dinamiche al gettito di alcuni tributi, per il
finanziamento di funzioni proprie degli enti medesimi o ad essi trasferite.
Parallelamente sono state approvate anche disposizioni di segno opposto, che
hanno ridotto il gettito di tributi di competenza locale, prevedendo una
corrispondente compensazione mediante incremento dei trasferimenti erariali.
Va sottolineato come la mancanza di un disegno organico, in
cui inserire le predette innovazioni normative, aumenti il rischio che non
siano integralmente valutate le ricadute finanziarie delle disposizioni
introdotte sui diversi comparti di enti territoriali interessati, con
conseguente possibilità di indurre mutamenti non previsti negli equilibri
finanziari tra i diversi settori della p.a.
L’introduzione di detti meccanismi
necessita, pertanto, di una puntuale quantificazione delle relative
implicazioni sui saldi di finanza pubblica, al fine di assicurare un’adeguata
compensazione tra effetti di segno opposto e, quindi, una complessiva
neutralità finanziaria delle nuove misure adottate per regolare i rapporti di carattere
finanziario tra i diversi comparti di enti territoriali.
Tale necessità è emersa chiaramente con riferimento ad
esempio alle disposizioni comportanti la devoluzione di entrate per il
finanziamento di funzioni locali. Si tratta di disposizioni che comportano
l’attribuzione a livello locale dell’evoluzione del gettito di alcuni tributi,
al fine di garantire l’esercizio di funzioni da parte degli enti territoriali.
Il trasferimento della componente evolutiva del gettito, dovuta al ciclo
economico e, di conseguenza, scontata nei tendenziali di finanza pubblica - che
incorporano gli effetti dei previsti andamenti macroeconomici - fa emergere
l’esigenza, non sempre tenuta in debita considerazione nelle relazioni
tecniche, di misure di copertura adeguate, al fine di scongiurare effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica.
In particolare, è possibile individuare due casi distinti, a
seconda che all’attribuzione agli enti territoriali di forme di compartecipazione
fiscale dinamica si accompagni o meno l’imputazione ai medesimi enti di nuovi
oneri e/o funzioni.
Una prima fattispecie attiene alle disposizioni che prevedono l’attribuzione
ad amministrazioni locali di una compartecipazione dinamica al gettito
di taluni tributi senza una corrispondente attribuzione di nuovi oneri o
funzioni. In questi casi il Servizio Bilancio dello Stato ha sempre
segnalato la necessità di individuare e di quantificare adeguatamente nella RT,
ai fini delle conseguenti misure di copertura, i relativi effetti peggiorativi
sui saldi di finanza pubblica.
Infatti, l’attribuzione a livello locale del gettito di
tributi – anche nei casi in cui sia compensato con una decurtazione dei
trasferimenti erariale, stabilita nella misura individuata all’atto del
dell’attribuzione dei tributi stessi - implica effetti peggiorativi sui
saldi dovuti all’andamento dinamico del gettito stesso. Ciò in quanto la
stima degli effetti dell’operazione alla data del trasferimento del tributo e
la relativa copertura in termini statici (riduzione annua in misura fissa dei
trasferimenti erariali) può non garantire la piena compensazione degli effetti
dell’operazione ai fini dei saldi complessivi di finanza pubblica. Infatti:
·
con riferimento al bilancio dello Stato si
determina il venir meno di una delle componenti dell’andamento delle entrate,
che assume necessariamente carattere crescente nel tempo (per effetto della
crescita economica), scontato nei tendenziali. In assenza di un’adeguata
compensazione di tale effetto negativo dinamico si determinano quindi, nel
tempo, effetti peggiorativi del saldo netto da finanziare;
·
con riferimento ai bilanci delle amministrazioni
locali, beneficiarie dell’attribuzione del tributo, non si determina un
corrispondente effetto migliorativo dei saldi, atto a compensare quello
peggiorativo riferito al bilancio dello Stato; viene quindi a determinarsi un
complessivo peggioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento.
Ciò di in quanto:
-
se le amministrazioni beneficiarie sono enti
locali, i vincoli del patto di stabilità interno – che, com’è noto, sono
formulati in termini di saldo - consentono alle amministrazioni in questione di
incrementare la spesa, utilizzando pienamente le maggiori risorse ricevute e
mantenendo quindi il medesimo equilibrio di saldo antecedente all’attribuzione
del gettito aggiuntivo;
-
se le amministrazioni beneficiarie sono regioni,
soggette quindi a vincolo sul lato della spesa, egualmente potrebbe non
verificarsi il conseguimento dell’effetto positivo sul saldo del comparto regionale,
necessario a controbilanciare quello negativo che si realizza a livello statale. Infatti, pure in
presenza di un vincolo sulla spesa, le regioni potrebbero comunque utilizzare
le maggiori risorse disponibili o sfruttando appieno gli eventuali margini non
utilizzati concessi dal patto stesso, oppure concedendo agevolazioni sul lato
dell’entrata. Ne consegue che al peggioramento del saldo di bilancio dello
Stato può non corrispondere un miglioramento del saldo delle regioni, con
conseguente peggioramento del saldo complessivo della p.a.
Di seguito si riportano alcuni esempi della fattispecie
descritta: solo nel primo dei casi segnalati l’esigenza – più volte
sottolineata dal Servizio Bilancio - è stata recepita nel corso dell’esame.
- Nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria
per il 2007, il Servizio Bilancio ha
segnalato la necessità di quantificare gli effetti negativi derivanti dalle
disposizioni contenute nell’articolo 12 del testo originario, riguardante l’attribuzione
di una compartecipazione dinamica al gettito IRPEF, in favore dei comuni, con
una contemporanea riduzione dei trasferimenti: a tale disposizione la relazione
tecnica originaria non ascriveva infatti effetti finanziari.
Veniva infatti osservato che la norma, attribuendo una
compartecipazione dinamica ai comuni a decorrere dal 2009, appariva
suscettibile di determinare, a decorrere dal medesimo anno, effetti negativi
per il bilancio dello Stato. Infatti, a fronte dell’attribuzione ai comuni dell’incremento
di gettito dovuto alla crescita delle basi imponibili, la riduzione dei
trasferimenti sarebbe rimasta costante al livello stabilito per il 2008. Si
segnalava inoltre che tale effetto negativo avrebbe dovuto essere
contabilizzato, non solo con riferimento al bilancio dello Stato, ma anche con
riferimento ai saldi del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento
netto della P.A.
Nel corso del successivo esame della disposizione presso il
Senato, il Governo ha opportunamente quantificato, ai fini di tutti i saldi di
finanza pubblica, sia gli effetti della riduzione dei trasferimenti che quelli
dell’attribuzione della compartecipazione dinamica, facendo emergere una
differenza negativa di importo significativo e crescente nel tempo, corrispondente
all’ammontare di risorse attribuite ai comuni non compensato dalla riduzione
dei trasferimenti.
- Con riferimento, invece, alle disposizioni contenute nella
legge finanziaria per il 2008, in particolare
al comma 5, dell’art. 2, il testo originario della disposizione prevedeva che i
maggiori introiti per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, derivanti
dall’applicazione del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio
2007, n. 137 - che ha ridefinito la base imponibile per la compartecipazione al
gettito IRPEF[206]
- non avrebbero potuto superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli
importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. Venivano pertanto
scontate, ai fini del solo saldo netto da finanziare, maggiori spese correnti
per 20 milioni nel 2008 e per 30 milioni, rispettivamente nel 2009 e 2010.
La norma in esame prevedeva inoltre che, a partire dall’anno
2010, i maggiori introiti, rispetto all’importo riconosciuto per l’anno 2009
fossero attribuiti alla regione solo con contestuale trasferimento di funzioni
da parte dello Stato. Tale ultima disposizione è stata soppressa dall’art. 47-ter del D.L. n. 248/2007, che ha contestualmente
prorogato al 2010 il regime transitorio, con determinazione in quota fissa del
gettito spettante alla regione in misura pari a 30 milioni di euro. Ne discende
che dal 2011 spettino alla regione maggiori attribuzioni di risorse, a titolo
di compartecipazione dinamica all’IRPEF, senza che a ciò corrisponda
l’attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato.
Il Servizio Bilancio ha pertanto osservato che la
disposizione in esame, come modificata dal citato DL 248, appare suscettibile
di determinare l’attribuzione di ingenti risorse alla regione Friuli-Venezia
Giulia a decorrere dal 2011, senza contestuale attribuzione di funzioni, con
conseguenti effetti negativi, privi di compensazione, sia sul bilancio dello
Stato che ai fini degli altri saldi di finanza pubblica.
Una seconda fattispecie attiene alle disposizioni che prevedono l’attribuzione
alle amministrazioni locali di una compartecipazione dinamica al gettito, con corrispondente
attribuzione di nuovi oneri a carico dei medesimi enti. In tal caso si pone
l’esigenza di assicurare una compensatività tra le dinamiche afferenti,
rispettivamente, alle entrate trasferite e alle spese cui le stesse sono poste
a fronte.
La relazione tecnica dovrà infatti dimostrare che tra la
dinamica delle maggiori risorse, attribuite in virtù della compartecipazione, e
la dinamica con cui si produrranno gli oneri aggiuntivi, sussista una
corrispondenza, in modo da evitare riflessi negativi sui saldi di finanza
pubblica, anche nel lungo periodo.
- Ad esempio, con riferimento alle disposizioni contenute
nella legge finanziaria per il 2008, riguardanti il trasporto
pubblico locale, è stata disposta
l’attribuzione alle regioni di una compartecipazione al gettito dell’accisa sul
gasolio per autotrazione. La misura della compartecipazione è stata limitata,
per i soli esercizi 2008-2010, all’ammontare di alcuni trasferimenti
contestualmente soppressi, mentre è previsto che, a decorrere dal 2010, la
compartecipazione assuma carattere dinamico. Contestualmente è stata prevista l’esclusione,
a decorrere dal 2008, di qualsiasi trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato per il finanziamento delle spese correnti del settore del trasporto
pubblico locale, comprendendo in tale categoria anche gli oneri per i rinnovi
contrattuali degli addetti al comparto.
Il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che l’adeguamento
delle quote di compartecipazione al gettito dell’accisa a decorrere dall’anno
2011, sulla base dei volumi di gasolio impiegato come carburante per
autotrazione erogato nell’anno 2010 in
ciascuna regione, comporta necessariamente un incremento delle risorse
attribuite alle regioni rispetto all’ammontare dei trasferimenti sostituiti e,
di conseguenza, un minor gettito incassato dallo Stato a titolo di accisa sul
gasolio per autotrazione a decorrere dal 2011. Al fine di verificare l’invarianza
finanziaria della disposizione, sarebbe pertanto stato necessario fornire
un’analisi comparativa della dinamica sia del gettito devoluto alle regioni sia
degli oneri posti a loro carico, in particolare quelli per i rinnovi
contrattuali del settore del trasporto pubblico locale.
- Un ulteriore esempio è costituito dalla disposizione della
legge finanziaria per il 2008, con la quale, per il
finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e ai collegamenti stradali e
ferroviari nei porti, si attribuisce alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise,
relative alle operazioni nei porti e negli interporti, conseguito in ciascuna
regione rispetto all’anno precedente, a condizione che,
nell’esercizio precedente, il gettito complessivo delle citate imposte sia risultato
almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica
riferita al medesimo esercizio. La norma in questione non risultava corredata
di una quantificazione dei relativi effetti finanziari.
In proposito il Servizio Bilancio dello Stato ha segnalato
che la formulazione letterale della norma sembra destinare a finalità di spesa,
a decorrere dal 2008, l’intera dinamica del gettito IVA e delle accise sulle merci
in transito nei porti – ossia quote di gettito derivanti dalla vigente
legislazione e non da nuove norme introdotte - configurando pertanto una misura
onerosa sprovvista della necessaria quantificazione e di idonea copertura,
secondo le modalità individuate dalle norme generali di contabilità contenute
nella legge n. 468/1978. Va in proposito considerato che, benché la norma
recata dalla legge finanziaria 2008 subordini l’utilizzazione delle risorse per
le predette finalità al pieno conseguimento dell’incremento di gettito complessivo
previsto nella RPP, la condizione posta non sembra costituire una garanzia
idonea ad evitare l’insorgenza di effetti onerosi in quanto, una volta
accertato l’effettivo conseguimento del predetto incremento di gettito, potrà
essere attribuita alle autorità portuali per il finanziamento delle opere
infrastrutturali l’intera quota del medesimo incremento riferita all’IVA e alle
accise sulle merci in transito nei porti, ivi compresa quindi la componente già
scontata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
Né peraltro l’attribuzione alle autorità portuali della
funzione relativa alla realizzazione di opere infrastrutturali nei porti può
configurarsi come misura compensativa delle maggiori risorse erogate, in quanto
è espressamente previsto che le risorse attribuite possano eccedere i
trasferimenti iscritti a tale titolo nel bilancio statale. Inoltre, con
riferimento agli esercizi futuri, non viene fornita alcuna analisi del grado di
corrispondenza fra la dinamica, riscontrata su di un idoneo arco temporale,
delle spese infrastrutturali e quella del gettito dei tributi attribuiti.
Da ultimo, si segnala che
problemi di natura analoga, ma di segno opposto, si riscontano nei casi di norme
che riducano o sopprimano tributi locali, prevedendo trasferimenti erariali
compensativi.
Limitando l’analisi ai
profili riferiti agli equilibri di bilancio e prescindendo quindi da
considerazioni sul grado di autonomia finanziaria degli enti locali, si segnala
che, qualora la misura dei trasferimenti compensativi venga fissata senza
tenere conto della dinamica del gettito dei tributi soppressi o ridotti, possono
determinarsi i presupposti per possibili difficoltà future nei bilanci degli
enti locali. Questi ultimi vedono infatti ridurre la dinamica delle proprie
entrate rispetto ad un profilo della spesa invariato; ne potrebbero conseguire
richieste di integrazione dei trasferimenti.
- Si possono richiamare in proposito le disposizioni della legge
finanziaria 2008, con riferimento alle agevolazioni introdotte in materia
di ICI sulla prima casa, compensate da maggiori
trasferimenti erariali quantificati in misura costante nel tempo. In tal caso
occorre peraltro tener conto del fatto che la dinamica del gettito del tributo
in questione risente meno – rispetto ad altre forme di imposizione -
dell’andamento del PIL. Tuttavia andrebbe comunque valutato, in tali casi, se questa
più ridotta dinamica, in quanto applicata ad una riduzione di gettito di
importo significativo, possa determinare difficoltà per il mantenimento, nel
tempo, degli equilibri di bilancio degli enti locali.
La
copertura degli oneri correnti nelle leggi finanziarie
In base all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978,
la legge finanziaria può prevedere oneri correnti, sotto forma di nuove o
maggiori spese ovvero di riduzioni di entrate, nei limiti delle disponibilità
derivanti da nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive nonché da riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente. Il rispetto di tale vincolo - stabilito in attuazione del disposto
costituzionale di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – è
verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato
al disegno di legge finanziaria, che espone gli oneri correnti recati dal
medesimo disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura.
Nelle ultime sessioni di bilancio si è fatto prevalentemente
ricorso alle seguenti forme di copertura degli oneri correnti recati dal
disegno di legge finanziaria:
·
risorse previste dallo stesso disegno di
legge finanziaria, derivanti dalle norme in esso contenute e dalle tabelle
allegate (tabella A e tabella C limitatamente alle voci di spesa corrente);
·
risorse derivanti da effetti indotti
prodotti dal medesimo disegno di legge finanziaria. L’incidenza tra i mezzi di
copertura di effetti indotti, particolarmente rilevante nelle finanziarie per
il 2002, il 2003 ed il 2004, risulta nettamente ridimensionato nella successive
leggi finanziarie relative sia alla XIV che alla XV legislatura;
·
effetti diretti ed effetti indotti derivanti
da altri provvedimenti “collegati” alla manovra di finanza pubblica. Analogamente
a quanto verificatosi frequentemente nella precedente legislatura, la legge
finanziaria per il 2007 ha fatto ricorso anche a risorse (maggiori entrate e
risparmi di spesa) apprestate con un provvedimento esterno al disegno di legge
finanziaria, il D.L. n. 262/2006 (tali risorse hanno costituito circa il 35,7
per cento della copertura per il 2007 e il 24,8 per cento dei mezzi di
copertura complessivamente utilizzati per il triennio di riferimento;
·
miglioramento del risparmio pubblico a
legislazione vigente. Il ricorso a tale modalità di copertura è consentito
in base alla prassi interpretativa dell’articolo 11, comma 5, della legge n.
468 del 1978, sancita dalla Camera e dal Senato con le risoluzioni di
approvazione del DPEF 1990-92.
In merito alle questioni metodologiche affrontate nella
verifica dei prospetti di copertura, particolare rilievo assumono le
considerazioni svolte dal Servizio Bilancio dello Stato ed emerse anche nel
corso del dibattito presso la Commissione Bilancio, relative alla coerenza
temporale tra oneri e mezzi di copertura. Tale criterio impone una
corrispondenza tra i tempi in cui si determinano gli oneri e quelli in cui si
verifica la disponibilità dei relativi mezzi di copertura.
Una prima conseguenza di tale principio è che le norme da
cui derivano le risorse utilizzate nel prospetto di copertura devono
necessariamente entrare in vigore fin dal primo esercizio in cui si verificano
i corrispondenti oneri.
- Si ricorda, in proposito, che il disegno di legge
finanziaria per il 2007, nel testo originario, comprendeva tra i mezzi di
copertura somme per 1 mld di euro nel 2007 e 2 mld annui nel 2008 e 2009,
derivanti da un disegno di legge delega in materia di tassazione delle
rendite finanziarie, per il cui esercizio era previsto il termine del
luglio 2007.
Sulla base dell’istruttoria svolta dal Servizio Bilancio
dello Stato, nel corso della seduta della Commissione Bilancio dedicata alla
verifica del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria 2007, è stato osservato come
l’utilizzo di risorse provenienti da tale delega ponesse un problema di
coerenza temporale tra oneri e mezzi di copertura, in quanto questi ultimi
avrebbero dovuto sussistere ed essere iscritti in bilancio a decorrere dal
primo anno del triennio considerato dal prospetto. Poiché il conseguimento
dell’effetto finanziario era rimesso all’adozione della normativa delegata, occorreva
individuare modalità che ne garantissero effettivamente il conseguimento già
nel 2007.
Nel parere espresso dalla Commissione Bilancio sul contenuto
proprio del disegno di legge finanziaria è stata quindi evidenziata la
necessità che le disposizioni cui si attribuiva l'effetto di maggior gettito
entrassero comunque in vigore e potessero produrre i loro effetti nell'anno
fiscale 2007 in modo da assicurare piena e integrale copertura agli oneri
recati dal disegno di legge finanziaria. A seguito di tali considerazioni il
riferimento alla delega legislativa è stato successivamente espunto dal
prospetto di copertura.
La
questione della coerenza temporale tra oneri e mezzi di copertura costituisce
oggetto di valutazione anche per quanto attiene alla probabile evoluzione,
nell’intero periodo di applicazione delle norme - e quindi anche oltre il
triennio – delle risorse impiegate, rispetto alla prevista dinamica degli
oneri ai quali far fronte. E’ stato quindi sottolineato come l’esigenza di una
coerenza tra il profilo temporale degli oneri e quello dei mezzi di copertura
vada verificata anche in un’ottica ultratriennale.
- Nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria per
il 2008, il Servizio Bilancio dello Stato, ad esempio, ha evidenziato che una
cospicua quota delle maggiori spese correnti e delle minori entrate previste
nel prospetto di copertura presentava carattere permanente o protratto comunque
oltre il triennio.
Inoltre, per alcune disposizioni comportanti perdite di
gettito sussistevano rischi di un incremento dell’onere oltre il triennio: ciò
in ragione della possibile minore efficacia, nel tempo, di misure cui erano
attribuiti effetti di maggiore entrata, parzialmente compensativi delle
predette riduzioni di gettito. Era questo
il caso del complesso delle misure relative all’IRES, di cui la
RT e l’allegato 7 fornivano
esclusivamente gli effetti netti sui saldi nel triennio di riferimento. Tali
dati risultavano
peraltro dalla parziale compensazione di minori entrate di carattere
strutturale (riduzioni di aliquote legali) e di maggiori entrate che, pur
incidendo in misura rilevante nei primi anni, erano presumibilmente suscettibili di
esplicare effetti più contenuti oltre il triennio (con riferimento, ad esempio, eliminazione ammortamenti
anticipati e deduzioni extracontabili).
In talune circostanze è stato segnalato
il carattere non prudenziale dell’utilizzo, tra i mezzi di copertura degli
oneri correnti, di risparmi di spesa, soprattutto allorquando la norma volta a
conseguirli non introduceva adeguati meccanismi di presidio e garanzia.
In base
a tale criterio, talune leggi finanziarie, pur introducendo procedure
suscettibili di produrre risparmi, non hanno previsto l’utilizzo dei relativi
effetti nel prospetto di copertura né nel quadro relativo all’equilibrio
complessivo della manovra, trattandosi di conseguenze finanziarie il cui reale
conseguimento si sarebbe potuto verificare soltanto a consuntivo.
Laddove
è stato invece previsto l’utilizzo, a fronte di oneri correnti derivanti dal
disegno di legge finanziaria, di previsioni di risparmi, non supportate da
adeguate procedure atte a garantirne l’effettivo conseguimento, sono stati
evidenziati possibili profili critici della copertura.
Ad
esempio, per quanto attiene alle risorse derivanti da
disposizioni che prevedono tagli lineari di bilancio è stato segnalato come tale modalità si
prestasse a rilievi in quanto, per analoghe misure attuate in precedenti anni,
in molti casi era emersa la necessità di integrare con provvedimenti successivi
i tagli operati, al fine di far fronte ai fabbisogni delle amministrazioni
interessate.
Come già segnalato, la prassi sancita dalle risoluzioni di
approvazione del DPEF 1990-92 consente il ricorso, per finalità di copertura
degli oneri correnti della legge finanziaria, al miglioramento del risparmio
pubblico a legislazione vigente, ossia al miglioramento di tale saldo
riscontrabile dal raffronto tra l’assestamento di bilancio riferito all’anno in
corso ed il bilancio a legislazione vigente riferito agli esercizi successivi.
Fino alla sessione di bilancio per il 1999 non si è fatto
ricorso a tale mezzo di copertura, che è stato invece utilizzato nelle leggi
finanziarie relative agli anni tra il 2000 e il 2003. Nelle successive leggi
finanziarie, riferite agli esercizi dal 2004 al 2006, tale modalità di copertura
non è stata utilizzata, presumibilmente in ragione del valore negativo che il
predetto saldo ha continuato ad assumere nelle previsioni di bilancio
riguardanti i predetti anni.
Nella legge finanziaria per il 2007 l’utilizzo del risparmio
pubblico ha rappresentato, nel primo anno, il 26,3 per cento e, nell’intero
triennio, il 19,9 per cento dei mezzi di copertura previsti; nella legge
finanziaria per il 2008 l’utilizzo del risparmio pubblico a fini di copertura
degli oneri correnti è salito al 56,8 per cento, per il primo anno, e al
47,6 per cento, per l’intero triennio di riferimento.
Tenuto conto del
cospicuo ricorso a tale strumento, nella documentazione prodotta dal Servizio
Bilancio dello Stato sono stati rilevati, sotto il profilo della prudenzialità,
aspetti problematici, legati al carattere necessariamente provvisorio delle
stime concernenti l’andamento del saldo corrente di bilancio negli esercizi di
riferimento, soprattutto in quelli successivi al primo.
Infatti, il dato relativo al
miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente è ricavato dal
raffronto tra il valore del saldo corrente riferito al bilancio dell’esercizio
in corso - che emerge dal provvedimento di assestamento - ed il corrispondente
valore che lo stesso saldo assume nel bilancio per il nuovo esercizio 2008.
Tale differenza può risentire quindi del carattere provvisorio sia dei valori
assestati riferiti all’esercizio in corso, sia delle nuove previsioni di
bilancio che, per quanto affidabili, sono soggette presumibilmente a
modificarsi in corso d’anno. Il margine di incertezza sembra accentuarsi con
riferimento al secondo e terzo esercizio del triennio di previsione, rispetto
ai quali più probabile appare l’eventualità di una successiva revisione delle
stime iniziali di bilancio.
Inoltre, è stato evidenziato che il
ricorso a quote consistenti del miglioramento, a legislazione vigente, del
saldo corrente di bilancio dovrebbe in ogni caso essere suffragato da dati ed
elementi volti a confermare la stabilità del predetto miglioramento almeno con
riferimento alla parte utilizzata a fini di copertura di oneri che si
proiettano oltre il triennio.
Una specifica
attività del Servizio Bilancio ha per oggetto l’analisi ed il monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica.
Tale attività ha ricevuto particolare impulso nella XV
legislatura con la legge finanziaria per il 2007 che ha previsto il
potenziamento degli strumenti di analisi e monitoraggio della finanza pubblica
delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi di altre
istituzioni e istituti di ricerca.
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 481 dell’art. 1
della legge n. 296/2006, a partire dal 2007, è stata avviata la collaborazione
tra i competenti Uffici della Camera (Servizio Bilancio dello Stato e Servizio
Studi) e del Senato (Servizio Bilancio) ai fini della predisposizione di
analisi integrate per l’esame parlamentare dei documenti presentati dal
Governo.
In tale contesto,
sono esaminati i dati contenuti nei documenti di fonte governativa o comunque
di fonte ufficiale (Banca d’Italia, Istat, Commissione e Consiglio dell’Unione
europea, ecc.), riguardanti i principali flussi finanziari relativi sia al
bilancio dello Stato ed al settore statale, che al conto delle pubbliche
amministrazioni, i cui andamenti sono soggetti alla procedura di sorveglianza
in ambito europeo.
Specifiche analisi
sono, quindi, dedicate ai documenti presentati dal Governo in relazione al
ciclo annuale della decisione di bilancio. Ulteriori contributi sono, peraltro,
predisposti in occasioni di attività parlamentare (svolgimento di audizioni,
attività di indirizzo, ecc.) aventi per oggetto tali tematiche.
Particolare
attenzione riveste l’analisi della Relazione
unificata sull’economia e la finanza
che il Governo presenta alla fine del primo trimestre, e che reca sia i
risultati conseguiti nell’anno precedente, sia le prime indicazioni per l’anno
in corso alla luce della manovra di finanza pubblica approvata alla fine
dell’esercizio precedente e degli andamenti rilevati. Le informazioni contenute
nella RUEF si completano con i dati di consuntivo diffusi dall’Istat e comunicati agli organi europei,
come previsto dalle procedure di monitoraggio dei conti pubblici nazionali.
Specifiche analisi
sono poi riservate alle previsioni, per l’anno in corso ed il successivo
triennio, dell’andamento dei principali saldi di finanza pubblica e
l’evoluzione delle singole componenti di entrata e di uscita, contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato il 30 giugno, che costituisce il punto di
riferimento per le scelte da adottare con la manovra per l’anno successivo.
Particolare attenzione è dedicata, in questa sede, all’analisi dei saldi
strutturali (l’indebitamento netto corretto per il ciclo e per gli effetti
delle misure una tantum), che
assumono rilievo per il percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio
termine fissato nel Programma di stabilità.
Anche in questo
caso, l’analisi del quadro tendenziale si arricchisce con le informazioni (di
carattere consuntivo) contenute nella Relazione
generale sulla situazione economica del Paese presentata nel mese di
maggio. Il confronto con gli andamenti registrati negli anni precedenti
consente una prima valutazione circa l’attendibilità delle previsioni e la
solidità, quindi, del quadro programmatico che incorpora le future misure che
il Governo intende adottare.
Nell’analisi
dedicata alla Nota di aggiornamento del
DPEF, presentata (eventualmente) dal Governo contestualmente alla manovra,
si mettono in evidenza gli scostamenti negli andamenti delle variabili
macroeconomiche e di finanza pubblica rispetto a quelli delineati nel DPEF, e
si pongono in luce le variazioni o viceversa la conferma, degli obiettivi in
precedenza indicati.
Con la presentazione
della manovra, l’analisi è diretta a
verificare, rispetto agli obiettivi delineati con il DPEF (e con la Nota) come
approvati nelle risoluzioni parlamentari, sia la tenuta dei saldi che la
coerenza della sua composizione e l’impatto, quindi, sulla pressione fiscale e
sulla spesa complessiva. Le analisi utilizzano le informazioni circa gli
effetti sui saldi delle singole componenti in cui la manovra si articola
contenute negli allegati al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge
di bilancio, nelle relazioni tecniche e nei prospetti della contestuale Relazione previsionale e programmatica.
Esse tengono conto, inoltre, degli elementi contenuti nell’Aggiornamento del Programma di stabilità, presentato
annualmente dal Governo alla Commissione UE, che reca l’illustrazione della
manovra nel testo iniziale.
Nell’elaborazione di
tali analisi il Servizio Bilancio, anche utilizzando, ove disponibili, studi ed
elaborazioni di istituti di ricerca, mette in evidenza i fattori alla base
delle tendenze delineate, sempre partendo dai dati ufficiali e tenendo conto
sia dell’evoluzione del quadro normativo che del contesto economico generale.
Qualora dai documenti
non emerga con chiarezza il contributo dei diversi fattori alle dinamiche
riscontrate, si formulano, ove possibile, delle ipotesi interpretative dei
fenomeni, chiedendo conferma delle stesse al Governo. In alternativa, può
essere formulata una richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di
valutazione.
Nel caso che oggetto
dei documenti siano le previsioni a breve o medio termine delle variabili di
finanza pubblica, il Servizio Bilancio può valutare le ipotesi in base alle
quali sono costruite tali proiezioni, al fine di verificarne la coerenza
rispetto ad altre previsioni provenienti da soggetti governativi o centri
pubblici di ricerca o inserite in analisi di istituti europei ed internazionali
(Commissione UE, FMI, OCSE, ecc.). In particolare, il confronto con i dati di
fonte internazionale è ricorrente per quanto attiene alla verifica delle
ipotesi relative all’evoluzione del quadro macroeconomico, determinante per la
definizione delle previsioni di finanza pubblica.
Anche con
riferimento ai dati previsionali, il Servizio può formulare segnalazioni ovvero
richieste di chiarimenti qualora ravvisi carenze della base informativa,
possibili incongruenze nella definizione delle ipotesi, o evidenti elementi di
contrasto rispetto alle proiezioni di altri organismi accreditati nel settore.
Il Patto di
stabilità e crescita
Gli obiettivi di
finanza pubblica indicati nei documenti presentati in corso d’anno dal Governo
e alla cui realizzazione sono finalizzate le manovre correttive annuali o
infra-annuali, si inquadrano nel contesto più generale delineato dal Patto di
stabilità e crescita.
Il Patto risulta formalmente costituito dalla Risoluzione
del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 (97/C 236/01), dal Regolamento del
Consiglio (1466/97) sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di
bilancio e del coordinamento delle politiche economiche, dal Regolamento del
Consiglio (1467/97) che regola le modalità di attuazione della procedura per i
disavanzi eccessivi, e dal Codice di Condotta approvato dall’Ecofin
nell’ottobre del 2005.
Approvato dal
Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, il Patto tendeva a
rendere più cogente, alla vigilia dell’avvio della terza fase dell’Unione
economica e monetaria,
la disciplina di bilancio ed, in particolare, il rispetto da parte degli Stati
membri delle soglie del 3 e del 60 per cento del PIL, rispettivamente per
l’indebitamento netto e il debito delle Pubbliche amministrazioni, fissate dal
Protocollo sui disavanzi eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.
Con le modifiche
apportate nel 2005,
confermato l’impianto generale del Patto quale strumento fondamentale per la
disciplina fiscale e confermati, altresì, i due parametri quantitativi indicati
dal Protocollo, sono stati ridefiniti gli obiettivi di finanza pubblica a medio
termine, prevedendo la possibilità di percorsi di avvicinamento differenziati
per i singoli Stati membri, al fine di tener conto delle diversità delle
posizioni di bilancio, degli sviluppi sul piano economico e della sostenibilità finanziaria.
Gli Stati membri,
nell’ambito dell’aggiornamento dei rispettivi programmi di stabilità,
presentano quindi un obiettivo di medio termine (MTO), definito sulla base del
potenziale di crescita dell’economia e del rapporto debito/PIL. Esso consiste
in un livello di indebitamento netto strutturale (corretto, cioè, per il ciclo
e al netto delle misure temporanee e una tantum) che può divergere dal
requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, ma che deve essere tale
da garantire, in presenza di normali fluttuazioni cicliche, un adeguato margine
di sicurezza rispetto alla soglia del 3 per cento ed un ritmo di avvicinamento
certo ad una situazione di sostenibilità. In linea generale, gli obiettivi
devono essere compresi in una forcella stabilita tra l’1 per cento del PIL e il
pareggio o l’attivo.
Il percorso di
avvicinamento si fonda su una regola di correzione strutturale annuale di 0,5
punti; la regola può tuttavia variare in relazione all’andamento del ciclo
economico (good or bad times), richiedendosi uno sforzo più limitato in
presenza di una congiuntura sfavorevole.
In base al Codice di Condotta relativo al PSC,
l’identificazione di good e bad times implica un’analisi complessiva
della situazione economica del paese. In linea generale, i "periodi
buoni" sono quelli in cui il prodotto eccede il suo livello potenziale,
ovvero in cui l’output gap è
positivo. Viene, peraltro, tenuta altresì in considerazione anche la variazione
dell’output gap nel periodo di
programmazione. Se ad esempio l’output
gap è negativo, ma con un valore che tende a ridursi alla fine del periodo,
la posizione del Paese potrebbe comunque essere valutata in good times.
Deviazioni dalla
misura dello 0,5 per cento possono, inoltre, essere accettate in caso che un
paese abbia effettuato riforme strutturali rilevanti, con un effetto
quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, a
condizione che sia comunque mantenuto un margine adeguato rispetto alla soglia
del 3 per cento e che il deficit ritorni all’obiettivo di medio termine entro
il periodo coperto dal programma.
Nel luglio 2005 il Consiglio Ecofin
ha adottato una decisione sull’esistenza
di una situazione di disavanzo eccessivo in Italia.
La procedura è stata chiusa nel maggio 2008.
Con la raccomandazione annessa alla decisione del 2005, il
Consiglio ha chiesto all’Italia di:
·
riportare
il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 3% del PIL in modo
credibile e sostenibile entro il 2007. A tal fine il Consiglio ha rilevato
la necessità, oltre che di attuare con rigore il bilancio 2005, di adottare le
misure necessarie per garantire una riduzione cumulativa del disavanzo
strutturale di almeno l'1,6% del PIL nel periodo 2006-2007 rispetto al livello
del 2005, realizzando almeno metà dell'aggiustamento nel 2006;
·
assicurare
che il rapporto debito pubblico/PIL si riduca sufficientemente e si avvicini al
valore di riferimento (60%) ad un ritmo soddisfacente, ripristinando a medio
termine un adeguato livello di avanzo primario;
·
riportare
le finanze pubbliche ad una posizione a medio termine prossima al pareggio o
positiva, tramite una riduzione del disavanzo strutturale di almeno lo 0,5% del
PIL all'anno dopo la correzione del disavanzo eccessivo.
Nel marzo 2006 e nel
febbraio 2007, il Consiglio ha esaminato gli Aggiornamenti annuali del
Programma di stabilità presentati dall’Italia, rispettivamente, nel dicembre
2005 e nel dicembre 2006, ritenendoli compatibili con una correzione del
disavanzo eccessivo entro il 2007.
Il 12 febbraio 2008
il Consiglio ha espresso il parere sul Programma aggiornato relativo al periodo
2007-2011, rilevando che nel complesso esso dovrebbe consentire la correzione
del disavanzo eccessivo nel 2007 con ampio margine.
Il Consiglio ha ritenuto che il risultato 2007 potesse
risultare più positivo rispetto alle aspettative
e che un esito migliore avrebbe potuto essere conseguito senza le spese
aggiuntive approvate in corso d’anno, misure queste che non possono
considerarsi pienamente conformi all’invito a sfruttare un andamento del
bilancio più positivo rispetto alle previsioni ai fini della riduzione dei
disavanzo.
Per il 2008, l'avvicinamento
al MTO previsto nel programma (correzione dello 0,2 per cento) è considerato
inadeguato e dovrebbe quindi essere rafforzato per essere in linea con il Patto
di stabilità e crescita, che richiede un miglioramento annuo del saldo strutturale
pari allo 0,5 per cento del PIL.
L’aggiustamento, infatti, è concentrato negli ultimi anni
del programma, senza peraltro che ne siano specificate le misure, il che
impedisce una valutazione adeguata. L’obiettivo a medio termine potrebbe,
pertanto, non essere raggiunto entro il 2011 come previsto nel Programma e il
rapporto debito/PIL potrebbe non scendere in misura sufficiente verso il valore
del 60% del PIL nel periodo di riferimento.
Per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche,
il Consiglio ha valutato l’Italia “a
medio rischio”. L’impatto a lungo termine dell’invecchiamento demografico sul
bilancio è inferiore alla media europea, con un incremento della spesa
pensionistica mediamente più limitato che nell’UE, grazie alle riforme
pensionistiche adottate. Tuttavia, la spesa pensionistica in percentuale del
PIL resta tra le più elevate della UE. Tali proiezioni si basano sull’ipotesi
che le riforme adottate di recente ricevano piena attuazione, in particolare
che la revisione dei coefficienti attuariali sia attuata a partire dal 2010 e
che non vi siano scostamenti dal principio contributivo sotteso alla riforma
del sistema pensionistico.
Sulla base di tali valutazioni, il Consiglio ha invitato
l’Italia a:
-
rafforzare l’obiettivo di bilancio per il 2008
sfruttando i buoni risultati del 2007,
in modo da garantire un aggiustamento ambizioso e
attuare il risanamento di bilancio garantendo progressi adeguati in direzione
del MTO , in modo da raggiungere quest’ultimo entro il periodo di riferimento,
accelerando il ritmo di riduzione del debito;
-
attuare pienamente la riforma delle pensioni (ed
in particolare l’aggiustamento attuariale periodico previsto) per evitare
aumenti significativi delle spese legate all’invecchiamento della popolazione,
tenuto conto del livello molto elevato del debito pubblico;
-
precisare la strategia di bilancio a medio
termine in linea con il PSC, proseguire gli sforzi al fine di migliorare la
qualità delle finanze pubbliche, mettendo l’accento sulla loro composizione,
rafforzando la trasparenza del processo di bilancio ed attuando efficacemente
meccanismi di controllo e di monitoraggio della spesa.
Il 7 maggio 2008, la
Commissione UE,
alla luce dei risultati conseguiti dall’Italia nel 2006 e 2007, ha raccomandato al Consiglio l’abrogazione
della decisione sull’esistenza del disavanzo eccessivo.
La riduzione del disavanzo dal 3,4% del PIL nel 2006
all’1,9% nel 2007, al di sotto quindi della soglia del 3%, è considerata frutto
di misure prevalentemente di natura permanente. Il saldo strutturale migliora
di tre punti di PIL nel biennio (dal 4,5% del 2005 all’1,5% del 2007) a fronte
della correzione dell’1,6% richiesta dal Consiglio. In base alle previsioni
della Commissione, il disavanzo nominale
dovrebbe aumentare al 2,3% del PIL nel 2008 e al 2,4% nel 2009. Tale evoluzione
evidenzia come il disavanzo sia stato ricondotto al di sotto della soglia del 3
per cento in maniera credibile e sostenibile.
Anche per quanto riguarda il debito, rilevato come l’aumento
dell’incidenza sul PIL registrato nel 2006 (dal 105,8% al 106,5%) abbia
risentito in misura significativa delle maggiori spese straordinarie, la Commissione sottolinea il
risultato 2007 (104%) e il ridimensionamento atteso per il successivo biennio
(103,2% nel 2008 e 102,6% nel 2009).
La Commissione,
tuttavia, evidenzia il peggioramento del saldo strutturale atteso per il 2008
(-1,9%) rispetto al risultato 2007 (-1,5%), peggioramento chiaramente non in
linea con la correzione dello 0,5% annuo richiesta dal Patto di Stabilità e
crescita, richiamata dal Consiglio nella decisione del febbraio scorso.
Il conto
economico delle P.A. ed il Sistema europeo dei conti
Il Protocollo sui disavanzi eccessivi annesso al Trattato ed
il Patto di stabilità e crescita prende in considerazione, ai fini della
verifica di sostenibilità delle finanze pubbliche, due parametri, il rapporto
rispetto al PIL dell’indebitamento netto e del debito, entrambi riferiti al
settore delle amministrazioni pubbliche.
Tale settore comprende, in Italia, le amministrazioni
centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza ed assistenza (v. schema).
I sottosettori della P.A. elaborati dalla contabilità
nazionale trovano sostanziale corrispondenza negli analoghi aggregati di enti
pubblici utilizzati nella contabilità pubblica (settore statale e settore
pubblico). Il diverso criterio di classificazione[229] porta
ad alcune, peraltro limitate, differenze con riferimento ad alcuni enti minori
delle amministrazioni locali.
Le informazioni
relative ai sottosettori vengono rielaborate dall’Istat e consolidate nel conto
della P.A. secondo principi e regole contabili conformi al Sistema europeo dei
conti nazionali (Sec95).
Il Sec95 detta, infatti, una serie di regole necessarie per
l’armonizzazione dei dati riferiti alla contabilità nazionale degli Stati
membri, che assicurano la comparabilità delle informazioni relative alla
contabilità nazionale e regionale.
Tali regole implicano la registrazione dei flussi secondo il
principio della competenza economica (cosiddetto principio accrual[231]),
in base al quale un’operazione è considerata dal punto di vista contabile nel
momento in cui si realizza il fatto economico e gestionale sottostante. In
alcuni casi, come ad esempio per alcune voci della spesa in conto capitale,
come dato più prossimo al criterio della competenza economica si utilizza la
cassa.
Si tratta quindi di regole sostanzialmente diverse da quelle
che presiedono, nel nostro Paese, alla registrazione dei flussi nel bilancio
dello Stato e della maggior parte degli enti pubblici, che adottano invece una
contabilità di carattere finanziario, basata sulla rappresentazione dei dati di
entrata e di spesa in termini di competenza giuridica e di cassa.
Sempre con riferimento
al settore della P.A., ed in base alla metodologia del SEC 95, viene calcolato
(dalla Banca d’Italia) lo stock del debito pubblico, che rappresenta il valore
nominale di tutte le passività lorde,
al netto delle attività detenute dal settore nei confronti di soggetti esterni,
in essere in un determinato momento.
Entro il 1° aprile
ed il 1° ottobre di ogni anno, l’Istat notifica alla Commissione UE - ai fini
del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e del rispetto degli
obiettivi del Patto di stabilità e di crescita - le stime aggiornate del
prodotto interno lordo, dell’indebitamento netto e del debito delle P.A. per
l’esercizio già concluso, nonché le revisioni apportate ai dati riferiti agli
esercizi precedenti.
Sono inoltre trasmesse le previsioni (elaborate dal Ministero dell’Economia e
finanze) per l’esercizio in corso.
Particolare rilievo
ai fini delle decisioni di finanza pubblica assumono gli andamenti relativi sia
al conto economico delle pubbliche amministrazioni, i cui risultati
differenziali sono presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto
dei parametri europei, che al bilancio dello Stato e al settore statale.

Per quanto riguarda
il bilancio dello Stato – il cui saldo (SNF) è oggetto di approvazione
specifica nell’ambito della legge finanziaria e nella legge di bilancio - è,
infatti, da osservare che, nonostante l’avvio del processo di federalismo
fiscale, esso gioca ancora un ruolo importante all’interno del conto
complessivo della P.A., sia per quanto riguarda il volume di risorse
direttamente gestite, che per quelle che dal bilancio vengono trasferite ad
altri soggetti, ed in particolare a regioni ed enti locali. Le spese iscritte
nel bilancio dello Stato pesano, infatti, per oltre il 57 per cento sulle
uscite complessive delle P.A. (34% al netto dei trasferimenti a enti pubblici).
Per quanto riguarda
il settore statale, l’andamento del relativo saldo di cassa, il fabbisogno,
consente di monitorare in corso d’anno la tenuta del controllo dei conti
pubblici e le variazioni indotte nello stock del debito.
Nel dossier si dà
conto dell’andamento di tali saldi e delle loro principali determinanti,
mettendo in evidenza le cause degli scostamenti, rispettivamente, tra
indebitamento e fabbisogno, e tra questo saldo e le variazioni che si
registrano nello stock del debito, cui è dedicata una specifica analisi.
I saldi del
conto economico delle Pubbliche amministrazioni
Le informazioni
principali del conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni sono
sintetizzate da alcuni indicatori (indebitamento netto, saldo primario, saldo
corrente, pressione fiscale), la cui analisi consente una rappresentazione dei
conti pubblici, della loro recente evoluzione e dei valori previsti per l’anno
in corso ed il successivo triennio.
Gli andamenti dei
saldi sono poi messi a confronto sia con i corrispondenti valori strutturali,
rispetto ai quali il Patto di stabilità e crescita impone specifici requisiti,
sia con i valori indicati in sede di previsione, evidenziandone gli
scostamenti.
Nelle pagine che
seguono si dà conto dell’evoluzione dei saldi complessivi, rinviando per
un’analisi più approfondita delle determinanti delle entrate e delle spese alla
parte “Andamenti di finanza pubblica - Approfondimenti settoriali”.
In tali analisi, per
gli anni di consuntivo, sono utilizzati (salvo diversa indicazione) i dati
Istat, elaborati secondo i criteri del Sec95, del 29 febbraio scorso nonché
quelli contenuti nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese,
presentata il 22 aprile; per il 2008 ed il successivo triennio 2009-2011 si fa,
invece, riferimento ai dati di previsione contenuti dalla Relazione unificata
sull’economia e la finanza pubblica del 12 marzo (RUEF).
L’indebitamento netto misura la differenza
tra le entrate e le uscite complessive del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche e rappresenta uno dei parametri di riferimento del
Trattato e del Patto di stabilità e crescita. Le entrate e le uscite che
concorrono alla formazione del saldo sono definite generalmente sulla base
delle grandezze di competenza economica, avendo cioè riguardo al momento
economico dell’operazione piuttosto che alla sua regolazione finanziaria. In alcuni casi, come ad esempio per alcune
voci della spesa in conto capitale, quale proxy
del criterio della competenza economica si utilizza la cassa.
L’evoluzione dell’indebitamento netto,
misurato in percentuale del PIL è riportata nella tavola e nella figura
seguenti. Nel grafico gli istogrammi rappresentano il saldo complessivo, mentre
le due linee rappresentano le due componenti, rispettivamente il saldo primario
(che misura la differenza tra le entrate complessive e le uscite totali al
netto della spesa per interessi) e gli interessi passivi.

|
Indebitamento netto
(%PIL)
|
|
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Indebitamento netto
|
2,7
|
2,8
|
1,7
|
0,8
|
3,1
|
2,9
|
3,5
|
3,5
|
4,2
|
3,4
|
1,9
|
|
Saldo primario
|
6,6
|
5,1
|
4,9
|
5,5
|
3,2
|
2,7
|
1,6
|
1,2
|
0,3
|
1,3
|
3,1
|
|
Interessi passivi
|
9,3
|
7,9
|
6,6
|
6,3
|
6,3
|
5,5
|
5,1
|
4,7
|
4,5
|
4,6
|
5,0
|
Fonte: Istat
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Indebitamento netto
|
2,4
|
2,1
|
1,7
|
1,4
|
|
Saldo primario
|
2,6
|
2,8
|
3,1
|
3,4
|
|
Interessi passivi
|
5,0
|
4,9
|
4,9
|
4,8
|
Fonte:
RUEF
Come si vede, il
rapporto indebitamento netto/PIL, sceso al di sotto della soglia del 3 per
cento nel 1997 (rispetto a valori superiori al 10% registrati fino all’inizio
degli anni ‘90), anno rilevante ai fini della verifica dei requisiti per
l’ammissibilità all’Unione economica e monetaria fin dalla prima fase, subisce
una sensibile riduzione fino al 2000,
per poi tornare, fin dal 2001, ad attestarsi su valori superiori al 3%. Tale
andamento
comporta, nel luglio 2005, l’apertura della procedura sui disavanzi eccessivi
nei confronti dell’Italia.
L’aumento
dell’indebitamento netto in tali anni si verifica in presenza di una riduzione
costante dell’avanzo primario, che non
consente quindi di sfruttare i margini offerti dalla riduzione della spesa per
interessi, che diminuisce in valore assoluto e che, tra il 1997 e il 2005,
riduce di ben 4,7 punti il suo peso rispetto al PIL. In un contesto di bassa
inflazione e di riduzione dei tassi europei, la mutata e più favorevole percezione dei mercati circa la sostenibilità
del debito in seguito all’adesione dell’Italia alla UEM consente, in questi
anni, una rapida discesa dei tassi sui titoli del debito pubblico.
Nel 2006-2007, si
determina un sensibile miglioramento dei conti, con una riduzione
dell’indebitamento netto pari a 2,3 punti di PIL, interamente ascrivibile al
miglioramento del saldo primario, a fronte di una ripresa della spesa per
interessi.
Per il 2008, secondo
le stime contenute nella RUEF, l’indebitamento netto dovrebbe attestarsi su un
valore del 2,4% rispetto al PIL, quale risultato di un avanzo primario pari al
2,6% e di un onere per il servizio del debito pari al 5% del PIL.
Si evidenzia quindi un peggioramento del saldo complessivo
di 0,5 punti rispetto al 2007, anno in cui si è registrato un valore
estremamente contenuto dell’indebitamento netto (1,9 per cento del PIL), e di
0,2 punti rispetto alle precedenti previsioni per il 2008 contenute nella
Relazione previsionale e programmatica e nell’Aggiornamento del programma di
stabilità, presentati a novembre.
Il peggioramento rispetto alle stime della RPP (0,2 punti) è
determinato, secondo la RUEF, dalla correzione al ribasso della crescita
dell’economia reale (dall’1,5 allo 0,6%), e dallo slittamento di minori entrate
(tra cui la riduzione del cuneo fiscale) e maggiori spese (tra cui la chiusura
dei rinnovi contrattuali 2006-2007 e il “bonus incapienti”) autorizzate
nell’ultimo trimestre dello scorso anno.
Tali effetti peggiorativi dei saldi sono, in parte, compensati dal
trascinamento strutturale delle maggiori entrate e dal contenimento della spesa
primaria registrati nel 2007.
Nel successivo triennio 2009-2011, il quadro tendenziale
evidenzia una progressiva diminuzione dell’indebitamento netto, che si colloca
all’1,4 per cento del PIL a fine periodo, a fronte di una lieve riduzione della
spesa per interessi (appena due decimi di punto) e di un aumento dell’avanzo
primario di circa 0,8 punti di PIL.
E’ da
rilevare peraltro che, trattandosi di una previsione a legislazione vigente,
essa non tiene conto delle maggiori spese che, per prassi consolidate, vengono
annualmente autorizzate con la legge finanziaria (ad es. i rinnovi contrattuali
relativi al biennio 2008-2009, o il rifinanziamento di alcune spese in conto
capitale), il cui importo complessivo è stimato dalla RUEF in circa 3-4
miliardi l’anno.
Il quadro
programmatico contenuto nella RUEF indica un valore dell’indebitamento netto
pari all’1,8 per cento del PIL nel 2009, all’1 per cento nel 2010 e allo 0,2
per cento nel 2011. Il raggiungimento di tali valori-obiettivo comporta una
manovra strutturale di importo crescente (da 0,3 punti di PIL nel 2009 a 0,5
punti nel 2011), corrispondenti ad una correzione netta di circa 20 miliardi
nel triennio. A tale importo occorre aggiungere i 10-12 miliardi derivanti
dalle maggiori spese relative a prassi consolidate, che comportano una manovra
lorda pari a complessivi 30-32 miliardi.
Tale evoluzione evidenzia un peggioramento nel triennio in
termini di obiettivi rispetto al quadro programmatico contenuto nella Relazione
previsionale e programmatica, confermato dall’Aggiornamento del Programma di
stabilità del novembre scorso, che indicava un indebitamento netto che passava
dall’1,5% nel 2009 e allo 0,7 nel 2010, per poi azzerarsi nel 2011.
Al riguardo, nella RUEF, si specifica che “il nuovo quadro
programmatico deve necessariamente tenere conto delle condizioni economiche
correnti: (…) l’attuale significativo rallentamento suggerisce di non
intervenire con una politica che possa ulteriormente appesantire la congiuntura
economica nel breve periodo”. In tale contesto, secondo quanto precisato nella
RUEF, gli obiettivi vanno stabiliti in termini strutturali (al netto cioè degli
effetti delle misure una tantum e del
ciclo economico). La politica economica dovrà pertanto impostare
l’aggiustamento strutturale, lasciando agire liberamente gli stabilizzatori
economici. Questi ultimi, infatti, evidenziano un peggioramento, ma più
contenuto rispetto ai saldi nominali.
|
2008-2011-
Quadro tendenziale e programmatico
|
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
RUEF (marzo 08)
|
|
|
|
|
|
Indebitamento tendenziale
a legislazione vigente
|
-2,4
|
-2,1
|
-1,7
|
-1,4
|
|
Manovra netta (in valore)
Manovra netta (in %PIL)
|
|
4.500
0,3
|
6.500
0,4
|
9.500
0,5
|
|
Indebitamento programmatico
|
-2,4
|
-1,8
|
-1,0
|
-0,2
|
|
Indebitamento strutturale
|
-2,2
|
-1,5
|
-0,7
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Aggiornamento Programma stabilità (nov. 07)
|
|
|
|
|
|
Indebitamento programmatico
|
-2,2
|
-1,5
|
-0,7
|
0,0
|
|
Indebitamento strutturale
|
-2,1
|
-1,3
|
-0,6
|
0,1
|
Fonte: RUEF
Il saldo primario
misura la differenza tra le entrate complessive delle amministrazioni pubbliche
e le uscite al netto degli interessi passivi. Esso costituisce uno dei
principali fattori che concorrono alla variazione annua del debito pubblico e
assume, pertanto, una particolare valenza ai fini delle analisi di
sostenibilità.
In termini
programmatici, essendo il saldo primario una grandezza che il Governo è in
grado di controllare, è possibile calcolarne il valore che, in relazione ad un
determinato stock di debito, e dati
il tasso di interesse di mercato ed il tasso di crescita dell’economia
(variabili non controllabili dall’Autorità fiscale), consente di raggiungere
l’obiettivo atteso in termini di debito pubblico.
La composizione del
saldo primario è distinta in saldo corrente primario, ossia la differenza tra
entrate correnti e spese correnti al netto degli interessi passivi, e saldo in
conto capitale (differenza tra entrate e uscite in conto capitale).
La tavola ed grafico
di seguito riportati ne evidenziano l’andamento effettivo e atteso, rispettivamente, nel decennio 1997-2007, e
nel periodo 2008-2011.

|
Saldo
primario
(%PIL)
|
|
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Saldo
primario
|
6,6
|
5,1
|
4,9
|
5,5
|
3,2
|
2,6
|
1,6
|
1,2
|
0,3
|
1,2
|
3,1
|
|
Saldo
corrente
|
9,0
|
8,2
|
8,3
|
7,7
|
7,1
|
5,8
|
4,3
|
4,3
|
4,0
|
5,9
|
7,3
|
|
Saldo
c/capitale
|
-2,4
|
-3,1
|
-3,4
|
-2,2
|
-3,9
|
-3,2
|
-2,7
|
-3,1
|
-3,7
|
-4,7
|
-4,2
|
Fonte: Istat
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Saldo primario
|
2,6
|
2,8
|
3,1
|
3,4
|
|
Saldo corrente
|
6,4
|
6,8
|
6,9
|
7,0
|
|
Saldo c/capitale
|
-3,8
|
-4,0
|
-3,8
|
-3,5
|
Fonte: RUEF
La riduzione del
saldo primario osservata nella prima parte del periodo in esame è ascrivibile
alla contrazione del saldo corrente, che si riduce di 5 punti di PIL tra il
1997 e il 2005, a fronte di una sostanziale stabilità del disavanzo di parte
capitale che, grazie anche agli introiti dei condono fiscali e delle
dismissioni immobiliari – contabilizzati con segno positivo tra gli
investimenti fissi lordi (come disinvestimenti) – oscilla intorno a una media
del 3,1 per cento del PIL.
Nel biennio 2006-2007,
i dati evidenziano un’inversione di tendenza, con un aumento del saldo corrente
al netto degli interessi che cresce di oltre 3 punti in termini di PIL, a
fronte di un peggioramento, peraltro più contenuto (0,5 punti di PIL), del
disavanzo di parte capitale.
Come si vedrà dalle
analisi successive, il positivo andamento dell’avanzo corrente è ascrivibile
sia al forte aumento delle entrate registrato in ciascuno dei due anni in
esame, che da una dinamica più contenuta della spesa primaria. Per quanto
riguarda il saldo di parte capitale, è da notare che su di esso incidono oneri
straordinari – contabilizzati tra le maggiori spese in conto capitale – pari a circa 14,4 miliardi nel 2006 e a 6
miliardi nel 2007.
Nel 2008, la
riduzione di 0,5 punti dell’avanzo primario rispetto al risultato 2007 (dal 3,1
al 2,6 per cento del PIL) è spiegata dalla riduzione dell’avanzo corrente solo
parzialmente compensata dalla riduzione del disavanzo di parte capitale.
Per quanto riguarda
il triennio di previsione 2009-2011, in base ai dati contenuti nella RUEF si
evidenzia un miglioramento del saldo primario pari al 3,4 per cento del PIL a
fine periodo, a fronte di un’ulteriore crescita dell’avanzo corrente (7% del
PIL) e di una riduzione del disavanzo in conto capitale (3,5 % del PIL).
Come sopra ricordato con riferimento all’indebitamento
netto, tale evoluzione tiene conto degli andamenti del quadro tendenziale a
legislazione vigente e non incorpora, quindi, le maggiori spese che per prassi
consolidate vengono annualmente autorizzate in sede di legge finanziaria. La
RUEF, inoltre, non reca informazioni circa gli andamenti programmatici di tali
saldi, limitandosi ad indicare il valore relativo all’indebitamento netto.
I saldi
strutturali
Nell’ambito delle
procedure di valutazione degli impegni assunti dai singoli Stati membri con il
Patto di Stabilità e Crescita e delle procedure di sorveglianza per il rispetto
dei parametri di bilancio fissati con il Trattato di Maastricht, una valenza
particolare ha assunto, con la revisione del Patto nel 2005, il livello e
l’evoluzione dell’indebitamento netto strutturale delle amministrazioni
pubbliche. Il saldo così definito è pari all’indebitamento netto corretto per
gli effetti del ciclo economico sulle componenti di bilancio e per gli effetti
delle misure una tantum, che influiscono solo temporaneamente sull’andamento del
disavanzo.
Il saldo corretto
per il ciclo (cyclically adjusted balance,
CAB) misura il saldo del settore delle pubbliche amministrazioni al netto
dell'impatto delle fluttuazioni economiche. Esso consente di distinguere le
variazioni automatiche di entrata e spesa rispetto alla componente
discrezionale di politica fiscale, e di valutare il carattere espansivo o restrittivo
di questa.
Le misure degli indicatori strutturali si
basano, quindi, sull’identificazione della componente ciclica del saldo,
definita come il prodotto tra la stima della sensibilità al ciclo delle entrate
e delle spese correnti e la misura della deviazione dell’economia dal suo
livello potenziale (output gap). Per
ottenere il saldo strutturale, la componente ciclica viene sottratta al rapporto indebitamento netto/PIL.
Sulla determinazione
dell'indebitamento strutturale risulta, quindi, determinante sia il calcolo
della elasticità,
che il segno e l'ampiezza dell'output gap,
calcolato come scarto tra PIL effettivo e PIL potenziale
in un determinato periodo (rapportato al PIL potenziale).
Il PIL potenziale
non è direttamente osservabile, ma risulta, secondo la metodologia approvata
dall’Ecofin e utilizzata dagli Stati membri per il calcolo degli indicatori
strutturali richiesti dal Programmi di stabilità, dalla stima statistica
prodotta utilizzando sia i valori effettivamente registrati a consuntivo negli
anni precedenti, sia il valore del PIL atteso nel periodo di previsione.
Da ciò derivano due
particolarità: i) difficilmente il calcolo del PIL potenziale è in grado di
cogliere a pieno i punti di inversione del ciclo e gli effetti dei cambiamenti
strutturali; ii) la variazione del valore atteso del PIL per il periodo di
previsione o le modifiche indotte da revisioni contabili rispetto ai dati di
consuntivo determinano una revisione dell’intera serie storica dell’output gap anche negli anni in cui non
si è verificata alcuna variazione nella crescita effettiva (o attesa).
A parità di
parametro relativo alla sensibilità del bilancio al ciclo e di valore
dell’indebitamento netto effettivo (o atteso), si verifica pertanto una
variazione nel saldo strutturale.
L’introduzione delle
misure una tantum e temporanee nella
correzione del saldo strutturale ha lo scopo di garantire un’analisi obiettiva
e trasparente degli sviluppi di finanza pubblica dei Paesi membri e incentivare
il perseguimento di politiche di riduzione del deficit pubblico con misure
strutturali, aventi effetti di natura permanente sulla correzione dei
disavanzi.
Come specificato nel nuovo Codice di
condotta, si definiscono una tantum e
temporanee quelle misure che hanno un impatto transitorio sui saldi di bilancio
e non apportano variazioni significative all’evoluzione di lungo periodo della
finanza pubblica.
Tale indicazione lascia comunque
aperta la possibilità ad ampi margini di interpretazione che necessariamente
richiedono almeno una prima, seppure indicativa, individuazione di linee guida.
La
Commissione europea in proposito ha specificato alcune caratteristiche che possono
identificare gli interventi una tantum:
-
le
misure devono incidere sui saldi di bilancio, effettivo e strutturale, solo in
modo temporaneo, con un effetto sull’indebitamento netto concentrato in un solo
anno o, al più, esteso ad un numero limitato di anni;
-
le
misure non devono essere ricorrenti.
Inoltre, la
Commissione prevede la distinzione tra interventi che comportano una riduzione del
disavanzo pubblico e quelli che, al contrario, inducono un peggioramento del
saldo di bilancio.
I primi includono: condoni con
pagamenti una tantum (come ad esempio
il caso dello scudo fiscale introdotto in Italia); vendita e dismissione del
patrimonio non finanziario (come la vendita delle concessioni UMTS); modifiche
legislative di carattere temporaneo che comportano variazioni nei tempi di
pagamenti o incassi con un effetto di miglioramento dell’indebitamento netto;
entrate di natura straordinaria collegate al trasferimento di obblighi
pensionistici; proventi da operazioni di cartolarizzazione; entrate
straordinarie per lo Stato derivanti da dividendi di società partecipate;
variazioni di entrata o di spesa derivanti da sentenze giuridiche o della
Commissione.
Tra le seconde misure sono da
includere: spese di carattere eccezionale ed erogate solo per brevi periodi
connesse all’insorgere di catastrofi naturali o altre emergenze; variazioni di
entrata o di spesa derivanti da sentenze giuridiche o della Commissione.
Nell’aggiornamento annuale del
Programma di stabilità,
ogni paese deve fornire le informazioni necessarie ad identificare gli
interventi (programmati e di recente applicazione) con effetti transitori e
quantitativamente rilevanti, sul saldo di bilancio.
Come si vede dalla
tavola relativa all’indebitamento netto strutturale del biennio 2006-2007 (cfr infra), l’effetto delle misure una tantum, e delle loro
riclassificazioni, hanno influenzato in misura rilevante gli stessi risultati
di bilancio e le previsioni sull’indebitamento netto.
In questo senso,
particolarmente evidente risulta nel 2006 l’effetto della riclassificazione che
ha compiuto l’Istat nel febbraio 2008, in accordo con Eurostat, relativamente ai rimborsi
Iva sulle auto aziendali dovuti in seguito alla sentenza della Corte di
giustizia europea del settembre 2006. In seguito a tale riclassificazione, tali
uscite, in precedenza contabilizzate tra le maggiori spese in conto capitale,
non concorrono più alla formazione dell’indebitamento netto e risultano, di
conseguenza, escluse anche dal computo delle misure una tantum.
Di conseguenza,
l’indebitamento netto effettivo è stato rivisto al ribasso per un punto di PIL
(dal 4,4 al 3,4 per cento del PIL), mentre le una tantum sono state rideterminate in -0,5 per cento del PIL
rispetto alla precedente stima di -1,2.
|
Misure una tantum 2006
|
Stime
11/07
|
Stime
02/08
|
|
|
Milioni
euro
|
%PIL
|
%PIL
|
|
Una tantum spese
|
|
-1,7
|
-1
|
|
-
Rimborsi Iva auto
-
Accollo debiti FS
-
Retrocessione crediti agricoli
-
Gestori telecomunicazioni
|
15.982
12.950
734
700
|
-0,7*
-0,9
-0,04
-0,04
|
-
-0,9
-0,04
-0,04
|
|
Una tantum entrate
|
|
0,5
|
0,5
|
|
-
Entrate una tantum
-
Dismissioni immobiliari
|
5.881
1.683
|
0,4
0,1
|
0,4
0,1
|
|
Totale una tantum
|
|
-1,2
|
-0,5
|
*Relativamente agli effetti della
sentenza Iva, è stata contabilizzata tra le una
tantum soltanto la quota relativa al debito pregresso (circa lo 0,7 per
cento del PIL), in quanto la parte residua (circa lo 0,3 per cento del PIL) è
stata considerata come un aggravio strutturale.
N.B. Le una tantum costituite da maggiori spese hanno convenzionalmente il segno meno in quanto, ai fini del
calcolo dell’indebitamento strutturale, si portano in riduzione
dell’indebitamento netto effettivo.
La principale revisione, in termini quantitativi, introdotta
con il comunicato Istat sui conti pubblici diffuso a febbraio 2008 ha riguardato la
contabilizzazione, nel 2006, dell’onere straordinario previsto dallo Stato per
il rimborso dell’IVA sulle auto aziendali in seguito alla sentenza della Corte
di giustizia, inizialmente stimato in circa 16 miliardi di euro (17,2 miliardi
di rimborsi di IVA meno 1,2 miliardi di recupero di imposte dirette).
La metodologia seguita nella versione provvisoria dei conti
era stata quella di considerare come momento di registrazione la data della
sentenza e di procedere ad una stima indiretta del potenziale numero dei
contribuenti e del potenziale importo da rimborsare, nel presupposto che tutti
gli aventi diritto presentassero istanza di rimborso.
L’emanazione di alcuni provvedimenti normativi (es.
introduzione del regime forfetario) e il numero limitato delle istanze di
rimborso presentate nel corso del 2007 hanno determinato la probabilità di un
sensibile ridimensionamento dell’onere dello Stato. Per cui, in accordo con
Eurostat, è stato deciso di adottare una metodologia statistica diretta, già
utilizzata per gli altri tipi di rimborsi di imposte, in base alla quale il
debito dello Stato viene registrato nel momento della validazione delle istanze
di rimborso in seguito allo spoglio da parte dell’amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, è stato eliminato dal conto economico 2006
l’onere straordinario pari a circa 16
miliardi, mentre la prima contabilizzazione dei rimborsi IVA sulle auto
aziendali è stata effettuata nel conto del 2007, riferita alle sole istanze
presentate in via telematica con il regime forfetario, pari a 847 milioni di
euro.
Il rimanente onere sarà registrato negli anni successivi,
man mano che l’amministrazione finanziaria controllerà e validerà le istanze di
rimborso con regime analitico, la cui presentazione scadrà nel novembre 2008.
Data tale scadenza, nel quadro tendenziale contenuto nella RUEF, non viene
scontato alcun rimborso nel 2008, mentre per il triennio 2009-2011 viene
ipotizzato un rimborso di 400 milioni annui.
Per quanto riguarda
il 2007, la riclassificazione dei rimborsi IVA determina una revisione in
aumento delle uscite una tantum per
847 milioni, cui si aggiungono 234 milioni per il ripiano di debiti verso Poste
s.p.a per agevolazioni tariffarie all’editoria e 4,9 miliardi derivanti dalla cancellazione dell’acconto
dei concessionari alla riscossione, con un’incidenza complessiva sul PIL dello
0,4 per cento. Le misure una tantum
per tale anno, pari inizialmente a 0,2 punti di PIL derivanti da maggiori
entrate straordinarie, si rideterminano quindi in -0,2 punti di PIL, da portare
in diminuzione dell’indebitamento effettivo.
Non sono, invece,
attese variazioni rispetto ai dati indicati nella RPP e nell’Aggiornamento del
Programma di stabilità presentato lo scorso novembre per quanto riguarda le una tantum relative al 2008 e al biennio
2009-2011, attribuibili al programma di dismissioni (1 miliardo di euro in
ciascun anno, pari a circa lo 0,1 per cento del PIL).
|
Misure una tantum 2007
|
Stime
11/07
|
Stime
02/08
|
|
|
Milioni
euro
|
%PIL
|
Milioni
euro
|
%PIL
|
|
Una tantum spese
|
-
|
-
|
|
-0,39
|
|
-
Rimborsi Iva auto
-
Cancellazione acconto
concessionari
-
Ripiano debiti verso Poste SpA
per agevolazioni tariffarie editoria
|
-
-
-
|
-
-
-
|
0,847
4.939
0,234
|
-0,05
-0,32
-0,02
|
|
Una tantum entrate
|
|
0,16
|
|
0,16
|
|
-
Entrate una tantum
-
Dismissioni immobiliari
|
1.100
1.437
|
0,07
0,09
|
1.100
1.437
|
0,07
0,09
|
|
Totale una tantum
|
|
0,16
|
|
-0,22
|
Come si evidenzia
dalla tavola di seguito riportata, l’indebitamento netto strutturale si riduce
sensibilmente nel biennio 2006-2007, passando dal 2,9 per cento nel 2006 (4,5%
nel 2005) all’1,6 per cento nel 2007.
Tale variazione si determina in
presenza di: una sensibile riduzione dei valori registrati a consuntivo
dall’indebitamento netto rispetto alle previsioni iniziali; un andamento dell’economia che cresce più rapidamente del
previsto nel primo anno (dall’1,6% previsto a dicembre 2006 all’1,8% registrato
a consuntivo) per poi rallentare nel secondo (dal 2% previsto a giugno 2007
all’1,5% effettivo), con un conseguente effetto sulla componente ciclica del
saldo di bilancio; una variazione significativa nell’entità e nel segno delle
misure una tantum, anche per effetto
delle intervenute riclassificazioni Istat (cfr
infra).
La variazione conseguita
tra il 2006 e il 2007 consente di rispettare gli impegni assunti con l’Europa
rispetto al sentiero di rientro dal deficit eccessivo concordato e risulta di
dimensioni ben più elevate di quelle assunte dalla stessa riduzione misurata in
media europea: secondo le ultime stime della Commissione europea,
la riduzione dell’indebitamento netto negli anni 2006-2007 ammonta per l’Italia
a 2,2 punti percentuali contro l’1,1 per cento per l’intera Europa e l’1,3 per
cento per l’Area euro a 15 paesi.
Per il 2008, la RUEF prevede un indebitamento netto strutturale
pari al 2,2 per cento, in aumento rispetto al risultato conseguito l’anno
precedente (1,6 per cento del PIL).
Rispetto alle previsioni contenute
nella RPP e nell’Aggiornamento del Programma di stabilità presentati a novembre
2007, dal miglioramento inizialmente previsto pari a 0,2 punti di PIL (dal 2,3
al 2,1 per cento) si passa ad un peggioramento di 0,6 punti.
Secondo quanto specificato dalla
RUEF, il peggioramento nell’anno in corso è dovuto essenzialmente allo
slittamento di maggiori oneri che migliorano il risultato 2007 peggiorando
quello 2008 per circa 0,2 punti di PIL. Il saldo strutturale tiene conto,
inoltre, di una revisione del PIL potenziale di 0,1 punti quale effetto della
minore crescita. Resta invariata per tale anno la stima delle una tantum.
|
Variazione nella
stima dell’indebitamento netto strutturale
|
2007
|
2008
|
|
Indebitamento netto strutturale RPP (nov. 2007)
|
-2,3
|
-2,1
|
|
Variazione
indebitamento netto nominale
|
0,5
|
-0,2
|
|
Revisione PIL
potenziale
|
-0,2
|
0,1
|
|
Revisione misure una
tantum
|
0,4
|
0,0
|
|
Indebitamento netto strutturale RUEF (marzo 2008)
|
-1,6
|
-2,2
|
Fonte: RUEF
Nel successivo
triennio, in considerazione di una manovra correttiva pari complessivamente a
1,2 punti di PIL, è prevista, secondo la RUEF, una riduzione dell’indebitamento netto
strutturale che passa all’1,5 per cento del PIL nel 2009, allo 0,7 per cento
nel 2010 per annullarsi del 2011.
A fronte di una
correzione dello 0,7 per cento annuo, sostanzialmente identica a quella
indicata in precedenza dalla RPP e dall’Aggiornamento del Programma di
stabilità, in presenza di valori più
elevati dell’indebitamento nominale programmatico si determina un aumento nel
saldo strutturale, rispetto alla precedente stima, di due decimi di punto nel
2009 e di un decimo di punto nel 2011.
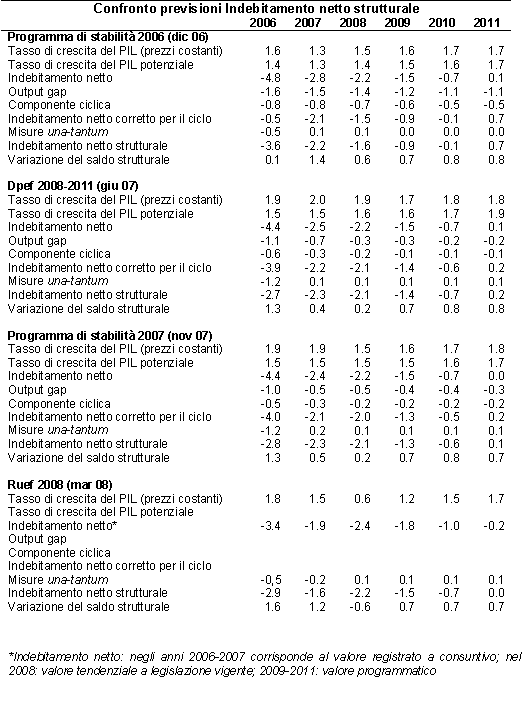
Le manovre di
finanza pubblica
Nel corso della XV legislatura sono stati adottati
molteplici interventi normativi finalizzati ad incidere sui saldi di finanza
pubblica. Un’analisi limitata alle sole manovre attuate con le leggi finanziare
non risulterebbe pertanto sufficiente ad illustrare l’azione complessiva di
politica economica della legislatura trascorsa che viene in questa sede
esaminata con riferimento al complesso degli interventi attuati nel corso del
ciclo di bilancio dei singoli esercizi.
Si tralascia in questa sede l’analisi settoriale
dell’intervento pubblico, focalizzando invece l’attenzione, per ciascun
intervento, su due aspetti:
§
l’incidenza
sui saldi di finanza pubblica. Il segno e la dimensione della correzione
apportata da ciascun intervento ai saldi, identifica l’orientamento prioritario
dell’intervento pubblico: nel caso di manovre che peggiorano il deficit (cd manovre espansive) infatti si evidenza
un’attribuzione di priorità all’azione di sostegno all’economia, anche al
prezzo di peggiorare il bilancio del settore pubblico; viceversa, nel caso
opposto di manovre che riducono il deficit (cd. manovre restrittive), si evidenza l’obiettivo di miglioramento dei
saldi di finanza pubblica, anche al costo di assorbire risorse dall’economia
privata;
§
l’incidenza
sulla composizione delle entrate e delle spese. Tale elemento informa in merito
alla modifica operata dalle manovre sulla dimensione del bilancio pubblico.
Indipendentemente dal suo intervento sul saldo di bilancio, infatti, ciascuna
manovra può prevedere un aumento oppure una riduzione complessiva delle entrate
e delle spese della pubblica amministrazione: nel primo caso si determina
un’espansione della dimensione del settore pubblico, nel secondo caso, al
contrario, la misura dell’intervento pubblico si riduce.
I due aspetti sopra evidenziati verranno in questa sede
esaminati con riferimento al Conto consolidato della Pubblica amministrazione,
il cui saldo, indebitamento netto, costituisce il parametro fondamentale cui si
applicano i vincoli imposti in sede europea dal Patto di stabilità e crescita[246].
Pur nella sua brevità, la legislatura trascorsa può essere
più efficacemente descritta se analizzata in due fasi:
§
la prima, di carattere restrittivo, caratterizzata da un’attribuzione di
priorità all’obbiettivo di miglioramento dei saldi: in tale fase pertanto gli
interventi attuati operano una riduzione del deficit;
§
la seconda, di carattere espansivo, caratterizzata dall’attribuzione di priorità
alla funzione di sostegno all’economia: in tale fase sono posti in essere
interventi che peggiorano il deficit.
Dopo una sintetica descrizione delle due fasi, sarà operata
una valutazione di sintesi dell’azione complessiva attuata nella legislatura.
I dati utilizzati nell’analisi, salvo diversamente indicato,
sono quelli tratti dalle relazioni tecniche allegate ai diversi provvedimenti.
La legislatura si è aperta in una situazione che vedeva la
pendenza di una procedura per disavanzo eccessivo a carico dell’Italia il cui
deficit era risultato superiore alla soglia ammessa dal Trattato europeo in 4
degli ultimi 5 esercizi[247]
conclusi. Inoltre, a partire dal 2001[248], le
previsioni formulate nei DPEF di ciascun anno si erano rivelate eccessivamente
ottimistiche alla luce dei risultati effettivamente conseguiti. Tali elementi
sono stati alla base della valutazione di priorità attribuita all’obiettivo di
risanamento della finanza pubblica nella prima fase della legislatura.
Di seguito si riporta un grafico che illustra le previsioni
presentate nel primo DPEF della legislatura,[249] in
merito all’evoluzione attesa del deficit in assenza di interventi correttivi da
parte del governo[250],
posta a confronto con il percorso di rientro del deficit concordato in sede
europea nell’ambito della procedura di rientro dal disavanzo eccessivo:
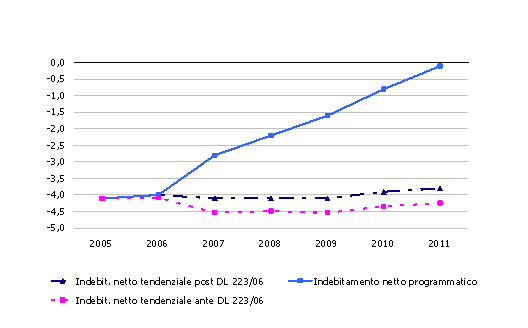
Il grafico mostra come si ritenesse che il deficit tendenziale
sarebbe rimasto largamente oltre la soglia ammessa del 3%. Per tale ragione,
contestualmente al DPEF, venne disposto un primo immediato intervento
correttivo – il DL n. 223/06, recante un effetto correttivo del deficit pari a
circa 0,4 punti di PIL annui a decorrere dal 2007[251] - e
definita la dimensione della manovra da attuare per il 2007, la cui entità fu
fissata in 1,3 punti percentuali di PIL.
La Nota di aggiornamento al DPEF ‘07, presentata nel
settembre 2006, operò una prima rettifica dell’andamento tendenziale del
deficit, previsto nel precedente mese di giugno, al fine di tenere conto
dell’incremento inatteso del gettito tributario e contributivo[252].
In considerazione del miglioramento del deficit tendenziale, venne inoltre
ridotta all’1 per cento del PIL l’entità della manovra correttiva per il 2007,
rispetto all’importo indicato nel DPEF (1,3% del PIL).
La tabella seguente sintetizza gli effetti di tali
interventi:
(mln di euro)
|
Fase
restrittiva
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
DL
n. 223/2006
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
1.238
|
6.585
|
6.015
|
7.087
|
|
Manovra
sulla spesa
|
-2.353
|
702
|
764
|
906
|
|
Manovra
sull'entrata
|
3.591
|
5.883
|
5.251
|
6.181
|
|
Manovra
2007[253]
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
-12.916
|
14.016
|
11.135
|
13.649
|
|
Manovra
sulla spesa
|
-12.916
|
-3.612
|
-2.579
|
-2.384
|
|
Manovra
sull'entrata[254]
|
|
17.628
|
13.714
|
16.033
|
|
Effetto complessivo degli
interventi
|
-11.678
|
20.601
|
17.150
|
20.736
|
|
In
percentuale del PIL
|
-0,8
|
1,3
|
1,1
|
1,2
|
|
Manovra
sulla spesa
|
-15.269
|
-2.910
|
-1.815
|
-1.478
|
|
Manovra
sull'entrata
|
3.591
|
23.511
|
18.965
|
22.214
|
Segno meno = peggioramento
Il segno positivo degli interventi sul saldo
dell’indebitamento netto evidenzia il carattere restrittivo degli stessi[255],
finalizzati ad ottenere una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
Tale effetto correttivo è ottenuto utilizzando essenzialmente la leva delle
maggiori entrate nette, mentre il lato della spesa è utilizzato in chiave
espansiva[256]:
l’aumento congiunto di entrate e spese configura quindi un incremento della
dimensione dell’intervento pubblico nell’economia.
La manovra approvata a fine 2006 conclude la fase
restrittiva. Gli aggiornamenti delle stime, operati nel corso del 2007, hanno
evidenziato l’emersione graduale di miglioramenti inattesi del deficit
tendenziale rispetto alle previsioni formulate nel primo DPEF della
legislatura. Nel grafico che segue le linee tratteggiate evidenziano le
successive revisioni operate nelle previsioni tendenziali, poste a confronto
con la linea continua che rappresenta gli obiettivi programmatici concordati in
sede europea. Il miglioramento registrato risulta ascrivibile essenzialmente ad
un andamento delle entrate migliore del previsto e ad una sostanziale conferma
delle previsioni formulate sull’andamento della spesa.

I dati sono tratti dai documenti citati in legenda, salvo la
serie “Nota agg. DPEF 08 senza DL 81” che è frutto di un’elaborazione volta a
depurare le previsioni tendenziali della Nota stessa dell’utilizzo del cd.
“tesoretto” operato dal DL n. 81/07, adottato nel precedente mese di giugno,
contestualmente al DPEF ’08.
La linea tratteggiata “Nota agg. DPEF 08 pre DL 159”
incorpora, invece gli effetti del DL 81, ma non quelli del successivo
provvedimento espansivo (DL 159/07) presentato nell’ottobre 2007.
Come si vede dal grafico, il miglioramento tendenziale dei
saldi avrebbe consentito di ottenere per gli esercizi 2007-2009, senza operare
manovre correttive, risultati migliori[257]
rispetto agli obiettivi concordati in sede europea.
L’orientamento espresso dal Governo, in occasione di ogni
revisione delle stime operata, è stato invece quello di sfruttare il
miglioramento imprevisto dei conti in chiave espansiva[258], e di
utilizzare il margine di manovra creatosi per attuare misure di sostegno allo
sviluppo.
Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti sul
saldo della P.A. dei provvedimenti adottati[259] e la
relativa composizione fra entrate e spese.
Dai dati contenuti nella tabella emerge che le manovre
espansive hanno operato essenzialmente mediante aumenti della spesa, mentre
minoritaria risulta la riduzione delle entrate[260]. Se
si considera che la copertura delle manovre espansive avviene mediante
l’utilizzo del miglioramento dei saldi, a sua volta largamente ascrivibile
all’extragettito fiscale, risulta evidente che, come già la fase restrittiva,
anche la fase espansiva ha agito nel senso dell’aumento della dimensione del
bilancio pubblico.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
DL
n. 81/2007
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
-5.621
|
-1.624
|
-1.614
|
-1.614
|
|
Manovra
sulla spesa
|
-5.621
|
-1.624
|
-1.614
|
-1.614
|
|
Manovra
sull'entrata
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
DL
n. 159/2007
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
-7.145
|
0
|
0
|
0
|
|
Manovra
sulla spesa[261]
|
-7.145
|
0
|
0
|
0
|
|
Manovra
sull'entrata
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Legge
244/2007
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
0
|
-6.089
|
-4.411
|
-4.989
|
|
Manovra
sulla spesa
|
0
|
-3.734
|
-647
|
-2.814
|
|
Manovra
sull'entrata
|
0
|
-2.355
|
-3.763
|
-2.174
|
|
DL
n. 248/2007
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
-4.610
|
-983
|
191
|
154
|
|
Manovra
sulla spesa[262]
|
-4.610
|
-1.242
|
48
|
42
|
|
Manovra
sull'entrata
|
0
|
259
|
143
|
112
|
|
Effetto
complessivo degli interventi
|
-17.376
|
-8.696
|
-5.834
|
-6.449
|
|
In
percentuale del PIL
|
-1,1
|
-0,5
|
-0,4
|
-0,4
|
|
Manovra
sulla spesa
|
-17.376
|
-6.600
|
-2.213
|
-4.386
|
|
Manovra
sull'entrata
|
0
|
-2.096
|
-3.621
|
-2.062
|
La tabella che segue riassume gli interventi operati
nelle due fasi sopra descritte al fine di evidenziare come l’azione complessiva
di politica economica della legislatura trascorsa abbia inciso sul saldo delle
P.A.
Segno meno = peggioramento (mln di euro)
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
Totale
fase restrittiva
|
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
-11.678
|
20.601
|
17.150
|
20.736
|
20.736
|
|
Manovra
sulla spesa
|
-15.269
|
-2.910
|
-1.815
|
-1.478
|
-1.478
|
|
Manovra
sull'entrata
|
3.591
|
23.511
|
18.965
|
22.214
|
22.214
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
fase espansiva
|
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
0
|
-17.376
|
-8.696
|
-5.834
|
-6.448
|
|
Manovra
sulla spesa
|
0
|
-17.376
|
-6.600
|
-2.213
|
-4.385
|
|
Manovra
sull'entrata
|
0
|
0
|
-2.096
|
-3.621
|
-2.062
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effetto
complessivo manovre
|
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
-11.678
|
3.225
|
8.454
|
14.902
|
14.289
|
|
Manovra
sulla spesa
|
-15.269
|
-20.286
|
-8.416
|
-3.691
|
-5.863
|
|
Manovra
sull'entrata
|
3.591
|
23.511
|
16.870
|
18.593
|
20.152
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In
percentuale del Pil:
|
|
|
|
|
|
|
Effetto
sull'indebitamento netto
|
-0,8
|
0,2
|
0,5
|
0,9
|
0,8
|
|
Manovra
sulla spesa
|
-1,0
|
-1,3
|
-0,5
|
-0,2
|
-0,3
|
|
Manovra
sull'entrata
|
0,2
|
1,5
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
La tabella evidenzia che gli interventi adottati hanno
inciso complessivamente nel senso di un miglioramento del deficit della PA[263].
Peraltro, sulla base dei dati delle relazioni tecniche allegate ai
provvedimenti, l’ammontare della correzione operata sembrerebbe risultare
particolarmente esiguo con riferimento all’esercizio 2007.
Il grafico seguente mostra come il contributo delle manovre
al risanamento dei conti conseguito in tale esercizio appaia marginale, specie
se confrontato con la misura della manovra che si riteneva necessaria all’inizio
della legislatura:

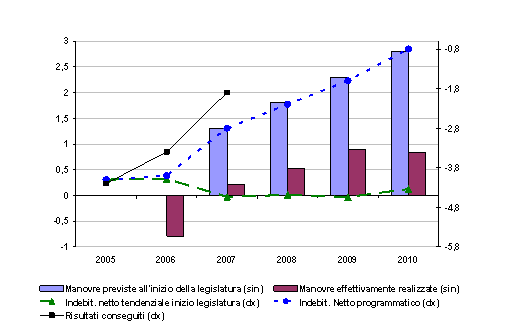
Come indicato nella legenda del grafico, le linee
tratteggiate verde e blu (asse dx) mostrano rispettivamente l’andamento
tendenziale e programmatico del deficit stimato all’inizio della legislatura.
Gli istogrammi azzurro e viola (asse sin) mostrano, rispettivamente,
l’ammontare delle manovre ritenute necessarie all’inizio della legislatura e
quello delle manovre effettivamente attuate, come risultante dalle relazioni
tecniche allegate ai singoli provvedimenti. La linea continua (asse dx) indica
i risultati effettivamente conseguiti, comunicati dall’Istat il 29 febbraio
scorso. Lo spazio evidenziato dalla parentesi graffa indica la quota di
miglioramento del deficit per il 2007 - distanza fra previsione tendenziale
iniziale e risultato effettivamente conseguito - che non sembrerebbe
ascrivibile alle manovre operate nel corso della legislatura, come quantificate
dalle rispettive relazioni tecniche.
Alcune informazioni contenute nel comunicato Istat del 29
febbraio scorso e nella RUEF portano, peraltro, a ritenere che l’entità
effettiva della correzione del deficit apportata dalle manovre della
legislatura con riferimento al 2007 sia superiore a quella stimata dalle
relazioni tecniche riferite ai singoli provvedimenti. In particolare la RUEF,
nell’operare una rettifica peggiorativa della previsione del deficit per il
2008, indica fra le diverse ragioni alla base della revisione, lo slittamento a
tale esercizio di alcune misure di maggiore spesa o minore entrata che
avrebbero dovuto incidere sul 2007[264].
L’ammontare effettivo per tale esercizio delle manovre espansive adottate
sarebbe, quindi, a consuntivo inferiore rispetto a quello stimato dalle
relazioni tecniche. Ne risulterebbe conseguentemente aumentato l’effetto
correttivo netto delle manovre complessivamente adottate per tale esercizio e
il loro contributo al risanamento riscontrato[265].
In assenza di una valutazione a consuntivo degli effetti
delle singole manovre, per le quali si dispone unicamente delle relazioni
tecniche prodotte in sede di previsione, non risulta possibile una valutazione
dell’incidenza effettiva sui saldi dei provvedimenti adottati.
L’analisi sopra condotta ha evidenziato che le manovre
adottate nella quindicesima legislatura, idealmente distinguibili in due fasi,
restrittiva ed espansiva, hanno complessivamente contribuito al risanamento del
saldo di bilancio della PA nel 2007, in misura anche superiore rispetto a
quanto risultante dalle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti. Al tempo
stesso le predette manovre, operando essenzialmente mediante incrementi delle
entrate nella fase restrittiva e incrementi delle spese nella fase espansiva,
hanno contribuito ad accrescere la dimensione del bilancio pubblico nei suoi
macro aggregati di entrata e di spesa.
Il fabbisogno
ed il debito
Il fabbisogno complessivo delle Amministrazioni pubbliche
costituisce un aggregato consolidato, formato dal fabbisogno delle Amministrazioni
centrali e dai fabbisogni aggiuntivi delle Amministrazioni locali e degli enti
di previdenza.
Il fabbisogno complessivo delle Amministrazioni centrali si
compone del saldo tra gli incassi ed i pagamenti del bilancio dello Stato ed il
saldo delle altre operazioni delle Amministrazioni centrali, che riflette
principalmente il saldo tra i versamenti in Tesoreria effettuati dal bilancio
dello Stato e da altri soggetti ed i pagamenti dalla Tesoreria a soggetti
diversi dallo Stato. I fabbisogni aggiuntivi delle Amministrazioni locali e
degli Enti di previdenza riflettono le necessità di finanziamento di tali enti
non soddisfatte attraverso entrate proprie o trasferimenti da altri enti
pubblici.
Sul fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche incidono,
inoltre, i proventi delle dismissioni di partecipazioni in imprese pubbliche, al
netto dei versamenti per eventuali acquisizioni, effettuate dalle
Amministrazioni centrali ed altri proventi di natura straordinaria, quali i
dividendi connessi ad operazioni di liquidazione di imprese e gli incassi delle
licenze UMTS, nonché gli esborsi per la regolazione di posizioni debitorie
pregresse, effettuati sempre dalle Amministrazioni centrali.
Il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche è calcolato
dalla Banca d’Italia dal lato della copertura, considerando la variazione degli
strumenti finanziari utilizzati per il suo finanziamento.
Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche
2000-2007
(Valori in milioni di euro e in rapporto al
PIL)
|
ANNO
|
FABBISOGNO
COMPLESSIVO
|
PROVENTI
DI DISMISSIONI DI BENI MOBILIARI E ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE
|
REGOLAZIONI
DI DEBITI PREGRESSI
|
FABBISOGNO
AL NETTO DI REGOLAZIONI DI DEBITI PREGRESSI E DISMISSIONI
|
|
|
Valore
|
% PIL
|
Valore
|
Valore
|
Valore
|
% PIL
|
|
2000
|
26.212
|
2,20
|
15.450
|
4.601
|
37.061
|
3,11
|
|
2001
|
57.591
|
4,61
|
4.659
|
9.310
|
52.939
|
4,24
|
|
2002
|
37.967
|
2,93
|
1.951
|
5.328
|
34.591
|
2,67
|
|
2003
|
39.876
|
2,99
|
16.866
|
8.537
|
48.205
|
3,61
|
|
2004
|
49.778
|
3,58
|
8.316
|
529
|
57.565
|
4,14
|
|
2005
|
69.441
|
4,86
|
4.618
|
1.864
|
72.195
|
5,05
|
|
2006
|
54.380
|
3,67
|
38
|
243
|
54.175
|
3,66
|
|
2007
|
30.520
|
1,99
|
3.500
|
2.420
|
31.600
|
2,06
|
Il fabbisogno delle
Amministrazioni pubbliche, dopo una drastica riduzione nel 2002, è tornato a
crescere nel triennio successivo, collocandosi al 5 per cento del PIL nel 2005.
Nell’ultimo biennio il dato mostra una ripresa della fase discendente,
collocandosi a circa il 2 per cento del PIL nel 2007.
I proventi delle
dismissioni mobiliari hanno contribuito alla riduzione del fabbisogno in modo
cospicuo soprattutto nel 2003, in conseguenza della cessione di partecipazioni
del Tesoro nell’ambito delle operazioni di trasformazione della Cassa depositi
e prestiti, che ha determinato incassi per circa 12 miliardi di euro. Negli
anni successivi il loro contributo decresce fino al 2007, anno in cui è stata
realizzata una riduzione del capitale sociale della Sace, che ha comportato un
introito di 3,5 miliardi di euro.
I pagamenti per
regolazioni di debiti pregressi mostrano una flessione nel periodo 2004-2006, a
fronte dei cospicui valori registrati negli anni precedenti, per effetto del
ripiano dei disavanzi per la spesa sanitaria e per il rimborso di crediti
d’imposta. Nel 2007 si assiste ad un incremento di tali pagamenti, da porsi in
relazione con gli interventi di ripiano dei disavanzi sanitari previsti dal
decreto legge n. 23 del 2007 e con la parziale restituzione dei rimborsi IVA
auto dovuti ai contribuenti a seguito della Sentenza emessa nel 2006 dalla
Corte di giustizia europea.
Divario tra fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche al netto delle
dismissioni ed indebitamento netto. Anni 2000-2007
(Valori in milioni di euro e in rapporto al
PIL)
|
ANNO
|
FABBISOGNO
P.A. NETTO DISMISSIONI
|
INDEBITAMENTO
NETTO P.A.
|
DIFFERENZA
|
DIFFERENZA/PIL
|
|
|
Valore
|
%PIL
|
Valore
|
Valore
|
% PIL
|
|
2000
|
41.662
|
3,50
|
9.962
|
31.700
|
2,66
|
|
2001
|
62.249
|
4,99
|
38.501
|
23.748
|
1,90
|
|
2002
|
39.918
|
3,08
|
37.085
|
2.833
|
0,22
|
|
2003
|
56.742
|
4,25
|
46.614
|
10.128
|
0,76
|
|
2004
|
58.093
|
4,17
|
48.312
|
9.781
|
0,70
|
|
2005
|
74.059
|
5,18
|
60.428
|
13.631
|
0,95
|
|
2006
|
54.418
|
3,68
|
49.634
|
4.784
|
0,32
|
|
2007
|
34.020
|
2,2
|
29.179
|
4.841
|
0,32
|
Il fabbisogno delle
Amministrazioni pubbliche al netto delle dismissioni mobiliari si colloca, in
rapporto al PIL, sempre sopra ai 3 punti percentuali, con la sola eccezione del
2007, anno in cui il valore si cifra al 2,2 per cento del PIL, con una
riduzione di 1,5 punti rispetto all’anno precedente. A tale risultato ha
contribuito anche la riduzione del fabbisogno delle Amministrazioni locali,
passato da 18,4 a 3,7 milioni di euro.
Si segnala che, a contenimento della dinamica di tale
aggregato, hanno operato nel periodo considerato anche misure di carattere
temporaneo.
Si tratta, in particolare, di operazioni di
cartolarizzazione di crediti in possesso delle Amministrazioni pubbliche. I
proventi di tali operazioni, configurandosi le medesime come cessione di asset di natura finanziaria, ove
conformi ai criteri generali fissati nel 2002 da Eurostat in materia di
valutazione contabile delle cartolarizzazioni, concorrono alla riduzione del
fabbisogno, mentre non hanno rilievo ai fini dell’indebitamento netto.
Nel periodo considerato sono state effettuate cartolarizzazioni
dei crediti contributivi dell’INPS; nel 2004 sono state effettuate anche
operazioni di cessione alla Sace di crediti dello Stato nei confronti della
Federazione russa e di crediti dello Stato a fronte di finanziamenti agevolati
per la ricerca scientifica.
Il divario tra il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche, al netto
delle dismissioni mobiliari, e l’indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche, ridottosi nel triennio 2002-2004 – anche in conseguenza di talune
riclassificazioni contabili
- è tornato a crescere nel 2005, collocandosi a quasi un punto percentuale del
prodotto. Negli anni 2006 e 2007 tale divario si colloca allo 0,3 per cento del
PIL.
Il divario fra i due saldi è imputabile alle diverse
modalità di calcolo utilizzate per la costruzione dei due indicatori.
In linea generale:
·
il saldo delle partite finanziarie incide sul
fabbisogno, ma non sull’indebitamento netto;
·
il fabbisogno è computato in base ad un criterio
di cassa, mentre l’indebitamento netto è computato in base ad un criterio di
competenza economica, per cui le operazioni nei due aggregati sono registrate
in riferimento a momenti diversi;
·
nel passaggio dall’uno all’altro dei due
aggregati occorre considerare le poste di riclassificazione dovute alle
differenze di registrazione delle operazioni ai fini dei due saldi. Tali poste
riguardano alcune voci non incluse nel fabbisogno (ad esempio le cancellazioni
di debiti, la riscossione di crediti contributivi a seguito di operazioni di
cartolarizzazione) ed altre voci relative alla riclassificazione di partite
finanziarie ed economiche. Vi sono, infatti alcune operazioni che sono
classificate come partite finanziarie nel fabbisogno (e, quindi, incluse), che
sono riclassificate come economiche ai fini dell’indebitamento netto e
viceversa.
Un’analisi delle singole poste che spiegano il divario tra fabbisogno e
indebitamento netto è stata recentemente resa disponibile dall’Istat per gli
anni dal 2004 al 2007, nell’ambito dei dati notificati alla Commissione europea
in applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (PDE),
annessa al Trattato di Maastricht, che fissa i valori limite che possono
assumere l’indebitamento netto ed il debito pubblico.
L’individuazione delle poste di raccordo tra i due aggregati di finanza
pubblica è oggetto di attento monitoraggio da parte delle autorità europee ed i
relativi dati costituiscono parte integrante della Notifica. Tale analisi
consente, infatti, di valutare, in sede europea, la coerenza ed affidabilità
delle stime di finanza pubblica dei Paesi membri.
L’analisi, riportata nella tavola che segue, fornisce, in particolare
le poste del quadro di raccordo tra il fabbisogno complessivo del settore
pubblico e l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche.
Il fabbisogno del settore pubblico è calcolato dal
Ministero dell’economia e delle finanze dal lato della formazione e si
riferisce ad un insieme di enti che non coincide perfettamente con quello delle
Amministrazioni pubbliche, in riferimento al quale è calcolato l’indebitamento
netto.
Per alcuni enti minori centrali, locali e previdenziali non
vi è, infatti, completa corrispondenza con quelli considerati dall’Istat per
definire l’aggregato delle Amministrazioni pubbliche, il cui elenco è
periodicamente aggiornato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il fabbisogno calcolato dal MEF esclude sia la variazione
dei depositi attivi del Tesoro presso la Banca d’Italia, sia le dismissioni di
azioni e partecipazioni.
Il quadro di raccordo ricostruito dall’Istat analizza le
singole poste che differenziano i due aggregati.
Le variazioni nette di partite finanziarie attive
comprendono i prestiti erogati a soggetti esterni alle Amministrazioni
pubbliche, l’acquisizione di partecipazioni in imprese pubbliche ed altre
partite, la cui componente più importante è costituita dai depositi bancari.
Tali variazioni, che debbono essere escluse nel passaggio dal fabbisogno
all’indebitamento, in quanto quest’ultimo non le contiene, hanno concorso in
modo decrescente, nel periodo considerato, alla formazione del fabbisogno.
La posta relativa alla
differenza tra valutazioni per competenza e per cassa, connessa alla diversa
imputazione temporale delle operazioni utilizzata nel calcolo dei due saldi,
mostra un dato significativo nel 2006, anno nel quale gli esborsi per cassa
sono stati più elevati di quelli per competenza, anche a causa del rimborso di
cospicui ammontari di buoni postali, per i quali gli interessi maturati sono
pagati al momento del rimborso.
|
Raccordo tra
fabbisogno del settore pubblico e indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche. Anni 2004 - 2007
(milioni di
euro)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Fabbisogno del settore pubblico
|
-57.180
|
-74.728
|
-55.593
|
-35.259
|
|
|
|
|
|
|
|
Partite finanziarie attive
comprese nel Fabbisogno (variazioni)
|
13.769
|
17.707
|
8.885
|
6.269
|
|
Concessione di prestiti (+)
|
13.693
|
13.022
|
6.231
|
4.017
|
|
Riscossione di prestiti (-)
|
-1.728
|
-4.145
|
-2.486
|
-3.864
|
|
Acquisizione di partecipazioni azionarie (+)
|
1.223
|
1.738
|
1.457
|
874
|
|
Vendite di azioni (-)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Aumenti/Riduzioni di altre attività finanziarie (+/-)
|
581
|
7.092
|
3.683
|
5.242
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenza tra valutazioni per
competenza e per cassa
|
-4.126
|
-3.211
|
11.318
|
-957
|
|
Entrate (+)
|
182
|
4.985
|
6.674
|
9.011
|
|
Uscite al netto degli interessi passivi (-)
|
-1.323
|
-8.452
|
2.788
|
-5.341
|
|
Interessi passivi (EDP) (-)
|
-2.985
|
256
|
1.856
|
-4.627
|
|
|
|
|
|
|
|
Riclassificazioni di operazioni
|
-446
|
-1.189
|
-14.434
|
149
|
|
Cancellazioni di debiti dei Paesi in via di sviluppo
|
-229
|
-1.200
|
-1.035
|
-108
|
|
Sospensione delle attività di riscossione dei crediti contributivi
INPS
|
0
|
0
|
-734
|
0
|
|
Cancellazione dei crediti verso RFI/TAV per l'alta velocità
|
0
|
0
|
-12.950
|
0
|
|
Riscossioni di crediti contributivi non inclusi nel fabbisogno (INPS)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Riclassificazioni di dividendi derivanti da privatizzazioni (TERNA)
|
-633
|
-250
|
0
|
0
|
|
Riclassificazioni di altre partite finanziarie (crediti e
partecipazioni)
|
416
|
261
|
285
|
257
|
|
Apporti di capitale a Cassa Depositi e Prestiti
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Discrepanza statistica
|
-329
|
994
|
190
|
619
|
|
|
|
|
|
|
|
Indebitamento netto
|
-48.312
|
-60.428
|
-49.634
|
-29.179
|
Sempre nel 2006 si riscontra un
elevato ammontare della voce dovuta alla riclassificazione delle operazioni.
Tale dato è da porsi soprattutto in relazione con la cancellazione dei crediti
verso RFI/TAV che ha comportato, a seguito della decisione Eurostat, ai fini
del calcolo dell’indebitamento netto, la classificazione di tali crediti, per
un ammontare di circa 13 miliardi di euro, tra i trasferimenti in conto
capitale, contribuendo a ridurre il divario tra i due saldi. Al netto di tale
posta, infatti, tale divario sarebbe risultato superiore per circa un punto di
PIL.
Il debito delle Amministrazioni pubbliche si compone dell’insieme delle passività
finanziarie del settore, valutate al valore facciale di emissione.
In linea con la definizione adottata ai fini della procedura per i
disavanzi eccessivi della UE, si tratta di un aggregato consolidato, dal quale
sono escluse le passività che costituiscono nel contempo stesso attività,
nell’ambito dei medesimi strumenti di indebitamento, di enti appartenenti al
medesimo comparto delle Amministrazioni pubbliche.
Le variazioni annue del debito non coincidono con
l’ammontare del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche a causa dei diversi
criteri contabili utilizzati per il computo dei due aggregati.
In particolare:
·
le variazioni delle attività nei confronti della
Banca d’Italia sono considerate una forma di copertura del fabbisogno, mentre
le corrispondenti consistenze non sono portate a riduzione del debito;
·
nel fabbisogno, ad eccezione dei BOT, le
emissioni dei titoli sono valutate al “netto ricavo”, mentre nel debito sono
considerate al valore nominale;
·
nel fabbisogno, le passività denominate in
valuta diversa dall’euro sono convertite al tasso di cambio vigente al momento
della regolazione dell’operazione, mentre nel debito la conversione è
effettuata al tasso di cambio vigente alla fine del periodo di riferimento.
Nella tavola che segue sono riportate la variazione del
debito e le sue componenti nel periodo 2003-2007.
Nel 2003 e nel 2007 la crescita nominale del debito è stata
notevolmente inferiore al fabbisogno. Nel 2003 per effetto sia della riduzione
delle attività detenute dal Tesoro presso la Banca d’Italia, sia degli scarti
di emissione, sia dell’apprezzamento del cambio dell’euro. Nel 2007 ha concorso
alla minore crescita del debito, rispetto al fabbisogno, soprattutto la
sensibile riduzione delle attività detenute presso la Banca d’Italia, la cui
consistenza a fine anno è scesa a 9,7 miliardi di euro.
Tale riduzione è da porsi in relazione con una imprevista
accelerazione negli ultimi giorni dell’anno dei pagamenti di cassa da parte delle Amministrazioni
pubbliche, necessariamente finanziati con le disponibilità del conto di
tesoreria, non essendo più possibile il ricorso ad emissione di titoli di
debito pubblico.
Variazioni del debito delle Amministrazioni
pubbliche e sue componenti.
Anni 2003-2007
(Valori in milioni di euro)
|
COMPONENTI
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Variazione
Debito (a)+(b)+(c)+(d)
|
24.983
|
51.108
|
66.951
|
64.082
|
21.126
|
|
(a)
Fabbisogno complessivo
|
39.876
|
49.778
|
69.441
|
54.380
|
30.520
|
|
(b)
Variazione depositi presso la Banca d’Italia
|
-8.022
|
2.578
|
-1.197
|
8.230
|
-13.142
|
|
(c) Scarti di emissione
|
-3.692
|
-227
|
-2.444
|
2.274
|
4.083
|
|
(d) Variazione
controvalore in euro di passività in valuta
|
-3.179
|
-1.021
|
1.150
|
-801
|
-333
|
In rapporto al PIL, il debito mostra un andamento
discendente fino al 2004, per poi tornare ad aumentare nel biennio successivo.
Nel 2007 si assiste di nuovo ad una consistente riduzione del rapporto, che in
larga parte riassorbe gli incrementi determinatisi nel 2005 e 2006.
Debito delle
Amministrazioni pubbliche: rapporto al PIL e sue variazioni.
Anni 2000-2007
(Valori in milioni
di euro - %)
|
ANNO
|
DEBITO A.P.
|
VARIAZIONE DEBITO A.P.
|
PIL
|
DEBITO A.P /PIL
|
VARIAZIONE DEBITO A.P./PIL
|
|
|
Valore
|
Valore
|
Valore
|
% PIL
|
% PIL
|
|
2000
|
1.300.341
|
18.279
|
1.191.057
|
109,2
|
-4,6
|
|
2001
|
1.358.333
|
57.992
|
1.248.648
|
108,8
|
-0,4
|
|
2002
|
1.368.512
|
10.179
|
1.295.226
|
105,7
|
-3,1
|
|
2003
|
1.393.495
|
24.983
|
1.335.354
|
104,4
|
-1,3
|
|
2004
|
1.444.603
|
51.108
|
1.391.530
|
103,8
|
-0,5
|
|
2005
|
1.511.554
|
66.951
|
1.428.375
|
105,8
|
2,0
|
|
2006
|
1.575.636
|
64.082
|
1.479.981
|
106,5
|
0,6
|
|
2007
|
1.596.762
|
21.126
|
1.535.540
|
104,0
|
-2,5
|
La variazione annua del rapporto tra il debito ed il PIL può
essere scomposta in due componenti principali – l’indebitamento netto primario
e il differenziale tra l’onere medio del debito e la crescita nominale del
prodotto interno lordo – ed in una componente di natura residuale.
In particolare:
·
l’indebitamento netto primario (saldo
primario) corrisponde alla differenza fra le uscite complessive delle
Amministrazioni pubbliche, al netto degli interessi passivi, e le entrate
complessive. Esso concorre, se positivo, alla riduzione del rapporto;
·
il differenziale tra l’onere medio del debito
(calcolato come incidenza della spesa per interessi passivi sostenuta nell’anno
di riferimento sulla consistenza del debito dell’anno precedente) ed il
tasso di crescita del PIL nominale, se assume valore positivo, opera in
senso accrescitivo del rapporto debito/PIL. Ciò in quanto la crescita del
prodotto, che aumenta il denominatore del rapporto, non è sufficiente a
neutralizzare l’effetto sul numeratore determinato dall’onere del debito;
·
la componente residuale, indicata anche
come aggiustamento stock- flussi, è pari
alla differenza tra la variazione del debito e l’indebitamento netto. Su tale
componente influiscono diversi fattori, quali i diversi criteri contabili adottati
per il calcolo dell’indebitamento netto e del fabbisogno delle amministrazioni
pubbliche, le acquisizioni nette di attività finanziarie, le regolazioni di
debiti pregressi, la variazione dei depositi attivi presso la Banca d’Italia,
le risultanze delle operazioni di ristrutturazione del debito, gli scarti di
emissione e l’andamento del tasso di cambio.
Debito delle
Amministrazioni pubbliche. Determinanti della variazione del rapporto
debito - PIL e
sue variazioni. Anni 2003-2007
(Valori in
milioni di euro - %)
|
COMPONENTI
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Debito/PIL
|
104,4
|
103,8
|
105,8
|
106,5
|
104,0
|
|
Variazione rapporto Debito/PIL
|
-1,3
|
-0,5
|
2,0
|
0,6
|
-2,5
|
|
Indebitamento netto primario/PIL
(il segno “-“ indica avanzo)
|
-1,6
|
-1,2
|
-0,3
|
-1,3
|
-3,1
|
|
Onere medio
del debito
|
5,0
|
4,7
|
4,5
|
4,5
|
4,9
|
|
Tasso di
crescita del PIL nominale
|
3,1
|
4,2
|
2,6
|
3,6
|
3,8
|
|
Differenza tra onere medio del debito e tasso di crescita
del PIL
|
1,9
|
0,5
|
1,8
|
0,9
|
1,1
|
|
Componente residuale
|
-1,6
|
0,2
|
0,5
|
1,0
|
-0,5
|
Nel periodo considerato il saldo
primario permane positivo (avanzo primario), tuttavia il suo contributo
riduttivo del rapporto debito/PIL va progressivamente affievolendosi negli anni
centrali della serie. L’onere medio del debito, dopo una fase discendente, in
conseguenza della riduzione dei rendimenti registrata fino al dicembre 2005 e
degli effetti delle politiche di gestione del debito stesso, quali il ricorso
ad operazioni di swap, è tornato a crescere nel 2007.
In tale anno, infatti, la spesa per interessi ha subito un
significativo aumento, da porsi in relazione essenzialmente con il progressivo
aumento dei tassi all’emissione registrato nei primi sette mesi dell’anno, con
il minore ricorso ad operazioni di swap, che negli anni precedenti avevano
contenuto gli esborsi e con fattori di natura contabile. Inoltre, ad accentuare
l’effetto dei tassi di mercato sugli interessi, sarebbe stato, secondo quanto
precisato nella RUEF presentata nel marzo 2008, anche il maggior ricorso da
parte del Tesoro a strumenti a breve e brevissimo termine emessi in corso
d’anno per compensare la maggiore volatilità mensile e giornaliera del
fabbisogno del settore statale.
La differenza tra onere medio
del debito e tasso di crescita del PIL nominale permane positiva, operando nel
periodo in senso accrescitivo del rapporto debito/PIL a causa della bassa
quanto irregolare crescita del prodotto.
La componente residuale opera
nel periodo in senso accrescitivo del rapporto, tranne che per gli anni 2003 e
2007. In particolare, nel 2006, tale componente concorre per un punto di PIL alla crescita del rapporto.
Hanno concorso a tale risultato l’emissione di debito sotto la pari e
l’incremento dei depositi attivi del Tesoro presso la Banca d’Italia,
effettuato per far fronte nell’anno successivo ai rimborsi IVA connessi alla
sentenza della Corte di giustizia europea del settembre 2006.
Nel 2003 hanno influito
sull’impatto riduttivo della componente residuale le cospicue dismissioni
mobiliari (circa 16,9 miliardi di euro) pari ad 1,3 punti di PIL, in larga
parte ascrivibili alle operazioni di trasformazione della CDP.
Nel 2007, sull’effetto di
riduzione del rapporto debito/PIL dovuto alla componente residuale hanno
influito la riduzione dei depositi attivi del Tesoro presso la Banca d’Italia
per oltre 13 miliardi di euro e dismissioni di partecipazioni mobiliari per 3,5
miliardi di euro, solo parzialmente bilanciate dall’emissione di debito sotto
la pari.
Nel 2008 il debito delle
Amministrazioni pubbliche è previsto attestarsi a 1.638,3 miliardi di euro,
corrispondenti al 103 per cento del PIL. Il quadro programmatico contenuto
nella RUEF prevede che il rapporto debito/PIL si collochi sotto la soglia del
100 per cento dal 2010.
Nel 2008, rispetto al 2007, il
rapporto diminuisce di un punto di PIL. L’avanzo primario contribuisce a
ridurre la dinamica del debito per 2,6 punti di PIL. In senso opposto opera il
differenziale tra onere medio del debito e tasso di crescita nominale del
prodotto, pari ad 1,4 per cento: si registra, infatti, un ulteriore lieve
incremento dell’onere medio del debito (dal 4,9 al 5 per cento) a fronte di una
decelerazione del tasso di crescita nominale del PIL (dal 3,8 al 3,6 per
cento). La componente residuale concorre alla crescita del debito per 0,2 punti
di PIL.
Debito delle
Amministrazioni pubbliche. Analisi per strumenti.
Anni 2000-2007 –
Composizione percentuale.
|
STRUMENTI
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Monete e depositi
|
8,91
|
10,23
|
10,97
|
8,06
|
8,92
|
9,89
|
9,96
|
8,96
|
|
di cui raccolta postale
|
8,55
|
9,57
|
10,13
|
5,45
|
5,17
|
4,67
|
4,16
|
2,33
|
|
Titoli
a breve termine
|
7,84
|
8,37
|
8,28
|
8,57
|
8,19
|
7,77
|
7,76
|
8,01
|
|
Titoli
a medio lungo
|
77,57
|
75,82
|
75,56
|
75,37
|
75,50
|
74,71
|
73,87
|
74,52
|
|
Totale titoli
|
85,41
|
84,19
|
83,84
|
83,94
|
83,69
|
82,48
|
81,63
|
82,53
|
|
Prestiti IFM
|
5,20
|
4,72
|
4,50
|
4,01
|
3,77
|
3,98
|
7,85
|
7,86
|
|
Altre passività
|
0,49
|
0,86
|
0,68
|
3,99
|
3,62
|
3,65
|
0,55
|
0,65
|
|
Debito AP
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
di cui in valuta
|
3,53
|
2,82
|
2,78
|
1,96
|
1,84
|
1,80
|
0,68
|
0,22
|
|
di cui medio lungo termine
|
85,67
|
83,72
|
82,90
|
85,11
|
84,35
|
83,22
|
82,73
|
83,36
|
La tavola che precede esamina la
struttura del debito delle Amministrazioni pubbliche in base alla composizione
per strumenti di finanziamento.
L’aggregato debito delle Amministrazioni pubbliche include i
seguenti strumenti finanziari:
·
le monete ed i depositi: comprendono le monete
in circolazione, i depositi presso la Tesoreria statale di pertinenza di
soggetti esterni alle A.P. e la raccolta postale. Dal dicembre 2003, in seguito
alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, tale
ultima voce comprende solo la quota dei buoni postali attribuita al Ministero
dell’economia e delle finanze ed i conti correnti postali intestati a soggetti
privati. Nella voce “monete e depositi”, in seguito alla decisione Eurostat del
23 maggio 2005, sono confluiti i versamenti anticipati effettuati dai
concessionari della riscossione (decreto legge n. 341 del 2003 e decreto legge
n. 282 del 2004);
·
titoli diversi dalle azioni (esclusi gli
strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni
pubbliche. Sempre in seguito alla decisione Eurostat del 23 maggio 2005, nei
titoli a medio e lungo termine è confluita la quota in titoli dei debiti
contratti nel 2004 da Infrastrutture S.p.a. per il finanziamento dell’alta
velocità ferroviaria;
·
prestiti delle istituzioni finanziarie monetarie
(IFM): comprende i prestiti erogati in favore di enti delle A.P. o il cui onere
di rimborso sia a carico dei medesimi. Dal 2004 comprende la restante parte dei
prestiti contratti da Infrastrutture S.p.a. per il finanziamento degli investimenti
per l’alta velocità. In questa voce confluiscono anche i proventi di alcune
operazioni di cartolarizzazione, che in base ai criteri Eurostat sono
classificate come accensione di prestiti, anziché cessioni di attività;
·
altre passività: la voce comprende le passività
verso la Banca d’Italia e, dal 2003, vi confluiscono i prestiti erogati dalla
Cassa depositi e prestiti in favore delle Amministrazioni pubbliche. Dal
settembre 2006, tuttavia, tali prestiti sono classificati nella voce “Prestiti
IFM” in quanto la Cassa è stata inclusa tra le istituzioni finanziarie
monetarie.
Nel 2007 l’83,4 per cento del debito delle Amministrazioni
pubbliche è a medio e lungo termine, a fronte dell’85,7 per cento nel 2000. I
titoli rappresentano 82,5 per cento del valore del debito a fronte dell’85,4
per cento nel 2000. Del loro ammontare complessivo, circa il 90,3 per cento è
rappresentato nel 2007 da titoli a medio e lungo termine, con una lieve
riduzione rispetto al peso assunto nel 2000 (90,8 per cento).
La vita residua media ponderata
dei titoli di Stato prosegue il suo trend
di crescita, passando dai circa 6 anni del gennaio 2004 ai 6,85 anni di fine
2007.
La quota delle monete e depositi
si riduce nel periodo, a seguito della flessione dal 2003 della raccolta postale,
causata dalle revisioni contabili derivanti dalla trasformazione della CDP.
Sempre a seguito di tali revisioni si incrementa dal 2003 al 2005 la quota
delle altre passività, in cui confluiscono i prestiti erogati dalla CDP alle
Amministrazioni pubbliche. Dal 2006, invece, a seguito dell’inserimento della
Cassa tra le Istituzioni finanziarie monetarie tali prestiti concorrono a
determinare il maggior peso relativo di tale tipologia di strumento.
Nel corso del periodo
considerato si riduce, inoltre, il peso relativo del debito in valuta.
Debito delle Amministrazioni pubbliche.
Analisi per sottosettori e strumenti.
Anni 2000-2007 – Composizione percentuale.
|
SOTTOSETTORI P.A.
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Amministrazioni centrali
|
96,52
|
96,36
|
96,20
|
94,68
|
94,57
|
94,04
|
93,14
|
92,97
|
|
Titoli
|
87,93
|
86,69
|
86,13
|
87,38
|
86,92
|
85,77
|
85,35
|
86,55
|
|
Prestiti di banche e fondi monetari
|
2,84
|
2,46
|
2,24
|
1,87
|
1,66
|
1,87
|
3,92
|
3,79
|
|
Amministrazioni locali.
|
3,01
|
3,05
|
3,40
|
5,12
|
5,33
|
5,96
|
6,86
|
6,99
|
|
Titoli
|
17,93
|
21,41
|
29,14
|
23,51
|
27,95
|
30,65
|
31,21
|
29,51
|
|
Prestiti di banche e fondi monetari
|
81,37
|
76,62
|
68,61
|
43,58
|
41,25
|
37,12
|
61,12
|
61,44
|
|
Enti di previdenza
|
0,47
|
0,59
|
0,40
|
0,20
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
|
Debito delle Amministrazioni pubbliche
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
In merito alla ripartizione per
sottosettori della P.A., alla fine del 2007, il debito delle Amministrazioni
centrali rappresenta circa il 93 per cento del debito complessivo, quello a
carico delle Amministrazioni locali raggiunge il 7 per cento, mentre risulta
quasi nullo il debito contratto dagli Enti di previdenza. Nel 2000 tali quote
erano pari, rispettivamente, al 96,5 per cento, al 3 per cento ed allo 0,5 per
cento circa.
In valore assoluto lo stock di
debito delle Amministrazioni locali passa da circa 39 miliardi di euro nel 2000
a circa 112 miliardi di euro nel 2007.
Tale andamento risente in parte, a decorrere dal 2003, della
riallocazione del debito tra i due sottosettori delle Amministrazioni centrali
e delle Amministrazioni locali, conseguente alla trasformazione della CDP,
nonché della circostanza che taluni interventi straordinari di riduzione del
debito adottati in alcuni anni della serie hanno inciso sulla sola componente
del debito di pertinenza delle Amministrazioni centrali .
L’incidenza del debito delle
Amministrazioni locali sul PIL è salita nel periodo considerato di circa 4
punti percentuali, raggiungendo il 7,3 per cento del PIL a fine 2007
Mentre i titoli rappresentano
per le Amministrazioni centrali il principale strumento di indebitamento - con
un’incidenza sul debito delle stesse che passa dall’88 per cento circa nel 2001
all’86,6 per cento nel 2007 - il debito delle Amministrazioni locali è in
misura preponderante costituito da prestiti delle istituzioni monetarie e
finanziarie residenti e non residenti e della CDP s.p.a. Tuttavia, la quota di
debito in titoli delle Amministrazioni locali risulta crescente, passando dal
18 per cento circa nel 2000 al 29,5 per cento nel 2007.
Nella RUEF presentata nel marzo scorso si sottolinea come ad
una quota significativa delle passività delle Amministrazioni locali
attualmente in circolazione si applichi un tasso di interesse variabile e come
quindi tale quota sia esposta ad incrementi di spesa in caso di rialzo significativo
dei tassi di mercato. Tale circostanza si è prodotta nel 2007 ed ha concorso ad
incrementare la spesa complessiva per interessi delle Amministrazioni
pubbliche.
Dall’analisi per comparti della
finanza locale si evidenzia come, nel periodo di tempo considerato il ritmo di
crescita dello stock di debito delle province e dei comuni sia stato superiore
a quello dell’intero comparto. Infatti, lo stock di debito iniziale è aumentato
di circa cinque volte per le province e di circa due volte per i comuni.
Parimenti è andata aumentando la rispettiva quota di debito di pertinenza di
tali enti, mentre si sono ridotte corrispondentemente le quote afferenti alle
regioni ed agli altri enti locali, prevalentemente produttori di servizi
sanitari.
Debito delle Amministrazioni locali.
Analisi per comparti e strumenti.
Anni 2000-2007 – Composizione percentuale.
|
COMPARTI
AMMINISTRAZIONI LOCALI
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Regioni
e Province autonome
|
45,32
|
46,46
|
47,82
|
38,70
|
39,49
|
37,85
|
41,75
|
42,20
|
|
Titoli
|
26,86
|
31,55
|
44,44
|
42,60
|
44,63
|
40,89
|
41,46
|
38,28
|
|
Prestiti
di banche, fondi monetari e CDP
|
72,43
|
65,08
|
52,71
|
48,19
|
45,63
|
44,84
|
42,01
|
41,58
|
|
Province
|
3,73
|
3,85
|
4,22
|
6,71
|
7,38
|
8,09
|
8,02
|
7,92
|
|
Titoli
|
22,22
|
24,80
|
36,02
|
23,64
|
35,66
|
44,77
|
42,28
|
42,45
|
|
Prestiti
di banche, fondi monetari e CDP
|
77,07
|
74,43
|
63,38
|
74,69
|
63,01
|
54,27
|
57,11
|
56,95
|
|
Comuni
|
39,38
|
37,92
|
36,01
|
46,66
|
45,81
|
45,36
|
41,87
|
41,74
|
|
Titoli
|
12,34
|
15,08
|
17,46
|
11,52
|
16,63
|
25,10
|
24,79
|
23,63
|
|
Prestiti
di banche, fondi monetari e CDP
|
86,95
|
84,16
|
81,94
|
86,65
|
81,79
|
73,36
|
74,05
|
75,60
|
|
Altri
enti locali
|
11,57
|
11,76
|
11,96
|
7,94
|
7,31
|
8,70
|
8,36
|
8,14
|
|
Debito
Amministrazioni locali
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
La composizione del debito delle
regioni per strumenti, che nel 2000 appariva fortemente sbilanciata in favore
del ricorso ai prestiti (che rappresentavano circa il 72 per cento del debito a
fronte di una quota in titoli pari al 27 per cento), presenta nel 2007
un’incidenza del debito in titoli del 38
per cento circa, a fronte di una quota in prestiti vicina al 42 per cento.
In notevole aumento risulta
anche la quota del debito in titoli delle province e dei comuni, anche se i
prestiti rimangono il primo strumento di finanziamento di tali enti,
destinatari, per la quasi totalità del loro ammontare, dei prestiti erogati
dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. alle Amministrazioni locali.
Le entrate
Le entrate complessive delle Amministrazioni Pubbliche, dopo
aver registrato una tendenza alla riduzione della propria incidenza sul PIL,
tra il 2001 e il 2005, hanno ripreso la loro crescita, a partire dal 2005. Tra
il 2005 e il 2007, le entrate totali aumentano, in percentuale del prodotto, di
3 punti percentuali. La variazione riguarda essenzialmente le entrate correnti.
Le entrate in conto capitale vedono invece ridurre il proprio peso sul prodotto
interno lordo, a causa del venir meno dei provvedimenti di sanatoria fiscale,
il cui gettito è classificato tra le entrate in conto capitale.
Le entrate della P.A.
|
(Milioni di euro)
|
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Imposte dirette
|
171.833
|
183.998
|
179.554
|
178.745
|
185.331
|
189.815
|
213.308
|
233.660
|
|
Imposte indirette
|
175.037
|
176.952
|
185.174
|
186.770
|
195.401
|
202.736
|
220.181
|
225.928
|
|
Contributi sociali
|
147.985
|
153.823
|
161.275
|
168.776
|
175.965
|
183.445
|
189.683
|
204.772
|
|
Altre entrate correnti
|
35.489
|
40.090
|
40.613
|
45.278
|
50.247
|
49.600
|
52.194
|
55.272
|
|
Entrate correnti
|
535.377
|
558.872
|
571.231
|
579.569
|
606.944
|
625.596
|
675.366
|
719.632
|
|
Imposte in c/capitale
|
1.117
|
1.065
|
2.986
|
17.932
|
8.374
|
1.871
|
225
|
300
|
|
Totale entrate in c/capitale
|
5.044
|
3.469
|
5.667
|
22.290
|
12.180
|
5.952
|
4.474
|
4.614
|
|
Totale entrate
|
540.421
|
562.341
|
576.898
|
601.859
|
619.124
|
631.548
|
679.840
|
724.246
|
|
(Variazioni %)
|
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Imposte dirette
|
2%
|
7,1%
|
-2,4%
|
-0,5%
|
3,7%
|
2,4%
|
12,4%
|
9,5%
|
|
Imposte indirette
|
5%
|
1,1%
|
4,6%
|
0,9%
|
4,6%
|
3,8%
|
8,6%
|
2,6%
|
|
Contributi sociali
|
5%
|
3,9%
|
4,8%
|
4,7%
|
4,3%
|
4,3%
|
3,4%
|
8,0%
|
|
Altre entrate correnti
|
-
|
13,0%
|
1,3%
|
11,5%
|
11,0%
|
-1,3%
|
5,2%
|
5,9%
|
|
Entrate correnti
|
3%
|
4,4%
|
2,2%
|
1,5%
|
4,7%
|
3,1%
|
8,0%
|
6,6%
|
|
Imposte in c/capitale
|
-11%
|
-4,7%
|
180,4%
|
500,5%
|
-53,3%
|
-77,7%
|
-88,0%
|
33,3%
|
|
Totale entrate in c/capitale
|
-10%
|
-31,2%
|
63,4%
|
293,3%
|
-45,4%
|
-51,1%
|
-24,8%
|
3,1%
|
|
Totale entrate
|
3%
|
4,1%
|
2,6%
|
4,3%
|
2,9%
|
2,0%
|
7,6%
|
6,5%
|
|
|
|
(% del PIL)
|
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Imposte dirette
|
14,4%
|
14,7%
|
13,9%
|
13,4%
|
13,3%
|
13,3%
|
14,4%
|
15,2%
|
|
Imposte indirette
|
14,7%
|
14,2%
|
14,3%
|
14,0%
|
14,0%
|
14,2%
|
14,9%
|
14,7%
|
|
Contributi sociali
|
12,4%
|
12,3%
|
12,5%
|
12,6%
|
12,6%
|
12,8%
|
12,8%
|
13,3%
|
|
Altre entrate correnti
|
3,0%
|
3,2%
|
3,1%
|
3,4%
|
3,6%
|
3,5%
|
3,5%
|
3,6%
|
|
Entrate correnti
|
44,9%
|
44,8%
|
44,1%
|
43,4%
|
43,6%
|
43,8%
|
45,6%
|
46,9%
|
|
Imposte in c/capitale
|
0,1%
|
0,1%
|
0,2%
|
1,3%
|
0,6%
|
0,1%
|
0,0%
|
0,0%
|
|
Totale entrate in c/capitale
|
0,4%
|
0,3%
|
0,4%
|
1,7%
|
0,9%
|
0,4%
|
0,3%
|
0,3%
|
|
Totale entrate
|
45,4%
|
45,0%
|
44,5%
|
45,1%
|
44,5%
|
44,2%
|
45,9%
|
47,2%
|
Le entrate correnti rappresentano,
nel periodo considerato, una percentuale delle entrate complessive il cui
valore è prossimo al 99 per cento. La riduzione, nel 2003, di circa 3 punti
percentuali del peso delle entrate correnti sulle entrate complessive è da
collegare al corrispondente incremento delle entrate in conto capitale. Quest’ultimo è dovuto, in via prevalente,
al gettito delle sanatorie fiscali introdotte con la legge finanziaria per il
2003, che ha avuto i suoi riflessi anche nel 2004 per effetto della facoltà di
versamento rateizzato delle imposte.
Nell’ambito delle
entrate correnti, le imposte dirette vedono progressivamente ridurre il loro
peso fino al 2005, per poi riacquistarlo nel 2006, mentre le imposte indirette
mostrano un’incidenza piuttosto stabile nel periodo considerato.
Incidenza % delle varie voci sul totale delle entrate
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Imposte
dirette
|
31,8
|
32,7
|
31,1
|
29,7
|
29,9
|
30,1
|
31,4
|
32,3
|
|
Imposte
indirette
|
32,4
|
31,5
|
32,1
|
31,0
|
31,6
|
32,1
|
32,4
|
31,2
|
|
Imposte
in c/capitale
|
0,2
|
0,2
|
0,5
|
3,0
|
1,4
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Totale entrate tributarie
|
64,4
|
64,4
|
63,7
|
63,7
|
62,8
|
62,5
|
63,8
|
63,5
|
|
Contributi
sociali effettivi
|
26,7
|
26,6
|
27,3
|
27,4
|
27,8
|
28,5
|
27,4
|
27,7
|
|
Contributi
sociali figurativi
|
0,7
|
0,7
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
Totale contributi sociali
|
27,4
|
27,4
|
28,0
|
28,0
|
28,4
|
29,0
|
27,9
|
28,3
|
|
Altre entrate correnti
|
6,6
|
7,1
|
7,0
|
7,5
|
8,1
|
7,9
|
7,7
|
7,6
|
|
Totale entrate correnti
|
99,1
|
99,4
|
99,0
|
96,3
|
98,0
|
99,1
|
99,3
|
99,4
|
|
Totale entrate in c/capitale
|
0,9
|
0,6
|
1,0
|
3,7
|
2,0
|
0,9
|
0,7
|
0,6
|
Per quanto riguarda il gettito del 2007, al cui andamento ha
contribuito sia la componente erariale (il Bilancio dello Stato) che quella
locale che ha registrato tassi di crescita più elevati, particolarmente
positivo è stato l’andamento del gettito IRPEF cresciuto su base annua del 5,7
per cento, delle imposte dirette pagate in autoliquidazione (IRES e una parte
dell’IRPEF) aumentate del 24,1 per cento e delle imposte di registro e bollo.
L’IVA è cresciuta del 4 per cento, in parte frenata da una riduzione dei
consumi dei prodotti petroliferi.
Complessivamente, come si evince dalla seguente tabella, fra
il 2000 e 2005, si registra una riduzione della pressione fiscale, pur
evidenziandosi un picco nel 2003 dovuto al gettito delle sanatorie fiscali, ed
un successivo innalzamento fra il 2005 e il 2007.
Più in particolare, il risultato relativo agli anni dal 2000
al 2005 è determinato da una riduzione della pressione tributaria (imposte
dirette, indirette e in conto capitale) che passa dal 29,2% al 27,6%,
parzialmente compensata da un incremento della pressione contributiva
(contributi sociali effettivi e figurativi) che dal 12,4% è salita al 12,8%.
Conto economico consolidato della P. A.
Indicatori della pressione fiscale
(% sul PIL)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Imposte indirette
|
14,4
|
14,7
|
13,9
|
13,4
|
13,3
|
13,3
|
14,4
|
15,2
|
|
Imposte dirette
|
14,7
|
14,2
|
14,3
|
14,0
|
14,0
|
14,2
|
14,9
|
14,7
|
|
Imposte c/capitale
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
1,3
|
0,6
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Totale imposte
|
29,2
|
29,0
|
28,4
|
28,7
|
28,0
|
27,6
|
29,3
|
29,9
|
|
Contributi
sociali effettivi
|
12,1
|
12,0
|
12,2
|
12,4
|
12,4
|
12,6
|
12,6
|
13,1
|
|
Contributi
sociali figurativi
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|
Totale contributi
|
12,4
|
12,3
|
12,5
|
12,6
|
12,6
|
12,8
|
12,8
|
13,3
|
|
Pressione
fiscale consolidata
|
41,6
|
41,3
|
40,8
|
41,4
|
40,6
|
40,5
|
42,1
|
43,3
|
Esaminando in dettaglio le voci relative alle imposte, si
assiste, nel medesimo periodo, ad una riduzione dell’incidenza rispetto al PIL
delle imposte dirette (-1,3 punti
percentuali). Si registra invece un’invarianza dei valori del 2005, rispetto a
quelli del 2001, per quanto attiene sia alle imposte indirette sia alle imposte
in conto capitale, determinandosi quindi una sostanziale corrispondenza tra
tassi di incremento del PIL e delle imposte in esame.
Con particolare riferimento al 2005, si rileva la forte
contrazione su base annua dell’incidenza sul PIL delle imposte in conto
capitale, connessa al venir meno degli introiti dei condoni fiscali,
parzialmente compensata dalla crescita, superiore al PIL, delle imposte
indirette e dei contributi sociali.
Con riferimento al 2007 si è registrato un aumento della
pressione fiscale pari a 1,2 punti percentuali rispetto al 2006.
Più in particolare, tale risultato è l’effetto di una
dinamica diversificata delle componenti del prelievo fiscale e parafiscale,
all’interno del quale le imposte dirette sono aumentate del 9,5 per cento,
quelle indirette del 2,6 per cento, i contributi sociali effettivi dell’8,0 per
cento. Alla crescita dei contributi sociali hanno contribuito, oltre
all’aumento dell’aliquota di legge per i lavoratori autonomi, anche gli
introiti dei contributi sociali per il TFR che le imprese con oltre 50 addetti
hanno versato all’INPS nel 2007, per i dipendenti che hanno scelto di mantenere
tale istituto piuttosto che destinare tali contributi alla previdenza
complementare.
Al riguardo si ricorda che l’indicatore della pressione
fiscale è ottenuto dal rapporto tra l’ammontare delle imposte (dirette,
indirette e in c/capitale) e dei contributi sociali (effettivi e figurativi) e
il PIL. L’Istituto nazionale di statistica, con un comunicato del 4 marzo 2008, in riferimento all’entità
della pressione fiscale nel 2007 e alla classificazione di alcune poste, ha
precisato quanto segue:
-
nei contributi sociali effettivi sono compresi,
in linea con i criteri Eurostat, i 5.508 milioni di euro versati all’INPS a
titolo di TFR;
-
l’importo relativo all’erogazione del bonus agli
incapienti (pari a 562 milioni di euro), previsto dall’articolo 44 del D.L. n.
159 del 2007, è stato classificato tra le prestazioni sociali in denaro. Tale
importo, essendo erogato ai soggetti passivi di IRPEF la cui imposta netta per
i redditi del 2006 è risultata pari a zero, è assimilabile alla fattispecie di
rimborso eccedente l’ammontare dell’imposta netta dovuta dal contribuente e
quindi, secondo le raccomandazioni stabilite a livello internazionale, va
classificato come prestazione sociale, in uscita del Conto delle
Amministrazioni pubbliche e non a riduzione delle imposte dirette;
-
l’importo di 4.939 milioni di euro conseguente
al D.L. n. 248 del 2007, che ha soppresso l’obbligo dei versamenti in acconto
da parte delle imprese Concessionarie della riscossione delle imposte, è stato
classificato tra gli altri trasferimenti in conto capitale. L’operazione
corrisponde ad un rimborso alle imprese Concessionarie di imposte pagate una - tantum nel 1997 (una prima volta)
e negli anni 1998, 1999 e 2002 (anni in cui si è avuto un aumento di aliquota).
Tale operazione, infatti, essendo disposta con un provvedimento legislativo ad hoc, genera un trasferimento
straordinario da classificare nel Conto delle Amministrazioni pubbliche tra le
“altre uscite in conto capitale”, analogamente a quanto già operato in
occasione di rimborsi pregressi di imposte decisi unilateralmente dallo Stato
(es. Eurotassa).
Come si evince dalla tabella iniziale, il 2006 e il 2007
sono anni caratterizzati da un forte incremento delle entrate. In particolare
nel corso del 2007 si è evidenziato un miglioramento del quadro tendenziale dovuto
prevalentemente a una dinamica molto positiva delle entrate tributarie,
superiore ai tassi di crescita dell’economia. Il Governo ha deciso di
utilizzare tale miglioramento per compensare misure di spesa, tese a realizzare
gli obiettivi di sviluppo ed equità sociale.
Ci si riferisce in particolare ai due decreti legge di
utilizzo dell’extragettito, il DL 81 del 2007 e il DL 159 del 2007, convertiti
rispettivamente dalle leggi n. 127 del 2007 e n. 222 del 2007.
L’andamento positivo delle entrate è stato ritenuto, in
parte di carattere strutturale, in quanto dovuto alla politica di lotta all’evasione.
In particolare nella Relazione riguardante i risultati della
lotta all’evasione, presentata al Parlamento dal Ministro dell’economia e delle
finanze in data 23 ottobre 2007, si stima che tra il 2006 e il 2007 siano stati
recuperati circa 23 miliardi di maggiori entrate non pagate e in buona parte
legate al miglioramento della tax
compliance dei cittadini.
Nel 2006, come si evidenzia dalla tabella che segue, le
entrate tributarie nette della Pubblica Amministrazioni sono cresciute del 10
per cento. Tale incremento è solo in misura limitata influenzato dagli introiti
dei provvedimenti una-tantum, al
netto dei quali il tasso di crescita delle entrate erariali è stato di circa
l’8,8 per cento.
Crescita annuale delle entrate tributarie, 2006
(%)
|
Entrate totali (al lordo delle una- tantum)
|
9,9
|
|
Imposte dirette
|
12,8
|
|
IRE
|
6,4
|
|
IRES
|
16,3
|
|
Imposte indirette
|
6,9
|
|
IVA
|
8,8
|
|
Accise
|
1,5
|
|
Atre indirette (Bolli e altro)
|
8,9
|
|
Varie (Giochi)
|
4,0
|
|
Entrate totali (al netto delle una- tantum)
|
8,8
|
Nelle tabelle che seguono, vengono inoltre spiegate le
determinanti della variazione di gettito registrate nel 2006 e 2007, sulla base
di quanto esposto nella stessa Relazione riguardante i risultati della lotta
all’evasione.
Cause di aumento del gettito erariale lordo dello Stato (2005-2006)
|
|
(miliardi di euro)
|
(%)
|
|
Totale aumento
|
35,8
|
100
|
|
Crescita
PIL
|
11,0
|
31
|
|
Una-tantum
e fattori eccezionali
|
8,1
|
22
|
|
Extra
gettito settore utilities
|
0,6
|
2
|
|
Manovre
permanenti (stimate)
|
5,0
|
14
|
|
Residuo/tax compliance
|
11,2
|
31
|
|
Misure
antievasione/elusione (DL 223/2006)
|
2,4
|
7
|
|
Altro
recupero di base imponibile/tax
compliance
|
8,8
|
24
|
Cause di aumento del gettito erariale lordo dello Stato (2006-2007)
|
|
(miliardi di euro)
|
(%)
|
|
Totale aumento
|
25,5
|
100
|
|
Crescita
PIL
|
15,9
|
62
|
|
Una-tantum
e fattori eccezionali
|
-5,5
|
-22
|
|
Manovre
permanenti (stimate)
|
3,0
|
12
|
|
Residuo/tax compliance
|
12,1
|
47
|
|
Misure
antievasione/elusione manovra 2007
|
5,4
|
21
|
|
Altro
recupero di base imponibile/tax
compliance
|
6,7
|
26
|
La medesima Relazione sottolinea, peraltro, la difficoltà di
sostenere per un tempo indefinito gli elevati tassi di recupero di gettito
registrati. Infatti, via via che la politica di contrasto all’evasione recupera
a tassazione base imponibile, i margini per ulteriori miglioramenti si
ridurranno e con essi gli effetti positivi aggiuntivi sulle entrate. Questo
fenomeno è, inoltre, in parte visibile nella diminuzione dell’elasticità delle
entrate totali al PIL, fra il 2006 e il 2007 (passata dal 2,72 nel 2006,
all’1,01 nel 2007).
Si espongono, di seguito, alcuni dati riguardanti gli incassi
tributari contabilizzati nel bilancio dello Stato e la loro composizione.
Si precisa che i dati non consentono un confronto del tutto
omogeneo tra i vari esercizi, occorre infatti precisare che l’analisi condotta
sugli incassi del Bilancio dello Stato ha una finalità meramente indicativa in
quanto, trattandosi di dati di cassa, le variazioni rilevate da un esercizio
all’altro possono risultare ampiamente influenzate da fattori di natura
meramente contabile, che possono aver agito sulle modalità e sui tempi di
acquisizione delle somme.
Gli incassi tributari
erariali passano da 294.337 milioni nel 2000 a 403.850 nel 2007.
Nella tabella che segue, vengono forniti i dati disaggregati
in ragione delle diverse tipologie d’imposta, riferiti agli incassi tributari
per ciascun anno considerato e alle relative variazioni percentuali annue.
Bilancio dello Stato – Incassi rettificati realizzati
Analisi per tipo di imposta (voci principali)
(milioni di euro – in corsivo i valori percentuali)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Imposte dirette(1)
|
162.749
|
176.644
|
170.476
|
177.541
|
182.036
|
179.529
|
203.324
|
219.220
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
IRE/IRPEF
|
113.707
|
121.111
|
120.087
|
124.216
|
127.692
|
132.654
|
142.033
|
150.283
|
|
|
69,87
|
68,56
|
70,44
|
69,96
|
70,15
|
73,89
|
69,86
|
68,55
|
|
IRES/IRPEG
|
28.589
|
32.516
|
30.615
|
29.056
|
28.018
|
33.691
|
39.468
|
50.530
|
|
|
17,57
|
18,41
|
17,96
|
16,37
|
15,39
|
18,77
|
19,41
|
23,05
|
|
ILOR
|
165
|
192
|
146
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
0,10
|
0,11
|
0,09
|
|
|
|
|
|
|
Sostitutiva
|
6.073
|
8.816
|
8.884
|
7.348
|
6.726
|
6.763
|
8.664
|
10.626
|
|
|
3,73
|
4,99
|
5,21
|
4,14
|
3,69
|
3,77
|
4,26
|
4,85
|
|
Ritenuta sui dividendi
|
243
0,15
|
239
0,14
|
301
0,18
|
258
0,15
|
305
0,17
|
489
0,27
|
733
0,36
|
528
0,24
|
|
Condoni, concordati e pendenze
tributarie
|
-
|
-
|
-
|
7.932
4,47
|
7.484
4,11
|
-
|
-
|
-
|
|
Rivalutazione beni d'impresa
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
719
0,40
|
4.316
2,12
|
313
0,14
|
|
Altre
|
13.972
|
13.770
|
10.443
|
8.731
|
11.811
|
5.213
|
8.110
|
6.940
|
|
|
8,58
|
7,80
|
6,13
|
4,92
|
6,49
|
2,90
|
3,99
|
3,17
|
Segue
tabella
|
(milioni di euro – in corsivo i valori percentuali)
|
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
IMPOSTE INDIRETTE(1)
|
131.588
100
|
144.553
100
|
149.218
100
|
155.117
100
|
159.338
100
|
162.867
100
|
176.142
100
|
184.630
100
|
|
di cui
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AFFARI(2)
|
88.143
|
102.953
|
106.740
|
111.676
|
116.644
|
119.938
|
131.772
|
138.635
|
|
|
66,98
|
71,22
|
71,53
|
71,99
|
73,21
|
73,64
|
74,81
|
75,09
|
|
- IVA
|
84.355
|
86.709
|
89.463
|
92.257
|
97.053
|
101.733
|
111.272
|
116.633
|
|
|
64,11
|
59,98
|
59,95
|
59,48
|
60,91
|
62,46
|
63,17
|
63,17
|
|
- Registro, bollo e sostitutiva
|
7.446
5,66
|
7.431
5,14
|
7.651
5,13
|
7.824
5,04
|
9.815
6,16
|
9.417
5,78
|
10.947
6,21
|
11.395
6,17
|
|
-
Condoni, concordati e pendenze tributarie
|
-
|
-
|
-
|
3.184
2,05
|
1.327
0,83
|
-
|
-
|
-
|
|
PRODUZIONE
|
27.191
|
26.565
|
25.917
|
28.823
|
27.677
|
28.673
|
28.899
|
28.455
|
|
|
20,66
|
18,38
|
17,37
|
18,58
|
17,37
|
17,61
|
16,41
|
15,41
|
|
- Oli minerali
|
19.606
|
20.091
|
19.886
|
21.805
|
20.994
|
21.228
|
21.354
|
21.082
|
|
|
14,90
|
13,90
|
13,33
|
14,06
|
13,18
|
13,03
|
12,12
|
11,42
|
|
MONOPOLI
|
7.367
|
7.314
|
7.703
|
7.779
|
8.509
|
8.516
|
9.355
|
9.791
|
|
|
5,60
|
5,06
|
5,16
|
5,01
|
5,34
|
5,23
|
5,31
|
5,30
|
|
- Tabacchi
|
7.357
|
7.305
|
7.685
|
7.770
|
8.502
|
8.511
|
9.349
|
9.785
|
|
|
5,59
|
5,05
|
5,15
|
5,01
|
5,34
|
5,23
|
5,31
|
5,30
|
|
LOTTO(3)
|
8.887
|
7.721
|
8.858
|
6.839
|
6.508
|
5.740
|
6.116
|
7.749
|
|
|
6,75
|
5,34
|
5,94
|
4,41
|
4,08
|
3,52
|
3,47
|
4,20
|
|
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE
|
294.337
|
321.197
|
319.694
|
332.658
|
341.374
|
342.396
|
379.466
|
403.850
|
(1) I dati del 2007 comprendono la quota di condono di
spettanza dell’erario, ancora da ripartire, stimata in 44 milioni, attribuibile
per 35 milioni alle imposte dirette e per 9 milioni alle indirette.
(2) Al netto delle regolazioni contabili dell’acconto
da parte dei concessionari pari a 4.592 nel 2003, 4.407 milioni nel 2004, 4.248
milioni nel 2005 e 4.511 milioni nel 2006. Tale acconto non è stato effettuato
nel 2007 in
virtù delle disposizioni di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del D.L. 248 del
2007.
(3) Al netto delle regolazioni contabili relative al
LOTTO (pari a 8.150 milioni nel 2004, 6.614 milioni nel 2005, 4.078 milioni nel
2006 e 4.048 milioni nel 2007)
Sull’andamento del gettito
dell’IRES
incide anche la riforma dell’imposta sul reddito delle società che ha
modificato il sistema di tassazione dei redditi delle imprese, producendo
effetti, in termini di cassa, a decorrere al 2005.
La legge delega per la riforma del sistema fiscale prevedeva un incremento
delle imposte sul reddito delle società (attraverso l’ampliamento della base
imponibile) diretto a compensare la graduale eliminazione dell’IRAP. In sede
attuativa, si è proceduto all’approvazione del decreto di riforma dell’IRES,
mentre non è stata portata a termine l’attuazione della delega in materia di
IRAP. Tuttavia, nel corso
della XV legislatura, il Governo è intervenuto in materia di IRAP, prima con la
legge finanziaria per il 2007 e le norme relative al “cuneo fiscale” e successivamente con le
disposizioni
contenute nella legge finanziaria per il 2008, relative alla riduzione
dell’aliquota IRAP, dal 4,25 al 3,9 per cento.
Il gettito IRPEF evidenzia un andamento discontinuo dovuto alla
presenza di fattori con effetti finanziari contrapposti.
Ad esempio, tra i fattori che presumibilmente hanno
contribuito al contenimento del gettito si segnalano i provvedimenti
emanati in attuazione della legge delega diretti a ridurre il carico fiscale
delle persone fisiche.
D’altro canto, effetti di ampliamento del gettito,
particolarmente evidenti nel 2005, sono da collegare alla dinamica delle
retribuzioni che, comportando un ampliamento della base imponibile, induce
incrementi del gettito IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.
Con riferimento agli anni 2006 e 2007, si registra un
aumento sia delle imposte dirette che di quelle indirette. Per quanto riguarda
le imposte dirette, l’aumento registrato per l’IRE è ascrivibile
prevalentemente alle ritenute sui dipendenti privati e, solo per il 2006, sui
dipendenti pubblici,
nonché alle ritenute d’acconto per i redditi da lavoro autonomo. Il 2007,
inoltre, registra un forte incremento dei versamenti per autotassazione, sia a
saldo, sia in acconto. Anche l’IRES registra un andamento molto positivo,
dovuto prevalentemente ai versamenti per autotassazione in acconto e a saldo.
Nel comparto delle imposte indirette si registra un
incremento per la categoria “Affari”, imputabile oltre che all’IVA, alle
imposte di bollo, registro e sostitutiva, nonché alle imposte sulle
assicurazioni e ipotecaria.
La categoria Monopoli registra un incremento sia nel 2006
che nel 2007 dovuto, essenzialmente, all’imposta sui tabacchi.
Nel 2007, invece, si evidenzia una flessione della categoria
della “Produzione”, dovuta prevalentemente alle perdite di gettito registrate
dalle accise sugli oli minerali.
Per quanto riguarda le principali entrate tributarie degli
enti territoriali si riportano, nella seguente tabella, i dati relativi agli
incassi dell’IRAP e delle addizionali all’IRE comunale e regionale.
Bollettino delle
entrate tributarie erariali – Incassi
Entrate tributarie
degli enti territoriali
(milioni di euro)
|
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Addizionale regionale IRE
|
4.430
|
4.975
|
6.166
|
6.741
|
6.430
|
6.199
|
7.387
|
|
di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
privati
|
2.929
|
3.015
|
3.743
|
3.822
|
3.913
|
3.776
|
4.450
|
|
-
amministrazioni pubbliche
|
1.501
|
1.960
|
2.423
|
2.919
|
2.517
|
2.423
|
2.937
|
|
Addizionale comunale IRE
|
715
|
1.096
|
1.572
|
1.615
|
1.555
|
1.561
|
2.229
|
|
di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
privati
|
416
|
607
|
844
|
881
|
909
|
906
|
1.291
|
|
-
amministrazioni pubbliche
|
299
|
489
|
728
|
734
|
646
|
651
|
938
|
|
IRAP
|
31.287
|
32.072
|
33.590
|
33.384
|
35.995
|
39.090
|
40.927
|
|
di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
privati
|
23.098
|
23.689
|
24.322
|
23.803
|
26.293
|
28.744
|
30.543
|
|
-
amministrazioni pubbliche
|
8.189
|
8.383
|
9.268
|
9.581
|
9.702
|
10.346
|
10.384
|
Per quanto riguarda le stime complessive per l’anno 2008, si
riportano, nella tabella che segue, i dati, relativi alle entrate nel conto
economico consolidato della P.A., indicati nella Relazione unificata
sull’economia e la finanza pubblica del marzo 2008, confrontati con le
previsioni indicate nel Documento di programmazione economica 2008-2011, del
giugno 2007 e nella Relazione previsionale e programmatica per il 2008, del
settembre 2007.
Previsioni per il 2008
(milioni di euro)
|
|
DPEF
|
RPP
|
RUEF
|
|
Totale entrate tributarie
|
468.192
|
472.487
|
470.810
|
|
imposte dirette
|
237.569
|
241.228
|
241.102
|
|
imposte indirette
|
230.267
|
230.903
|
229.476
|
|
imposte in c/capitale
|
356
|
356
|
232
|
|
Contributi sociali
|
216.214
|
218.141
|
214.141
|
|
contributi effettivi
|
212.531
|
214.429
|
210.143
|
|
contributi figurativi
|
3.683
|
3.712
|
3.998
|
|
Altre entrate correnti
|
54.000
|
54.106
|
56.631
|
|
Totale entrate correnti
|
738.050
|
744.378
|
741.350
|
|
Entrate in conto capitale
|
4.410
|
4.411
|
4.876
|
|
Totale entrate finali
|
742.816
|
749.145
|
746.458
|
Rispetto ai dati indicati nella Relazione Previsionale e
Programmatica, le nuove stime evidenziano alcuni scostamenti. Ci si riferisce
in particolare a:
-
un minor gettito tributario netto per 1.677
milioni in seguito a: la revisione al ribasso della crescita per il 2008,
dall’1,5 per cento di settembre 2007 allo 0,6 per cento attuale, con un effetto
complessivo stimato in 2.392 milioni; lo slittamento dal 2007 di parte delle
previste minori entrate per la riduzione del “cuneo fiscale” (circa 1.000
milioni); l’adeguamento dei coefficienti catastali di riferimento per l’ICI
(circa 600 milioni). Il minor gettito è in parte compensato dall’effetto di
trascinamento delle maggiori entrate acquisite nel 2007;
-
minori contributi sociali per 4.286 milioni
correlati alla revisione del quadro macroeconomico (950 milioni) e, per la
restante parte, principalmente ad una rivalutazione, da parte dell’ISTAT, del
coefficiente di svalutazione utilizzato ai fini dell’accertamento dell’evasione
contributiva;
-
maggiori “altre entrate correnti” per 2.525
milioni, per adeguamento della stima rispetto ai maggiori introiti realizzati
nel 2007.
In linea generale le stime, contenute nella RUEF, relative
alle entrate complessive, si discostano rispetto alle previsioni contenute
nella RPP di 2.687 milioni di euro.
Rispetto al 2007, le previsioni per l’anno in corso scontano
una diminuzione delle entrate complessive rispetto al PIL dello 0,3%.
Conseguentemente la pressione fiscale è prevista diminuire dal 43,3 per cento
nel 2007 al 43,1 per cento nel 2008.
Con riferimento al triennio 2009–2011, la RUEF stima un andamento delle entrate
come illustrato nella tabella che segue.
Previsioni per il 2009-2011
(milioni di euro)
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Totale entrate tributarie
|
484.004
|
503.636
|
521.389
|
|
imposte dirette
|
245.846
|
258.842
|
269.752
|
|
imposte indirette
|
237.926
|
244.562
|
251.405
|
|
imposte in c/capitale
|
232
|
232
|
232
|
|
Contributi sociali
|
220.450
|
226.833
|
233.790
|
|
contributi effettivi
|
216.406
|
222.721
|
229.605
|
|
contributi figurativi
|
4.044
|
4.112
|
4.185
|
|
Altre entrate correnti
|
57.782
|
59.005
|
60.519
|
|
Totale entrate correnti
|
762.004
|
789.242
|
815.466
|
|
Entrate in conto capitale
|
5.320
|
5.363
|
5.404
|
|
Totale entrate finali
|
767.556
|
794.837
|
821.102
|
Si prevede pertanto che, nel periodo, le entrate complessive
diminuiscano in percentuale al PIL, rispetto al 2008 in misura pari a circa lo 0,2
per cento e conseguentemente la pressione fiscale è prevista assestarsi, nel
periodo considerato, sul valore del 42,9 per cento.
Le uscite
delle pubbliche amministrazioni
Tra il 2000 e il
2007 si è verificato un aumento delle uscite complessive, la cui incidenza sul
PIL è passata dal 46,2 al 49,1 per
cento. L’incremento di circa tre punti è ascrivibile interamente alla spesa
primaria, che passa da circa il 40 al 44 per cento del PIL, a fronte di una
contrazione della spesa per interessi (dal 6,3 al 5 per cento). Parte della
variazione è spiegata dalla particolare evoluzione delle uscite una tantum. Se si considerano le uscite complessive al netto
degli oneri straordinari e delle altre misure una tantum (quali le
dismissioni immobiliari) che incidono sulle spesa in conto capitale,
nel periodo in esame, l’incidenza sul PIL aumenta infatti in misura più
limitata e pari a 1,3 punti.
|
Le
uscite della P.A.
(%PIL)
|
|
Anni
|
Uscite correnti al netto interessi
|
Interessi
|
Uscite correnti
|
Uscite capitali
|
Totale uscite
|
Totale uscite al netto interessi
|
Totale uscite al netto una
tantum
|
Totale uscite al netto interessi e
una tantum
|
|
2000
|
37,3
|
6,3
|
43,6
|
2,6
|
46,2
|
39,9
|
47,5
|
41,1
|
|
2001
|
37,6
|
6,3
|
43,9
|
4,2
|
48,1
|
41,8
|
48,3
|
42,0
|
|
2002
|
38,3
|
5,5
|
43,8
|
3,6
|
47,4
|
41,9
|
48,3
|
42,7
|
|
2003
|
39,1
|
5,1
|
44,2
|
4,3
|
48,6
|
43,4
|
48,8
|
43,7
|
|
2004
|
39,3
|
4,7
|
44,0
|
3,9
|
48,0
|
43,3
|
48,3
|
43,6
|
|
2005
|
39,8
|
4,5
|
44,4
|
4,1
|
48,4
|
43,9
|
48,7
|
44,1
|
|
2006
|
39,7
|
4,6
|
44,3
|
5,0
|
49,3
|
44,7
|
48,4
|
43,8
|
|
2007
|
39,6
|
5,0
|
44,6
|
4,5
|
49,1
|
44,1
|
48,8
|
43,8
|
|
2008
|
40,2
|
5,0
|
45,2
|
4,2
|
49,4
|
44,4
|
49,4
|
44,5
|
|
2009
|
39,6
|
4,9
|
44,5
|
4,3
|
48,8
|
43,9
|
48,9
|
44,0
|
|
2010
|
39,5
|
4,9
|
44,3
|
4,1
|
48,4
|
43,6
|
48,5
|
43,7
|
|
2011
|
39,2
|
4,8
|
44,0
|
4,1
|
48,1
|
43,2
|
48,1
|
43,3
|
|
Fonte: Istat anni 2000-2007; RUEF
anni 2008-2011
|
Per il 2008, è
previsto un ulteriore aumento delle uscite complessive (3 decimi di punto),
quale effetto di maggiori spese primarie correnti (6 decimi di punto),
parzialmente compensate da minori spese in conto capitale. La spesa per
interessi risulta stabile al 5 per cento del PIL, dopo essere aumentata di
circa quattro decimi nel 2007.
Nel triennio
2009-2011, le previsioni contenute nella RUEF indicano un ridimensionamento
delle uscite complessive, che passano dal 49,4 del 2008 al 48,8 del 2009 e al
48,1 del 2011. Tale andamento riflette quello di tutte le componenti della
spesa, ed in particolare delle uscite primarie correnti che si riducono di un
punto di PIL.
Con un’incidenza sul PIL superiore al 49%, le uscite complessive
tornano, quindi, nel 2007, sui livelli di fine anni ’90 quando peraltro, a
fronte di una spesa per interessi ancora piuttosto elevata (8-9 punti di PIL),
la spesa primaria si collocava intorno al 41%. Negli anni successivi
all’ingresso nella Unione economica e monetaria si assiste, invece, ad un
costante ridimensionamento della spesa per interessi, mentre la spesa primaria,
toccato il minimo nel 2000 (39,9% del PIL),
riprende ad aumentare.
Tale dinamica sembra invertirsi nel biennio 2006-2007 quando ricomincia
a crescere la spesa per interessi e si riducono le uscite primarie.
L’evoluzione illustrata può essere scomposta in due principali
componenti: da una parte l’effetto prezzo; dall’altra la variazione reale della
spesa. Il primo dei due fattori, misurato come rapporto tra il valore a prezzi
correnti della spesa e le quantità di beni e servizi offerti, risulta nel
periodo considerato più elevato del corrispondente deflatore dei consumi
privati, ma anche dei corrispondenti valori degli stessi indici per i
principali Paesi europei. Il
secondo, misurato dalla variazione delle quantità di beni e servizi offerti,
registra in tutto il periodo illustrato, fatta eccezione per il triennio
1993-1995, un valore positivo e pari in media al 2 per cento seppure negli
ultimi anni si registri una decelerazione del tasso di crescita.

Guardando alla composizione della spesa, come evidenziato dalla tavola
che segue, oltre il 10% delle uscite complessive (al netto una tantum) risulta
assorbito, nel 2007, dalla spesa per interessi e, per il 35,4%, dalle
prestazioni sociali in denaro: sono, queste, spese relativamente rigide e solo
marginalmente influenzabili dalle Autorità fiscali nel breve periodo, o perché
dipendenti dallo stock di debito pubblico accumulato e dall’andamento dei tassi
di interesse sui mercati finanziari internazionali, o perché influenzate da
dinamiche demografiche e dal conseguente accesso ai benefici pensionistici
(configurabili come diritti soggettivi e come tali non comprimibili) previsti
dalla legislazione vigente.
Un grado di flessibilità solo lievemente superiore presentano le uscite
della P.A. per le retribuzioni del pubblico impiego, che costituiscono circa il
22% del totale. Tra le altre uscite, circa il 16% è dato dalla spesa per
consumi intermedi; la quota residuale delle altre uscite correnti si
colloca invece intorno al 7,6 per cento. La spesa in conto capitale, infine,
assorbe l’8,5% della spesa complessiva.
Composizione % della spesa
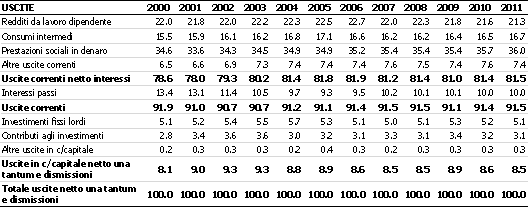
Rispetto all’anno 2000, il peso
degli interessi sulla spesa complessiva si riduce di oltre 3 punti, mente si
osserva un aumento di 2,7 punti per la spesa corrente. L’incremento più
rilevante è quello delle “altre spese correnti” (+1,1 punti) e delle
prestazioni sociali in denaro (+0,8 punti); l’incidenza dei consumi intermedi
cresce complessivamente di 0,7 punti (dal 15,% al 16,2%) seppure con un
andamento discontinuo. Aumenta infatti il loro peso nel primo quinquennio, a
fronte di un contenimento negli ultimi due anni. Risultano invece stabili i
redditi da lavoro dipendente grazie anche al rinvio al 2008 di parte dei
rinnovi contrattuali relativi al biennio 2006-2007. La spesa in conto capitale,
al netto delle misure una tantum,
aumenta di 4 decimi di punto, per effetto dei contributi agli investimenti,
mentre risulta stabile l’incidenza della spesa per investimenti fissi lordi e
delle altre uscite in conto capitale.
L’evoluzione
complessiva della spesa risente negli ultimi anni di molteplici fattori: assume
un ruolo non trascurabile il fattore inerziale, per cui, una volta acquisito un
certo livello di spesa è particolarmente complesso tornare su valori inferiori
a quelli già conseguiti; riflette i numerosi interventi di contenimento
adottati con le successive finanziarie e, generalmente, in corso d’anno con
provvedimenti definiti con carattere di urgenza; risente, in particolare per il
2007, delle disposizioni di alcuni interventi – decreto legge 81/2007 e decreto
legge 159/2007 - che hanno prodotto un non trascurabile incremento netto delle
uscite impiegando le risorse in eccesso rispetto alle previsioni sui saldi
formulate con i successivi Documenti programmatici; infine, sconta gli effetti,
a volte rilevanti, di alcune misure di carattere non permanente contabilizzate
tra le uscite in conto capitale.
Rispetto ai valori
indicati con le Relazioni Trimestrali di Cassa degli ultimi anni, le uscite
registrate a consuntivo hanno tendenzialmente mostrato valori discosti da
quelli attesi sulla base delle previsioni contenute nei citati Documenti. Nel
grafico seguente si riporta la differenza tra la variazione percentuale
registrata a consuntivo per le uscite totali primarie (al netto una tantum), rispetto alla variazione
prevista nella RTC di marzo dello stesso anno di quello stimato. Tali andamenti
evidenziano come le pur numerose misure di contenimento adottate in questi anni
non siano riuscite, nel breve periodo, a produrre un ridimensionamento
strutturale della spesa pubblica primaria, condizione, questa, necessaria, dati
i vincoli posti dal rispetto del Patto di stabilità e crescita, per una
riduzione del livello della pressione fiscale.
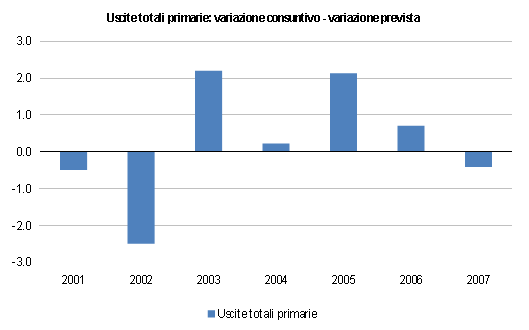
Proprio alla luce di
tali considerazioni é stata avviata nel 2007 un’azione di revisione complessiva
dei meccanismi alla base della spesa pubblica (la spending review). Con
l’obiettivo di ottenere un ridimensionamento e, al contempo, una
riqualificazione della spesa, la finanziaria per il 2007 ha affiancato alle misure di contenimento delle
uscite l’istituzione di un’apposita commissione, Commissione Tecnica per la
Finanza Pubblica,
che ha avviato, in via sperimentale, l’analisi del bilancio di cinque Ministeri
che si sono offerti di collaborare in questo percorso.
Una prima esposizione del percorso che la
Commissione ha compiuto ed una indicazione del programma di lavoro, sono contenuti
nel Rapporto intermedio pubblicato nel dicembre del 2007; una più ampia
rassegna delle principali criticità riscontrate per i Ministeri analizzati e
delle rispettive proposte saranno oggetto dei prossimi documenti della stessa
Commissione.
In termini generali,
vale la pena sottolineare, il cambio di impostazione che la costituzione della
Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica dovrebbe imprimere al controllo della spesa.
L’analisi micro-fondata delle problematiche e criticità della spesa, da
condurre, peraltro, in collaborazione con le Amministrazioni e con il supporto
della Ragioneria Generale dello Stato, dovrebbe consentire il superamento delle
difficoltà incontrate negli ultimi anni dalle misure di taglio indistinto alle
dotazioni di bilancio dei singoli Enti. Il coinvolgimento delle Amministrazioni
interessate, dovrebbe inoltre consentire la diffusione di una cultura della
valutazione, molto spesso assente nel settore pubblico.
La spesa per
interessi,
tra il 2000 e il 2007, riduce la sua incidenza sul PIL di 1,3 punti.
L’andamento è tuttavia differenziato se si prendono in considerazione,
rispettivamente, il periodo 2000-2005 e l’ultimo biennio.
Nel periodo
2000-2005, si verifica una riduzione della spesa sia come incidenza sul PIL (dal
6,3 al 4,5 per cento), sia in valore
assoluto. Tale variazione può spiegarsi con la riduzione dello stock del debito
pubblico e una più accorta gestione degli strumenti dello stesso, la discesa
dei tassi di interesse sui mercati internazionali e la riduzione del premio
aggiuntivo richiesto sui titoli del debito pubblico italiano in relazione al
minor grado di “rischio paese” che l’Italia sconta in seguito all’ingresso
nell’area euro.
Tale favorevole
andamento si arresta nel 2006, quando, a fronte di un aumento dello stock del
debito dal 105,8 per cento del PIL nel 2005 al 106,5 per cento dell’anno
successivo, la spesa per interessi riprende a crescere.
Nel 2007 la spesa presenta un nuovo,
significativo, aumento (+12,4%), passando dal 4,6 al 5 per cento del PIL,
nonostante la riduzione di 2,5 punti del rapporto debito/PIL (104%).
La crescita della spesa del 2007 si
è verificata in presenza di un aumento generalizzato dei tassi di interesse di
mercato nei primi sette mesi dell’anno, che ha determinato un aumento del costo
medio ponderato delle emissioni del 4,14% rispetto al 3,32% del 2006. In tale periodo, infatti, è stato
infatti collocato oltre il 70% del programma annuale di emissioni di titoli di
Stato, anche in previsione (come specificato nella RUEF) di ulteriori
incrementi di tassi poi non realizzatisi per via della crisi finanziaria
internazionale. Per quanto riguarda le Amministrazioni locali, il rialzo dei
tassi registrato nel 2007 si è immediatamente tradotto in un incremento di
spesa data l’elevata quota di passività in circolazione a tasso variabile.
Sull’aumento della spesa hanno inciso, inoltre, le operazioni di swap, che negli anni precedenti avevano
invece contenuto gli esborsi, e un fattore di natura contabile: la flessione
della stima dell’onere relativo ai SIFIM (servizi di intermediazione
finanziaria misurati indirettamente) che nei conti nazionali viene portato in
riduzione degli interessi e imputato ai consumi intermedi.
Per l’anno in corso
si prevede una sostanziale stabilità (5%) in termini di incidenza sul PIL della
spesa per interessi, che si riduce lievemente (2 decimi di punto) entro la fine
del periodo di previsione (4,8% nel 2011), quale effetto principalmente di una
riduzione dello stock del debito pubblico,
a fronte di un’evoluzione dei tassi sui mercati internazionali che tornano su
livelli (più elevati rispetto al primo trimestre del 2008) coerenti con il
quadro macroeconomico previsto prima dell’inizio della crisi finanziaria
statunitense.
Per quanto riguarda
la spesa primaria, nel periodo 2000-2007 si riscontra un aumento dell’incidenza
sul PIL di circa 2,3 punti nelle uscite correnti (che passano dal 37,3 al 39,6
per cento) e di 1,9 punti in quelle in conto capitale (dal 2,6 al 4,5 per
cento).
Su quest’ultima, peraltro, incidono,
in diminuzione, le maggiori risorse derivanti dalle dismissioni immobiliari e,
in aumento, le maggiori spese straordinarie sostenute negli anni 2006 e 2007.
Al netto di tali componenti, si osserva una crescita più contenuta della spesa
in conto capitale che passa dal 3,8% del Pil nel 2000 al 4,2% del 2007.
Si può inoltre osservare che
sull’evoluzione della spesa primaria corrente pesa per 1 punto di PIL la
dinamica della spesa sanitaria, che passa dal 5,7% nel 2000 al 6,7% nel 2007.
Tale voce non è indicata autonomamente nel conto economico consolidato della
P.A., ma è il risultato dell’aggregazione di varie componenti di spesa
riconducibili al settore sanitario, ed in particolare i costi del personale
(facenti parte dell’aggregato redditi da lavoro dipendente) e le spese per
l’acquisto di beni e servizi (facenti parte dell’aggregato consumi intermedi).
In termini di tasso
di variazione, nel periodo in esame le uscite complessive primarie crescono in
media del 4,6% annuo (al netto delle misure straordinarie in diminuzione o in
aumento della spesa). Una variazione più elevata mostrano, nello stesso
periodo, i consumi intermedi (+5,5%), le altre uscite correnti (+6,2%) e i
contributi agli investimenti (+6,7%).
Tali variazioni sono il risultato, peraltro, di andamenti
alquanto differenziati nei singoli anni: a fronte di una crescita media annua
delle uscite complessive primarie
pari al 5,1% nel periodo 2000-2005, nel biennio 2006-2007 la variazione è del
3,3%. Si riduce in particolare il ritmo di crescita dei consumi intermedi (dal
6,9% all’1,1%), delle “altre uscite correnti” (dal 6,5% al 5,4%) e degli
investimenti fissi lordi (dal 5,2% all’1%). Per quanto riguarda i redditi da
lavoro dipendente (dal 4,7 al 2,6%), sulla variazione più contenuta nel biennio
2006-2007 influisce il parziale rinvio dei rinnovi contrattuali.
Per il 2008, la previsione a legislazione vigente contenuta
nella RUEF, indica un nuovo aumento dell’incidenza della spesa primaria sul
PIL, che passa dal 44,1 al 44,4 per cento. L’aumento è più rilevante se si
considera che sul 2007 pesavano oneri straordinari per circa 0,4 punti di PIL.
In termini di tasso di variazione annuo, le uscite complessive al netto degli
interessi crescono del 4,3%, quale risultato di un aumento del 5,2% delle spese
correnti e di una riduzione del 3,5% di quelle in conto capitale (+5% se si
considera il dato al netto degli misure straordinarie).
Nel triennio
2009-2011, la spesa primaria che dovrebbe riprendere a diminuire per collocarsi,
a fine periodo, al 43,2 per cento del PIL. Tale stima non tiene conto,
peraltro, delle maggiori spese correnti (come ad esempio i rinnovi
contrattuali) e di parte capitale che, per prassi consolidate, vengono
rifinanziate con la legge finanziaria.
Ove si
considerassero anche tali spese, pari complessivamente a 3-4 miliardi di euro
annui secondo la RUEF, l’incidenza della spesa primaria sul PIL passerebbe già
nel 2009 dal 43,9 al 44,2 per cento.
Guardando in particolare al 2007, si
rileva come in tale anno si verifichi, rispetto al precedente, un rallentamento
nella dinamica della spesa primaria: le uscite complessive al netto degli
interessi crescono del 2,3% rispetto al
5,4% del 2006. Si riduce, quindi, il rapporto sul PIL, che passa dal
44,7% del 2006 al 44,1% del 2007.
Tale evoluzione ingloba, tuttavia,
maggiori spese straordinarie, di ammontare significativo in entrambi gli anni
in esame, ma ben più elevate nel 2006:
depurando, pertanto, i dati da tali componenti (nonché dalle dismissioni
immobiliari), si osserva una crescita della spesa nel 2007 pari al 3,6%, più
elevata di quella registrata nel 2006 (2,9%), ma comunque inferiore a quella
rilevata nella prima parte del decennio.
L’incidenza sul PIL delle uscite primarie così rideterminate rimane stabile nei
due anni (43,8%).
Analizzando le componenti della
spesa che hanno contribuito alla crescita nel 2007 si rileva, per quanto
riguarda la spesa corrente (+3,6% rispetto al 3,2% del 2006), un aumento
consistente nelle “altre uscite” (+6,8% rispetto al 4% del 2006), e delle
prestazioni sociali in denaro (+5,2% rispetto al 4% nel 2006).
Queste ultime, pari al 17,3% del PIL
(17% nel 2006) hanno risentito, più che della dinamica della spesa
pensionistica cresciuta in linea con l’anno precedente, dell’aumento delle
altre prestazioni sociali in favore delle famiglie, quale effetto delle misure
discrezionali approvate nel corso del 2007, ed in particolare l’assegno per il
nucleo familiare[299]
e il “bonus incapienti”, che peraltro ha pesato solo in parte, rispetto a
quanto stimato nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento, sui
conti dello scorso anno[300].
Più contenuta, invece, è stata la
dinamica dei redditi da lavoro dipendente, e delle voci di spesa che compongono
i consumi intermedi, cioè i consumi in senso stretto e le prestazioni sociali
in natura.
Per quanto riguarda le retribuzioni,
la crescita dell’1,1% registrata nel 2007 rispetto al 4,1% del 2006 è
riconducibile, secondo la RUEF, oltre che al mancato rinnovo di
una parte dei contratti, anche al contenimento della dinamica occupazionale.
Mentre il secondo dei due fattori rappresenta tuttavia un miglioramento
permanente, lo slittamento dei contratti produrrà una maggiore pressione sulla
spesa per retribuzioni del 2008 che infatti cresce, nelle previsioni, del 6,3%.
A fronte di una variazione
complessiva dei consumi intermedi pari al 2,1%, le spese per acquisti di beni e
servizi sono aumentate del 2,7%. Pur in accelerazione rispetto al 2006, anno in
cui si erano ridotte in valore assoluto (-1,2%), tale variazione appare inferiore,
rispetto alla dinamica osservata negli anni precedenti (+5,8% medio annuo nel
periodo 2000-2005).
Le prestazioni sociali in natura,
che per oltre il 90% riguardano la spesa sanitaria,
aumentano appena dello 0,9% (+2,7% nel 2006), riflettendo il rallentamento del
comparto ed in particolare la riduzione della spesa farmaceutica (-6,1%).
Per quanto riguarda la spesa in
conto capitale, al netto dei fattori straordinari che, sia pure con ampiezza
diversa, hanno riguardato sia il 2006 che il 2007, si è registrata nello scorso
anno una crescita del 4,2% (-0,4% nel 2006).
A fronte di una crescita dell’11,1%
dei contributi agli investimenti (1,4% nel 2006), gli investimenti fissi lordi
sono cresciuti del 3,9% (+3,2% nel 2006). Se si considera tale voce al netto
delle dismissioni immobiliari[302],
si osserva un aumento del 3% nel 2007 a fronte di una riduzione nel 2006
(-1,1%).
Il dato relativo al 2007 (37,6
miliardi) evidenzia peraltro, a consuntivo, una riduzione consistente (oltre 6
miliardi di euro) rispetto alle previsioni formulate in corso d’anno e da
ultimo dalla Relazione previsionale e programmatica, che scontava sia la piena
efficacia delle misure autorizzate nella seconda parte dell’anno con il D.L. n.
159/2007 e l’entrata a regime dei meccanismi di sblocco delle risorse a valere
sulle entrate da TFR, sia una maggiore capacità di realizzazione di interventi
da parte dell’Anas e degli enti territoriali[303].
La rilevanza dello scarto tra consuntivo e
stime della RPP è sottolineato dalla Corte dei conti[304],
quale “indiretta evidenza del fatto che l’effettiva realizzazione dei progetti
di investimento non ha tra i suoi prerequisiti soltanto la disponibilità delle
risorse finanziarie, ma risente della possibilità di programmare le attività in
un contesto di stabilità di norme, di cui negli anni più recenti le
Amministrazioni non si sono potute giovare”.
Per il 2008, si prevede un
nuovo aumento dell’incidenza della spesa primaria sul PIL, che passa dal 44,1
al 44,4 per cento. L’aumento è più rilevante se si considera che sul 2007
pesavano oneri straordinari per circa 0,4 punti di PIL. In termini di tasso di
variazione annuo, le uscite complessive al netto degli interessi crescono del
4,3%, quale risultato di un aumento del 5,2% delle spese correnti e di una
riduzione del 3,5% di quelle in conto capitale. Al netto delle misure
straordinarie, la spesa primaria cresce del 5,2%.
Come precisato dalla RUEF, tale
dinamica sconta, da un lato, lo slittamento di alcune spese autorizzate
nell’ultimo trimestre dello scorso anno, dall’altro, in diminuzione della
spesa, l’effetto di trascinamento del contenimento rilevato nel 2007.
All’interno della spesa corrente, i
redditi da lavoro dipendente crescono del 6,3%: di tale incremento, 5,1 punti
percentuali sono dovuti ai rinnovi contrattuali,
mentre la parte restante è il risultato di una più contenuta dinamica
occupazionale (stimata in calo dello 0,1% nel 2008), a fronte dell’aumento
della spesa legata alla stabilizzazione dei precari.
Per i consumi intermedi è
prevista una crescita del 5,2% (+2,1% nel 2007), che sconta, per le
Amministrazioni centrali, un effetto di rimbalzo della spesa a seguito del
contenimento degli anni precedenti, e che si pone maggiormente in linea con le
dinamiche storiche.
Le prestazioni sociali in denaro
crescono del 4,9% (+5,2% nel 2007): la stima ingloba lo slittamento di una
quota (circa 780 milioni) dell’onere per il riconoscimento del “bonus
incapienti”.
Le altre spese correnti presentano
una variazione più contenuta (+3,2% rispetto al 6,8% del 2007), nonostante lo
slittamento di alcune spese per trasferimenti alle famiglie, istituzioni
private e all’estero autorizzate dal D.L. n. 159/2007.
L’evoluzione della spesa in conto
capitale (+5% se si depurano i dati dalle misure straordinarie, incluse le
dismissioni immobiliari)
riflette una riduzione dei contributi agli investimenti (-0,6%) a fronte di un
aumento accentuato degli investimenti fissi lordi (+7,2%), principalmente
ascrivibili alle Amministrazioni centrali.
Tale variazione sconta l’attuazione nel 2008 di alcuni interventi
autorizzati dal D.L. n. 159/2007 e non realizzatisi lo scorso anno, nonché
l’entrata a regime dei meccanismi di sblocco degli stanziamenti condizionati al
preventivo accertamento delle entrate da TFR.
Il pubblico
impiego
Le considerazione
svolte nel presente capitolo si basano sui dati del Conto annuale raccolti ed
elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato[308]. Gli ultimi dati di
consuntivo disponibili sono quelli relativi all’anno 2006, i dati del 2007
saranno resi pubblici intorno alla fine dell’anno in corso.
La maggioranza del
personale utilizzato dalle pubbliche amministrazioni è legato da un rapporto di
servizio a tempo indeterminato. Meno del dieci per cento del personale è,
invece, impiegato con forme contrattuali flessibili. In alcune casi queste
implicano la costituzione di un rapporto di impiego propriamente detto: è il
caso del personale assunto con contratto a tempo determinato, con contratto di
formazione al lavoro e dei volontari e degli allievi delle Forze armate e dei
Corpi di polizia. In altri casi il personale rimane estraneo alla Pubblica
amministrazione, come avviene per i lavoratori interinali e quelli socialmente
utili. Un discorso a parte deve essere fatto per i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, utilizzati per il reperimento di specifiche
professionalità non presenti nella Pubblica amministrazione. In questi
contratti l’aspetto rilevante è la tipologia della prestazione richiesta e,
dunque, la durata della prestazione non è l’elemento centrale del rapporto; ne
consegue che i dati ad essi relativi non sono raffrontabili né aggregabili con
i dati relativi al personale con rapporto di lavoro flessibile.
Nelle tabelle che
seguono sono riepilogati i dati relativi al personale utilizzato dalle Pubbliche
amministrazioni, raggruppati per comparto e per tipologia contrattuale.
Unità di personale a tempo indeterminato
|
Comparto
|
2004
|
2005
|
2006
|
Variazione %
|
|
Servizio
sanitario nazionale
|
687.586
|
688.403
|
686.518
|
-0,2
|
|
Enti
pubblici non economici
|
62.248
|
61.645
|
59.446
|
-4,5
|
|
Enti
di ricerca
|
16.867
|
16.627
|
16.171
|
-4,1
|
|
Regioni
ed autonomie locali (CCNL)
|
541.868
|
533.949
|
520.229
|
-4,0
|
|
Regioni
a statuto speciale e prov. aut.
|
55.192
|
56.496
|
72.610[311]
|
31,6
|
|
Ministeri
|
196.102
|
193.588
|
189.377
|
-3,4
|
|
Agenzie
|
54.861
|
54.490
|
54.182
|
-1,2
|
|
Presidenza
del Consiglio
|
2.374
|
2.515
|
2.423
|
2,1
|
|
Monopoli
e Vigili del fuoco
|
33.603
|
34.145
|
33.392
|
-0,6
|
|
Scuola
e A.F.A.M
|
1.129.474
|
1.136.286
|
1.157.194
|
2,5
|
|
Università
|
110.576
|
115.345
|
116.942
|
5,8
|
|
Corpi
di polizia
|
324.731
|
330.548
|
331.698
|
2,1
|
|
Forze
armate
|
132.792
|
132.585
|
137.342
|
3,4
|
|
Magistratura
|
10.768
|
10.627
|
10.429
|
-3,1
|
|
Carriera
diplomatica
|
1.014
|
996
|
983
|
-3,1
|
|
Carriera
prefettizia
|
1.518
|
1.551
|
1.561
|
2,8
|
|
Carriera
penitenziaria
|
-
|
-
|
506
|
n.a.
|
|
Totale
|
3.361.574
|
3.369.796
|
3.391.003
|
0,9
|
Fonte: Conto annuale 2004-2005-2006
a cura della Ragioneria generale dello Stato
Unità di personale a tempo determinato e con contratto di formazione
lavoro[312]
|
Comparto
|
2004
|
2005
|
2006
|
Variazione %
|
|
Servizio
sanitario nazionale
|
27.053
|
31.613
|
34.726
|
28,4
|
|
Enti
pubblici non economici
|
3.637
|
3.363
|
3.543
|
-2,6
|
|
Enti
di ricerca
|
3.527
|
3.590
|
3.742
|
6,1
|
|
Regioni
ed autonomie locali
|
37.586
|
42.998
|
46.272
|
23,1
|
|
Regioni
a statuto speciale e prov. aut.
|
8.342
|
8.326
|
6.163
|
-26,1
|
|
Ministeri
|
6.304
|
6.123
|
5.806
|
-7,9
|
|
Agenzie
|
1.969
|
3.199
|
4.222
|
114,4
|
|
Presidenza
del Consiglio
|
100
|
15
|
19
|
-81,0
|
|
Monopoli
e Vigili del fuoco
|
1.605
|
2.265
|
2.617
|
63,1
|
|
Scuola
e A.F.A.M
|
663
|
742
|
756
|
14,0
|
|
Università
|
5.839
|
5.759
|
5.490
|
-6,0
|
|
Totale
|
96.625
|
107.993
|
113.356
|
17,3
|
Fonte: Conto annuale 2004-2005-2006
a cura della Ragioneria generale dello Stato
Unità di personale esterno alla Pubblica amministrazione: lavoratori
interinali e socialmente utili
|
Comparto
|
2004
|
2005
|
2006
|
Variazione %
|
|
Servizio
sanitario nazionale
|
2.870
|
2.988
|
4.041
|
40,8
|
|
Enti
pubblici non economici
|
479
|
539
|
768
|
60,3
|
|
Enti di
ricerca
|
7
|
6
|
7
|
0,0
|
|
Regioni
ed autonomie locali
|
41.412
|
38.708
|
34.633
|
-16,4
|
|
Regioni a
statuto speciale e prov. aut.
|
692
|
719
|
529
|
-23,6
|
|
Ministeri
|
467
|
143
|
143
|
-69,4
|
|
Scuola e
A.F.A.M
|
2
|
2
|
2
|
0,0
|
|
Università
|
460
|
416
|
338
|
-26,5
|
|
Totale
|
46.389
|
43.521
|
40.461
|
-12,8
|
Fonte: Conto annuale 2004-2005-2006
a cura della Ragioneria generale dello Stato
Dati di riepilogo sui pubblici dipendenti: totale degli occupati
|
Comparto
|
2004
|
2005
|
2006
|
Variazione %
|
|
Personale
a tempo indeterminato
|
3.361.574
|
3.369.796
|
3.391.003
|
0,9
|
|
Lavoratori
dipendenti con contratti flessibili
|
96.625
|
107.993
|
113.356
|
17,3
|
|
Lavoratori
estranei alla Pubblica amministrazione
|
46.389
|
43.521
|
40.461
|
-12,8
|
|
Altro
personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate[313]
|
66.459
|
77.025
|
68.173
|
2,6
|
|
Totale
|
3.571.047
|
3.598.335
|
3.612.993
|
1,2
|
Fonte: Conto annuale 2004-2005-2006
a cura della Ragioneria generale dello Stato
I dati sopra esposti
consentono alcune considerazioni:
-
i
blocchi delle assunzioni disposti nel corso dell’ultimo decennio, che peraltro
hanno effetti diretti ed immediati sui comparti statali (ad eccezione di quello
della Scuola), non sono stati strumentali al conseguimento dell’obiettivo di
riduzione del numero dei pubblici dipendenti, ma unicamente a consentire un
maggior controllo centralizzato sulle politiche di assunzioni. Le deroghe al
blocco disposte con provvedimenti mirati hanno lasciato sostanzialmente
immutata la dimensione complessiva dell’impiego pubblico;
-
nel
corso dell’ultimo triennio, si è assistito ad un ulteriore ridimensionamento
dei comparti Ministeri ed Enti pubblici non economici a favore del comparto
sicurezza, che ha visto incrementare il numero dei propri dipendenti;
-
una
parte ragguardevole del modesto incremento dei pubblici dipendenti è dovuta al
comparto Scuola, dove il numero dei dipendenti è direttamente correlato alla
popolazione scolastica, a sua volta incrementata nel corso degli ultimi anni a
causa dell’immigrazione;
-
nel
corso dell’ultimo triennio è notevolmente incrementato il numero dei dipendenti
del comparto Università. In tale ambito è, altresì, aumentato in misura
accentuata il ricorso alla figura del professore a contratto, peraltro non
rilevata nel quadro delle statistiche sul numero dei pubblici dipendenti
delineato nelle presenti pagine;
-
nel
comparto delle Regioni ed autonomie locali si è verificata una riduzione del
personale impiegato pari a circa 21.000 unità. Di queste circa 13.000 sono
adesso considerate nell’ambito del personale delle province autonome di Trento
e Bolzano in relazione all’adozione, a decorrere dall’anno 2007, di nuovi
criteri di rilevazione statistica da parte della Ragioneria generale dello
Stato i quali prevedono che i dipendenti delle Regioni a statuto speciale e
delle province autonome siano rilevati separatamente;
-
il
numero dei dipendenti a tempo determinato ammonta a circa il tre per cento del
totale e la maggior parte di essi presta servizio nei comparti del SSN e delle
Regioni e enti locali.
Le tavole che
seguono mostrano la spesa sostenuta per il pagamento dei redditi da lavoro
dipendente nel periodo 2000-2007 e le previsioni formulate per il quadriennio
2008-2011[314], come
risultanti dal Conto economico della Pubblica amministrazione. I dati dei
redditi, inoltre, sono messi a confronto con il PIL.
Redditi da lavoro dipendente nella
P.A. – anni 2000-2007
(milioni di euro -%)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Redditi
|
124.306
|
131.647
|
137.621
|
144.749
|
149.866
|
156.542
|
162.889
|
164.645
|
|
Var % annua
|
|
5,9
|
4,5
|
5,2
|
3,5
|
4,5
|
4,1
|
1,1
|
|
Incidenza % PIL
|
10,4
|
10,5
|
10,6
|
10,8
|
10,8
|
11,0
|
11,0
|
10,7
|
|
Var % annua del PIL
|
|
4,8
|
3,7
|
3,1
|
4,2
|
2,6
|
3,6
|
3,8
|
Redditi da lavoro dipendente nella
P.A. - previsioni 2008-2011
(milioni di euro - %)
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Redditi
|
175.050
|
174.931
|
177.901
|
180.877
|
|
Var % annua
|
6,32
|
-0,07
|
1,70
|
1,67
|
|
Incidenza % PIL
|
11,01
|
10,65
|
10,46
|
10,27
|
|
Var % annua del PIL
|
3,57
|
3,29
|
3,53
|
3,57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nel corso degli anni
2000-2007 la spesa per redditi da lavoro dipendente ha evidenziato un trend
crescente, sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL. Il tasso di crescita
di tale voce di spesa è stato, infatti, salvo negli anni 2004 e 2007,
costantemente superiore a quello del prodotto nominale. Stando ai soli dati
della contabilità nazionale risulterebbe, quindi, che ai lavoratori pubblici
sia stato più che pienamente riconosciuta la conservazione del potere
d’acquisto dei loro salari: infatti mentre il PIL nominale, nel corso del
periodo 2000-2007, è cresciuto del 28,9
per cento la spesa per retribuzioni segna un incremento del 32,5 per cento.
E’ da notare,
peraltro, che la crescita limitata nel 2007 è in parte dovuta, come indicato
nella RUEF, alle misure di razionalizzazione del comparto scuola oltre che allo
slittamento al 2008 di parte dei rinnovi contrattuali.
I dati di previsione
per il 2008-2011 evidenziano una progressiva riduzione della spesa dovuta,
sostanzialmente, al criterio adottato, per prassi, per la costruzione delle
stime: le somme indicate nei tendenziali per i rinnovi contrattuali dei bienni
2008-2009 e 2010-2011 includono la sola indennità di vacanza contrattuale.
L’indennità di vacanza contrattuale è definita nell’accordo
23 luglio 1993 concernente la politica dei redditi e dell'occupazione firmato
dal Governo e dalle OO.SS. Il contenuto dell’Accordo non è vincolante, ma ha
costituito un punto di riferimento per la gestione delle dinamiche contrattuali
connesse con il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). In
particolare si prevede che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3
mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si
applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire
dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove
successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale
elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai
minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di
contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al
50% dell'inflazione programmata.
La Relazione
unificata (RUEF) aggiorna le ultime previsioni di spesa contenute nella
Relazione previsionale e programmatica (RPP) e fornisce alcune chiavi
interpretative dei nuovi dati.
Conto economico della PA a
legislazione vigente – scostamento delle previsioni
(milioni di euro)
|
|
2007
|
2008
|
|
|
RPP
|
RUEF
|
Variazione
previsione
|
RPP
|
RUEF
|
Variazione
previsione
|
Crescita
della spesa
|
|
Redditi da lavoro
|
166.031
|
164.645
|
- 1.386
|
177.442
|
175.050
|
- 2.392
|
10.405
|
L’ammontare totale
della spesa 2008, pari a 175.050 milioni di euro, nella RUEF si riduce di 2.392
rispetto alle precedenti stime, “in seguito all’effetto di trascinamento
dell’evoluzione più contenuta registrata nel 2007 in base ai dati di
consuntivo”. La stessa Relazione afferma
che le minori spese 2007 per circa 1,4 miliardi sono correlate, tra l’altro,
alle misure di razionalizzazione nella scuola.
Dal momento che nel corso dell’ultimo trimestre 2007, ossia
successivamente alla compilazione della RPP, non sembrano essere stati adottati
provvedimenti destinati a produrre rilevanti effetti di risparmio per lo stesso
anno, sembra potersi dedurre che un contenimento del personale scolastico sia
stato conseguito in via amministrativa in misura maggiore delle previsioni.
La crescita della
spesa nel 2008 (+10.405 milioni) è stimata considerando la completa
sottoscrizione dei rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2006-2007,
che comporta un onere di 7.500 milioni di euro, di cui 3.570 a titolo di
arretrati. E’ stata altresì considerata una spesa di 260 milioni di euro per la
chiusura delle code contrattuali relative ai bienni 2002-2003 e 2004-2005 ed
una di 677[316] milioni
per la corresponsione della sola indennità di vacanza contrattuale per il
biennio economico in corso. Ne consegue che il rinnovo dei contratti già
scaduti determinerà, a livello di PA, una crescita permanente della spesa pari
al 2,9 per cento circa del totale ed una variazione una tantum del 2,2 per cento destina a riassorbirsi nel 2009 in
quanto conseguenza della erogazione di arretrati.
Le spese finora
elencate ammontano complessivamente a circa 8,4 miliardi su un totale di
crescita pari a circa 10,4 miliardi. I restanti 2 miliardi di crescita della
spesa si spiegano, sempre secondo la RUEF, in relazione a “l’andamento degli
altri fattori di dinamica dei redditi da lavoro dipendente diversi dai rinnovi
contrattuale” cui si contrappongono “gli effetti del contenimento della
dinamica occupazionale stimata in calo dello 0,1 per cento nel 2008”.
Se tale contenimento determinasse un decremento della spesa
di pari importo, il risparmio conseguente ammonterebbe a circa 1,7 miliardi e
dunque la crescita complessiva per fattori diversi dal rinnovo si eleverebbe a
circa 3,7 miliardi di euro. Non sono forniti indicazioni se tali componenti siano
di natura strutturale o meno ma, qualora lo fossero, ne risulterebbe che, pur
in assenza di rinnovi e di riduzione del numero degli occupati, la spesa per
retribuzioni possiede una dinamica di crescita autonoma superiore al 2 per
cento.
Pur non disponendo
di dati puntuali sulla struttura retributiva e sulla distribuzione del
personale nelle varie qualifiche è comunque possibile tracciare alcune ipotesi
di massima al fine di quantificare l’onere derivante dal prossimo rinnovo
contrattuale relativo al biennio economico 2008-2009.
La quantificazione può essere effettuata sulla base dei dati
forniti dal Governo a corredo della relazione tecnica allegata al disegno di
legge finanziaria per il 2008 e formulando alcune ipotesi circa le future
dinamiche contrattuali e le politiche sulle assunzioni che potranno essere
concretamente adottate. Stime ed ipotesi verranno successivamente applicate ad
alcuni scenari al fine di determinare la spesa che potrebbe rendersi necessario
sostenere.
Al fine di tracciare
questi scenari, è possibile, in via approssimativa, valutare in 1,7 miliardi di
euro il maggior onere che scaturisce da un incremento pari all’1 per cento
delle retribuzioni contrattuali pubbliche.
Tale quantificazione si basa sui dati forniti dal Governo[317]
il quale, con riferimento alla tornata contrattuale 2008-2009, ha stimato che le
risorse necessarie a corrispondere, a tutti i pubblici dipendenti, un
incremento stipendiale a regime pari a circa lo 0,4 per cento corrispondono a
677 milioni di euro.
Per quanto concerne
il numero dei pubblici dipendenti è possibile ipotizzare una sostanziale
invarianza del loro numero. Tale ipotesi è coerente con le risultanze del conto
annuale[318]
elaborato della Ragioneria generale dello Stato e con quanto generalmente affermato
dal Governo in sede previsionale[319].
Per quanto riguarda
le dinamiche contrattuali si rileva che i rinnovi relativi agli ultimi bienni
economici sono stati sistematicamente sottoscritti sulla base di percentuali
concordate di incremento delle retribuzioni ampiamente superiori ai tassi
programmati di inflazione ed effettivi. La tabella che segue mostra i dati in
oggetto a partire dalla tornata contrattuale 2002-2003.
(valori %)
|
Tornata contrattuale
|
Inflazione[320]
programmata
|
Inflazione[321]
effettiva
|
Incremento delle retribuzioni
contrattuali[322]
|
|
2002-2003
|
3,1
|
5,2
|
5,66
|
|
2004-2005
|
3,3
|
4,1
|
5,01
|
|
2006-2007
|
3,7
|
3,9
|
4,85
|
Sulla base di quanto
avvenuto nel recente passato, appare dunque realistico ipotizzare che i rinnovi
contrattuali avvengano, nella più favorevole delle ipotesi, applicando tassi di
crescita delle retribuzioni pari ai tassi di inflazione programmati pari per il
2008 ed il 2009 rispettivamente, all’ 1,7 ed all’ 1,5 per cento. Rammentando
che un punto di incremento percentuale ammonta a circa 1,7 miliardi di euro e
che nei tendenziali di spesa sono stati già scontati[323] oneri lordi a regime per
1,2 miliardi, relativi alla corresponsione dell’indennità di vacanza
contrattuale, la maggior somma non ancora considerata nelle previsioni della
RUEF a decorrere dal 2009 è pari a circa 4,2 miliardi.
1,7 miliardi x 3,2 per cento di
inflazione programmata – 1,2 miliardi già stanziati = 4,2 miliardi lordi.
Considerato che il
riconoscimento di incrementi stipendiali lordi determina il reincasso di parte
delle cifre liquidate a titolo di tributo o di contributo previdenziale o
sanitario, il maggior onere ai fini dell’indebitamento si riduce a circa 2,2
miliardi.
Potrebbe, peraltro,
essere ipotizzato che i rinnovi siano effettuati riconoscendo in pieno il recupero
della perdita del potere di acquisto. In tal caso il maggior onere lordo può
essere valutato in circa 7,6 miliardi e, di conseguenza, quello netto
ammonterebbe a 3,9 miliardi.
La quantificazione si basa sulle ultime previsioni formulate dalla Commissione
europea le
quali prevedono, per l’Italia, un’inflazione su base annua del 3,0 per cento
nel 2008 e del 2,2 per cento nel 2009.
1,7 miliardi x 5,2 per cento di inflazione programmata – 1,2
miliardi già stanziati = 7,6 miliardi lordi.
A detta somma
potrebbe aggiungersi un’ulteriore spesa finalizzata al riconoscimento degli
incrementi di produttività ovvero alla valorizzazione del merito.
La spesa per i
redditi da lavoro dipendente incide per oltre il 25 per cento sulla spesa pubblica
totale. Di seguito si fornisce una sintetica analisi degli strumenti adottati
in questi anni per il contenimento della spesa e della loro efficacia.
La programmazione delle assunzioni è stato introdotta nel
1997 e
si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. Tale meccanismo prevede che il Consiglio dei ministri
definisca preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare,
tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità. In tale quadro il Consiglio dei ministri determina il numero
massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione
numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le disposizioni
sulla programmazione si applicano anche alle assunzioni previste da norme
speciali o derogatorie.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le Camere di commercio, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca hanno, parimenti,
adeguato i propri ordinamenti ai princìpi della programmazione dei fabbisogni
del personale finalizzandoli, anche, alla riduzione programmata della spesa.
Il meccanismo si è rivelato particolarmente efficace al fine
di potenziare il controllo amministrativo centrale sulle politiche di
assunzioni ed è risultato strategico per la gestione razionale delle deroghe da
effettuare, annualmente, ai divieti generali di assunzione (c.d. blocchi delle
assunzioni). La sua applicazione è, pertanto, di norma richiamata da tutte le
disposizioni di carattere generale in materia.
Al fine di ridurre il numero dei dipendenti pubblici è stato
disposto, inizialmente per l’anno 2002, il divieto di assunzione per le
pubbliche amministrazioni. Il divieto è stato reiterato con le successivi leggi
finanziarie ed ha cessato di essere operativo il 31 dicembre 2007. A decorrere
dal 2008, il blocco è stato sostituito da misure di contenimento del turn over volte, comunque, ad escludere
una piena sostituzione del personale cessato.
Lo strumento, pur risultando utile al fine di contenere la
crescita del numero dei pubblici dipendenti, non si è rivelato, in concreto,
idoneo a determinare una sensibile riduzione del loro numero, per due
ordini di ragioni:
-
l’ambito applicativo del blocco è stato, nei
fatti, progressivamente ridotto con il passare degli anni. A tal proposito, si
rammenta che, sin dall’origine, il divieto non è stato applicato al comparto
della Scuola, in quanto il servizio pubblico di istruzione deve essere
istituzionalmente assicurato. In seguito, il blocco non ha trovato diretta
applicazione per i comparti delle Regioni e delle autonomie locali, della
Sanità, dell’Università. Per quanto concerne le Regioni, si è definito un
obiettivo generale di contenimento delle spese nel loro complesso (Patto di
stabilità interno) e non è stato fissato uno specifico l’obbligo di riduzione
del personale, demandando a tali enti la
scelta concreta dei mezzi per conseguirlo. Per le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l’obiettivo è stato, di recente, espresso in
termini di riduzione della spesa di personale, da perseguire anche con
strumenti diversi dalla riduzione delle assunzioni. Infine, le Università sono unicamente
sottoposto alla programmazione triennale dei fabbisogni ed al vincolo posto
dalle risorse presenti nei loro bilanci;
-
annualmente sono state disposte numerose
assunzioni in deroga al blocco.
Di fatto, il blocco delle assunzioni ha dispiegato i suoi
maggiori effetti con riferimento ai comparti Ministeri, agenzie fiscali,
aziende autonome ed enti pubblici non economici. Il cosiddetto comparto
sicurezza (Corpi di polizia e Forze armate) non ha, al contrario, risentito
affatto dei blocchi in quanto maggior beneficiario delle assunzioni effettuate,
annualmente, in deroga al blocco stesso ovvero in quanto soggetto ad un più
generale programma di riordino delineato nel provvedimento di
professionalizzazione delle Forze armate.
Le modalità applicative testé descritte hanno determinato
una redistribuzione del personale pubblico tra i vari comparti: alcuni sono
stati ridimensionati a vantaggio di altri. La tavola che segue mostra la
variazione in percentuale del numero complessivo degli impiegati a tempo
indeterminato nei singoli comparti con riferimento al periodo 2002-2006.
|
COMPARTO
|
2002
|
2006
|
Variazione
06/02
|
|
Servizio sanitario nazionale
|
692.684
|
686.518
|
-0,9
|
|
Enti pubblici non economici
|
64.181
|
59.446
|
-7,4
|
|
Enti di ricerca
|
17.087
|
16.171
|
-5,4
|
|
Regioni ed autonomie locali
|
605.538
|
592.839
|
-2,1
|
|
Ministeri, agenzie fiscali e presidenza
|
261.908
|
245.982
|
-6,1
|
|
Aziende autonome
|
34.368
|
33.392
|
-2,8
|
|
Scuola e AFAM
|
1.139.713
|
1.157.194
|
1,5
|
|
Università
|
113.395
|
116.942
|
3,1
|
|
Corpi di polizia
|
321.674
|
332.204
|
3,3
|
|
Forze armate
|
125.564
|
137.342
|
9,4
|
|
Magistratura
|
10.514
|
10.429
|
-0,8
|
|
Carriera diplomatica e prefettizia
|
2.574
|
2.544
|
-1,2
|
|
Totale
pubblico impiego
|
3.389.200
|
3.391.003
|
0,1
|
Un altro potenziale limite del blocco dell’assunzioni è
costituito dal fatto che la sua applicazione è stata prorogata più volte anche
per un solo anno. Privato così di una valenza strategica, esso non ha
consentito una vera e propria pianificazione di lungo periodo delle politiche
del personale proprie dei singoli comparti.
Le regole fissate dall’Accordo del luglio 1993
hanno introdotto due livelli di contrattazione. Il primo livello concerne il
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), ed è finalizzato alla
conservazione del potere d’acquisto dei salari. Il secondo livello è di tipo
decentrato ed integrativo, e riguarda materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL; la contrattazione
decentrata dovrebbe valorizzare i risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di
produttività,
di qualità ed altri elementi di competitività. Il meccanismo di finanziamento
dei CCNL, fissato a norma dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 165/2001, ha
consentito di esercitare un controllo sulla dinamica degli incrementi delle retribuzioni
contrattuali.
Minori sono invece gli strumenti di controllo centrale e diretto sulle risorse
destinate alla contrattazione integrativa, in quanto questa è alimentata anche
attraverso una serie di voci, variabili da ente ad ente, quali risparmi di
gestione, quote di retribuzione del personale cessato o entrate proprie.
L’ammontare complessivo delle risorse rese disponibili con l’aggregazione di
tali voci costituisce, peraltro, una parte non trascurabile della spesa
sostenuta dalle Pubbliche amministrazioni per il pagamento dei redditi da
lavoro (in media circa il 14 per cento della spesa complessiva per retribuzioni
del 2005). Partendo da tali premesse, il dibattito svoltosi negli ultimi anni
ha iniziato a focalizzare l’attenzione sulla contrattazione integrativa, anche
al fine di porre sotto un maggior controllo la dinamica delle retribuzioni
di fatto.
La criticità di tale controllo è stata evidenziata anche
dall’ARAN, che ha effettuato una rilevazione statistica sulle retribuzioni di
fatto erogate dalle amministrazioni locali.
L’Agenzia ha rilevato che oltre la metà degli incrementi retributivi conseguiti
nel periodo 2000-2006 non sono dovuti alla contrattazione di primo livello,
ossia nazionale.
I consumi
intermedi
Secondo la definizione Istat, tale categoria rappresenta “il
valore dei beni e servizi consumati quali input
nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato
come ammortamento”. Essa comprende, pertanto, numerose tipologie di spese delle
Amministrazioni pubbliche, quali l’acquisto dei beni e servizi necessari per lo
svolgimento dell’attività amministrativa, ivi inclusi le spese per la gestione
degli immobili, i fitti, le utenze. Nella categoria sono incluse anche le spese
per i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM),
come previsto dalla contabilità SEC 95 (Reg. CE n. 1889/2002).
Nella stessa voce rientrano inoltre ulteriori spese,
relative alla sanità, quali le “prestazioni sociali in natura acquistate
direttamente sul mercato”, categoria che individua gli acquisti di beni e
servizi da produttori privati (market), vale a dire le spese per l’assistenza farmaceutica
e per le prestazioni sanitarie erogate in convenzione.
Nel periodo
2000-2007, la spesa per consumi intermedi ha evidenziato una crescita media
annua del 5,5%, determinando un aumento della sua incidenza sul PIL di 6 decimi
di punto (dal 7,3% al 7,9%).
La spesa per consumi intermedi nel conto della P.A. - anni 2000-2007
(milioni di euro - %)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Milioni
di euro
|
87.394
|
96.046
|
100.835
|
105.633
|
112.988
|
118.823
|
118.992
|
121.460
|
|
Var.
% annua
|
9,6
|
9,9
|
5,0
|
4,8
|
7,0
|
5,2
|
0,1
|
2,1
|
|
%
Uscite complessive
|
15,9
|
16,0
|
16,4
|
16,3
|
16,9
|
17,2
|
16,3
|
16,1
|
|
% PIL
|
7,3
|
7,7
|
7,8
|
7,9
|
8,1
|
8,3
|
8,0
|
7,9
|
Fonte:Istat
La crescita è stata particolarmente accentuata nel periodo
2000-2005 (+6,9% annuo), per poi rallentare nel successivo biennio (+1,1%),
quale risultato sia delle sempre più stringenti misure di riduzione dei consumi
in senso stretto adottate fin dal 2005, che di un contenimento della componente
di spesa sanitaria.
Nel 2007 le prestazioni da produttori market sono cresciuti
dello 0,9%, in linea con la spesa sanitaria complessiva, mentre i consumi in
senso stretto, dopo la frenata del 2006 (-1,2%), hanno presentato comunque una
variazione contenuta (+2,7%).
La composizione dei consumi intermedi - anni 2000-2007
(milioni di euro – var % annua)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Consumi
intermedi in senso stretto
|
59.853
(6,7)
|
64.289
(7,4)
|
67.154
(4,5)
|
70.809
(5,4)
|
75.039
(6,0)
|
78.577
(4,7)
|
77.661
(-1,2)
|
79.738
(2,7)
|
|
Prestazioni
sociali in natura market
|
27.541
(16,5)
|
31.757
(15,3)
|
33.681
(6,1)
|
34.824
(3,4)
|
37.949
(9,0)
|
40.246
(6,1)
|
41.331
(2,7)
|
41.722
(0,9)
|
|
Totale
|
87.394
(7,3)
|
96.046
(7,7)
|
100.835
(7,8)
|
105.633
(7,9)
|
112.98
(8,1)
|
118.823
(8,3)
|
118.992
(8,0)
|
121.460
(7,9)
|
Fonte: Istat
Con riferimento ai consumi intermedi in senso stretto, la
tavola seguente ne evidenzia l’andamento per livelli di governo, relativamente
agli anni 2004-2007.
Consumi intermedi in senso stretto
(milioni di euro– var % annua)
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Amministrazioni
centrali
|
22.154
(1,1)
|
22.208
(0,2)
|
20.834
(-6,2)
|
21.049
(1,0)
|
|
Amministrazioni
locali
|
50.617
(8,0)
|
54.076
(6,8)
|
54.425
(0.6)
|
56.555
(3,9)
|
|
Enti di previdenza
|
2.268
(11,2)
|
2.293
(1,1)
|
2.402
(4,7)
|
2.134
(-11,2)
|
|
Totale
|
75.039
(6,0)
|
78.577
(4,7)
|
77.661
(-1,2)
|
79.738
(2,7)
|
Fonte: Istat
A fronte di un andamento, nel settore delle Amministrazioni
centrali, “sostanzialmente” in linea con gli obiettivi posti dalle misure di
contenimento di cui si dà conto nel prosieguo del paragrafo, nel medesimo
periodo, a livello di amministrazioni locali, si è assistito ad una crescita
sostenuta di tale voce di spesa.
In particolare, nel 2007, a fronte di una crescita del 3,9%
delle Amministrazioni locali e di una netta riduzione (-11,2%) dei consumi
degli enti previdenziali, i consumi delle Amministrazioni centrali sono
cresciuti dell’1%.
Per l’anno in corso e per il triennio 2009-2011, il quadro
tendenziale a legislazione vigente della P.A. contenuto nella RUEF reca le
seguenti stime:
La spesa per consumi intermedi nel conto della P.A. – previsioni
2008-2011
(milioni di euro - %)
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Milioni
di euro
|
127.744
|
131.645
|
136.077
|
141.226
|
|
Var.
% annua
|
5,2
|
3,1
|
3,4
|
3,8
|
|
%
Uscite
complessive
|
16,3
|
16,4
|
16,5
|
16,7
|
|
% PIL
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
Fonte:
RUEF
La RUEF, non offre
una stima disaggregata delle due componenti. Viene, tuttavia, precisato che per
le Amministrazioni statali si prevede un livello di economie più basso rispetto
al 2007, correlato sia ad un rimbalzo della spesa dopo un anno di stringenti
controlli, sia agli oneri per le elezioni politiche e amministrative (circa 700
milioni).
La crescita
dell’aggregato complessivo si riduce negli anni successivi (una crescita media
nel triennio 2009-2011 del 3,4% rispetto al 5,2% dell’anno in corso),
stabilizzando l’incidenza sul PIL al livello dell’8%.
Rinviando ad altra
parte del dossier gli approfondimenti sulla spesa sanitaria, si ricordano di
seguito le misure di contenimento dei consumi in senso stretto adottate negli
ultimi anni.
Nel corso degli ultimi anni si è più volte intervenuti per
contenere la dinamica della spesa pubblica, ed in particolare di quella
corrente, sia attraverso la fissazione di regole di crescita di tale aggregato
con riferimento all’intero comparto delle Amministrazioni pubbliche, sia
attraverso tagli lineari degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.
Per quanto riguarda la prima tipologia di interventi, va
ricordata la c.d. “regola del 2 per cento”, introdotta dalla legge
finanziaria per il 2005[338],
che fissava per il triennio 2005-2007 un tetto (rispetto alle previsioni
risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica) alla crescita delle
spese delle Amministrazioni pubbliche[339]. Secondo
tale regola, la spesa pubblica complessiva avrebbe dovuto aumentare ad un tasso
pari a meno della metà dell’incremento previsto, a quella data, per il PIL (2,1
contro 4,4%), consentendo una forte riduzione dell’incidenza della spesa sul
prodotto.
Nel caso delle Amministrazioni centrali, la “regola” comportava un tetto, del
2 per cento appunto, all’aumento degli stanziamenti, in competenza e in cassa,
aventi un impatto diretto sul conto economico consolidato della P.A., rispetto
alle previsioni iniziali del 2004[340].
Dai dati relativi al monitoraggio degli incassi e pagamenti
del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2006[341]
risulta che in tale anno la regola del 2 per cento è stata rispettata:
l’aggregato sottoposto a controllo (pari a 41,3 miliardi in termini di
previsioni definitive) è cresciuto dell’1,2 per cento per le previsioni
definitive e dell’1,5 per cento in termini di pagamenti, mentre gli impegni
hanno registrato una flessione del 2,7 per cento.
Quanto al 2007, i dati contenuti nella RUEF relativi ai
pagamenti del bilancio dello Stato aventi impatto diretto sulla P.A.
evidenziano una riduzione dei consumi intermedi (-5,8%), a fronte di un aumento accentuato delle altre
voci sottoposte al vincolo.
Per quanto riguarda i tagli degli stanziamenti iscritti
nel bilancio dello Stato, che hanno riguardato in prevalenza la spesa corrente
e, al suo interno, i consumi intermedi, essi sono stati previsti con cadenza
annuale fin dal 1999. Con riferimento agli interventi per il 2006, occorre
ricordare come in tale anno, oltre all’effetto di riduzione derivante dalla
regola del 2% (i cui risultati erano incorporati nelle previsioni a
legislazione vigente), la legge finanziaria[342] ha
disposto un contenimento della spesa per consumi intermedi per 1.445 milioni di
euro annui per il triennio 2006-2008. Il decreto legge n. 223 del 2006[343]
ha disposto, poi, un’ulteriore riduzione degli stanziamenti iscritti in
bilancio, per un importo complessivo di 683 milioni di euro per il 2006 e di
793 milioni annui per il triennio 2007-2009.
Per quanto riguarda il successivo triennio, il comma 507
dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che fosse
accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni di euro per il
2007, a 5.031 milioni per il 2008 e a 4.922 milioni per il 2009, delle
dotazioni iniziali del bilancio dello Stato.
Gli stanziamenti su cui incidono gli accantonamenti
riguardano sia le spese correnti che quelle in conto capitale, ivi incluse le
spese predeterminate legislativamente. Nonostante i margini di flessibilità
previsti dalla norma, tale taglio si è
rivelato difficilmente sostenibile da parte delle amministrazioni: il decreto
legge n. 81 del 2007 ha, infatti, disposto la
reintegrazione, per un importo pari a circa 2 miliardi per il 2007, di tali
accantonamenti. Ulteriori integrazioni
degli stanziamenti sono stati disposti con la legge di assestamento per il
2007.
Con riferimento ai consumi intermedi, la tavola di
seguito riportata ricostruisce, a partire
dallo stanziamenti iniziali (in termini di competenza) previsti dalla legge di
bilancio 2007, gli effetti degli accantonamenti del comma 507 della legge
finanziaria 2007 e del successivo DM
48902, cui hanno seguito le misure di disaccantonamento del DL 81/2007
e le integrazioni degli stanziamenti disposte con l’assestamento e le leggi
approvate nella secondo semestre. In termini di previsioni definitive, gli
stanziamenti sono risultati pari a 12.000 milioni di euro (di cui 819 milioni
indisponibili).
Un importo di 1.020 milioni è andato in economia.
Consumi intermedi – co. 507, art 1, L.F. 2007
(milioni di euro)
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
Previs. iniziali comp. LB ‘07
|
Previs. definitive comp. LB ‘07
|
Accant.,
art 1, co 507
LF
‘07
(a)
|
Var accant DM 48902
(b)
|
Accant. totali
c=a+b
|
Disaccanton. DL 81/07
(d)
|
Indisponibilità
post DL 81/07
e= c-d
|
Accant.,
art 1, co 507
LF
‘07
|
Accant.,
art 1, co 507
LF
‘07
|
|
9.904
|
12.000
|
978
|
23
|
1.001
|
182
|
819
|
1.100
|
944
|
Gli interventi in aumento delle dotazioni di bilancio hanno
riguardato il solo 2007. Sugli stanziamenti relativi agli anni successivi è
intervenuta nuovamente, in riduzione degli stessi, la finanziaria 2008, che ha disposto un
taglio lineare delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri relative a
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari
a 545 milioni per l’anno 2008 , 700 milioni per il 2009 e 900 milioni a
decorrere dal 2010. Al netto di tale riduzione, le previsioni iniziali sono
pari a 10.019 milioni per il 2008 (di cui 1.100 milioni indisponibili), a 9.644
milioni per il 2009 (di cui 944 indisponibili) e a 8.824 milioni per il 2010.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha chiesto chiarimenti al
Governo al fine di verificare i risparmi derivanti dal taglio lineare degli
stanziamenti, già oggetto ripetute misure di contenimento. Come osservato dalla
Corte dei conti tale riduzione “si
aggiunge a quella disposta dal comma 507 della finanziaria 2007, aggravando la
situazione di precarietà operativa delle amministrazioni conseguenti alle
precedenti manovre correttive. In tal modo rischia di riproporsi per il 2008,
la necessità del ricorso ad un provvedimento di urgenza analogo a quello
intervenuto nel 2007”.
La spesa
sociale
La spesa per prestazioni previdenziali ed assistenziali è
composta da:
·
prestazioni sociali in denaro: in tale voce confluiscono la spesa per
prestazioni sociali a copertura dei rischi invalidità, vecchiaia, superstiti,
disoccupazione, infortuni professionali, maternità e malattia, nonché alcune
spese di natura assistenziale;
·
prestazioni sociali in natura: tali prestazioni comprendono sia una parte
della spesa sanitaria, in particolare, quella erogata in convenzione[355], sia
una parte della spesa assistenziale, in particolare, i servizi sociali erogati
da una pluralità di istituzioni ed enti, per esempio, i comuni.
Tali due categorie,
nel complesso, costituiscono l’aggregato della spesa per protezione sociale di
cui si dà conto nel presente paragrafo, ad eccezione della spesa sanitaria,
oggetto di un autonomo approfondimento.
La spesa per
prestazioni sociali in denaro comprende sia la spesa per pensioni e rendite – che ne costituisce la parte
prevalente – sia la spesa per altre
prestazioni previdenziali di carattere non pensionistico[356].
Alle prestazioni
sociali in denaro è riconducibile anche la spesa
per alcune prestazioni assistenziali[357], voce di cui si terrà
conto nella successiva analisi, dedicata alla spesa assistenziale.
Si analizza ora
l’andamento generale dell’aggregato delle prestazioni sociali in denaro, per
poi esaminare, più in dettaglio, le sue componenti di natura più strettamente
previdenziale.
L’andamento della spesa complessiva per prestazioni sociali in denaro nel periodo 2005-2007 è stato il seguente:
(milioni di euro - %)
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Milioni
di euro
|
242.346
|
252.119
|
265.284
|
|
Variazione
annua (%)
|
3,3
|
4,0
|
5,2
|
|
%
del Pil
|
17,0
|
17,0
|
17,3
|
Fonte: RUEF
L’andamento tendenziale a legislazione vigente, per l’esercizio in
corso e il triennio 2008- 2011, è il
seguente:
(milioni di euro - %))
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Milioni
di euro
|
278.340
|
284.570
|
294.640
|
305.210
|
|
Variazione
annua (%)
|
4,9
|
2,2
|
3,5
|
3,6
|
|
%
del Pil
|
17,5
|
17,3
|
17,3
|
17,3
|
Fonte: RUEF
Dalle tabelle
risulta che, dopo una fase di stabilità della spesa in rapporto al PIL,
l’aggregato riprende a crescere nel 2007 per poi stabilizzarsi nuovamente al
17,3 per cento.
Tale aumento è
riconducibile alle componenti non pensionistiche, in primo luogo, all’incremento
della spesa per trattamenti di famiglia (per un onere pari a 900-1.000 milioni
di euro), disposto dalla legge finanziaria per il 2007 e, in secondo luogo,
all’intervento recato dal decreto-legge n. 159/2007[358] a favore dei cosiddetti
incapienti.
Tale intervento, originariamente classificato in riduzione
delle imposte dirette, interamente per l’anno 2007, sulla base dell’importo
originariamente previsto (1,9 miliardi), successivamente, nei dati di
consuntivo 2007, è stato riclassificato dall’Istat come incremento della spesa
per prestazioni sociali in denaro[359], per
un ammontare, nel 2007, di 560 milioni di euro[360].
Per il 2008, la
dinamica dell’aggregato (+4,9 per cento) risente, tra l’altro, dello
slittamento a tale esercizio di quota parte del bonus incapienti, per un
importo pari a 782 milioni di euro, oltre che degli incrementi previsti
nell’ambito della manovra 2008
e degli incrementi per le pensioni basse previsti dal decreto-legge n. 81/2007.
Per quanto riguarda
la principale voce di spesa nell’ambito delle prestazioni sociali in denaro, va
fatto riferimento alla definizione Istat utilizzata nei conti economici
nazionali, in base alla quale la spesa
delle amministrazioni pubbliche per pensioni e rendite[363] ha avuto, nel periodo
2004-2007, il seguente andamento, in valori assoluti e in variazione percentuale
rispetto all’anno precedente:
(milioni di euro - %)
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
194.362
|
201.239
|
207.925
|
216.380
|
|
(+3,9)
|
(+3,5)
|
(+3,3)
|
(+4,1)
|
Per quanto riguarda
il 2007, la RGSEP evidenzia, tra le cause della dinamica crescente della spesa
in esame, l’aumento del numero dei trattamenti e la perequazione automatica
pari al 2 per cento.
A tale dinamica ha contribuito anche l’effetto dell’incremento delle pensioni
di importo basso previsti in 900 milioni di euro nel 2007[366].
Per quanto riguarda
l’andamento della spesa pensionistica a decorrere dal 2008, esso sarà
influenzato principalmente dalle disposizioni recate dalla legge n. 247/2007
(Attuazione del Protocollo welfare)
che possono essere così sintetizzate[367]:
·
il nuovo
percorso di aumento graduale dell’età per l’accesso al trattamento
pensionistico[368], con
effetti già nel breve periodo[369];
·
l’aggiornamento
dei coefficienti di trasformazione e l’introduzione di un meccanismo automatico
di aggiornamento successivo con cadenza triennale; l’agevolazione del riscatto
degli anni di laurea; l’estensione della facoltà di cumulare i contributi
versati in gestioni diverse; l’aumento delle aliquote contributive e di computo
per i parasubordinati privi di altre forme di copertura.
Le modifiche alla
legislazione pensionistica previgente introdotte dalla legge n. 247/2007
comportano, nelle previsioni della RGS, un incremento dell’incidenza della
spesa in rapporto al PIL che raggiunge il massimo nel 2011 (circa 0,1-0,15
punti percentuali di PIL), per poi ridursi progressivamente fino ad azzerarsi
completamente a partire dal 2030-2035[370].
Prendendo quindi in
considerazione la spesa pensionistica, come determinata dalla legislazione
vigente, la RGS prevede una sua sostanziale stabilità in rapporto al PIL nel decennio
2007-2016.
Tale stabilità è significativamente condizionata dal
graduale elevamento dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento
anticipato, i cui effetti di contenimento controbilanciano i primi effetti
espansivi indotti dalla transizione demografica. L’aumento degli importi di
pensione conseguente al posticipo dell’accesso al pensionamento avrà, invece,un
effetto diluito nel tempo.
Per quanto riguarda
il periodo 2017-2038, nei modelli previsivi della RGS il rapporto spesa
pensionistica/PIL presenta una dinamica crescente con un’accelerazione nella
seconda parte del periodo a partire dal 2025.
A partire da tale data, infatti, si stima che all’aumento
del numero di pensioni si aggiunge la contemporanea riduzione del numero di
occupati. Più in particolare, l’aumento del numero di pensioni, solo in parte
contrastato dagli effetti restrittivi dovuti all’elevazione dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anticipato prevista nei regimi misto e
contributivo, dipende dal progressivo innalzamento della speranza di vita e dal
passaggio delle generazioni del baby boom
dalla fase attiva alla fase di quiescenza[371]. La
diminuzione del numero di occupati è determinata dal forte calo della
popolazione in età da lavoro, che sopravanza l’effetto indotto dall’aumento dei
tassi di occupazione. Un ulteriore effetto parzialmente calmierante la dinamica
della spesa in tale fase è recato dalla liquidazione di pensioni con quote
crescenti calcolate con il sistema contributivo.
Per il successivo periodo
2039-2050, infine, la RGS prevede una forte decrescita del rapporto spesa
pensionistica/PIL, dovuta essenzialmente al passaggio dal regime misto a quello
contributivo[372].
A tale risultato contribuisce anche la sostanziale
stabilizzazione del rapporto tra numero di pensioni e numero di occupati,
dovuto, prevalentemento, nell’ultima fase del periodo in esame, alla
progressiva eliminazione per morte delle generazioni del baby boom. In tale ultima fase, cessa anche l’effetto incrementativo
dell’importo medio del trattamento pensionistico recato dal progressivo
elevamento dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato.
L’andamento della
spesa nell’intero periodo di previsione è quello risultante dal grafico che
segue:
Spesa pensionistica in rapporto al PIL (scenario nazionale base)
(Fonte: Rapporto RGS
n. 9 – Anno 2007)
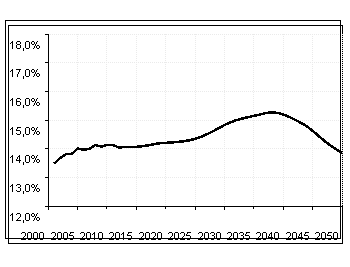
Con riferimento alle
altre prestazioni sociali in denaro di tipo previdenziale ma diverse dalle
pensioni, l’andamento nel periodo 2004-2007, relativamente al settore delle Pubbliche
amministrazioni, è stato il seguente[373]:
(milioni
di euro - %)
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Liquidazioni
TFR
|
4.679
|
4.786
|
5.914
|
8.297
|
|
Malattia
e maternità
|
5.055
|
5.133
|
5.327
|
5.823
|
|
Disoccupazione
|
4.359
|
4.689
|
4.857
|
4.831
|
|
Integrazione
salariale
|
815
|
898
|
904
|
833
|
|
Assegni
familiari
|
5.844
|
5.477
|
5.406
|
6.427
|
|
Altri
sussidi*
|
560
|
601
|
723
|
548
|
|
TOTALE
|
21.312
|
21.584
|
23.131
|
26.759
|
|
Variazione %
|
9,8
|
1,3
|
7,2
|
15,7
|
*Comprende: equo indennizzo,
liquidazioni in capitale, assegni, indennità e sussidi complementari al
reddito.
Tra le voci sopra
riportate, si evidenzia il consistente aumento nel 2007 della spesa per le
liquidazioni di fine rapporto (+40,3 per cento rispetto al 2006). Tra le cause
che hanno concorso alla determinazione di tale dinamica, si segnala
l’incremento del numero delle pensioni di anzianità del contratto scuola nel
2006.
E’ verosimile, anche se mancano i dati ufficiali, che una quota, sia pure
minima, di tale incremento di spesa sia da ascriversi anche alle prime
liquidazioni di TFR operate dall’Inps in attuazione del disposto della legge
finanziaria 2007 in materia.
Sempre con riferimento
a tale anno, anche la voce relativa agli assegni familiari ha scontato gli
effetti degli interventi in materia
disposti dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006)[376], i cui maggiori oneri sono
quantificati circa 900-1.000 milioni di euro.
Con riferimento al
periodo 2008-2011, la RUEF 2008[377] indica gli oneri connessi
agli interventi approvati nel settore degli ammortizzatori sociali, in termini
di indebitamento netto, come risulta dalla tabella che segue[378]:
(milioni di euro)
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Indennità di
disoccupazione
|
582
|
605
|
643
|
658
|
|
disoccupazione
agricola
|
90
|
90
|
91
|
92
|
|
Sostegno
lavoratori portuali
|
20
|
|
|
|
|
totale interventi
|
692
|
695
|
734
|
750
|
Fonte: RUEF
Il finanziamento
della spesa previdenziale[379]
avviene principalmente attraverso i contributi
sociali, cioè il versamento di contributi che affluiscono direttamente al
settore pubblico attraverso gli enti di previdenza e, ma in misura minore,
attraverso gli accantonamenti ai fondi quiescenza costituiti presso le imprese
e di contributi sociali versati ai fondi pensione. L’altra fonte di
finanziamento è costituita dalle contribuzioni
diverse, composte da trasferimenti statali destinati principalmente a
coprire le spese per l’erogazione di servizi di carattere generale destinati
alla popolazione[380], le
spese per l’erogazione di prestazioni in denaro ad invalidi civili e anziani
sprovvisti di reddito, per l’integrazione delle pensioni al minimo, per gli
sgravi fiscali e la fiscalizzazione degli oneri sociali concessi ai datori di
lavoro, nonché per la copertura dei disavanzi di gestione degli enti di
previdenza[381].
Con riferimento ai contributi
sociali, sulla base di SEC 95, nei conti economici nazionali essi sono
distinti in effettivi e figurativi.
I primi, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori,
sono costituiti dai versamenti effettuati agli organismi della sicurezza
sociale e comprendono tutti i contributi obbligatori e volontari[382],
relativi all’assicurazione contro i rischi di malattia, maternità, invalidità,
vecchiaia e superstiti, disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie
professionale e per gli assegni familiari.
I contributi sociali figurativi, invece, riguardano
esclusivamente i datori di lavoro e costituiscono la contropartita delle
prestazioni sociali erogate direttamente dai datori di lavoro ai loro
dipendenti o ex dipendenti e aventi diritto, senza passare, cioè, attraverso
gli organismi della sicurezza sociale[383]. Il
loro ammontare si stima pari alle prestazioni versate al netto dei contributi
sociali effettivi versati dai lavoratori dipendenti.
Essendo, pertanto, ancorati al mondo del lavoro, il loro
ammontare complessivo annuale dipende strettamente dall’andamento
dell’occupazione e dal livello delle retribuzioni.
I dati più aggiornati
e le stime per gli anni 2008-2011 sono i seguenti:
(milioni di euro - %)
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Contributi
sociali effettivi
|
179.972
|
186.072
|
200.911
|
210.143
|
216.406
|
222.721
|
229.605
|
|
Contributi
sociali figurativi
|
3.473
|
3.611
|
3.861
|
3.988
|
4.044
|
1.112
|
4.185
|
|
Totale
|
183.445
|
189.683
|
204.772
|
214.141
|
220.450
|
226.833
|
233.790
|
|
%
Pil
|
12,8
|
12,8
|
13,3
|
13,5
|
13,4
|
13,3
|
13,3
|
Fonte: RUEF, marzo 2008
La variazione annua
percentuale è stimata come segue:
(valori percentuali)
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Contributi
sociali effettivi
|
|
3,4
|
8,0
|
4,6
|
3,0
|
2,9
|
3,1
|
|
Contributi
sociali figurativi
|
|
4,0
|
6,9
|
3,5
|
1,2
|
1,7
|
1,8
|
|
Totale
|
|
3,4
|
8,0
|
4,6
|
2,9
|
2,9
|
3,1
|
Fonte: RUEF, marzo 2008
Dai dati riportati,
si evidenzia una importante crescita di tali entrate tra il 2006 e il 2007.
Essa è dovuta sia all’aumento delle aliquote contributive per i lavoratori
autonomi, sia al versamento all’Inps del TFR inoptato dei dipendenti delle
imprese con più di 50 dipendenti, provvedimenti disposti dalla legge
finanziaria per il 2007[384].
L’effetto di aumento si riverbera, sia pure in misura minore, anche
nell’esercizio in corso per poi, sostanzialmente, stabilizzarsi.
Con riferimento alle
maggiori entrate recate dagli aumenti contributivi disposti dalla normativa
vigente, la RUEF espone i seguenti dati (in termini di indebitamento netto) ,
al netto degli effetti fiscali[385]:
(milioni di euro)
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
legge
finanziaria 2007
|
4.000
|
3.100
|
3.350
|
3.320
|
3.220
|
|
legge n.
247/2007 (Protocollo)
|
|
243
|
326
|
459
|
873
|
|
Totale
|
4.000
|
3.343
|
3.676
|
3.779
|
4.093
|
Preliminarmente, si
segnala che il presupposto per la erogazione delle prestazioni di natura
assistenziale è la condizione di bisogno degli individui, spesso rappresentata
da un livello insufficiente di reddito, ma, a differenza di quanto avviene per
le prestazioni previdenziali, senza il vincolo di una precedente contribuzione
dei beneficiari.
Tale aggregato di
spesa si scompone in due ulteriori componenti, la prima, più consistente,
rientrante tra le prestazioni sociali in denaro e la seconda, di carattere
residuale, rientrante tra le prestazioni sociali in natura.
In merito alla prima
componente, nel periodo 2004-2007, le
principali prestazioni sociali in denaro di natura assistenziale[386] hanno
mostrato il seguente andamento[387]:
(milioni di euro - %)
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Pensione
sociale(*)
|
3.429
|
3.468
|
3.576
|
3.733
|
|
Pensione
di guerra
|
1.309
|
1.002
|
1.060
|
1.095
|
|
Prestazioni
agli invalidi civili
|
11.014
|
11.558
|
12.222
|
12.933
|
|
Prestazioni
ai ciechi
|
928
|
1.001
|
984
|
1.008
|
|
Prestazioni
ai sordomuti
|
157
|
164
|
157
|
161
|
|
Altri
assegni
|
2.190
|
2.330
|
3.064
|
3.215
|
|
TOTALE
|
19.027
|
19.523
|
21.063
|
22.145
|
|
Variazione
%
|
5,9
|
2,6
|
7,9
|
5,1
|
(*) Tale tipo di trattamento, nei
conti economici nazionali, non rientra tra gli istituti legati al rischio o
evento invalidità, come tutti gli altri elencati nella tabella, ma è compreso
tra quelli riconducibili al bisogno “vecchiaia”, pur essendo comunque
qualificabile tra le prestazioni assistenziali.
Dal punto di vista metodologico, si segnala preliminarmente
che, in questa sede, si preferisce utilizzare i dati di contabilità nazionale,
anziché i dati provenienti da altre fonti, per la difficoltà di compararli.
Infatti, ad esempio, l’Istat, nelle pubblicazioni realizzate con l’Inps[389],
include tra le pensioni assistenziali l’indennità di accompagnamento[390];
il Ministero della solidarietà sociale[391]
riporta, a seconda delle prestazioni considerate, dati ottenuti moltiplicando
l’importo unitario dei trattamenti relativo al mese di dicembre per le
mensilità spettanti (dodici o tredici); in tale modo, si ottiene una sorta di
spesa tendenziale che, però, non coincide con i dati di bilancio.
Con riferimento al
biennio 2006 e 2007, la tabella precedente evidenzia un consistente aumento della
voce di spesa relativa ad altri assegni e sussidi. Tale dinamica sostenuta
(+31,5 per cento nel 2006 rispetto al 2005) è da attribuirsi all’erogazione nel
2006 del cosiddetto bonus bebè introdotto dalla legge n. 266/2005
a sostegno della natalità nel biennio 2005-2006 e la cui erogazione si
concentra soprattutto nel 2006. Nel 2007, la dinamica della voce di spesa in
esame si mantiene sostenuta (+4,9 per cento) in quanto, pur venendo meno le
erogazioni per il bonus bebè, è stata imputata a tale tipologia di spesa l’erogazione
del cosiddetto bonus per gli incapienti per un importo pari a circa 560 milioni
di euro. Tale ultima voce avrà i suoi effetti anche nel 2008 per un ammontare
pari a 782 milioni di euro[393].
Per completare il
quadro delle prestazioni assistenziali, occorre considerare la parte rientrante
tra le prestazioni sociali in natura.
In proposito, va
segnalato che si tratta di prestazioni assistenziali che risultano erogate da
una pluralità di istituzioni ed enti; sia a causa della pluralità di
istituzioni operanti sia a causa della grande varietà delle politiche adottate
dalle regioni[394] e
dagli altri enti locali, la ricostruzione della spesa non appare agevole.
Tale aggregato ha
avuto nel periodo 2004-2007 il seguente andamento[395]:
(milioni di euro)
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Beni
e servizi di produttori market
|
2.660
|
2.679
|
2.807
|
2.846
|
|
Beni
e servizi di produttori non market
|
3.575
|
3.733
|
4.101
|
4.070
|
|
|
6.235
|
6.412
|
6.908
|
6.916
|
Per il finanziamento
di questo tipo di spesa (ad esempio, il contrasto della povertà, i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, la condizione degli anziani, la prevenzione e
il trattamento delle tossicodipendenze, l’inserimento dei cittadini stranieri)
è da segnalare la legge n. 449/1997 che ha istituito il Fondo per le politiche
sociali, la più importante fonte di finanziamento statale in materia di servizi
sociali.
Anche con
riferimento alla spesa pubblica per l’assistenza alle persone anziane e ai
disabili non autosufficienti (Long Term
Care – LTC), rientrante nell’ambito più generale della spesa sociale, la
Ragioneria Generale dello Stato elabora le previsioni a medio e lungo termine
sulla base di scenari e metodologie concordate in ambito europeo[396].
Tale aggregato di
spesa include tre componenti: la componente sanitaria, il cui andamento è
analizzato nell’ambito delle previsioni della spesa sanitaria pubblica; le
indennità di accompagnamento, erogate ad invalidi e ciechi civili e le
indennità di comunicazione riconosciute ai sordomuti; altre prestazioni per
LTC, comprendenti un insieme di prestazioni, largamente in natura, gestite
prevalentemente a livello locale per finalità socio-assistenziali.
Nel quadro di
previsione basato sullo scenario nazionale base, la spesa pubblica per LTC in
rapporto al PIL passa dall’1,6 per cento del 2006 al 2,8 per cento del 2050,
con un incremento distribuito in modo uniforme nell’intero periodo di
previsione.
Più in particolare,
in relazione alle diverse componenti dell’aggregato, a causa dell’aumento della
popolazione anziana, cresce il peso delle indennità di accompagnamento e quello
delle altre prestazioni LTC a discapito della componente sanitaria.
Quest’ultima cresce con minore intensità per il fatto che al suo interno sono
comprese prestazioni non strettamente legate all’invecchiamento (malati
psichici e dipendenti da alcol e droghe).
Con riferimento alla
distribuzione della spesa per età, la RGS prevede una crescita della quota di
spesa destinata agli ultraottantenni (dal 46 per cento del 2010 al 66 per cento
del 2050), prevalentemente a discapito di quella riguardante la fascia di età
0-64 anni.
La spesa
sanitaria
Nell’ambito della contabilità nazionale, non é previsto uno
specifico aggregato relativo alla spesa sanitaria pubblica. Questa, infatti, è
la somma delle diverse tipologie di spesa riconducibili al settore sanitario.
Si fa riferimento, principalmente, ai costi del personale (facenti parte
dell’aggregato redditi da lavoro dipendente) e alle spese per l’acquisto di
beni e servizi (facenti parte dell’aggregato consumi intermedi).
Il consolidamento dei conti riferiti al settore sanitario
avviene generalmente con la Relazione
generale sulla situazione economica del Paese, che fornisce un’analisi
dettagliata dell’andamento della spesa e delle sue componenti. La Relazione evidenzia una
classificazione della spesa con riferimento ai soggetti operatori: nel sistema
sanitario italiano le prestazioni sono erogate agli utenti o direttamente,
attraverso le strutture del Servizio sanitario nazionale, o indirettamente,
attraverso strutture accreditate o professionisti convenzionati, costituendo
quest’ultima la parte preponderante delle prestazioni sociali in natura. Da tale punto di vista,
pertanto, la spesa sanitaria si divide in quella riconducibile ai produttori
di beni e servizi non market (per le prestazioni erogate direttamente dalle
strutture del SSN) e nella spesa riconducibile a prestazioni erogate da
produttori market (erogate, quindi, per conto del SSN e da questo
remunerate).
Informazioni sulla spesa sanitaria, a livello aggregato,
sono inoltre disponibili in corso d’anno sia nella RUEF (relativamente a dati
di consuntivo) sia nel Documento di programmazione economico–finanziaria e
nella Nota di aggiornamento, che recano i dati di previsione, a legislazione
vigente, relativamente all’anno in corso e al successivo periodo di previsione.
Il conto della P.A. espone il seguente andamento della spesa
sanitaria:
La spesa
sanitaria nel conto della P.A.
(milioni di euro - %)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Valori
assoluti
|
67.574
|
74.744
|
79.106
|
81.816
|
89.924
|
96.141
|
101.349
|
102.290
|
|
Var
% annua
|
11,7%
|
10,6%
|
5,8%
|
3,4%
|
9,9%
|
6,9%
|
5,4%
|
0,9%
|
|
%
spesa complessiva
|
12,3%
|
12,4%
|
12,9%
|
12,6%
|
13,5%
|
13,9%
|
13,9%
|
13,6%
|
|
%
Pil
|
5,7%
|
6,0%
|
6,1%
|
6,1%
|
6,5%
|
6,7%
|
6,8%
|
6,7%
|
Fonti: Istat Relazione generale sulla situazione
economica del Paese 2007 e RUEF 2008
I dati evidenziano come, nel periodo in esame, la spesa
sanitaria abbia assorbito una quota significativa e crescente della spesa complessiva,
aumentando il peso sul PIL di un punto (dal 5,7% del 2000 al 6,7% nel 2007).
Tale dinamica presenta, peraltro, andamenti differenziati
negli anni: a fronte di una crescita media annua dell’8,1% nel periodo
2000-2005, si assiste a una variazione più contenuta nell’ultimo biennio
(+3,2%), ed in particolare nell’ultimo anno (+0,9%).
Il risultato 2007 sconta, tuttavia, come precisato dalla
RUEF, uno slittamento al 2008 di oneri contrattuali di competenza del biennio
2006-2007 (1.500 milioni), nonché la riallocazione di alcune partite contabili
per circa 700 milioni. Per contro, sul 2006 pesano arretrati contrattuali
relativi al biennio 2004-2005 per circa 2.300 milioni. Imputando gli oneri ai
periodi di competenza, la crescita della spesa nel 2007 dovrebbe essere
rideterminata in misura pari al 5,5%. Si tratterebbe, comunque, di una
variazione più limitata rispetto a quelle registrate negli anni precedenti.
Il dato relativo al 2007 riflette le misure di contenimento
della spesa adottate con la legge finanziaria
che, recependo l’accordo intervenuto nell’autunno 2006 tra il Governo e le
Regioni (c.d. Patto per la salute), ha posto l’obiettivo di stabilizzare la
quota della spesa rispetto al PIL al 6,7%, definendo conseguentemente il
livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre lo Stato
e le misure per raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr infra).
Al raggiungimento di tali obiettivi sono, inoltre,
preordinati i Piani di rientro che le Regioni che hanno evidenziato disavanzi strutturali
negli anni 2001-2005 (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia)
hanno concordato con il Governo nel corso del 2007. Nei primi mesi del 2008
altre regioni (Piemonte e Calabria) hanno avanzato la richiesta di
sottoscrivere un Accordo con l’allegato Piano di rientro (cfr infra).
Per quanto riguarda gli anni 2008 e 2009, non si dispone di
stime aggiornate, dal momento che quelle recate nella Nota di aggiornamento del
DPEF risultano superate. Si segnala, comunque, che, sulla base di quanto
riportato nella RUEF, la spesa tendenziale per il 2008, rispetto alle
previsioni precedenti, dovrà essere integrata dalla spesa conseguente
all’abolizione del ticket sulla assistenza specialistica prevista dalla legge
finanziaria, dagli oneri relativi allo slittamento all’anno in corso del
rinnovo del contratto relativo al biennio 2006-2007, nonché da partite contabili.
A ciò si aggiungerebbe un ulteriore aggravio della spesa,
che riguarda i rinnovi contrattuali per il biennio in corso, per i quali dovranno
essere stanziate le necessarie risorse. Peraltro, da quanto si evince dalla
RUEF, tale ulteriore onere dovrebbe incidere sul 2009.
La dinamica osservata nella spesa sanitaria è effetto di
andamenti differenziati nei vari comparti. La seguente tavola analizza la spesa
con riferimento alla classificazione per operatori, prendendo quindi in
considerazione le prestazioni offerte dalle strutture del SSN (c.d. produttori non market) e quelle erogate attraverso
strutture accreditate o professionisti convenzionati (c.d. produttori market).
Composizione della spesa sanitaria
(milioni di euro)
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
|
|
|
|
|
|
Prestazioni sociali in natura
|
84.088
|
89.606
|
94.218
|
94.678
|
|
corrispondenti a beni e servizi
prodotti da produttori market:
|
35.289
|
37.567
|
38.524
|
38.876
|
|
-
Farmaci
|
11.988
|
11.849
|
12.334
|
11.579
|
|
-
Assistenza
medico-generica
|
5.020
|
6.453
|
5.932
|
6.052
|
|
-
Assistenza
medico-specialistica
|
2.900
|
3.193
|
3.449
|
3.666
|
|
-
Assistenza
osped. in case di cura private
|
8.260
|
8.472
|
8.694
|
9.187
|
|
-
Assistenza
protesica e balneotermale
|
3.913
|
4.037
|
4.128
|
4.107
|
|
-
Altra
assistenza
|
3.208
|
3.563
|
3.987
|
4.285
|
|
corrispondenti a servizi
prodotti da produttori non market:
|
48.799
|
52.039
|
55.694
|
55.802
|
|
-
Assistenza
ospedaliera
|
38.113
|
40.722
|
43.628
|
43.704
|
|
-
Altri
servizi sanitari
|
10.686
|
11.317
|
12.066
|
12.098
|
Composizione della spesa sanitaria
(var % annua)
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
|
|
|
|
|
|
Prestazioni sociali in natura
|
10,0
|
6,6
|
5,1
|
0,5
|
|
corrispondenti a beni e servizi
prodotti da produttori market:
|
9,5
|
6,5
|
2,5
|
0,9
|
|
-
Farmaci
|
8,0
|
-1,2
|
4,1
|
-6,1
|
|
-
Assistenza
medico-generica
|
4,7
|
28,5
|
-8,1
|
2,0
|
|
-
Assistenza
medico-specialistica
|
7,0
|
10,1
|
8,0
|
6,3
|
|
-
Assistenza
osped. in case di cura private
|
15,4
|
2,6
|
2,6
|
5,7
|
|
-
Assistenza
protesica e balneotermale
|
5,2
|
3,2
|
2,3
|
-0,5
|
|
-
Altra
assistenza
|
16,6
|
11,1
|
11,9
|
7,5
|
|
corrispondenti a beni e servizi
prodotti da produttori non market:
|
10,3
|
6,6
|
7,0
|
0,2
|
|
-
Assistenza
ospedaliera
|
10,6
|
6,8
|
7,1
|
0,2
|
|
-
Altri
servizi sanitari
|
9,3
|
5,9
|
6,6
|
0,3
|
|
Fonte Istat 2008
|
|
|
|
|
La tavola evidenzia un notevole rallentamento del tasso di
crescita annuale delle prestazioni non
market (+0,2% nel 2007 rispetto al 7,0% del 2006), che ha investito
entrambe le componenti (assistenza ospedaliera e altri servizi sanitari). Sottostante
tale evoluzione, vi è una dinamica dei redditi da lavoro dipendente
(influenzata dal ricordato slittamento al 2008 dei rinnovi contrattuali del
biennio 2006-2007) che si riducono del 4,5%, a fronte di una variazione
significativa in aumento dei consumi intermedi + 8,3% (6,2% nel 2006), che
segnala la difficoltà di mantenere sotto controllo questa voce di spesa. Su di
essa, peraltro, incide la scelta di molte regioni di ricorrere alla
distribuzione diretta dei farmaci che, essendo contabilizzata, in aumento, tra
i consumi intermedi, riduce la voce relativa alla spesa farmaceutica
convenzionata, contribuendo, per questa via, al contenimento complessivo della
spesa sanitaria.
Per quanto concerne prestazioni da produttori market, nel periodo in esame si assiste
ad un rallentamento nella crescita, confermato anche per il 2007: secondo i
dati Istat, lo scorso anno questo aggregato è cresciuto dello 0,9% rispetto al
2,5% del nel 2006. Tale andamento riflette una riduzione della spesa
farmaceutica (-6,1% nel 2007) che, grazie ai provvedimenti assunti dall’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), ha conosciuto un forte ridimensionamento in questi
anni. Aumentano invece a ritmi sostenuti le componenti relative alla spesa per
assistenza, fatta eccezione per l’assistenza medico-generica (+2% nel 2007, a
fronte di una riduzione dell’8,1% dell’anno precedente), su cui tuttavia ha
influito il rinvio del rinnovo delle convenzioni con i medici di base, gli
specialisti ambulatoriali e i pediatri di libera scelta.
Il contenimento della spesa
farmaceutica
Secondo gli ultimi dati AIFA, nel 2007 la spesa
farmaceutica complessiva (convenzionata e non convenzionata) è risultata pari a
15,9 miliardi, oltre 498 milioni in più rispetto al tetto programmato del 16%.
Considerando il meccanismo di payback,
lo scostamento, tuttavia, si traduce in una riduzione di 15 milioni rispetto
alla soglia.
Tale risultato positivo è frutto di un andamento
differenziato nei due comparti: per quanto riguarda la farmaceutica
convenzionata, la spesa (11,5 miliardi) si è collocata al di sotto del tetto
programmato del 13%, evidenziando uno scostamento di 992 milioni in valore
assoluto, che crescono a 1.125 milioni considerando il payback. La spesa sostenuta attraverso la distribuzione diretta dei
farmaci, pari a 4,4 miliardi, è cresciuta invece al di sopra del tetto del 3%
con uno scostamento di 1,5 miliardi, che si riducono a 1,4 sempre per il payback.
Guardando in particolare alla farmaceutica convenzionata, si
rileva rispetto al 2006 una riduzione del 6,8% della spesa netta, a fronte di un aumento
del 4,3% del numero delle ricette: il contenimento della spesa è dovuto,
infatti, alla riduzione del valore medio di ciascuna ricetta (-10,6%). Aumenta inoltre
significativamente l’apporto dei tickets
(oltre il 30% rispetto l’anno precedente).
|
La spesa
convenzionata nel 2006 e nel 2007
|
|
|
2007
|
var 2007/2006
|
|
|
(in
milioni)
|
%
|
|
Spesa
lorda (a)
|
12.712
|
-5,4
|
|
Spesa
netta (b)
|
11.493
|
-6,8
|
|
Ricette
(numero)
|
525
|
4,3
|
|
Ticket
|
539
|
30,2
|
|
(a)
La spesa lorda è ottenuta moltiplicando le quantità vendute di ciascun
farmaco per il suo prezzo al pubblico
|
|
(b)
La spesa netta è pari alla spesa lorda meno gli importi derivanti dal ticket,
gli sconti a carico del farmacista e gli extra sconti derivanti dalle misure
di ripiano (a carico dei produttori dei farmacisti e dei grossisti).
|
Come sottolineato in precedenza, tale risultato è il frutto
degli interventi sui prezzi dei medicinali varati dall'Agenzia Italiana del
Farmaco (taglio selettivo dei prezzi dei farmaci a maggior impatto sulla spesa,
in vigore dal 15 luglio 2006, ed ulteriore taglio generalizzato del 5% dei
prezzi di tutti i medicinali, in vigore dal 1° ottobre 2006) e del crescente
impatto del prezzo di riferimento per i medicinali equivalenti. Sull'andamento
della spesa hanno inciso, inoltre, gli interventi di contenimento varati dalle
Regioni. Tali interventi vanno dalla reintroduzione dei ticket (Abruzzo e
Campania), alla loro rimodulazione (Sicilia), alla limitazione della
prescrizione a una confezione per ricetta (applicata, ad esempio, in Calabria)
nonché, infine, alla distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche
ovvero tramite le farmacie, a seguito di specifici accordi, di medicinali
acquistati dalle ASL. Accordi per la
distribuzione in farmacia di medicinali acquistati dalle ASL sono in atto in
numerose regioni.
La riduzione della spesa ha interessato tutte le regioni ed
in particolare quelle che hanno sottoscritto i Piani di rientro: il Lazio e la Sicilia riducono la spesa netta di
circa il 13 per cento, la Liguria
di poco meno del 10 per cento, la
Campania e la
Sardegna di circa il 9 per cento mentre l’Abruzzo e il Molise
contengono la spesa, rispettivamente, del 7,7 e del 5,8 per cento.
Risulta, infine, comune a tutte le Regioni anche l’aumento
del numero delle ricette.
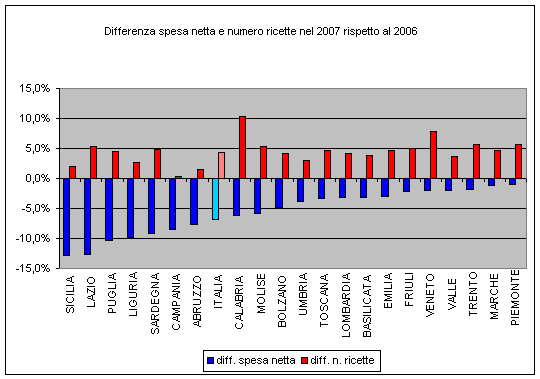
Fonte:
Federfarma
Per quanto riguarda l’evoluzione della spesa farmaceutica
attesa per il 2008, occorre sottolineare come in tale anno, da un lato,
verranno meno gli effetti degli interventi sui prezzi attivati nel 2006
dall'AIFA, dall’altro, agirà in favore di una riduzione della spesa la scadenza
di alcuni importanti brevetti di medicinali, determinando un risparmio che è
stato stimato dall'AIFA in 411 milioni di euro.
Come rilevato dalla Corte dei conti, “dovrà, inoltre, essere
attentamente monitorato l’effetto sulla spesa complessiva delle norme
introdotte con la manovra finanziaria per il 2008. Il divieto per le Regioni,
previsto dalla legge n. 222/2007 di conversione del decreto-legge n. 159/2007
di ricorrere a misure quali l'estensione del rimborso di riferimento ad altre
categorie rispetto a quelle individuate dall'AIFA, potrebbe privare le
amministrazioni di uno strumento di gestione della spesa che, per talune
categoria di farmaci, ha consentito di
ottenere nel 2007, a livello nazionale, un calo
della spesa di oltre il 14% rispetto al 2006. La limitazione degli spazi di
intervento regionali e l'applicazione di un sistema di pay-back che esclude le Regioni dai soggetti chiamati a ripianare
lo sforamento del tetto di spesa potrebbe comportare una attenuazione
dell’attenzione al settore dei soggetti preposti al controllo della spesa, ciò
nonostante il crescente rilievo posto da parte delle autorità centrali alle
misure di contenimento varate a livello regionale per il rispetto dei limiti di
spesa.”
Per quanto riguarda
l’aggregato in esame nel periodo di previsione 2006-2050, la
Ragioneria Generale dello Stato
prevede che il rapporto spesa sanitaria pubblica e PIL cresca in modo
sostanzialmente regolare fino al 2035, passando dal 6,7 per cento del 2006
all’8,1 per cento. Nell’ultimo quindicennio, il ritmo di crescita presenta una
leggera flessione dovuta all’uscita per morte delle generazioni del baby boom,
attestandosi all’8,6 per cento del 2050. Si tratta di una previsione,
nell’ambito dello scenario nazionale base, condotta con riferimento alle
ipotesi sottostanti il cosiddetto pure
ageing scenario che lega le variazioni del rapporto spesa sanitaria/PIL
alle modificazioni della struttura della popolazione. Pertanto, il progressivo
aumento della popolazione anziana, in termini assoluti e in termini relativi
(cioè, in rapporto alla popolazione in età da lavoro), che interessa l’intero
periodo di previsione, è alla base della dinamica crescente del rapporto.
L’aggancio dell’evoluzione della spesa sanitaria al PIL
costituisce uno dei cardini intorno a cui ruota il meccanismo di finanziamento
della spesa sanitaria.
Il presupposto normativo è costituito dal decreto
legislativo 56/2000, attuato solo in parte a causa delle modifiche
costituzionali nel frattempo intervenute, che ha sensibilmente modificato il
modello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale previgente,
sopprimendo in primo luogo i trasferimenti statali che finanziavano il Fondo
sanitario nazionale. In pratica, viene
cancellato lo stanziamento a carico del bilancio dello Stato che, nelle sue
diverse composizioni e consistenze, aveva storicamente alimentato il SSN dalla
sua originaria istituzione. A sostituire il suo compito istituzionale,
ovverosia quello di veicolare stanziamenti statali in favore delle regioni, è
stata individuata dal legislatore una pluralità di fonti finanziarie di natura
impositiva sia diretta (come l’incremento dell’addizionale regionale IPREF e
l’IRAP) che indiretta (tra cui
l’istituzione della compartecipazione IVA e l’accisa sulle benzine).
Data la mancata attuazione del decreto legislativo,
attualmente il finanziamento del SSN, ancorato al PIL, è concordato in modo
pattizio tra livello centrale (Governo) e Regioni tenendo conto in primo luogo
dei fabbisogni sanitari.
Il primo Accordo è stato siglato l’8 agosto 2001 ed ha
disciplinato, per il triennio 2002-2004, oltre all’ammontare del finanziamento, anche i meccanismi della
sua ripartizione. Per il triennio successivo è intervenuta l’Intesa siglata il
23 marzo 2005, seguita dall’Accordo del 22 settembre 2006, recepito dalla legge
finanziaria 2007. Il Patto, valido per il triennio 2007-2009,
si compone di un aspetto finanziario e di un aspetto normativo e programmatico.
Oltre alla previsione di azioni volte alla razionalizzazione e al contenimento
della spesa sanitaria, l’Accordo finanziario ha previsto:
·
l’incremento delle risorse messe a disposizione
dallo Stato centrale (da 91,2 miliardi nel 2006 a 97 miliardi nel 2007, 99
miliardi nel 2008 e 102,2 miliardi nel 2009), comprensive di un Fondo transitorio
di 1 miliardo per sostenere il risanamento delle Regioni attualmente non in
linea con i livelli di spesa concordati;
·
la conferma di meccanismi di piena
responsabilizzazione finanziaria per le Regioni che non raggiungono gli
obiettivi di spesa concordati, come le misure di affiancamento e gli
"automatismi fiscali" (aumento delle aliquote regionali dell'addizionale
Irpef e dell'Irap).
Per quanto attiene alla composizione del finanziamento
complessivo del SSN, esso proviene, per il 95% circa, dalla imposizione fiscale
diretta (sui redditi delle imprese e delle persone fisiche) e da quella
indiretta (sui consumi) e, per la rimanente parte, da ricavi ed entrate proprie
varie delle aziende sanitarie nonché dalla compartecipazione dei cittadini alla
spesa sanitaria pubblica (co-payment).
Più in dettaglio, le principali fonti di finanziamento del
SSN sono le seguenti:
-
le risorse derivanti dall’IRAP e
dall’addizionale regionale IRPEF;
-
il Fondo per il fabbisogno sanitario di cui al
decreto legislativo n. 56/2000 (Fondo perequativo nazionale), le cui risorse vengono
assegnate alle sole Regioni a statuto ordinario (RSO).
-
gliulteriori
trasferimenti dal settore pubblico e da quello privato, che comprendono le quote di partecipazione delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome, nonché risorse aggiuntive da parte delle
Regioni o province autonome e ulteriori trasferimenti da parte del settore
pubblico allargato (altre amministrazioni statali, province, comuni, etc…) e da
quello privato per garantire l’equilibrio economico-finanziario.
-
i ricavi e le entrate proprie varie delle
aziende sanitarie, che sono
rappresentati dai ricavi conseguiti dalle aziende sanitarie derivanti dalla
vendita di prestazioni sanitarie e non sanitarie a soggetti pubblici e privati,
della Regione e al di fuori della Regione di appartenenza, e da altri ricavi
quali interessi attivi e altri proventi finanziari, rimborsi, etc. Sono
ricompresi i ticket introitati direttamente e le compartecipazioni per
l’attività libero professionale svolta all’interno delle aziende sanitarie.
-
il Fondo sanitario nazionale assegnato come
quota parte a carico dello Stato:
·
per le Regioni, alla sola regione Sicilia
per il finanziamento dei LEA e a tutte le regioni a statuto ordinario per
quanto riguarda i fondi vincolati da norme speciali al finanziamento di spese
sanitarie inerenti l’esecuzione di particolari attività e il raggiungimento di
specifici obiettivi.
·
per gli altri Enti, ad alcuni enti del
SSN (CRI e IZS per le
rispettive esigenze di funzionamento, Cassa DD.PP. per il rimborso delle rate
dei mutui pre-riforma, Università per l’erogazione delle borse di studio ai
medici specializzandi).
Risorse pubbliche aggiuntive vengono, inoltre, destinate al
finanziamento degli investimenti
e della ricerca
in campo sanitario.
Nella tabella che segue è indicata la composizione delle
risorse finanziarie del SSN che, per l’anno 2007, non considerando i ricavi
della gestione straordinaria e
quelli per l’intramoenia, ammontano complessivamente a 99,351 miliardi di euro.
Fonti di finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale: anno 2007
(miliardi di euro - %)
|
Fonti di finanziamento
|
Finanziamento SSN
|
Composizione % su totale regioni e
prov. Autonome
|
|
Irap e Addizionale Irpef
|
38,200
|
38,7
|
|
Fabbisogno ex D.L.vo 56/00 (Iva e
Accise)
|
44,852
|
45,4
|
|
Ulteriori Trasferimenti da
Pubblico e da Privato
|
9,179
|
9,3
|
|
Ricavi e Entrate Proprie varie
|
2,871
|
2,9
|
|
FSN e ulteriori integrazioni a
carico dello Stato
|
3,731
|
3,8
|
|
TOTALE REGIONI e PROVINCE AUTONOME
|
98,833
|
100,00
|
|
Altri Enti Finanziati con Fondo
Sanitario Nazionale
|
0,517
|
|
|
TOTALE
|
99,351
|
|
Fonte: RGSEP
2007 – Rapporto sanità (Ministero della Salute)
Con riferimento alla dinamica storica del finanziamento del
SSN e della spesa pubblica, la tabella che segue sintetizza l’andamento complessivo
negli anni 2004-2007.
Finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale: anni 2004-2007
(miliardi di euro - %)
|
Anni
|
Finanziamento SSN
|
Variazione % anno precedente
finanziamento SSN
|
Spesa SSN
|
Rapporto % finanziamento SSN /
spesa SSN
|
Rapporto % finanziamento SSN / PIL
|
|
2004
|
84,800
|
5,9
|
91,222
|
93,0
|
6,1
|
|
2005
|
91,201
|
7,5
|
97,163
|
93,9
|
6,4
|
|
2006
|
95,129
|
4,3
|
99,648
|
95,5
|
6,4
|
|
2007
|
99,351
|
4,4
|
102,519
|
96,9
|
6,5
|
Fonte: RGSEP
2007 – Rapporto sanità (Ministero della Salute)
Come si evince dai dati, il rapporto medio tra finanziamento
complessivo del SSN e PIL nel periodo di osservazione si attesta al 6,35%,
evidenziando un trend sostanzialmente costante.
Per quanto riguarda, infine, l’anno in corso, rispetto
all’importo di 99 miliardi fissato dalla legge finanziaria 2007, si ricorda che
la legge finanziaria 2008 ha
previsto l’incremento della quota del concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria corrente nella misura di 661 milioni di euro per il 2008
e di 398 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 per il rinnovo dei
contratti del personale sanitario e,
limitatamente al 2008, un ulteriore incremento pari a 834 milioni di euro per
il rifinanziamento del SSN a seguito dell’abolizione della quota di
partecipazione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per
detto anno.
La differenza tra il livello del finanziamento e quello
della spesa sanitaria di cui alla precedente tavola corrisponde alla perdita
complessiva netta del SSN, pari alla somma algebrica degli utili e delle
perdite delle singole regioni e province autonome. Nel 2007 il disavanzo è
risultato pari a 3,169 miliardi, con una riduzione di circa il 30% rispetto
all’anno precedente (-4,519 miliardi), come risulta dalla tavola che segue.
|
Risultato di esercizio del SSN
anni 2006-2007
|
|
|
2006
|
|
2007
|
|
|
|
Risultato di esercizio
|
pro-capite
|
Risultato di esercizio
|
pro-capite
|
|
|
milioni di euro
|
euro
|
milioni di euro
|
euro
|
|
Piemonte
|
-7,172
|
-2
|
-96,117
|
-22
|
|
V.d.A.
|
-13,517
|
-110
|
-14,432
|
-116
|
|
Lombardia
|
-4,213
|
0
|
9,435
|
1
|
|
p.a. Bolzano
|
-25,272
|
53
|
17,448
|
36
|
|
p.a. Trento
|
-14,072
|
-28
|
-1,652
|
-3
|
|
Veneto
|
71,385
|
15
|
2,216
|
-
|
|
FVG
|
18,297
|
15
|
23,716
|
20
|
|
Liguria
|
-99,764
|
-62
|
-141,499
|
-88
|
|
Emilia Romagna
|
-38,417
|
-9
|
12,804
|
3
|
|
Toscana
|
-120,617
|
-33
|
95,152
|
26
|
|
Umbria
|
-40,647
|
-47
|
13,268
|
15
|
|
Marche
|
-38,953
|
-26
|
24,303
|
16
|
|
Lazio
|
-1.970,855
|
-373
|
-1.406,79
|
-261
|
|
Abruzzo
|
-140,413
|
-108
|
-117,306
|
-90
|
|
Molise
|
-58,785
|
-183
|
-62,397
|
-195
|
|
Campania
|
-751,116
|
-130
|
-679,268
|
-120
|
|
Puglia
|
-169,502
|
-42
|
-199,701
|
-49
|
|
Basilicata
|
-22,099
|
-37
|
-13,151
|
-22
|
|
Calabria
|
-34,931
|
-17
|
-24,17
|
-12
|
|
Sicilia
|
-975,978
|
-195
|
-524,385
|
-105
|
|
Sardegna
|
-133,352
|
-81
|
-68,24
|
-41
|
|
ITALIA
|
-4.519,451
|
-77
|
-3.168,77
|
-54
|
|
solo perdite
|
-4.634,405
|
|
-3.367108
|
|
|
solo utili
|
114,954
|
|
198,341
|
|
|
Fonte: SIS, dati al 28 febbraio 2008 – RGSEP 2007
|
Tale risultato si determina a fronte di 0,198 miliardi di
utili (registrati da Lombardia, p.a. Bolzano, Veneto, Friuli, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria e Marche) e 3,367 miliardi di perdite nelle rimanenti regioni e
province autonome.
Di queste, oltre l’82 per cento si concentra in tre regioni
(Lazio, Campania e Sicilia). Tale percentuale sale al 92 per cento se si
considerano anche le altre tre regioni che, nel corso del 2007, hanno
sottoscritto i Piani di rientro (Abruzzo, Molise e Liguria) (cfr infra).
Per quanto riguarda le restanti regioni, si evidenzia un
sensibile miglioramento delle regioni del Centro-Nord, ad eccezione del
Piemonte (la cui perdita passa dai 7 milioni del 2006 a oltre 96 milioni nel 2007). Tra
le regioni meridionali, a fronte di una riduzione della perdita della
Basilicata e della Sardegna, peggiora la situazione della Puglia.
Rispetto alla situazione descritta dalla tavola precedente
che riflette i dati, al IV trimestre 2007, comunicati al SIS dalle regioni, va
rilevato, tuttavia, che questi sono soggetti a continue revisioni per
l’attuazione della complessa procedura di rettifica che, attraverso fasi
successive, porterà al dato definitivo di consuntivo, pubblicato nella
Relazione generale sulla situazione economica del Paese riferita all’esercizio
successivo.
A tale proposito, infatti, si ricorda che i conti regionali
sono vagliati e, nel caso, rettificati, in linea generale, attraverso i
monitoraggi trimestrali dei Tavoli di verifica previsti dall’articolo 1, comma
174, della legge n. 311/2004 e, per le regioni che hanno in corso un Piano di
rientro dal deficit sanitario, attraverso il monitoraggio specificamente
previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006 (cfr. infra). Tutte le regioni, inoltre,
secondo quanto previsto dal Patto della Salute, devono predisporre idonee
coperture degli eventuali disavanzi, coperture anch’esse verificate in
occasione del monitoraggio.
Con riferimento agli esiti della verifica di marzo 2008,
come risulta da notizie di stampa, i dati sopra riportati dovrebbero avere
subito una prima rettifica nei termini esposti dalla tabella che segue. La
tavola evidenzia, inoltre, per alcune regioni l’ammontare di disavanzo non
coperto.
(milioni di euro)
|
|
Risultato di esercizio 2007
|
Tavolo di monitoraggio
|
|
|
|
|
|
Piemonte
|
-184,258
|
-91,258
|
|
Lombardia
|
+9,429
|
0,000
|
|
Veneto
|
-219,428
|
0,000
|
|
Liguria
|
-143,801
|
0,000
|
|
Emilia Romagna
|
-85,093
|
0,000
|
|
Toscana
|
+90,706
|
0,000
|
|
Umbria
|
+13,969
|
0,000
|
|
Marche
|
+10,204
|
0,000
|
|
Lazio
|
-1.606,668
|
-125,265
|
|
Abruzzo1
|
-130,891
|
-35,651
|
|
Molise
|
-61,571
|
0,000
|
|
Campania
|
-654,103
|
0,000
|
|
Puglia
|
-229,268
|
-49,268
|
|
Basilicata
|
-13,195
|
0,000
|
|
Calabria
|
-194,317
|
-194,317
|
|
Sicilia2
|
-612,533
|
0,000
|
|
totale disavanzo ancora scoperto
|
-495,760
|
1L’Abruzzo dovrebbe trascinare
sul 2007 un disavanzo 2006 di 197,064 milioni di euro, con un conseguente
aumento del disavanzo da coprire, che ammonterebbe, complessivamente a 232,715
milioni di euro.
2 La Sicilia sarebbe in ritardo
sull’attuazione del Piano e, nel caso in cui gli adempimenti in esso previsto
non si realizzassero, verrebbe meno il finanziamento a valere sul Fondo
transitorio di accompagnamento previsto dalla finanziaria 2007, lasciando
conseguentemente scoperto il disavanzo iniziale.
Ove tali esiti
fossero confermati, per Piemonte, Puglia e Calabria, scatterebbe la procedura
di cui al citato comma 174
dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 e l’aumento dell’addizionale IRPEF e la
maggiorazione dell’aliquota IRAP entro le misure stabilite dalla normativa
vigente.
La
norma stabilisce che, ove dai dati del monitoraggio del IV trimestre, si
evidenzi uno squilibrio di gestione a fronte del quale non siano stati adottati
i necessari provvedimenti o gli stessi risultano insufficienti, con la
procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003, la regione é
diffidata a provvedere entro il 30 aprile. Qualora la regione non adempia,
entro i successivi trenta giorni, il presidente della regione, in qualità di
commissario ad acta, determina il
disavanzo di gestione e adotta i provvedimenti necessari al ripiano, ivi
inclusi gli aumenti dell’addizionale IRPEF e la maggiorazione dell’aliquota
IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora tali
provvedimenti non siano adottati entro un mese, scatta comunque l’aumento delle
aliquote, nella misura massima.
Per quanto
riguarda invece Lazio e Abruzzo, la conferma della mancata copertura dei
disavanzi comporterebbe (ai sensi del richiamato articolo 1, comma 796,
lettera b), della legge n. 296/2006) l’automatico innalzamento dell’addizionale
IRPEF e della maggiorazione IRAP oltre i livelli massimi.
Sulla base delle
intese intercorse tra lo Stato e le Regioni[422], sono state introdotte
nell’ordinamento, a decorrere dal 2005, disposizioni specificamente volte a
responsabilizzare le Regioni nel perseguimento dell’obiettivo di azzerare i
disavanzi accumulatisi dal 2001, prevedendo al contempo il concorso finanziario
e tecnico dello Stato.
Più in particolare,
la legge finanziaria per il 2005ha previsto a carico delle Regioni adempimenti, organizzativi e
gestionali, intesi a garantire l’equilibrio economico-finanziario e il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Con la medesima legge, è
stata prevista la possibilità per le regioni di stipulare un apposito Accordo
con i Ministri dell’economia e della salute, accompagnato da un programma
operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio
sanitario nazionale, c.d. Piano di rientro dai disavanzi, che deve contenere
sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di
assistenza, che quelle necessarie all’azzeramento dei disavanzi entro il 2010.
Successivamente, la
legge finanziaria per il 2006,
confermando gli obblighi posti a carico delle Regioni, ha integrato il
meccanismo di automatismo relativo all’innalzamento al livello massimo delle
aliquote delle addizionali IRPEF ed IRAP nelle regioni che non coprono
integralmente i disavanzi registrati a partire dall’anno 2005.
Per rendere
concretamente conseguibile il riequilibrio dei conti sanitari, la legge
finanziaria per il 2007,
ha disposto l’istituzione di un Fondo transitorio, per il triennio 2007-2009
(con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro nel 2007, 850 milioni di euro
nel 2008 e 700 milioni di euro nel 2009)
destinato alle regioni con disavanzi elevati, subordinatamente alla
sottoscrizione di appositi accordi che prevedano i Piani di rientro. L’accesso
al Fondo è subordinato all’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale
IRPEF e dell’aliquota IRAP.
Qualora nel procedimento di verifica annuale si prefiguri il
mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo, la
regione può proporre misure equivalenti, che devono essere approvate dai
Ministri della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso,
l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi comporta
l’innalzamento dell’addizionale IRPEF e dell’aliquota IRAP oltre i livelli
massimi previsti dalla legislazione vigente, fino a totale copertura degli
obiettivi.
Il D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008 ha
previsto, con riferimento al 2007, che in alternativa all’innalzamento delle
aliquote oltre il livello massimo, le regioni potessero adottare, entro il 31
dicembre, altre misure di copertura del disavanzo, per un importo
corrispondente, idonee e congrue a conseguire l’equilibrio economico per il
medesimo anno.
Qualora, infine, nel
procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro si
prefiguri il mancato rispetto degli adempimenti previsti, fermo restando
l’incremento delle aliquote fiscali oltre il livello massimo, la regione è
diffidata ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento
degli obiettivi del Piano medesimo. Ove la regione non adempia alla diffida, o
gli atti e le azioni poste in essere siano valutati insufficienti o inidonei
al raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio dei Ministri nomina un
commissario ad acta per l’intero
periodo di vigenza del Piano.
Nel corso del 2006 è stata avviata la procedura di
affiancamento gestionale dal parte dei Ministeri della Salute e dell’Economia
per la Liguria, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania e la Sicilia.
La procedura si è conclusa, nel corso del 2007, con la sottoscrizione da parte
delle suddette regioni dei Piani di rientro dai deficit 2001-2005.
Altre due regioni, Piemonte e Calabria, hanno avanzato la
richiesta di avviare il confronto su una proposta di Piano finalizzata a sanare
le inadempienze relative ad anni precedenti (rispettivamente il 2004 per il
Piemonte e il 2001 per la Calabria) e lo sblocco dei relativi fondi non
assegnati. La Calabria, tuttavia, è risultata inadempiente anche per il 2005 ed
il 2006 e il Piano dovrà sanare queste ulteriori inadempienze.
Come si è detto (cfr supra),
dai primi risultati dei Tavoli di verifica (marzo 2008) è emerso un disavanzo
non coperto per Lazio (125,3 milioni) e Abruzzo (233,7 milioni, di cui 197
relativi al 2006): per tali regioni scatterebbe, quindi, l’aumento oltre i
livelli massimi dell’addizionale IRPEF e della maggiorazione IRAP.
Risulterebbero, invece, in equilibrio Liguria, Molise e Campania, mentre la
Sicilia, che ha firmato il Piano nel luglio 2007, sarebbe in ritardo nell’attuazione
dello stesso: nel caso in cui gli adempimenti in esso previsto non si
realizzassero, verrebbe meno il finanziamento a valere sul Fondo transitorio di
accompagnamento previsto dalla finanziaria 2007, lasciando conseguentemente
scoperto il disavanzo iniziale.
Ristrutturazione del debito
sanitario al 31 dicembre 2005
Nei Piani di rientro dai disavanzi sanitari è esposta la
situazione patrimoniale dei rispettivi sistemi sanitari regionali, con
particolare riferimento alla sostenibilità economica e finanziaria del debito
pregresso.
La tavola che segue ricostruisce, sulla base dei dati
contenuti nei Piani, la situazione debitoria delle singole regioni e le risorse
individuate per il ripiano.
Debito sanitario complessivo valutato al
31/12/2005
e risorse destinabili alla riduzione del
debito, come indicato nei piani di rientro
(milioni di euro)
|
|
Debito complessivo al 31/12/2005
(in linea capitale, al netto degli interessi)
|
Risorse complessive destinabili
alla riduzione del debito
di competenza degli anni 2001-2005 (1)
|
di cui
|
Prestito dello Stato alle regioni
per l'estinzione anticipata del debito (3)
|
|
Risorse a carico delle regioni
|
Risorse derivanti da erogazioni
statali (2)
|
|
Liguria
|
1.204
|
993
|
666
|
327
|
-
|
|
Abruzzo
|
1.760
|
989
|
812
|
177
|
-
|
|
Molise
|
396
|
299
|
89
|
210
|
97
|
|
Campania
|
6.914
|
3.532
|
3.069
|
463
|
630
|
|
Lazio
|
9.900
|
4.700
|
2.252
|
2.448
|
5.000
|
|
Sicilia
|
4.657
|
1.370
|
494
|
876
|
2.800
|
|
Totale
|
24.831
|
11.883
|
7.382
|
4.501
|
8.527
|
(1) Le
risorse tengono conto, per la sola regione Lazio, delle risorse di competenza
del 2006, pari a1.056 milioni, che dovranno essere reintegrate in quanto
destinate al pagamento delle rate di ammortamento relativo al 2006.
(2) Le
risorse statali sono comprensive delle somme destinate al ripiano dei disavanzi
pregressi previste dal decreto legge 23/2007, pari complessivamente a 3.000
milioni di euro, ripartiti dal DM del 4 maggio 2007.
(3) L’anticipazione è pari al
massimo livello di debito residuo cumulato al 2005, valutato al 2007 nei Piani
di rientro.
Come evidenziato nella tavola, i Piani di rientro di alcune
regioni (Molise, Campania, Lazio e Sicilia), sulla base di quanto stabilito in
sede di Accordi, prevedono un prestito dello Stato, che è stato poi autorizzato
dalla legge finanziaria per il 2008 (commi 46-48 dell’art. 2 della legge
244/2007) nella misura di 9.100 milioni di euro.
I livelli di debito di tali regioni, nonché le condizioni
contrattuali sottostanti particolarmente onerose, al di fuori delle ordinarie
condizioni di mercato, sono stati infatti ritenuti dal Governo tali da impedire
ogni azione di risanamento strutturale. Si è, pertanto, ritenuto opportuno un
intervento da parte dello Stato, sotto forma di prestito alle regioni, ai fini
dell'estinzione anticipata dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei
debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.
Fermo restando il limite complessivo di 9.100 milioni,
l'importo dell'anticipazione per ciascuna regione è determinato in base ai
procedimenti indicati nei singoli Piani di rientro, al netto delle risorse già
erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. Lo Stato procede all'erogazione,
anche graduale, delle anticipazioni, in seguito al riaccertamento definitivo e
completo del debito - con il supporto dell'advisor contabile e secondo le
previsioni del Piano di rientro - ed alla sottoscrizione, tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la singola regione, di un contratto che
specifichi gli obblighi di restituzione, che deve avvenire entro un periodo non
superiore a trenta anni.
La spesa per
l’istruzione
L’analisi degli
andamenti della spesa per l’istruzione di cui si dà conto nel presente
paragrafo è effettuata sulla base dei dati diffusi dall’Istat il 7 febbraio
2008 relativi alla spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione.
In base a tale
classificazione, la spesa è riferita a tutti i livelli di istruzione e
comprende pertanto oltre a quella relativa alla scuola primaria e secondaria,
anche l’istruzione pre-scolastica, quella universitaria (c.d. istruzione
superiore) e la formazione professionale non universitaria post-diploma (ad
esempio, i conservatori), nonché l’istruzione per adulti (c.d. istruzione di
diverso tipo).
Nel periodo
2000-2006, i dati riportati nella tavola 1 evidenziano una crescita di circa il
3% annuo della spesa per l’istruzione. Fatta eccezione per l’ultimo anno,
l’incidenza sul PIL si mantiene stabilmente intorno al 4,6%, mentre si riduce
di 4 decimi di punto il peso sulla spesa complessiva delle amministrazioni
pubbliche, che passa dal 9,9% del 2000 al 9,5% del 2005.
Nel 2006 si registra
una riduzione anche in valore assoluto della spesa per l’istruzione (circa 7
decimi di punto in termini di spesa complessiva): su tale fenomeno influisce lo
slittamento al 2007 dei rinnovi contrattuali per tale comparto.
Tavola 1 – Spesa delle Amministrazioni pubbliche per l’istruzione –
anni 2000-2006
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
valori
assoluti (mln di euro)
|
54.225
|
57.526
|
60.012
|
63.915
|
62.581
|
65.754
|
65.746
|
|
% spesa
complessiva P.A.
|
9,9
|
9,6
|
9,9
|
9,9
|
9,4
|
9,5
|
8,8
|
|
% sul PIL
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,8
|
4,5
|
4,6
|
4,5
|
La tavola 2 riporta
la composizione della spesa per livelli di istruzione, in base alla
classificazione COFOG[439]. Da
essa emerge il rilievo della spesa per la fascia della scuola dell’obbligo
(inclusa la fascia pre-scolastica), che assorbe oltre l’80% del totale[440].
L’istruzione
universitaria (classificata come “istruzione superiore”) pesa per circa il 7,8%
della spesa complessiva.
In tale voce deve
considerarsi inclusa una parte della spesa per il personale universitario,
docente e non docente. La spesa, invece, per i ricercatori (ovvero il personale
docente universitario che ha dichiarato di svolgere prevalentemente attività di
ricerca) rientra nella classificazione COFOG 01.5 (“R&S per i servizi
pubblici generali”).
Tavola 2 – La spesa pubblica per
l’istruzione secondo la classificazione funzionale COFOG, II livello
(milioni di euro)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
istruzione
pre-scolastica e primaria
|
21.492
|
22.746
|
22.257
|
24.602
|
23.644
|
25.000
|
24.795
|
|
istruzione
secondaria
|
23.464
|
24.816
|
26.999
|
28.130
|
27.462
|
28.815
|
28.767
|
|
istruz.
post-secondaria non superiore
|
1.559
|
2.011
|
2024
|
2140
|
2193
|
2368
|
2512
|
|
istruzione
superiore
|
4.216
|
4.160
|
4.527
|
4.597
|
4.652
|
4.937
|
5.078
|
|
istruzione
di diverso tipo
|
614
|
795
|
973
|
1.065
|
1.116
|
1.036
|
1.044
|
|
servizi
ausiliari dell'istruzione
|
2.203
|
2.314
|
2.649
|
2.708
|
2.862
|
2.994
|
3.021
|
|
R&S
per l'istruzione
|
4
|
3
|
3
|
10
|
19
|
28
|
27
|
|
istruzione
n.a.c.(*)
|
673
|
681
|
580
|
663
|
633
|
576
|
502
|
|
Totale
|
54.225
|
57.526
|
60.012
|
63.915
|
62.581
|
65.754
|
65.746
|
(*) non altrimenti
classificabile
Come evidenziato
dalle tavole 3 e 4 - che riportano la suddivisione della spesa per istruzione
nelle principali voci di uscita del conto della P.A. - la spesa per
l’istruzione si concentra nella fase di produzione e di offerta del servizio,
ossia nella spesa per i consumi finali, che rappresenta un valore prossimo al
90 per cento del totale; al suo interno, l’incidenza sul totale dei redditi da
lavoro si è mantenuta in media, nel periodo considerato, prossima al 76 per
cento.
La spesa per
trasferimenti correnti alle famiglie (borse di studio) rappresenta in media il
3 per cento della spesa complessiva per l’istruzione.
All’interno delle
spese di conto capitale, la spesa per investimenti fissi lordi e acquisizione
di attività non finanziarie rappresenta la voce più significativa, con
un’incidenza media sul totale della spesa del 4 per cento circa.
Tavola 3 – Composizione della spesa per l’istruzione – anni 2000-2006
(milioni di euro)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Spesa
per consumi finali
|
49.378
|
52.090
|
53.969
|
57.032
|
55.699
|
59.085
|
58.828
|
|
Redditi da lavoro
|
41.908
|
44.071
|
46.397
|
48.831
|
46.989
|
50.250
|
49.927
|
|
Consumi intermedi
|
6.061
|
6.536
|
5.925
|
6.541
|
7.221
|
7.184
|
6.995
|
|
Contributi
alla produzione
|
889
|
1.188
|
1.074
|
1.707
|
1.568
|
1.396
|
1.515
|
|
Redditi
da capitale
|
77
|
86
|
71
|
69
|
119
|
114
|
144
|
|
Imposte
dirette
|
38
|
29
|
32
|
35
|
39
|
42
|
42
|
|
Trasferimenti
correnti
|
1.344
|
1.741
|
2.081
|
2.194
|
2.226
|
2.062
|
2.056
|
|
TOTALE USCITE CORRENTI
|
51.726
|
55.134
|
57.227
|
61.037
|
59.651
|
62.699
|
62.585
|
|
Investimenti
fissi lordi
+ acquisizioni nette
di attività non finanziarie
|
2.468
|
2.232
|
2.599
|
2.624
|
2.638
|
2.557
|
2.677
|
|
Trasferimenti
in conto capitale
|
99
|
111
|
186
|
254
|
292
|
498
|
484
|
|
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE
|
2.499
|
2.392
|
2.785
|
2.878
|
2.930
|
3.055
|
3.161
|
|
TOTALE USCITE COMPLESSIVE
|
54.225
|
57.526
|
60.012
|
63.915
|
62.581
|
65.754
|
65.746
|
Tavola 4 – Composizione della spesa per l’istruzione – anni 2000-2006
(incidenza percentuale)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Spesa
per consumi finali
|
91,06
|
90,55
|
89,93
|
89,23
|
89,00
|
89,86
|
89,48
|
|
Redditi da lavoro
|
77,29
|
76,61
|
77,31
|
76,40
|
75,09
|
76,42
|
75,94
|
|
Consumi intermedi
|
11,18
|
11,36
|
9,87
|
10,23
|
11,54
|
10,93
|
10,64
|
|
Contributi
alla produzione
|
1,64
|
2,07
|
1,79
|
2,67
|
2,51
|
2,12
|
2,30
|
|
Redditi
da capitale
|
0,14
|
0,15
|
0,12
|
0,11
|
0,19
|
0,17
|
0,22
|
|
Imposte
dirette
|
0,07
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
Trasferimenti
correnti
|
2,48
|
3,03
|
3,47
|
3,43
|
3,56
|
3,14
|
3,13
|
|
TOTALE USCITE CORRENTI
|
95,39
|
95,84
|
95,36
|
95,50
|
95,32
|
95,35
|
95,19
|
|
Investimenti
fissi lordi + acquisizioni nette di attività non finanziarie
|
4,43
|
3,97
|
4,33
|
4,11
|
4,22
|
3,89
|
4,07
|
|
Trasferimenti
in c/capitale
|
0,18
|
0,19
|
0,31
|
0,40
|
0,47
|
0,76
|
0,74
|
|
TOTALE USCITE C/CAPITALE
|
4,61
|
4,16
|
4,64
|
4,50
|
4,68
|
4,65
|
4,81
|
|
TOTALE
USCITE COMPLESSIVE
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
La spesa pubblica
per l’istruzione è prevalentemente a carico dello Stato e, in misura minore,
delle amministrazioni locali.
In base alla legge 59/1997[441] e dei relativi
provvedimenti attuativi[442], lo
Stato determina gli obblighi formativi e detta le norme di principio che
attribuiscono diritti e doveri (obbligo di istruzione, gratuità dell’istruzione
nella scuola primaria e secondaria inferiore, diritto al sostegno per gli
alunni diversamente abili, dimensione massima delle classi). Le regioni
deliberano in merito alla rete scolastica, ovvero alla distribuzione delle
scuole sul territorio. Ai comuni e alle province provvedono agli immobili in
cui sono collocate le scuole, e alla copertura dei relativi costi di gestione.
La competenza dei comuni è limitata alla scuola primaria e alla scuola
dell’infanzia; la competenza provinciale riguarda invece la scuola secondaria.
Le scuole, infine, in base ai principi dell’autonomia didattica ed
amministrativa previsti dalla legge n. 59/1997, decidono in merito
all’organizzazione della didattica, con riflessi sugli organici di fatto e
dunque sui costi.
La tavola che segue
rappresenta il contributo, rispettivamente, delle amministrazioni centrali e
delle amministrazioni locali alla spesa per istruzione.
Tavola 5 – Spesa per l’istruzione delle amministrazioni centrali e
locali
(milioni di euro - %)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Amministrazioni centrali
|
40755
(75)
|
43150
(75)
|
44376
(74)
|
47673
(75)
|
45834
(73)
|
48414
(74)
|
47814
(73)
|
|
Amministrazioni locali
|
13470
(25)
|
14376
(25)
|
15636
(26)
|
16242
(25)
|
16747
(27)
|
17340
(26)
|
17932
(27)
|
|
totale
|
54225
(100)
|
57526
(100)
|
60012
(100)
|
63915
(100)
|
62581
(100)
|
65754
(100)
|
65746
(100)
|
Come evidenziato
dalla tavola 5, la spesa per l’istruzione si concentra nelle amministrazioni
centrali, ove è quasi interamente assorbita dalla voce relativa ai redditi da
lavoro, mentre per le amministrazioni locali assume un rilievo più marcato la
spesa di investimento che copre, in media, il 98 per cento dell’importo
complessivamente destinato dalla P.A. a tale finalità.
Elementi informativi
circa l’ammontare e le caratteristiche della spesa italiana per l’istruzione
scolastica, in rapporto ai dati che emergono dal contesto internazionale,
possono essere tratti dal rapporto annuale dell’OCSE, Educational at a
glance: tali dati sono utilizzati nelle
analisi contenute nel Quaderno bianco sulla scuola del
settembre 2007[443] e nel
rapporto intermedio (ottobre 2007) predisposto dalla Commissione tecnica per la
finanza pubblica nell’ambito della Spending review per il Ministero
della pubblica istruzione, cui si fa riferimento nel presente capitolo.
Tavola 6a – Spesa per l’istruzione scolastica
confronto internazionale - anno 2004
|
Paesi
|
% PIL
|
% spesa pubblica totale
|
|
Pubblica
|
Privata
|
Totale
|
Pubblica
|
|
Italia
|
3,3
|
0,1
|
3,4
|
7,0
|
|
Francia
|
3,9
|
0,2
|
4,1
|
7,4
|
|
Germania
|
2,8
|
0,6
|
3,5
|
6,3
|
|
Gran
Bretagna
|
3,8
|
0,6
|
4,4
|
8,7
|
|
Grecia
|
2,1
|
0,1
|
2,2
|
5,3
|
|
Spagna
|
2,8
|
0,2
|
3,0
|
Nd
|
|
Svezia
|
4,5
|
nd
|
4,5
|
8,3
|
|
Finlandia
|
3,9
|
nd
|
4,0
|
8,0
|
|
Canada
|
3,2
|
0,3
|
3,6
|
8,2
|
|
Stati
Uniti
|
3,7
|
0,4
|
4,1
|
10,1
|
|
Giappone
|
2,7
|
0,3
|
3,0
|
7,2
|
|
Media Ocse
|
3,6
|
0,3
|
3,9
|
9,2
|
Fonte: Elaborazione su dati OCSE, Education at a Glance (2007).
I dati evidenziano
come, in termini di PIL, la spesa per l’istruzione in Italia, pari al 3,4 per
cento, sia inferiore alla media OCSE (3,9 per cento) e della maggioranza dei
paesi considerati, sia per la componente pubblica (3,3% del PIL rispetto alla
media del 3,6%), sia per la componente privata (0,1 rispetto alla media dello
0,3%).
La componente di
spesa pubblica totale dedicata alla scuola (7%) è, inoltre, decisamente inferiore a quella media OCSE
(9,2%).
Risulta invece più
elevata, rispetto alla media, la spesa italiana per studente (5.710 euro
pro-capite rispetto ai 4.623 della media OCSE). Lo scostamento si riduce (5.172
euro pro-capite) se si normalizza la spesa per tenere conto del più elevato
numero di ore di insegnamento nelle scuole italiane.
Tavola 6b – Spesa per l’istruzione scolastica
confronto internazionale - anno 2003
|
Paesi
|
Spesa pubblica per studente (euro)
|
|
Italia
|
5.710
|
|
Francia
|
5.288
|
|
Germania
|
4.856
|
|
Gran
Bretagna
|
4.964
|
|
Grecia
|
3.378
|
|
Spagna
|
4.184
|
|
Svezia
|
4.015
|
|
Finlandia
|
4.787
|
|
Canada
|
4.773
|
|
Stati
Uniti
|
6.580
|
|
Giappone
|
5.038
|
|
Media Ocse
|
4.623
|
Fonte: Elaborazione contenute nel
“Quaderno bianco della scuola”, su dati tratti da OCSE, Education at a Glance
(2006).
A fronte di tale
spesa, guardando ai risultati del sistema dell’istruzione, occorre sottolineare
come in Italia si sia verificato un aumento del tasso di partecipazione
all’istruzione secondaria superiore, che passa dal 78,3% dell’anno scolastico
1994/95 al 92,4% dell’anno scolastico 2005/2006, in linea con la media OCSE.
Inoltre, dal 2004, la percentuale della popolazione in età da diploma che ha
concluso la scuola secondaria superiore ha raggiunta la media OCSE (circa
l’82%). Tuttavia, tali dati medi andrebbero letti in relazione alle specifiche
realtà territoriali che ancora oggi nascondono differenze alquanto marcate,
evidenti, ad esempio, nella percentuale di abbandoni scolastici, decisamente
più elevata al sud.
Il divario tra nord
e sud del Paese pesa in modo non indifferente anche sulla qualità del sistema
dell’istruzione, come hanno rivelato i risultati diffusi recentemente del Test PISA, effettuato nel 2006[445].
L’esito, che conferma la posizione di coda dell’Italia rispetto sia ai paesi
OCSE sia alla media europea, va anche addebitato al peso che le due componenti
più dinamiche all’interno della popolazione scolastica italiana - ovvero gli
alunni meridionali e quelli immigrati – esercitano all’interno della
popolazione di studenti che hanno sostenuto il test. In particolare, il test ha
confermato il fenomeno generalizzato dei bassi risultati delle scuole
meridionali italiane nonché il marcato scostamento dei risultati degli
immigrati rispetto alla media nazionale che, in Italia, è inoltre più pronunciato
che in altri Paesi europei.
Sul livello della
spesa, incide il rapporto insegnanti per 100 studenti che, come evidenziato
dalla tavola 7, è nettamente maggiore in Italia rispetto alla media OCSE, sia
per la scuola primaria (55%) che per la secondaria inferiore (36%) mentre è più
vicino, ma ancora nettamente superiore (18%), per la secondaria superiore[446].
Tavola 7 – Numero di insegnanti per 100 studenti
confronto internazionale - anno 2005
|
Paesi
|
Insegnanti per 100 studenti
|
|
Primaria
|
Secondaria inferiore
|
Secondaria superiore
|
|
Italia
|
9,4
|
9,9
|
9,1
|
|
Francia
|
5,2
|
7,0
|
9,7
|
|
Germania
|
5,3
|
6,5
|
7,1
|
|
Gran
Bretagna
|
4,8
|
5,9
|
8,5
|
|
Grecia
|
9,0
|
12,7
|
11,4
|
|
Spagna
|
7,0
|
8,0
|
12,3
|
|
Svezia
|
8,2
|
8,3
|
7,1
|
|
Finlandia
|
6,3
|
10,0
|
5,6
|
|
Stati
Uniti
|
6,7
|
6,6
|
6,3
|
|
Giappone
|
5,2
|
6,6
|
7,7
|
|
Media
Ocse
|
6,0
|
7,3
|
7,7
|
Fonte: Elaborazioni su dati Ocse,
Education at a Glance (2007).
Il divario
Italia-OCSE relativamente al rapporto insegnanti/studenti è legato, come
illustrato nella tavola che segue, ai seguenti fattori:
§
dimensione
media delle classi, inferiore in Italia, rispetto all’estero;
§
orario
degli studenti, superiore in Italia a quello medio OCSE;
§
orario
di insegnamento dei docenti italiani, inferiore a quello degli insegnanti
esteri.
Tavola 8 –Rapporto insegnanti/studenti: determinanti del divario Italia
- OCSE
anno 2005
|
Indicatori
|
|
Primaria
|
Secondaria inferiore
|
Secondaria superiore
|
|
Insegnanti/studenti
|
Italia
|
9,4
|
9,9
|
9,1
|
|
OCSE
|
6,0
|
7,3
|
7,7
|
|
Impegno
orario studenti
|
Italia
|
973
|
9631
|
9081
|
|
OCSE
|
786
|
898
|
911
|
|
Impegno
orario insegnanti
|
Italia
|
735
|
601
|
601
|
|
OCSE
|
803
|
707
|
664
|
|
Studenti/classe
|
Italia
|
18,3
|
20,9
|
n.d.
|
|
OCSE
|
21,5
|
24,1
|
n.d
|
1Anno 2004
Fonte: Elaborazioni su dati Ocse,
Education at a Glance (2007).
Come rilevato dalla
Commissione tecnica per la finanza pubblica[447], i fattori che influenzano
il divario Italia/Ocse nell’organizzazione del servizio di istruzione non
sempre riflettono la volontà politica del legislatore. Ad esempio, il numero di
studenti per classe é influenzato dalle condizioni territoriali, che portano a
classi sottodimensionate soprattutto (ma non solo) nei piccoli Comuni, oltre
che dalle stesse caratteristiche del patrimonio edilizio scolastico di
proprietà degli enti locali; mentre la scelta di un orario lungo costituisce,
di fatto, la risposta della scuola alla mancanza di altre forme organizzative
per la custodia dei bambini.
Per quanto riguarda
il primo aspetto, la CTFP osserva come la razionalizzazione della rete
scolastica (ad esempio: soppressione dei plessi di piccola dimensione e
accorpamento delle classi in altre scuole, ricorso più ampio a istituti comprensivi
che inglobano, cioè, scuole di più ordini e gradi) possa concretamente essere
attuata solo prevedendo meccanismi attraverso i quali il vantaggio netto in
termini di finanza pubblica che si determina a livello di P.A. venga
ridistribuito tra tutti gli operatori coinvolti.
Quanto alla
lunghezza dell’orario della scuola primaria e secondaria inferiore, secondo la
Commissione si sono scaricati sulla scuola degli oneri impropri, che potrebbero
essere assolti da altre istituzioni pubbliche o per i quali potrebbe essere
ipotizzabile un maggiore apporto da parte delle famiglie. Si tratterebbe non
solo di un problema di distribuzione delle risorse, ma anche di offrire
corretti incentivi a tutti gli enti coinvolti, introducendo forme di
compensazione per i compiti che la scuola assolve al di là delle sue funzioni
fondamentali.
Diverso è il
discorso relativo all’organizzazione del lavoro degli insegnanti, il cui numero
elevato costituisce una delle principali determinanti della spesa per
l’istruzione a fronte, peraltro, di una retribuzione che, dal confronto
internazionale, risulta relativamente più contenuta. Rispetto ai colleghi
esteri, Infatti, gli insegnanti italiani hanno una retribuzione inferiore[448] e
percorrono una carriera retributiva priva di incentivi ed interamente legata
all’anzianità di servizio, il cui apice viene raggiunto più tardi che in altri
Paesi.
Sul numero
complessivo degli insegnanti e sul volume della spesa per la loro retribuzione
incide il meccanismo del reclutamento che determina il considerevole divario
tra organico di diritto ed organico di fatto, quest’ultimo superiore per ogni
ordine di scuola in una percentuale che si attesta attorno al 5 per cento[449].
Si ricorda che gli organici di diritto sono definiti dal
Ministero della pubblica istruzione sulla base del numero di studenti, mentre
gli organici di fatto sono il frutto delle richieste dei capi di istituto e
delle scelte dei dirigenti scolastici regionali, basate su specifiche esigenze quali
assenze degli insegnanti di ruolo, numero di studenti disabili, capienza delle
aule ed altro). Il livello della spesa complessiva si determina quindi sulla
base degli organici di fatto, che non sono comprimibili se si vuole garantire
un servizio obbligatorio. Va inoltre evidenziato che per il personale, le
retribuzioni sono a carico dell’amministrazione centrale, tranne il pagamento
delle supplenze brevi che è a carico dei singoli istituti.
Quindi, pur essendo
il 76% della spesa per l’istruzione costituita dalle retribuzioni del personale
e, quindi, a carico dell’amministrazione centrale, non è in capo a quest’ultima
la determinazione del numero di insegnanti.
Ai fini di un
maggiore controllo dell’evoluzione della spesa per il personale, appare pertanto
opportuno, da un lato, migliorare la capacità di programmazione del centro
nella determinazione degli organici e, dall’altro, individuare dei meccanismi
che portino i decisori locali (i capi istituto) ad una maggiore condivisione
degli obiettivi generali.
Sul punto, la CTFP
rileva come le difficoltà per il Ministero della pubblica istruzione di
determinare gli organici delle singole scuole in modo adeguato dipenda in parte
dalla carenza di informazioni relative alle strutture scolastiche e dai ritardi
con cui le stesse informazioni sono trasmesse. In occasione degli incontri
avuti nell’ambito della Spending Review,
ha potuto verificare come la qualità dell’informazione sia molto migliorata e
che esistono margini per risolvere le questioni relative alla tempistica della
trasmissione dei dati. Ciò dovrebbe consentire in futuro una previsione degli
organici più rispondente alle necessità locali e più efficiente rispetto alle
esigenze di servizio.
Per quanto concerne,
invece, un maggior coinvolgimento dei dirigenti scolastici nell’utilizzo più
efficiente del personale, la Commissione prende in considerazione l’ipotesi di
attivare meccanismi di incentivazione/penalizzazione per i dirigenti medesimi
e, più in generale, per il personale della scuola. Un sistema di premi e
penalizzazioni potrebbe inoltre essere introdotto nella valutazione
dell’attività delle singole scuole, legati ai risultati ottenuti in termini di
miglioramento rispetto alla situazione precedente[450].
Alla luce di tali
valutazioni, la Commissione esprime una valutazione favorevole delle
disposizioni contenute nella finanziaria 2008, che prevede la sperimentazione
di forme di coordinamento tra Ministero, enti locali e scuole al fine di
accrescere l’efficienza e l’efficacia del sistema.
A tale proposito si
ricorda che la legge finanziaria per
il 2008 (art. 2, commi 411-424) ha rimodulato gli obiettivi delle misure di
razionalizzazione già previste dalla finanziaria 2007 finalizzate alla
riduzione complessiva di personale della scuola (aumento del rapporto
alunni/classe, certificazione all’insegnamento della lingua inglese dei docenti
della scuola primaria, riduzione dei quadri orari degli istituti professionali
e riconversione professionale del personale docente in soprannumero) ed ha
introdotto ulteriori misure di risparmio, quali l’attivazione delle prime
classi dei corsi sperimentali dell’istruzione liceale subordinata alla
valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i
vigenti ordinamenti nazionali nonché la determinazione del numero delle classi
prime e delle classi iniziali del ciclo di istruzione secondaria di secondo
grado, in base al numero complessivo degli alunni iscritti. Ha inoltre
introdotto misure finalizzate al contenimento della spesa per gli insegnanti di
sostegno ed ha dato l’avvio alla sperimentazione triennale di un nuovo modello
organizzativo avente l’obiettivo di innalzare la qualità del servizio di
istruzione e di accrescere l’efficienza ed efficacia della spesa.
La spesa in
conto capitale
L’andamento della spesa in conto capitale costituisce uno
dei principali indicatori dell’attività di investimento e di sostegno allo
sviluppo economico svolta dalle Pubbliche amministrazioni.
Nella seguente tavola sono esposti i dati, tratti dal conto
consolidato della P.A., riguardanti l’evoluzione della spesa in conto capitale nel periodo
2003-2007 e le previsioni formulate per l’esercizio 2008. Con riferimento alla
voce relativa agli investimenti fissi lordi, oltre ai dati tratti dal citato
conto consolidato – calcolati, in conformità con i criteri europei, sottraendo
dall’importo degli investimenti gli incassi per dismissioni immobiliari -
sono indicati gli investimenti fissi lordi reintegrati dell’importo dei
suddetti incassi. Per ciò che concerne le “altre spese in conto capitale” nella
tavola sono state precisate le misure una
tantum.
L’ammontare complessivo della spesa in conto capitale è
indicato quindi sia come riportato nel conto consolidato, sia reintergrato
dell’importo delle dismissioni immobiliari e depurato dalle altre misure una tantum.
Spesa
in conto capitale delle amministrazioni pubbliche
(valori espressi in
mln di euro e, in corsivo, valori in percentuale rispetto al PIL)
|
|
|
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Investimenti
fissi lordi detratte le dismissioni immobiliari
|
32.778
|
33.426
|
33.711
|
34.792
|
36.134
|
39.277
|
|
2,45%
|
2,40%
|
2,36%
|
2,35%
|
2,35%
|
2,47%
|
|
Dismissioni
immobiliari
|
2.773
|
4.404
|
3.178
|
1.683
|
1.437
|
1.000
|
|
0,21%
|
0,32%
|
0,22%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,06%
|
|
Investimenti
fissi lordi al lordo delle dismissioni
|
35.551
|
37.830
|
36.889
|
36.475
|
37.571
|
40.277
|
|
2,66%
|
2,72%
|
2,58%
|
2,46%
|
2,45%
|
2,53%
|
|
Contributi
agli investimenti
|
23.397
|
20.071
|
21.988
|
22.292
|
24.769
|
24.632
|
|
1,75%
|
1,44%
|
1,54%
|
1,51%
|
1,61%
|
1,55%
|
|
Altre
uscite in c/capitale
|
1.634
|
1.482
|
2.678
|
16.924
|
7.590
|
2.186
|
|
0,12%
|
0,11%
|
0,19%
|
1,14%
|
0,49%
|
0,14%
|
|
di cui
misure una tantum
|
|
|
|
14.384
|
6.020
|
|
|
|
|
|
|
0,97%
|
0,39%
|
|
|
Totale
uscite in conto capitale incluse le misure una tantum e le dismissioni immobiliari
|
57.809
|
54.979
|
58.377
|
74.008
|
68.493
|
66.095
|
|
4,33%
|
3,95%
|
4,09%
|
5,00%
|
4,46%
|
4,16%
|
|
Totale
uscite conto capitale escluse le misure una
tantum e le dismissioni immobiliari
|
60.582
|
59.383
|
61.555
|
61.307
|
63.910
|
67.095
|
|
4,54%
|
4,27%
|
4,31%
|
4,14%
|
4,16%
|
4,22%
|
Fonte: anni 2003-2007, Istat, Relazione generale sulla
situazione economica del paese 2007; con
riferimento all’esercizio di previsione 2008, sono riportati i dati della RUEF
In termini assoluti, le uscite in conto capitale presentano
un incremento nell’ultimo biennio e in particolar modo nell’esercizio 2006;
tale dato è però fortemente condizionato dalle variazioni delle altre uscite in
conto capitale ed in particolare delle una
tantum: nel 2006 14.384 milioni, di cui 12.950 milioni di euro per la
cancellazione dei crediti dello Stato nei confronti della società TAV, 734 milioni
per la retrocessione dei crediti agricoli e 700 milioni per la restituzione di
tasse pagate dai gestori di servizi di telecomunicazioni; per il 2007 6.020
milioni, di cui 847 milioni per i rimborsi Iva sulle auto aziendali auto, 4.939
milioni derivanti dalla cancellazione
dell’acconto dei concessionari alla riscossione, e 234 milioni per il ripiano dei debiti verso
Poste SpA per le agevolazioni tariffarie all’editoria.
Il dato delle uscite depurato dalle una tantum (e quindi reintegrato anche delle somme detratte per i
ricavati delle dismissioni immobiliari) presenta un andamento con meno
oscillazioni con un minimo nel 2004 ed un massimo nel 2007.
La lettura dell’evoluzione delle uscite in conto capitale in
relazione al PIL è resa più agevole dalla seguente tabella in cui per le
diverse voci si è considerata come base (pari a 100) il dato relativo al 2003:
Spesa
in conto capitale delle amministrazioni pubbliche
(valori in
percentuale rispetto al PIL, con base 2003 pari a 100)
|
|
|
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Investimenti
fissi lordi detratte le dismissioni immobiliari
|
100
|
98
|
96
|
96
|
96
|
101
|
|
Dismissioni
immobiliari
|
100
|
152
|
107
|
55
|
45
|
30
|
|
Investimenti
fissi lordi al lordo delle dismissioni
|
100
|
102
|
97
|
93
|
92
|
95
|
|
Contributi
agli investimenti
|
100
|
82
|
88
|
86
|
92
|
88
|
|
Altre
uscite in c/capitale
|
100
|
87
|
153
|
935
|
404
|
112
|
|
Totale
uscite in conto capitale incluse le misure una tantum
|
100
|
91
|
94
|
116
|
103
|
96
|
|
Totale
uscite conto capitale escluse le misure una tantum
|
100
|
94
|
95
|
91
|
92
|
93
|
Il totale delle uscite presenta un aspetto altalenante,
determinato dalla variabilità delle spese classificate come “altre uscite”. Il
totale depurato dagli effetti delle una
tantum presenta invece, pur con lievi oscillazioni, una tendenza alla
riduzione della spesa. Tale riduzione è meno marcata per la componente legata
agli investimenti, anche se assume maggiore rilevanza se si considera il dato
al lordo delle dismissioni immobiliari, posto che quest’ultime sono in costante
calo. Il dato relativo ai contributi agli investimenti presenta una riduzione
più accentuata con una correzione alla fine del quinquennio.
Nei successivi paragrafi si darà conto in maniera più
dettagliata e con dati disaggregati dell’andamento delle due principali
componenti della spesa in conto capitale nel periodo 2003-2007.
Per ciò che concerne l’andamento della voce residuale della
spesa denominata “altre spese in conto capitale”, si ribadisce che la
sua dinamica, fortemente variabile nel periodo considerato, concorre da un lato
a spiegare le oscillazioni della spesa in conto capitale nel suo complesso,
risentendo però fortemente degli interventi di carattere straordinario sopra
illustrati.
La seguente tabella fornisce un’analisi dettagliata della
composizione degli investimenti della P.A. per livelli di governo, riportando
in primo luogo l’ammontare degli investimenti indicato nella Relazione sulla
situazione economica del paese nel 2007 e i dati delle dismissioni immobiliari
forniti dall’ISTAT. Viene inoltre fornito il dato degli investimenti
reintegrato degli importi sottratti in corrispondenza degli incassi per le
dismissioni immobiliari e, relativamente a ciascun soggetto, la percentuale sul totale degli investimenti
della PA.
Investimenti
delle amministrazioni pubbliche
(valori espressi in
mln di euro)
|
|
|
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Amministrazioni centrali
|
Investimenti
|
5.599
|
7.079
|
6.979
|
8.096
|
|
Dismissioni immobiliari
|
2.248
|
1.171
|
196
|
123
|
|
Investimenti reintegrati
|
7.847
|
8.250
|
7.175
|
8.219
|
|
Percentuale sul totale
|
20,7%
|
22,4%
|
19,7%
|
21,9%
|
|
Stato
|
Investimenti
|
3.531
|
4.679
|
4.262
|
5.398
|
|
Dismissioni immobiliari
|
2.243
|
1.100
|
170
|
123
|
|
Investimenti reintegrati
|
5.774
|
5.779
|
4.432
|
5.521
|
|
Percentuale sul totale
|
15,3%
|
15,7%
|
12,2%
|
14,7%
|
|
Altri
enti amministrazione centrale
|
Investimenti
|
310
|
264
|
304
|
259
|
|
Dismissioni immobiliari
|
5
|
71
|
26
|
-
|
|
Investimenti reintegrati
|
315
|
335
|
330
|
259
|
|
Percentuale sul totale
|
0,8%
|
0,9%
|
0,9%
|
0,7%
|
|
ANAS
|
Investimenti
|
1.758
|
2.136
|
2.413
|
2.439
|
|
Dismissioni immobiliari
|
|
|
|
|
|
Investimenti reintegrati
|
1.758
|
2.136
|
2.413
|
2.439
|
|
Percentuale sul totale
|
4,6%
|
5,8%
|
6,6%
|
6,5%
|
|
Amministrazioni locali
|
Investimenti
|
28.579
|
27.206
|
27.810
|
27.927
|
|
Dismissioni immobiliari
|
888
|
978
|
1.233
|
1.143
|
|
Investimenti reintegrati
|
29.467
|
28.184
|
29.043
|
29.070
|
|
Percentuale sul totale
|
77,9%
|
76,4%
|
79,6%
|
77,4%
|
|
Regioni
|
Investimenti
|
4.814
|
4.749
|
4.992
|
4.533
|
|
Dismissioni immobiliari
|
141
|
66
|
264
|
127
|
|
Investimenti reintegrati
|
4.955
|
4.815
|
5.256
|
4.660
|
|
Percentuale sul totale
|
13,1%
|
13,1%
|
14,4%
|
12,4%
|
|
Province
e comuni
|
Investimenti
|
19.498
|
17.950
|
17.942
|
18.397
|
|
Dismissioni immobiliari
|
661
|
825
|
833
|
917
|
|
Investimenti reintegrati
|
20.159
|
18.775
|
18.775
|
19.314
|
|
Percentuale sul totale
|
53,3%
|
50,9%
|
51,5%
|
51,4%
|
|
Asl e
Aziende ospedaliere
|
Investimenti
|
2.062
|
2.126
|
2.273
|
2.338
|
|
Dismissioni immobiliari
|
62
|
63
|
65
|
65
|
|
Investimenti reintegrati
|
2.124
|
2.189
|
2.338
|
2.403
|
|
Percentuale sul totale
|
5,6%
|
5,9%
|
6,4%
|
6,4%
|
|
Altri
enti amministrazione locale
|
Investimenti
|
2.205
|
2.381
|
2.603
|
2.659
|
|
Dismissioni immobiliari
|
24
|
24
|
71
|
34
|
|
Investimenti reintegrati
|
2.229
|
2.405
|
2.674
|
2.693
|
|
Percentuale sul totale
|
5,9%
|
6,5%
|
7,3%
|
7,2%
|
|
Enti di Previdenza
|
Investimenti
|
- 752
|
- 574
|
3
|
111
|
|
Dismissioni immobiliari
|
1.268
|
1.029
|
254
|
171
|
|
Investimenti reintegrati
|
516
|
455
|
257
|
282
|
|
Percentuale sul totale
|
1,4%
|
1,2%
|
0,7%
|
0,8%
|
|
TOTALE
|
Investimenti
|
33.426
|
33.711
|
34.792
|
36.134
|
|
Dismissioni immobiliari
|
4.404
|
3.178
|
1.683
|
1.437
|
|
Investimenti reintegrati
|
37.830
|
36.889
|
36.475
|
37.571
|
In relazione alla ripartizione della spesa per investimenti
per livelli di governo, la tavola evidenzia che in media, nel periodo
2004-2007, la spesa per investimenti fissi lordi, al lordo degli incassi per
dismissioni immobiliari, è attribuibile per poco più di un quinto al complesso
delle Amministrazioni centrali, mentre per la restante quota essa risulta
attribuibile al complesso delle Amministrazioni locali, essendo trascurabile
l’apporto degli enti previdenziali (complessivamente negativo se si tiene conto
delle dismissioni). Tale composizione non presenta forti variazioni nel
quadriennio considerato. Con riferimento alle amministrazioni centrali si
segnala una riduzione degli investimenti statali nel 2006, in conseguenza di
quanto previsto dalla manovra finanziaria di quell’anno, seguita però da un
discreta ripresa nell’esercizio successivo, determinata in parte da maggiori
investimenti nel settore della Difesa. Il 2006 registra, inoltre, un incremento degli investimenti dell’ANAS,
in seguito al D.L. 223/2006,
che ha incrementato di 1 miliardo di euro il tetto di spesa previsto per
quell’anno ai pagamenti per le spese di investimento dell’azienda.
In relazione alle
Amministrazioni locali si rileva la lieve flessione della spesa in termini
assoluti, che può in parte essere motivata dai vincoli derivanti dalla vigenza
del Patto di stabilità interno.
La spesa per contributi agli investimenti, che costituisce
uno degli aggregati che compongono la spesa in conto capitale della Pubblica
amministrazione, è composta prevalentemente da contributi alle imprese.
Nella tabella che segue sono riportati i dati totali della
spesa per contributi agli investimenti - già presentati in precedenza con
riferimento all’andamento del complesso della spesa in conto capitale - e la
loro disaggregazione tra spese delle amministrazioni centrali, da cui sono
state detratti gli importi destinati agli enti pubblici, e spese delle
Amministrazioni locali.
Contributi
agli investimenti delle Pubbliche amministrazioni
|
|
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
milioni
di euro
|
Amm.
Centrali
|
14.843
|
10.338
|
12.127
|
12.806
|
14.602
|
|
Amm.
Locali
|
8.554
|
9.733
|
9.861
|
9.486
|
10.167
|
|
Totale PA
|
23.397
|
20.071
|
21.988
|
22.292
|
24.769
|
|
%
totale
|
Amm.
Centrali
|
63,4
|
51,5
|
55,2
|
57,4
|
59,0
|
|
Amm.
Locali
|
36,6
|
48,5
|
44,8
|
42,6
|
41,0
|
|
% sul
PIL
|
Amm.
Centrali
|
1,11
|
0,74
|
0,85
|
0,87
|
0,95
|
|
Amm.
Locali
|
0,64
|
0,70
|
0,69
|
0,64
|
0,66
|
|
Totale PA
|
1,75
|
1,44
|
1,54
|
1,51
|
1,61
|
La spesa per contributi agli investimenti negli ultimi
cinque anni vede un forte riduzione nel 2004 e una successiva ripresa che porta
a superare i livelli iniziali solo nel 2007, ultimo anno del periodo esaminato.
Il dato disaggregato mostra che la riduzione di spesa del 2004 è concentrata
esclusivamente nelle Amministrazioni centrali, dalle quali è dipesa anche la
successiva ripresa. A partire dal 2004 la spesa delle amministrazioni locali
appare, infatti, sostanzialmente stabile in termini assoluti anche se in
flessione in percentuale sul PIL, mentre il dato delle Amministrazioni centrali
vede un incremento non solo in termini assoluti ma anche in relazione al
prodotto interno lordo.
Il forte decremento della spesa nell’esercizio 2004, pari a
circa l’8,9% rispetto all’anno precedente, è ascrivibile in parte agli effetti
di provvedimenti adottati nel corso di tale esercizio.
Si ricorda in particolare il DL n. 168/2004, che ha ridotto
le risorse per l’anno 2004 destinate agli incentivi alle imprese previste dalla
legge n. 488/1992 e dalla legge n. 662/1996 (articolo 2, comma 203, lettere e)
e f), limitatamente ai contratti di programma ed ai contratti d’area, e ha
limitato le erogazioni da effettuare nel corso dell’anno per contributi a fondo
perduto a carico del Fondo innovazione tecnologica.
Nell’esercizio 2005 si registra una moderata ripresa della
crescita della spesa per contributi agli investimenti, ripresa che si fa più
consistente nell’ultimo anno del quinquennio. In relazione a tale dato si
ricordano i contributi in conto impianti al gruppo FS recati dai DL. n. 81 e
159 del 2007.
La seguente tabella espone i dati previsionali della spesa
in conto capitale relativa all’anno 2008 tratti dal conto economico consolidato
della Pubblica amministrazione pubblicato dalla RUEF.
Spese
in conto capitale delle Amministrazioni Pubbliche
Previsione
per l’anno 2008 confrontata con il 2007
|
|
|
2008
|
Variaz
in valori. ass.
|
Variaz.
Percent.
|
|
Investimenti
fissi lordi detratte le dismissioni immobiliari
|
Valori assoluti
|
39.277
|
3.143
|
8,0%
|
|
% PIL
|
2,47%
|
0,12%
|
|
|
Dismissioni
immobiliari
|
Valori assoluti
|
1.000
|
-437
|
-43,7%
|
|
% PIL
|
0,06%
|
-0,03%
|
|
|
Investimenti
fissi lordi reintegrati delle dismissioni
|
Valori assoluti
|
40.277
|
2.706
|
6,7%
|
|
% PIL
|
2,53%
|
0,09%
|
|
|
Contributi
agli investimenti
|
Valori assoluti
|
24.632
|
-137
|
-0,6%
|
|
% PIL
|
1,55%
|
-0,06%
|
|
|
Altre
uscite in c/capitale
|
Valori assoluti
|
2.186
|
616
|
28,2%
|
|
% PIL
|
0,14%
|
0,04%
|
|
|
Totale
uscite conto capitale
|
Valori assoluti
|
67.095
|
3.185
|
4,7%
|
|
% PIL
|
4,22%
|
0.06%
|
|
Il confronto con l’anno precedente è stato fatto non considerando
per il 2007 le uscite una tantum,
incluse in quell’esercizio tra le altre spese in conto capitale. Il totale
delle spese in conto capitale, da cui si evidenzia un incremento del 4,7% con
un lieve aumento dell’incidenza sul PIL, è calcolato reintegrando l’importo
delle dismissioni immobiliari, che per l’anno in questione si è desunto dai
dati forniti dalla RPP.
In relazione
all’incremento della spesa si nota l’apporto degli investimenti fissi
lordi, aumentati del 6,7%, e quello delle altre uscite in conto
capitale, mentre i contributi agli investimenti presentano una lieve
diminuzione.
Alla crescita della spesa per investimenti ha concorso lo
slittamento all’anno successivo di ingenti risorse in conto capitale (stanziate
per il 2007 dal DL 159/07, collegato alla manovra finanziaria, non spese
nell’anno di riferimento in conseguenza dell’approvazione del provvedimento al
termine dell’esercizio finanziario.
Si ricorda invece che la manovra 2008 presenta per le spese
in conto capitale un saldo negativo di circa 1.860 milioni di euro, peraltro in
gran parte connesso al taglio dei residui in conto capitale (1.530 milioni).
Bisogna peraltro considerare che gli interventi sulla spesa in conto capitale
previsti dalla manovra finanziaria di quest’anno sono stati effettuati
prevalentemente con il citato DL 159/07 e si sono quindi concentrati
nell’esercizio precedente, salvo il parziale slittamento sopra menzionato.
La spesa per
ricerca e sviluppo
La presente analisi
si è avvalsa dei dati elaborati e rilasciati dall’ISTAT[456], che ha rilevato i dati
relativa alla spesa per la ricerca e lo sviluppo (R&S) di imprese,
istituzioni pubbliche e istituzioni private non
profit che svolgono sistematicamente attività di ricerca intra muros.[457]
Si ricorda che in base al “Manuale di Frascati”, l’attività
di R&S si distingue in tre tipologie: la ricerca di base, che consiste nel
lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove
conoscenze, non finalizzato ad una specifica applicazione; la ricerca applicata,
ossia il lavoro originale intrapreso al fine di acquisire nuove conoscenze e
finalizzato ad una pratica e specifica applicazione; lo sviluppo sperimentale,
che costituisce il lavoro sistematico basato sulle conoscenze esistenti
acquisite attraverso la ricerca e l’esperienza pratica, al fine di sviluppare o
migliorare materiali, prodotti, processi produttivi, sistemi e servizi.
Con riferimento
all’attività di R&S, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche si
distinguono:
-
gli enti
di ricerca propriamente detti, che hanno come fine istituzionale lo svolgimento
di tale attività;
-
le
università;
-
le altre
istituzioni pubbliche, ovvero le amministrazioni dello Stato (laboratori e
istituti dipendenti dai ministeri) e degli altri enti pubblici per i quali la
ricerca non rappresenta l’attività principale.
I dati commentati
nella presente analisi si riferiscono al periodo 2000-2005, come consuntivo, e
agli anni 2006 e 2007, in termini di previsione (tali informazioni non sono
tuttavia disponibili per le università).
In particolare, per
quanto concerne la stima della spesa relativa all’attività di ricerca delle università italiane, la procedura
adottata è stata modificata in relazione ai dati dal 2005 in avanti. Secondo le
nuove modalità di stima, le spese correnti (escluse quelle per il personale)
e le spese in conto capitale per R&S sono stimate sulla base delle
spese di funzionamento e di investimento effettivamente sostenute dai
Dipartimenti ed Istituti universitari e oggetto di una rilevazione annuale
svolta dal Ministero dell’Università e della Ricerca tramite il Comitato
Nazionale per la Valutazione delle Strutture Universitarie (CNVSU). Le spese
per il personale impegnato in R&S sono stimate sulla base dei dati
forniti dal Miur – tramite il Consorzio CINECA[458] – con riferimento alle
somme liquidate al personale docente e non docente di ruolo delle università
italiane. I dati CINECA sono integrati con quelli relativi alle remunerazioni
del personale non docente delle università non statali.
La spesa per la
R&S evidenzia i seguenti aspetti:
-
la spesa
complessiva, pubblica e privata, per R&S è passata dai 12.460 milioni di
euro del 2000 ai 15.599 milioni di euro del 2005; il corrispondente incremento
percentuale annuo è stato superiore all’8% nei primi due anni, per poi
diminuire considerevolmente fino ad attestarsi al 3,3% nel 2004, e al 2,3% nel 2005;
-
l’incidenza
sul PIL, mediamente di poco superiore all’1,1%, ha mostrato un andamento
lievemente crescente fino al 2002 (1,07% nel 2000, 1,11% nel 2001 e 1,16% nel
2002), per poi decrescere fino al 2005, quando è risultata dell’1,14%;
-
l’incremento
in valore assoluto registrato per il complesso della spesa si riflette anche
sulla spesa per R&S sostenuta dalle università, passata dai 3.865 milioni di euro del 2000
(pari al 31% della spesa totale) ai 4.712 milioni di euro del 2005 (30,2% del
totale), con un picco di 5.005 milioni nel 2004. Rispetto al PIL, invece,
l’incidenza della spesa è aumentata fino all’anno 2003 (passando dallo 0,33%
del 2000 all’1,2% del 2003) per poi subire un decremento nel biennio successivo
(0,36% nel 2004 e 0,33% nel 2005);
-
la spesa
erogata dalle altre amministrazioni
pubbliche (enti di ricerca e altre istituzioni ) passa da 2.356 milioni di
euro nel 2000 a 2.701 milioni di euro nel 2005. Il contributo di tali enti,
peraltro, si riduce dal 18,9% del 2000 al 17,3% del 2005, pur rimanendo
sostanzialmente stabile l’incidenza della spesa sostenuta dagli enti medesimi
rispetto al PIL (0,2% circa);
-
nel
periodo considerato, il contributo delle imprese
alla spesa è andato riducendosi tra il 2000 ed il 2003 (passando dal 50,1% al
47,3%) per poi riaumentare nel biennio successivo (47,8% nel 2004 e 50,4% nel
2005). In quota PIL, la spesa delle imprese rimane sostanzialmente stabile,
assestandosi mediamente intorno allo 0,55%;
-
anche la
spesa sostenuta dalle istituzioni
private non profit, i cui dati
sono disponibili solo dall’anno 2002, è andata progressivamente aumentando sia
in valore assoluto (186 milioni di euro nel 2002 e 330 milioni di euro nel
2005), sia in termini di apporto percentuale rispetto alla spesa complessiva.
I dati esposti
vengono sintetizzati nella seguente tabella[459]:
SETTORI ISTITUZ.
|
SPESA
|
VAR. %
|
COMPOS. %
|
% SU PIL
|
|
ANNO 2000
|
|
AMM. PUBBLICHE
|
2.356
|
6,5
|
18,9
|
0,20
|
|
IST. PRIV. NON PROFIT
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.
|
|
|
IMPRESE
|
6.239
|
9,8
|
50,1
|
0,54
|
|
UNIVERSITA’
|
3.865
|
6,6
|
31
|
0,33
|
|
TOTALE
|
12.460
|
8,1
|
100
|
1,07
|
|
ANNO 2001
|
|
AMM. PUBBLICHE
|
2.493
|
5,8
|
18,4
|
0,20
|
|
IST. PRIV. NON PROFIT
|
n.d
|
n.d.
|
n.d.
|
|
|
IMPRESE
|
6.661
|
6,8
|
49,1
|
0,55
|
|
UNIVERSITA’
|
4.418
|
14,3
|
32,6
|
0,36
|
|
TOTALE
|
13.572
|
8,9
|
100
|
1,11
|
|
ANNO 2002
|
|
AMM. PUBBLICHE
|
2.565
|
2,9
|
17,6
|
0,20
|
|
IST. PRIV. NON PROFIT
|
186
|
-
|
1,3
|
0,01
|
|
IMPRESE
|
7.057
|
5,9
|
48,3
|
0,56
|
|
UNIVERSITA’
|
4.792
|
8,5
|
32,8
|
0,38
|
|
TOTALE
|
14.600
|
7,6
|
100
|
1,16
|
|
AMM. PUBBLICHE
|
2.582
|
0,7
|
17,5
|
0,20
|
|
ANNO 2003
|
|
IST.
PRIV. NON PROFIT
|
208
|
11,8
|
1,4
|
0,02
|
|
IMPRESE
|
6.979
|
-1,1
|
47,3
|
0,54
|
|
UNIVERSITA’
|
5.000
|
4,3
|
33,9
|
0,38
|
|
TOTALE
|
14.769
|
1,2
|
100
|
1,14
|
|
ANNO 2004
|
|
AMM.
PUBBLICHE
|
2.722
|
5,4
|
17,9
|
0,19
|
|
IST.
PRIV. NON PROFIT
|
233
|
12,0
|
1,5
|
0,01
|
|
IMPRESE
|
7.293
|
4,5
|
47,8
|
0,52
|
|
UNIVERSITA’
|
5.005
|
0,1
|
32,8
|
0,36
|
|
TOTALE
|
15.252
|
3,3
|
100
|
1,08
|
|
ANNO 2005
|
|
AMM.
PUBBLICHE
|
2.701
|
-0,8
|
17,3
|
0,19
|
|
IST.
PRIV. NON PROFIT
|
330
|
41,6
|
2,1
|
0,02
|
|
IMPRESE
|
7.856
|
7,7
|
50,4
|
0,55
|
|
UNIVERSITA’
|
4.712
|
-5,8
|
30,2
|
0,33
|
|
TOTALE
|
15.599
|
2,3
|
100
|
1,09
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda
il biennio 2006-2007, i dati Istat riportano solo i valori di previsione. Non
sono inoltre disponibili i dati relativi alle università.
Previsioni di spesa
per R&S per gli anni 2006-2007[460]
(milioni di euro)
|
SETTORI ISTITUZIONALI
|
SPESA
|
VARIAZIONE % ANNUA
|
COMPOSIZIONE %
|
% SU PIL
|
|
ANNO 2006
|
|
AMM.
PUBBLICHE
|
2.835
|
5,0
|
--
|
0,19
|
|
IST.
PRIV. NON PROFIT
|
331
|
0,3
|
--
|
0,02
|
|
IMPRESE
|
7.975
|
1,5
|
--
|
0,54
|
|
UNIVERSITA’
|
n.d.
|
n.d.
|
--
|
--
|
|
TOTALE
|
11.141
|
2,3
|
--
|
0,75
|
|
ANNO 2007
|
|
AMM.
PUBBLICHE
|
2.814
|
-0,7
|
--
|
0,18
|
|
IST.
PRIV. NON PROFIT
|
357
|
7,9
|
--
|
0,02
|
|
IMPRESE
|
8.381
|
5,1
|
--
|
0,55
|
|
UNIVERSITA’
|
n.d.
|
n.d
|
--
|
--
|
|
TOTALE
|
11.552
|
3,7
|
--
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le previsioni
suesposte evidenziano un’aspettativa di segno negativo per ciò che concerne la
spesa per R&S da parte della
amministrazioni pubbliche a vantaggio della spesa a carico delle imprese. Nel
complesso, si registra una crescita molto contenuta per la spesa complessiva
(2,3% nel 2006 e 3,7% nel 2007), a fronte di una variazione media degli anni precedenti
pari, per tale aggregato, al 5,23 per cento.
Ai fini di un
confronto delle performances dei
diversi paesi nel campo della ricerca scientifica, i dati Ocse-Eurostat[461]
riportati nella tabella che segue evidenziano come la spesa italiana sia
rimasta, nel periodo considerato, al di sotto sia della media dei Paesi
dell’Unione europea che dell’area Ocse.
|
La spesa per R&S: confronto internazionale
(%PIL)
|
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Italia
|
1,05
|
1,09
|
1,13
|
1,11
|
1,1
|
1,09
|
n.d
|
|
EU15
|
1,86
|
1,89
|
1,9
|
1,9
|
1,89
|
1,9
|
1,91
|
|
Totale Paesi
Ocse
|
2,23
|
2,27
|
2,24
|
2,25
|
2,26
|
n.d.
|
n.d.
|
Si rammenta che il
rapporto spesa per R&S/PIL fissato dal Programma di Lisbona e precisato dal Consiglio Europeo di
Barcellona del 2002 prevede che gli investimenti in R&S aumentino fino al
3% del PIL entro il 2010.
Tale Programma
prevede altresì che nell’ambito di tale spesa il contributo delle imprese alla
spesa nazionale per ricerca debba raggiungere la soglia dei due terzi. Nel Programma
nazionale per la ricerca 2005/2007 - premesso che la spesa in ricerca delle
imprese italiane potrebbe essere significativamente sottostimata a seguito
delle difficoltà connesse alla rilevazione di tale dato – si afferma che la
differenza tra l’Italia e la media dei Paesi UE quanto alle risorse per la
R&S “è da addebitarsi in buona parte alle ridotte spese in ricerca da parte
del settore privato”, correlata alla struttura del sistema produttivo italiano
“composto di piccole e medie imprese con bassa propensione a sostenere elevate
spese di ricerca e operanti, per una parte assai consistente, in settori a
bassa intensità tecnologica”.
L’Ocse sottolinea
inoltre il rapido aumento dell’internazionalizzazione della ricerca: nella zona
Ocse, la R&S eseguita all’estero e da filiali estere rappresenta in media
oltre il 16% della spesa totale della R&S industriale. Tale tendenza
conferma la sempre maggiore dispersione delle attività di R&S a misura che
i finanziamenti delle imprese private aumentano rispetto ai sussidi pubblici.
La spesa
ambientale
Nell’ambito delle analisi delle politiche pubbliche, l’esame
della spesa per la protezione dell’ambiente ha un interesse strategico in
quanto consente di identificare lo sforzo finanziario per tale finalità in relazione
a quello sostenuto per le altre politiche.
Diverso è, dal punto di vista dello sforzo finanziario, il
contributo dei diversi settori istituzionali dell’economia –Pubblica
amministrazione (PA), Imprese e Famiglie.
Sulla base dei dati raccolti da Eurostat con riferimento
agli anni 1990-1999 la PA è il settore che
realizza la maggior parte degli interventi diretti di protezione dell’ambiente
anche grazie il prelievo fiscale, canoni e tariffe, mentre per quanto riguarda
la spesa per il finanziamento degli altri operatori per l’abbattimento
dell’inquinamento generato da loro stessi o da altri, il contributo più
consistente è quello delle imprese.
L’informazione sul ruolo e il peso relativo della spesa
pubblica rispetto a quella degli altri soggetti dell’economia consente di
valutare il grado di efficacia delle politiche ambientali in atto rispetto all’attuazione
di altri modelli di riferimento come, ad esempio, quelli fondati sul principio
“chi inquina paga”: questi comporterebbero, infatti, un aumento della
componente privata della spesa o un incremento nel gettito delle c.d. tasse
ambientali. La crescita della quota di spesa sostenuta dalla pubblica
amministrazione può essere interpretato, quindi, nel senso che l’intervento
pubblico in campo ambientale tende a sostituirsi a quello dei responsabili
dell’inquinamento, piuttosto che a porsi in posizione complementare rispetto ad
essi e che, quindi, il richiamato principio non trova sufficiente applicazione.
Il regolamento comunitario del nuovo Sistema europeo di
conti economici nazionali –Sec95 – ha introdotto l’obbligo della produzione di
dati sulla spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione, secondo la
classificazione internazionale COFOG (Classification
Of Functions Of Government), che include, tra le altre, la funzione di Protezione
dell’ambiente.
A livello nazionale poi, da alcuni anni, tale
classificazione è stata recepita, nell’ambito del Rendiconto generale
dell’amministrazione dello Stato, ai fini della classificazione dei capitoli di
spesa per funzione-obiettivo. Dal 2007, a seguito della riforma della struttura
del Bilancio dello Stato (operata peraltro a legislazione vigente), la
classificazione funzionale, basata sui primi tre livelli di classificazione
COFOG,
ha consentito un confronto tra
macroaggregati e una rappresentazione sintetica della spesa pubblica.
Informazioni più analitiche vengono prodotte nell’ambito del
Conto satellite della spesa per la protezione dell’ambiente (Epea – Environmental Protection Expenditure Account,
parte del più ampio sistema Seriee), secondo una metodologia coerente con i
conti economici nazionali e tale da rendere confrontabili gli aggregati
appartenenti ai due sistemi. L’Unione europea e l’Ocse raccolgono
congiuntamente presso gli Stati membri dati sulla spesa ambientale dei diversi
soggetti dell’economia, secondo un sistema armonizzato – coerente con il conto
satellite Epea – che prevede uno specifico focus
sulla spesa del settore pubblico. I dati vengono utilizzati per molteplici
finalità di reporting, come ad
esempio l’elaborazione del Rapporto sulle performances
ambientali, che l’Ocse effettua per i vari Paesi membri.
I dati sulla spesa ambientale della pubblica amministrazione
vengono tradizionalmente portati all’attenzione del Parlamento nell’ambito
della Relazione sullo stato dell’ambiente, periodicamente predisposta dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Negli ultimi anni la diffusione di questo tipo di
informazione si è manifestata in Italia in maniera sempre più diversificata.
Si segnalano, ad
esempio, il Rapporto sulle riforme economiche, redatto dal Ministero
dell’economia e delle finanze,
e il Rapporto annuale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo sugli
interventi nelle aree sottoutilizzate, del Ministero dell’economia e delle
finanze. Si segnalano inoltre le sempre più numerose relazioni sullo stato
dell’ambiente predisposte dalle amministrazioni regionali.
Una serie di proposte di legge quadro in materia di
contabilità ambientale dello Stato,
presentate a partire dalla fine degli anni Novanta, ha portato l’argomento
all’attenzione degli organi costituzionali e delle amministrazioni locali
(soprattutto province e comuni), ai fini della predisposizione, per i vari
livelli di governo, di strumenti di supporto conoscitivo per la definizione di
politiche ambientali, analoghi a quelli normalmente utilizzati a supporto delle
politiche economiche.
L’analisi degli andamenti della spesa per l’ambiente che viene
qui presentata si basa sui dati forniti dall’Istat nell’ambito della
classificazione funzionale della spesa delle amministrazioni pubbliche che
viene presentata annualmente.
Secondo le definizione adottate dall’Istituto di Statistica,
rientrano nel campo della “protezione dell’ambiente” tutte le attività e le
azioni il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione
dell’inquinamento, così come di ogni altra forma di degrado ambientale.
La definizione si limita a considerare gli interventi
finalizzati a salvaguardare l’ambiente sotto il profilo qualitativo (in
relazione, cioè, a fenomeni di inquinamento e degrado).
Sono esclusi gli interventi finalizzati a salvaguardare
l’ambiente sotto il profilo quantitativo (in relazione, cioè, a fenomeni di
depauperamento dello stock delle risorse naturali). Questi interventi e misure
(e le connesse transazioni) rientrano nel campo cosiddetto“dell’uso e della
gestione delle risorse naturali”, cui è dedicato un apposito conto satellite
del SERIEE
distinto rispetto all’EPEA.
Tali dati sono coerenti con il conto economico consolidato
delle PA: i flussi, calcolati al netto delle transazioni effettuate tra i
diversi sottosettori delle PA, registrano le sole transazioni che intercorrono
con soggetti esterni.
Nel periodo considerato (anni 2000-2006), sebbene in
crescita, la spesa per la protezione dell’ambiente delle PA ha costituito in
Italia una quota relativamente piccola della spesa pubblica totale. In termini
di rapporto con il PIL, l’incidenza è appena dello 0,5%.
Spesa per la protezione dell’ambiente delle amministrazioni pubbliche
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Milioni
di euro
|
4.854
|
5.694
|
6.362
|
6.721
|
7.180
|
7.533
|
7.630
|
|
%
spesa complessiva
|
0,9
|
0,9
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1,0
|
|
% PIL
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Quanto alla spesa sostenuta, rispettivamente dalle
Amministrazioni centrali e dalle Amministrazioni locali, si riportano nella
tabella seguente i dati, relativi alla funzione “Protezione dell’ambiente” per
il periodo 2000-2006:
Spesa per la protezione dell’ambiente per livelli di Governo
(milioni di euro)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Amministrazioni centrali
|
689
|
947
|
932
|
1.024
|
983
|
1.229
|
1.171
|
|
Amministrazioni locali
|
4.165
|
4.747
|
5.430
|
5.697
|
6.197
|
3.304
|
6.459
|
Nella tabella che segue si riportano in dati relativi alla
spesa per la protezione dell’ambiente dei principali paesi europei. La
percentuale di spesa per la protezione dell’ambiente dell’Italia si colloca
all’1,7 per cento, al di sopra dei valori dei principali paesi europei.
Incidenza della spesa per protezione ambientale
confronto internazionale – anno 2005
(% sul totale della spesa pubblica)
|
Austria
|
0.8
|
Italia
|
1.7
|
|
Belgio
|
1.6
|
Lussemburgo
|
2.9
|
|
Finlandia
|
0.7
|
Paesi bassi
|
1.9
|
|
Francia
|
1.3
|
Portogallo
|
1.6
|
|
Germania
|
1.4
|
Slovenia
|
0.8
|
|
Grecia
|
1.2
|
Spagna
|
1.8
|
|
Media UE-12
|
|
1,5
|
La spesa pubblica nel settore dello
smaltimento dei rifiuti secondo il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali
(CPT).
Di seguito vengono forniti i dati, contenuti nella “Banca dati dei conti territoriali” (
Ministero dello sviluppo economico –DPS) che raccoglie, per tutti gli enti
appartenenti al settore pubblico allargato, i flussi di spesa e di entrata a
livello regionale, sulla base dei dati di cassa dei bilanci consuntivi degli
enti considerati.
Quanto alla definizione del settore “Smaltimento dei rifiuti”, sempre secondo la nozione adottata dal
progetto Conti Pubblici Territoriali, esso comprende le spese per discariche,
inceneritori e altri sistemi di raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei
rifiuti liquidi e solidi, inclusi quelli nucleari; la vigilanza sull’attività
di smaltimento dei rifiuti; il sostegno alle imprese incaricate della
costruzione, manutenzione e gestione di tali sistemi.
Spesa totale del SPA per lo
smaltimento dei rifiuti
(milioni di euro a prezzi costanti 2000)
|
|
Spesa corrente
|
Spesa in c/capitale
|
Spesa Totale
|
|
|
Centro
Nord
|
Mezzogiorno
|
Italia
|
Centro
Nord
|
Mezzogiorno
|
Italia
|
Centro
Nord
|
Mezzogiorno
|
Italia
|
|
2000
|
5.277
|
2.140
|
7.417
|
616
|
143
|
759
|
5.731
|
2.246
|
8.271
|
|
2001
|
5.484
|
2.326
|
7.810
|
501
|
112
|
614
|
5.912
|
2.449
|
8.564
|
|
2002
|
5.591
|
2.477
|
8.068
|
566
|
159
|
725
|
6.038
|
2.592
|
9.028
|
|
2003
|
5.713
|
2.589
|
8.302
|
514
|
95
|
609
|
6.273
|
2.712
|
9.279
|
|
2004
|
5.775
|
2.609
|
8.384
|
663
|
109
|
771
|
6.478
|
2.760
|
9.458
|
|
2005
|
5.948
|
2.548
|
8.497
|
589
|
156
|
745
|
6.580
|
2.671
|
9.552
|
|
2006
|
6.123
|
2.598
|
8.721
|
569
|
190
|
759
|
6.915
|
2.767
|
9.752
|
Dalla tavola risulta che la spesa del settore pubblico allargato per
la gestione dei rifiuti supera i 9 miliardi di euro annui, di cui circa 8
miliardi destinati alla spesa corrente. La spesa in conto capitale si aggira
intorno ad una media di circa 710 milioni di euro l’anno ed è concentrata
essenzialmente al Centro-Nord. Tale divario deve essere attribuito, oltre che
alla differenza di popolazione, al valore investito per tonnellata di rifiuto
prodotto al Centro-Nord, circa 28 euro, contro 14 euro nel Mezzogiorno.
Si riportano inoltre i dati relativi alla spesa totale
(corrente e capitale) del Settore pubblico allargato (SPA) nel settore
“Smaltimento dei rifiuti” con una disaggregazione per singola regione, dalla
quali risulta che le regioni contraddistinte da valori elevati sono la
Lombardia, l’Emilia Romagna, la Campania ed il Lazio:
Spesa per lo smaltimento dei rifiuti
per regione
(milioni di euro a prezzi correnti)
|
Regione
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Piemonte
|
639,51
|
676,57
|
743,30
|
726,36
|
852,95
|
949,49
|
968,62
|
|
Valle
d'aosta
|
12,52
|
4,77
|
4,68
|
4,60
|
4,34
|
9,25
|
9,25
|
|
Lombardia
|
1.328,47
|
1.414,81
|
1.398,14
|
1.425,33
|
1.395,67
|
1.419,91
|
1.490,25
|
|
Veneto
|
411,89
|
655,56
|
666,19
|
742,05
|
731,25
|
709,59
|
747,79
|
|
Friuli
V.Giulia
|
188,09
|
236,27
|
204,00
|
211,48
|
204,32
|
246,37
|
306,19
|
|
Liguria
|
323,45
|
327,94
|
400,03
|
346,21
|
408,35
|
420,43
|
374,61
|
|
Em.Romagna
|
811,02
|
841,22
|
1.022,84
|
1.191,75
|
1.465,31
|
1.536,99
|
1.666,67
|
|
Toscana
|
703,80
|
761,49
|
858,20
|
938,22
|
974,20
|
908,82
|
908,64
|
|
Umbria
|
144,88
|
147,38
|
142,20
|
168,55
|
159,41
|
168,50
|
174,78
|
|
Marche
|
156,38
|
184,37
|
197,29
|
217,24
|
224,70
|
269,60
|
294,84
|
|
Lazio
|
1.032,24
|
927,39
|
1.038,20
|
1.071,39
|
943,50
|
1.019,13
|
1.028,25
|
|
Abruzzo
|
104,42
|
121,20
|
134,11
|
134,60
|
150,26
|
183,61
|
189,87
|
|
Molise
|
18,10
|
15,80
|
20,09
|
22,16
|
24,20
|
30,73
|
31,00
|
|
Campania
|
916,42
|
1.051,10
|
1.105,46
|
1.320,01
|
1.295,06
|
1.310,32
|
1.325,82
|
|
Puglia
|
447,39
|
470,43
|
521,44
|
524,88
|
551,14
|
577,51
|
612,04
|
|
Basilicata
|
46,87
|
52,81
|
62,44
|
56,74
|
56,97
|
69,44
|
68,63
|
|
Calabria
|
118,87
|
144,34
|
140,65
|
161,66
|
179,21
|
188,12
|
200,81
|
|
Sicilia
|
513,65
|
529,94
|
669,27
|
598,58
|
666,91
|
652,30
|
702,47
|
|
Sardegna
|
125,30
|
132,25
|
155,99
|
160,91
|
166,17
|
199,33
|
208,32
|
|
Prov.
Trento
|
74,47
|
52,03
|
49,11
|
73,71
|
151,89
|
66,96
|
71,39
|
|
Prov.
Bolzano
|
153,23
|
70,67
|
73,52
|
81,99
|
72,16
|
91,61
|
76,56
|
Dal punto di vista dei soggetti erogatori, si osserva che le
amministrazioni locali e le imprese pubbliche locali (in cui rientrano consorzi
ed altre forme associative di enti locali, aziende e istituzioni locali e
società partecipate) sono i principali erogatori di spesa. Dai dati presenti
nel Sistema dei Conti pubblici territoriali risulta, inoltre, che nel
Mezzogiorno, essendo molto inferiore il numero di imprese locali presenti sul
territorio, la percentuale di spesa erogata dalle amministrazioni locali
risulta pari al 41,4 per cento contro il 15,8 per cento del centro-nord, dove
la spesa delle IPL supera l’80 per cento del totale erogato.
Spesa per lo smaltimento dei rifiuti per ente erogatore
(milioni
di euro a prezzi correnti)
|
Smaltimento dei rifiuti
|
Spesa totale
|
di cui
|
|
|
|
Amm.
centrali
|
Amm.
regionali
|
Enti
locali
|
imprese pubbliche locali
|
|
2000
|
8.270,97
|
39,04
|
7,77
|
5.160,74
|
3.063,41
|
|
2001
|
8.818,33
|
17,36
|
10,80
|
5.176,56
|
3.613,62
|
|
2002
|
9.607,15
|
22,97
|
8,25
|
5.392,37
|
4.183,56
|
|
2003
|
10.178,43
|
10,19
|
10,21
|
5.528,04
|
4.629,99
|
|
2004
|
10.677,99
|
14,07
|
90,68
|
5.321,36
|
5.251,88
|
|
2005
|
11.028,00
|
19,48
|
25,25
|
5.422,65
|
5.560,62
|
|
2006
|
11.456,77
|
18,32
|
17,13
|
5.336,28
|
6.085,05
|
Per fiscalità
ambientale si intendono quegli strumenti fiscali che incentivano l'uso di
risorse abbondanti e favoriscono il risparmio di risorse limitate. In base agli
obiettivi, gli strumenti di fiscalità ambientale possono essere distinti in:
tasse e tariffe sulle emissioni; tasse sui prodotti; tasse e tariffe d'uso sui
servizi ambientali.
In particolare in base alle linee guida adottate dalla
statistica ufficiale a livello internazionale
una imposta si qualifica ambientale se la sua base impositiva è costituita da
una grandezza fisica che ha un impatto negativo specifico e provato
sull’ambiente.
Le imposte ambientali costituiscono prelievi obbligatori non
commisurati a benefici che il singolo riceve dall’azione della pubblica
amministrazione.
I pagamenti forniti come contropartita di un servizio
rientrano nella categoria delle tariffe (come la Tariffa sui Rifiuti Solidi
Urbani e l’Imposta sui Rifiuti solidi urbani), i cui proventi non rientrano
pertanto nei dati sul gettito che verrà qui di seguito analizzato.
In Italia
costituiscono imposte ambientali gli strumenti elencati nella tabella seguente:
|
BASE
|
IMPOSTA
|
|
|
|
|
Emissioni atmosferiche
|
Tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di zolfo
|
|
Fonti non puntuali di inquinamento
dell’acqua
|
Contributo alla vendita di
prodotti fitosanitari
|
|
Gestione dei rifiuti
|
·
Tributo
speciale per il deposito in discarica
·
Tributo
provinciali per la tutela ambientale
|
|
Rumore
|
Imposta regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili
|
|
Prodotti energetici
|
·
Imposta
oli minerali
·
Imposta
gas incondensabili
·
Sovrimposta
di confine sul GPL
·
Imposta
gas metano
·
Imposta
addizionale energia elettrica di comuni e province
·
Imposta
energia elettrica
·
Imposta
sui consumi di carbone
|
|
Trasporti
|
·
Imposte
automobilistiche pagate dalle famiglie
·
Imposte
automobilistiche pagate dalle imprese
·
Imposta
relativa al PRA
·
Imposta
sulle assicurazioni relative alla RC auto
|
Ai fini del sistema
europeo dei conti satellite dell’ambiente SERIEE ed in particolare del conto
della spesa per la protezione dell’ambiente EPEA (Environmental Protection Expenditure Account) vengono distinte due
tipologie di imposte in base alla destinazione del relativo gettito:
-
imposte
specifiche, o di scopo, il cui gettito è destinato a finanziare spese per la
protezione ambientale;
-
altre
imposte ambientali,il cui gettito
non è utilizzato per finanziare le spese per la protezione ambientale.
Nel 2006 il gettito
complessivo
delle imposte ambientali in Italia è stato di circa 41 miliardi di euro, pari a
quasi il 3% del PIL
Rispetto al 2005 si
osserva un aumento del 2% circa - in linea con la variazione osservata per
l’anno precedente, determinando una riduzione della quota sul PIL (2% circa).
Si segnala in particolare che l’andamento complessivo delle
imposte ambientali è influenzato in massima parte dalla dinamica delle imposte
sull’energia - imposte su oli minerali e derivati, gas incondensabili, Gas
PropanoLiquido (GPL), gas metano, energia elettrica e consumi di carbone – il
cui gettito, pari nel 2006 a circa 32 miliardi di euro, rappresenta il 78% del
totale delle imposte ambientali e il 2% circa del PIL .
L’altra componente significativa è rappresentata dalle
imposte sui trasporti –imposte automobilistiche pagate dalle famiglie e dalle
imprese, l’imposta relativa al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e
l’imposta sulle assicurazioni relative alla RC auto; con un ammontare pari a
circa 8,5 miliardi di euro, questa categoria ha coperto nel 2006 circa il 21%
del gettito totale delle imposte ambientali, pari allo 0,6% circa del PIL.
Le imposte sull’inquinamento costituiscono infine la
componente residuale del gettito, pari a meno di 500 milioni di euro, ed
includono il tributo speciale per il deposito in discarica, la tassa sulle
emissioni di anidride solforosa (NO2) e di ossidi di zolfo (SOX), il tributo
provinciale per la tutela ambientale, il contributo sulla vendita di prodotti
fitosanitari e l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
Gettito delle imposte ambientali per settore CEPA
(milioni di euro)
|
SETTORE AMBIENTALE
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Protezione dell'aria e del clima
|
37.396
|
37.445
|
37.027
|
39.693
|
38.917
|
39.690
|
40.422
|
|
Gestione rifiuti
|
467
|
440
|
418
|
407
|
413
|
434
|
447
|
|
Protezione e risanamento suolo, acque del
sottosuolo e acque di superficie
|
|
1
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
|
Abbattimento rumore e vibrazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
|
37.863
|
37.886
|
37.447
|
40.103
|
39.332
|
40.126
|
40.871
|
La ripartizione del gettito delle imposte
ambientali per settore ambientale secondo la classificazione internazionale
adottata per il conto satellite EPEA4 ( vedi supra), non è variata in modo significativo nell’ultimo anno . Nel
2006, infatti, la quasi totalità del gettito delle imposte ambientali è
relativa al settore “protezione dell’aria e del clima”, mentre soltanto una
componente marginale riguarda i settori della “gestione dei rifiuti”, della
“protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque
di superficie” e dell’“abbattimento del rumore e delle vibrazioni”.
Si segnala in particolare che essendo la base
impositiva (e non la destinazione del gettito) il riferimento cruciale
considerato nella definizione di imposta ambientale, nel 2006 la quota delle
imposte ambientali esplicitamente finalizzata al finanziamento di interventi di
protezione ambientale è pari a poco più dell’1% del gettito totale.
Dal punto di vista
delle tendenze di lungo periodo, le variazioni negli ultimi due anni sono in
linea con la dinamica finora osservata: tra il 1990 e il 2006, a fronte
dell’incremento del gettito delle imposte ambientali (pari a 22,4 milioni di euro nel 1990 ed a 40,9
milioni di euro dell’anno 2006), si rileva
una diminuzione dell’incidenza delle imposte ambientali sul PIL, che
passa dal 3,7 % del 1990 al 2,7 % dell’anno 2006.
Dal punto di vista
del confronto con gli altri paesi europei,
nel 2004, ultimo anno disponibile, il gettito totale delle imposte ambientali
ammontava nell’insieme dei paesi della Ue15, a più di 260 miliardi di euro,
pari a circa il 2,7 % del PIL comunitario. Il dato relativo all’Italia è
lievemente sopra la media UE, sia per l’aggregato complessivo che per le
singole componenti.
Le imposte sull’energia, il cui gettito nel 2004 ha
rappresentato il 79% del totale, costituiscono la componente più rilevante,
seguita dalle imposte sui trasporti, il cui peso è pari al 20% circa del
gettito complessivo; le imposte sull’inquinamento e sulle risorse rappresentano
invece complessivamente solo il 1% circa del totale; per quanto riguarda l’Unione europea si può osservare la medesima composizione percentuale del
gettito pari al 74 % per le imposte sull’energia, al 22% per i trasporti ed al
4 % per le imposte sull’inquinamento e risorse.
Gettito delle imposte ambientali nella UE anni 2000-2004
(% PIL)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
ENERGIA
|
|
UE
15
|
2,09
|
2,04
|
2,03
|
2,04
|
1,99
|
|
UE
25
|
2,09
|
2,04
|
2,03
|
2,05
|
1,99
|
|
Italia
|
2,57
|
2,42
|
2,28
|
2,37
|
2,22
|
|
TRASPORTO
|
|
UE
15
|
0,60
|
0,59
|
0,58
|
0,58
|
0,59
|
|
UE
25
|
0,58
|
0,58
|
0,57
|
0,57
|
0,58
|
|
Italia
|
0,56
|
0,57
|
0,57
|
0,59
|
0,57
|
|
INQUINAMENTO
E RISORSE
|
|
UE
15
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
|
UE
25
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
|
Italia
|
0,04
|
0,04
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
TOTALE
IMPOSTE AMBIENTALI
|
|
UE
15
|
2,78
|
2,72
|
2,70
|
2,72
|
2,67
|
|
UE
25
|
2,77
|
2,71
|
2,69
|
2,71
|
2,67
|
|
Italia
|
3,17
|
3,03
|
2,89
|
3,00
|
2,83
|
Gettito delle imposte ambientali in
Italia per categoria - Anni 2000-2006
(% PIL)
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Energia
|
2,57
|
2,43
|
2,29
|
2,38
|
2,22
|
2,20
|
2,16
|
|
Trasporti
|
0,56
|
0,57
|
0,57
|
0,59
|
0,57
|
0,58
|
0,58
|
|
Inquinamento
e risorse
|
0,04
|
0,04
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
TOTALE
|
3,17
|
3,04
|
2,89
|
3,00
|
2,82
|
2,81
|
2,77
|
Sul totale del
gettito delle imposte ambientali nella Ue, le imposte italiane rappresentano
una quota pari al 15% circa (16% circa se si considera la componente delle
imposte sull’energia e al 14% per quanto riguarda le imposte sui trasporti).
La quota delle imposte ambientali sul totale delle entrate
della Pubblica Amministrazione e sul PIL risulta superiore in Italia rispetto
alla media europea anche se lo scarto si è ridotto nel tempo a causa della
diminuzione del peso delle imposte sull’energia, non compensata dal lieve
incremento del peso delle imposte sui trasporti e sull’inquinamento.
La finanza
locale
Il presente paragrafo intende fornire una sintetica
rappresentazione del contributo delle Amministrazioni locali ai risultati
conseguiti dal complesso della PA in termini di indebitamento netto nella XV
legislatura. Per un’analisi di maggior dettaglio, riguardante il contributo
fornito dai diversi sottosettori che compongono il comparto delle
Amministrazioni pubbliche, si rinvia ad una successiva fase, non risultando
infatti disponibili al momento i dati relativi al 2007.
Nella tabella che segue e nel relativo grafico, al fine di
inquadrare i risultati in un contesto più ampio, viene considerato un arco
temporale che parte dal 2000, nel quale risulta più agevole cogliere le
tendenze in corso e i mutamenti riscontrati.
Indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche
|
Dati
in mln di euro
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Amministrazioni pubbliche
|
-9.962
|
-38.501
|
-37.085
|
-46.614
|
-48.312
|
-60.428
|
-49.634
|
-29.179
|
|
Amministrazioni centrali
|
-13.619
|
-38.612
|
-38.690
|
-39.529
|
-40.956
|
-54.535
|
-40.243
|
-38.208
|
|
Amministrazioni locali
|
-1.670
|
-3.493
|
-10.437
|
-5.988
|
-13.638
|
-12.183
|
-16.705
|
-948
|
|
Enti di Previdenza
|
5.327
|
3.604
|
12.042
|
-1.097
|
6.282
|
6.290
|
7.314
|
9.977
|
|
PIL
|
1.191.057
|
1.248.648
|
1.295.226
|
1.335.354
|
1.391.530
|
1.428.375
|
1.479.981
|
1.535.540
|
|
Dati
in percentuale del PIL
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Amministrazioni pubbliche
|
-0,84
|
-3,08
|
-2,86
|
-3,49
|
-3,47
|
-4,23
|
-3,35
|
-1,90
|
|
Amministrazioni centrali
|
-1,14
|
-3,09
|
-2,99
|
-2,96
|
-2,94
|
-3,82
|
-2,72
|
-2,49
|
|
Amministrazioni locali
|
-0,14
|
-0,28
|
-0,81
|
-0,45
|
-0,98
|
-0,85
|
-1,13
|
-0,06
|
|
Enti di Previdenza
|
0,45
|
0,29
|
0,93
|
-0,08
|
0,45
|
0,44
|
0,49
|
0,65
|
Fonte:
Istat 2000-2003, Relazione generale sulla situazione economica del paese
2004-2007
Esaminando il periodo 2000-2005, durante il quale il
complesso della PA mostra risultati di finanza pubblica in progressivo
peggioramento, si nota che il comparto delle Amministrazioni locali mostra a
sua volta un deficit crescente. Fa eccezione l’esercizio 2003, sul quale
incidono misure specifiche con effetti limitati al comparto delle regioni, e
l’esercizio 2005, che mostra un andamento stazionario nel deficit delle
Amministrazioni locali. Il contributo di queste ultime al peggioramento
riscontrato nel complesso del periodo 2000-2005 ammonta a circa un quinto del
deterioramento del saldo riscontrato a livello complessivo.
Nel periodo considerato si rileva un generale rispetto, dei
vincoli previsti dal Patto di stabilità interno, formulati come limiti
all’incremento della spesa per tutti i comparti degli enti territoriali. Tale
strumento si rivela di fatto, nel periodo in questione, inefficace rispetto
alla finalità di contrastare la tendenza al peggioramento dei saldi delle
Amministrazioni locali, dovuta in larga misura a voci escluse dal Patto (come
la spesa sanitaria o quella del personale, soggette a specifiche forme di
regolamentazione, o la spesa gestita mediante forme di esternalizzazione).
Con riferimento all’esercizio 2006 si nota che, mentre la PA
nel suo complesso ottiene un risultato migliore rispetto all’esercizio
precedente, le Amministrazioni locali registrano un peggioramento che vanifica
parte del miglioramento ottenuto dalle Amministrazioni centrali.
Fra le determinanti di tale risultato negativo possono
ricordarsi l’elevata dinamica in questo esercizio della spesa corrente, in
particolare la spesa per redditi da lavoro dipendente
(gravata dagli arretrati conseguenti al rinnovo del contratto per il biennio
2004-2005) la spesa sanitaria e la spesa per interessi. La spesa in conto
capitale resta, invece, pressoché costante in valore assoluto, riducendosi di
un decimo di punto in termini di incidenza percentuale sul PIL, proseguendo una
tendenza già riscontrata negli esercizi precedenti. L’elevata dinamica della
spesa corrente risulta insufficientemente compensata da quella delle entrate,
sulle quali grava la riduzione dei trasferimenti erariali, ridottisi in termini
nominali del 3,5%,
non sufficientemente compensati da aumenti delle entrate tributarie, soggette
ai vincoli all’utilizzo dei margini di manovra delle aliquote locali.
Lo strumento del Patto di stabilità interno, ancora
formulato con riferimento al solo lato della spesa, con importanti esclusioni,
continua anche nell’esercizio in esame, a mostrare una limitata efficacia nel
contrastare la tendenza al disequilibrio dei bilanci delle amministrazioni
locali. Nonostante la sua formulazione in termini di vincoli differenziati con
tassi di contenimento per la spesa corrente e tassi di espansione per quella in
conto capitale, quest’ultima registra una contrazione nell’esercizio in esame.
Contrariamente a quanto rilevato per il 2006, il risultato
ottenuto dalle Amministrazioni locali risulta determinante nello spiegare il
miglioramento del risultato 2007 ottenuto dal complesso della PA: quest’ultimo
risulta infatti spiegato per i tre quarti proprio dal contributo del comparto
delle Amministrazioni locali,
che raggiunge un saldo prossimo al pareggio.
Data la rilevanza di tale contributo, risulta fondamentale
individuare la natura del miglioramento riscontrato al fine di comprendere in
che misura esso sia da attribuire a componenti di carattere strutturale e
quanto, invece, sia imputabile a fattori non ripetibili.
Fra questi ultimi si ricordano:
-
sul lato della spesa la modulazione degli oneri
per il personale che risente del ritardo strutturale di uno o due esercizi con
il quale vengono rinnovati i contratti
rispetto al biennio di riferimento. Tale ritardo fa sì che nell’esercizio di
stipula gravino gli effetti dovuti alla corresponsione degli arretrati,
introducendo un elemento di ciclicità nella spesa. Tale fattore ha inciso in
modo sostanziale sul dato relativo all’esercizio 2006 ed in modo marginale
sull’esercizio 2007. Risulta pertanto opportuno rideterminare l’importo della
spesa per redditi sostenuta negli anni 2006 e 2007 depurandola della componente
ciclica legata alla sottoscrizione dei CCNL.
A tale scopo la spesa sostenuta
nel corso di ciascuno degli anno 2006 e 2007:
§
viene ridotta delle somme liquidate a titolo di
arretrati;
§
ed incrementata delle somme di sarebbero state
liquidate in competenza in caso di tempestiva stipula del nuovo CCNL.
La spesa rideterminata ammonta a
circa 67.328 milioni di euro per il 2006 e a circa 69.236 milioni di euro per
il 2007 evidenziando che la flessione della spesa era legata al fattore ciclico
in questione;
-
sul lato dell’entrata, l’effetto dovuto all’acconto del 30% introdotto dalla
finanziaria per il 2007 sull’addizionale comunale all’IRPEF: il
maggior gettito per i comuni era stimato, a
parità di aliquote, in 500 mln di euro per il 2007. Tale fattore, pur non
essendo formalmente incluso fra le misure una
tantum ai fini del saldo strutturale, determina un effetto di maggior gettito nel
2007 non ripetibile negli anni successivi.
Sempre sul lato delle entrate si ricorda inoltre il cospicuo
aumento dei trasferimenti, sia di
parte corrente che in conto capitale, alle regioni che potrebbe, almeno in
parte, non essere di natura strutturale. In particolare ci si riferisce alle
somme relative alla mancata attuazione del DLgs. 56/2000 per le annualità
2002-2004, attribuite alle regioni nel corso degli esercizi 2006 e 2007: ne
consegue la possibilità che una parte dell’aumento riscontrato in tali esercizi
nei trasferimenti per l’attuazione del federalismo amministrativo e fiscale
potrebbe in parte avere natura non strutturale. Si ricorda inoltre il netto
incremento, fra le entrate, dei contributi agli investimenti che potrebbe, in
parte, derivare dall’accelerazione dei pagamenti connessa alla conclusione dei
programmi comunitari di sviluppo. Da
ultimo si rammentano i trasferimenti alle amministrazioni locali, relativi principalmente
al settore delle opere infrastrutturali e dei trasporti, deliberati con i
provvedimenti di utilizzo dei cd. tesoretti riferiti all’esercizio 2007:
il corrispondente aumento delle risorse di parte capitale per tale esercizio
assume carattere straordinario, in quanto legato ad una specifica modalità di
utilizzo delle risorse eccedentarie resesi disponibili.
Ulteriori fattori che possono aver inciso sul miglioramento
dei saldi delle Amministrazioni locali nel 2007 presentano invece un carattere
strutturale. Si ricorda in particolare il venir meno dei vincoli
all’applicazione degli aumenti delle addizionali IRPEF e IRAP,
che ha permesso alle amministrazioni locali l’utilizzo della leva delle maggiori entrate.
La RUEF sottolinea in proposito
che la crescita delle entrate tributarie delle Amministrazioni locali,
cresciute del 6,8% nel 2007, è da ascriversi alla
forte crescita delle addizionali IRPEF, sia regionali che comunali, il cui
gettito nel 2007 è aumentato, rispettivamente, del 19,5 e del 43 per cento, per effetto di aumenti
delle aliquote stabiliti a livello locale. In particolare nel 2007 circa il 43%
dei comuni ha aumentato l’aliquota dell’addizionale IRPEF e il 56 per cento
l’ha lasciata invariata. La RUEF sottolinea in proposito che l’aumento dei
tributi locali riflette la scelta delle Amministrazioni di utilizzare la
variazione dei tributi, più che la riduzione della spesa, al fine di ottenere
il rispetto del Patto di stabilità interno.
Al riguardo si segnala che, con riferimento al solo comparto
dei comuni,
gli aumenti disposti nel corso del 2007 si applicano a decorrere dal medesimo
anno d’imposta. Pertanto, per i meccanismi di versamento dell’addizionale
comunale IRPEF, i citati aumenti dovrebbero aver inciso sul 2007 solo limitatamente
ai versamenti di acconto, commisurati al 30% dei maggiori importi dovuti.
Peraltro, come sopra evidenziato, una larga quota del
maggior gettito delle addizionali comunali IRPEF ottenuto nel 2007, non sarebbe
attribuibile tanto agli aumenti di aliquota disposti quanto all’effetto una tantum dovuto all’introduzione
dell’acconto.
Con riferimento al comparto delle regioni, si ricorda
inoltre che la ripristinata facoltà di manovrare le aliquote dell’addizionale
IRPEF e della maggiorazione IRAP si è configurata nel 2007 come un obbligo per
le regioni con deficit sanitari, per le quali l’art. 1, comma 174, della legge
n. 311/2004
prevede l’attivazione automatica delle misure fiscali. Tale obbligo è in larga
misura alla base dell’incremento del gettito delle imposte dirette delle
regioni.
Un ulteriore fattore di carattere strutturale alla base del
miglioramento dei risultati ottenuti dalle Amministrazioni locali può
ravvisarsi nella riforma del Patto di
stabilità interno per gli enti locali operata dalla legge finanziaria per
il 2007. La formulazione di tale vincolo in termini di saldo e la concomitante
riduzione delle poste escluse dal vincolo, se, da un lato, ha consentito agli
enti locali una maggiore libertà nella gestione delle politiche di bilancio, con
un ampio ricorso alla leva delle entrate, dall’altro ha ridotto l’efficacia
delle misure elusive precedentemente utilizzate, finalizzate a minimizzare la
portata restrittiva del vincolo mediante riclassificazioni della spesa in voci
escluse dal Patto.
Da ultimo, non vanno dimenticati gli effetti strutturali che
hanno inciso sul 2007 in senso peggiorativo del deficit: fra di essi si ricorda
in particolare l’aumento della spesa per
interessi, cresciuta nell’esercizio in esame di circa 800 milioni per l’intero
comparto delle amministrazioni locali (di 1,35 miliardi nel biennio 2006-2007).
La RUEF evidenzia come tale aumento di
spesa si verifichi sebbene il debito delle Amministrazioni locali non abbia
fatto registrare incrementi significativi sull’anno precedente. Viene
sottolineato in proposito come la configurazione a tasso variabile di una quota
significativa delle passività in circolazione esponga i conti delle
Amministrazioni locali ad incrementi della spesa in caso di rialzo
significativo dei tassi di mercato, come accaduto nel 2007.
Mentre con riferimento agli anni di consuntivo la Relazione
generale sulla situazione economica del paese fornisce, oltre al conto
consolidato delle Amministrazioni pubbliche, il corrispondente conto delle Amministrazioni
locali, con riferimento agli esercizi di previsione non risulta disponibile la
medesima disaggregazione. Informazioni solo parziali possono trarsi dai quadri
previsionali relativi ai conti consolidati di cassa, i quali peraltro non
presentano dati coerenti con quelli espressi in termini di competenza economica
utilizzati dall’ISTAT ai fini della costruzione del quadro complessivo della
P.A..
Dal lato delle entrate, sia per le regioni che per gli enti
locali è previsto un consolidamento del gettito conseguito nel 2007 la cui
crescita è attesa per il 2008 a tassi contenuti (attorno al 2%). Con
riferimento alle regioni, l’incremento di gettito dovuto all’aumento delle
aliquote tributarie si è infatti già registrato nell’esercizio appena concluso e
non si prevedono, pertanto, effetti ulteriori dovuti ai meccanismi di
versamento. Viceversa, per i comuni, parte del maggior gettito conseguente agli
aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF deliberati nel 2007 si registrerà
in sede di saldo nel 2008, ma al contempo verrà meno l’effetto transitorio di
maggior gettito dovuto alla prima applicazione nel 2007 dell’acconto del 30%.
Con riferimento ai pagamenti di parte corrente, si ricorda
l’incremento di quelli relativi alla spesa per il personale, particolarmente
significativo per i comparti degli enti locali e della sanità (oltre il 9 per
cento) piuttosto che per quello delle regioni (4,8 per cento).
Prosegue inoltre la tendenza, già riscontrata nel 2007,
all’aumento della spesa per interessi, in particolar modo per il settore delle
regioni, sul quale grava oltre all’effetto dovuto all’aumento dei tassi, anche
l’incidenza dell’onere delle anticipazioni erogate dal bilancio dello Stato ai
sensi della finanziaria per il 2008,
per il ripiano dei debiti sanitari.
Con riferimento alla spesa in conto capitale, i dati del
conto consolidato di cassa prevedono una sostanziale staticità per il comparto
delle regioni, per le quali il permanere di vincoli sul solo lato della spesa
presenta riflessi particolarmente penalizzanti per quella in conto capitale, e
una lieve crescita per il comparto di province e comuni che registrano
l’effetto di slittamento al 2008 dell’utilizzo delle risorse in conto capitale
stanziate con il DL 159/07 e non utilizzate nel corso dell’esercizio concluso.
Si rammenta da ultimo che la RUEF specifica che le
previsioni contenute nel conto consolidato di cassa dei diversi comparti di
Amministrazioni locali scontano il pieno rispetto dei vincoli disposti dal
Patto di stabilità interno, come modificato dalla ultima legge finanziaria.
Con specifico riferimento a tale strumento di controllo
delle dinamiche della finanza locale si evidenzia come i dati sul rispetto del
Patto di stabilità interno non attualmente oggetto di specifica comunicazione
al Parlamento, benché l’acquisizione non episodica di tali dati consentirebbe
una più agevole interpretazione dell’effettivo contributo dello strumento in
questione al contenimento di un maggiore controllo delle dinamiche locali.
In merito agli effetti attesi dalle modifiche operate dalla
legge finanziaria 2008 si rinvia alle apposite schede del dossier di verifica
predisposto dal Servizio bilancio sulla legge finanziaria, nonché alle
osservazioni operate dalla Corte dei conti nell’ultima Relazione quadrimestrale
sulla copertura delle leggi di spesa.
Un breve cenno risulta opportuno con riferimento al percorso
attuato nella legislatura conclusa in materia di passaggio da una finanza
locale derivata, basata principalmente sull’attribuzione a livello locale di
risorse provenienti dal bilancio dello Stato, ad una finanza decentrata, basata
principalmente sull’attribuzione a livello locale di fonti autonome di risorse,
la cui gestione presenti margini di manovrabilità discrezionale da parte delle
Amministrazioni locali.
Nella legislatura conclusa è proseguito il lavoro di studio
in materia di federalismo fiscale, avviato nella legislatura precedente, ma non
è stato portato a termine un provvedimento di riassetto organico della finanza
territoriale. In attesa della definizione di tale disegno che governi il
processo di transizione, sono peraltro state introdotte numerose disposizioni
volte a regolare i criteri di attribuzione delle risorse alle Amministrazioni
locali, seppure con riferimento ad aspetti circoscritti. Il tenore degli
interventi disposti presenta qualche elemento contraddittorio, sia in termini
di non linearità del percorso, che in alcuni casi spinge verso un aumento del
grado di autonomia finanziaria delle amministrazioni locali e in altri casi
compie passi in direzione opposta, sia in termini di individuazione dei
corretti criteri metodologici di valutazione degli effetti finanziari prodotti
dalle misure introdotte. Rinviando per tale ultimo aspetto all’apposito
paragrafo della sezione metodologica del presente dossier, ci
si limita in questa sede a richiamare talune delle principali misure che
appaiono determinare effetti contraddittori in termini di aumento o riduzione
del grado di autonomia finanziaria delle Amministrazioni locali.
Con riferimento al comparto delle regioni, gli interventi disposti risultano in buona misura
finalizzati ad un aumento dell’autonomia finanziaria del comparto. Sono infatti
numerosi gli interventi che comportano un aumento del gettito di tributi
regionali o di quote di compartecipazione dei tributi erariali, a fronte di una
corrispondente riduzione dei trasferimenti.
Tale tipologia di interventi assicura alle regioni
l’acquisizione di risorse finanziarie crescenti nel tempo, controbilanciate da
una riduzione dei trasferimenti che si mantiene invece costante al livello
iniziale. L’aumento della disponibilità di risorse si accompagna
all’acquisizione di una maggiore autonomia gestionale, in quanto la dinamica
futura del gettito risulta correlata ad andamenti macroeconomici e non dipende
da decisioni incrementali assunte di anno in anno dall’Amministrazione
centrale, consentendo quindi alle Amministrazioni locali un maggior grado di
certezza nella propria attività di programmazione.
Fra gli interventi in questione si ricordano in particolare l’incremento
delle compartecipazioni in favore di alcune regioni a statuto speciale, le
nuove modalità di finanziamento del settore del trasporto pubblico locale
disposte dalla legge finanziaria per il 2008 e
l’attribuzione di compartecipazioni in favore delle Autorità portuali.
Concorrono inoltre ad aumentare l’autonomia finanziaria
delle regioni le misure che aumentano la possibilità di manovra delle aliquote
dei tributi regionali: in tal senso si segnala in primo luogo la rimozione dei
vincoli all’utilizzo delle addizionali IRPEF e della maggiorazione IRAP,
vigenti fino all’esercizio 2006, nonché l’obbligo di attivazione degli stessi
nella misura massima in caso di necessità di ripiano dei disavanzi sanitari.
In senso opposto opera, invece, l’intervento di riduzione
del cuneo fiscale, mediante l’introduzione della deducibilità ai fini IRAP dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori a tempo
indeterminato. La disposizione determina infatti una ingente riduzione del
gettito di tale tributo, destinato a finanziare la spesa sanitaria, compensata
mediante l’aumento dei trasferimenti. Parimenti, non concorre all’aumento
dell’autonomia gestionale delle politiche di bilancio delle regioni il
mantenimento della struttura del Patto di stabilità interno con vincoli
limitati al solo lato della spesa, finalizzato a disincentivare l’utilizzo a
livello decentrato della leva fiscale, obbligando le regioni ad un controllo
della dinamica della spesa.
Con riferimento alle amministrazioni
provinciali, concorre a determinare un aumento dell’autonomia finanziaria l’incremento
delle tasse automobilistiche disposto dalla legge finanziaria per il 2007,
compensato da una corrispondente riduzione dei trasferimenti, mentre operano in
senso inverso sia le esenzioni dal medesimo tributo incluse nel pacchetto di
agevolazioni per la sostituzione dei veicoli inquinanti mediante rottamazione,
sia il mantenimento della natura statica della compartecipazione provinciale
all’IRPEF, che rende di fatto tale gettito totalmente assimilabile a
trasferimenti.
Con riferimento ai comuni,
fra le misure suscettibili di aumentare l’autonomia finanziaria del comparto si
segnalano quelle adottate con la manovra finanziaria per il 2007, fra cui in
particolare l’aumento della misura della compartecipazione all’IRPEF e
l’attribuzione della stessa in forma dinamica a partire dall’esercizio 2008,
nonché l’attribuzione ai comuni della facoltà di istituire tributi di scopo, di
portata peraltro limitata.
Un’altra significativa misura della manovra per il 2007 si
ravvisa nella riforma del Patto di stabilità interno, che restituisce autonomia
alle politiche di bilancio degli enti locali, pur vincolando questi ultimi al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese. La
formulazione del vincolo in termini di saldo sconta, implicitamente, la
possibilità che gli enti possano agire sulla pressione tributaria locale anche
in senso contrario rispetto all’orientamento di politica fiscale deciso a
livello centrale, con una conseguente assunzione di responsabilità da parte
degli amministratori locali.
Fra le ulteriori misure finalizzate ad aumentare il grado di
autonomia finanziaria degli enti locali, si segnala il decreto legge 262/2006,
collegato alla legge finanziaria 2007, che, aveva inoltre previsto misure in
materia catastale
dalle quali erano attesi incrementi di gettito ICI e dell’addizionale comunale
all’IRPEF per un importo pari a circa 600 milioni nel 2007,
compensate da una corrispondente riduzione dei trasferimenti. Il mancato
conseguimento di tale effetto positivo e la conseguente necessità di rifondere
gli enti locali dei minori trasferimenti ricevuti, è uno dei fattori indicati
dalla RUEF fra le cause della revisione peggiorativa del saldo tendenziale
atteso per il 2008.
Infine l’intervento operato dalla legge finanziaria per il
2008 in materia di riduzione dell’ICI sulla prima abitazione, compensato da un
corrispondente aumento dei trasferimenti, opera, invece, nella direzione di una
riduzione dell’autonomia finanziaria degli enti locali.
Dalla parziale rassegna di interventi sopra riportata,
emerge la necessità di una definizione organica del sistema delle relazioni
finanziarie fra i diversi livello di governo territoriale, che costituisca una
cornice quadro in grado di fornire stabilità al sistema di finanziamento delle
Amministrazioni locali e aumentare al tempo stesso il loro grado di
responsabilità.