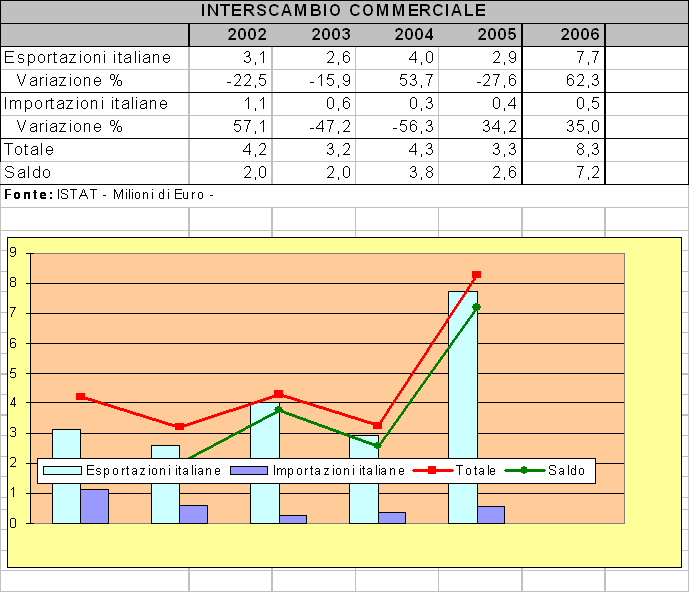VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,PAUL KAGAME
Roma, 29 agosto 2007
|
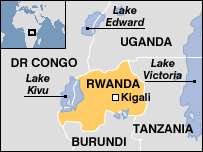
REPUBBLICA DEL RUANDA
CENNI STORICI (a cura del MAE)
Indipendente dal luglio 1962, il Ruanda è stato teatro di continue violenze tra l’etnia maggioritaria Hutu (85% della popolazione) e la minoranza Tutsi (14%), politicamente ed economicamente dominante, che aveva goduto del sostegno del Belgio nel periodo coloniale. Molti Tutsi, per sfuggire alle uccisioni di massa sobillate dal primo Presidente dopo l’indipendenza, Gregoire Kayibanda, appartenente alla fazione radicale degli Hutu, si erano rifugiati nei Paesi confinanti.
Nel 1973, il Generale Habyarimana giunse al potere con un colpo di Stato sostenuto dalla Francia e cercò in un primo tempo di cooptare i Tutsi nella gestione del Paese. Habyarimana tuttavia evitò sempre di affrontare il problema dei numerosi esuli vittime dei “pogrom” di Kayibanda. Permaneva quindi uno stato di tensione con i gruppi dissidenti Tutsi che nel frattempo si erano riorganizzati, con l’aiuto del Presidente ugandese Museveni, in un’opposizione armata, quella del "Fronte Patriottico Ruandese" (FPR).
La crisi esplose nell'ottobre 1990 con l'invasione di una provincia ruandese da parte dell’FPR proveniente dall'Uganda. Habyarimana, secondo la sua strategia compromissoria e sotto le pressioni della comunità internazionale, cercò in un primo tempo l’accordo con l’FPR. Si giunse quindi agli Accordi di Arusha dell’agosto 1993 che stabilivano le quote di attribuzione degli incarichi di governo e dei seggi parlamentari alle varie forze politiche.
La linea di Habyarimana entrò in urto con la fazione radicale degli Hutu che, fedele al lascito ideologico del vecchio Presidente Kayibanda, non vedeva alternative alle espulsioni forzate dei Tutsi e finanche al loro sterminio. Gli eventi precipitarono nell’aprile 1994, quando un attentato di matrice tuttora ignota (ma probabilmente da attribuirsi agli stessi estremisti Hutu) portò alla morte del Presidente Habyarimana innescando una spirale di violenza sfociata nel genocidio istigato da una parte della dirigenza Hutu a danno dei Tutsi, in cui persero la vita circa 800.000 persone, in gran maggioranza appartenenti a tale etnia.
Il 18 luglio 1994 l’FPR, vincitore sul campo, poneva fine ai massacri e nominava un Governo di transizione a base interetnica, con la sola esclusione degli esponenti Hutu appartenenti alla precedente dirigenza. L'esponente moderato Hutu, Pasteur Bizimungu, veniva nominato Presidente della Repubblica, mentre l'uomo forte del regime, il Tutsi Paul Kagame, assumeva le cariche di Vice Presidente e Ministro della Difesa.
Ben presto la centralità di Kagame si affermava a scapito dello stesso Presidente Bizimungu, prima costretto alle dimissioni (nel marzo 2000) e poi arrestato e condannato per attività sovversive a quindici anni di carcere.
Kagame ed il Front Patriotique Rwandais (FPR) inauguravano dunque una fase politica caratterizzata da un forte accentramento e da una ferrea repressione delle ideologie anche lontanamente sospetta di avere una connotazione etnica, per le quali veniva coniato il neologismo di “divisionismo”.
La fase transitoria terminava infine nel 2003 con le elezioni presidenziali e legislative che hanno sancito la vittoria di Kagame e dell’FPR.
CRONOLOGIA RECENTE |
|
|
2002 |
LUGLIO. Repubblica Democratica del Congo e Ruanda firmano un accordo di pace in base al quale il Ruanda si ritira dal Congo e le autorità di Kinshasa si impegnano a disarmare le milizie hutu accusate di aver perpetrato i massacri del 1994. OTTOBRE. Il Ruanda completa il ritiro delle sue truppe. |
|
2003 |
MAGGIO. I ruandesi approvano con referendum un progetto di Costituzione in cui viene espressamente vietato ogni forma di odio etnico. AGOSTO. Paul Kagame vince le prime elezioni presidenziali dal genocidio del 1994. OTTOBRE. Il Fronte Patriottico del Ruanda prevale nelle elezioni politiche, durante il cui svolgimento vengono rilevate dagli osservatori UE numerose frodi ed irregolarità.
|
|
2004 |
MARZO. Il Presidente Kagame contesta i risultati di un rapporto francese che lo accusa di aver ordinato l’attacco all’aereo presidenziale di Gregoire Kayibanda del 1994, atto che ha dato via al genocidio. GIUGNO. Il precedente Presidente della Repubblica, Pasteur Bizimungu, viene condannato a 15 anni di reclusione per peculato, incitamento alla violenza ed appartenenza ad associazioni criminali. |
|
2005 |
MAGGIO. Il maggior gruppo ribelle hutu, le FDLR (Forze Democratiche di Liberazione del Ruanda), dichiara la fine della lotta armata. Le FDLR sono uno dei numerosi gruppi accusati di aver creato instabilità nella Repubblica Democratica del Congo. Molti dei suoi affiliati sono accusati di aver preso parte al genocidio del 1994. LUGLIO. Il Governo inizia il rilascio di 36.000 reclusi, la maggior parte dei quali accusata di aver preso parte ai massacri del 1994. Il provvedimento ha lo scopo principale di evitare il sovraffollamento delle carceri. |
|
2006 |
GENNAIO. Le 12 province esistenti vengono suddivisi in entità territoriali minori con lo scopo di amalgamare meglio le due etnie. DICEMBRE. Padre Athanase Seromba diviene il primo prete cattolico ad essere condannato per il suo coinvolgimento nel genocidio del 1994. Il Tribunale Criminale Internazionale lo condanna a 15 anni di prigione.
|
|
2007 |
FEBBRAIO. Circa 8.000 reclusi accusati di aver partecipato al genocidio vengono rilasciati. A causa del sovraffollamento, dal 2003 i sospetti di genocidio rilasciati dalle autorità raggiungono le 60.000 unità. Il Presidente Kagame, i cui rapporti continuano a rimanere critici con la Francia, dichiara l’intenzione del Ruanda di entrare a far parte del Commonwealth[1]. APRILE. L’ex Presidente Pasteur Bizimungu viene rilasciato dopo tre anni di reclusione dopo aver ricevuto il perdono presidenziale. MAGGIO. Anche le autorità del vicino Burundi acconsentono all’istituzione di un tribunale per giudicare reati di guerra e di genocidio commessi tra il 1993 ed il 2005. LUGLIO. Il Ruanda approva l’abolizione della pena di morte. Un capo dell’esercito ruandese, Bernard Ntuyanaga, viene dichiarato colpevole dalla Corte di Bruxelles per l’uccisione dei dieci caschi blu belgi che scortavano il Primo Ministro, Agate Uwilingiyimana, nel 1994[2]. Ntuyanaga è condannato a venti anni di reclusione. AGOSTO. Bernard Kouchner, Ministro degli Esteri francese, annuncia la propria intenzione di volersi recare al più presto in Ruanda per riallacciare le relazioni diplomatiche.
|
DATI GENERALI |
|
|
Superficie |
25.271 Kmq (meno di un decimo del territorio italiano) |
|
Abitanti |
9.910.000 Il Ruanda è il Paese più densamente popolato dell’Africa |
|
Tasso di crescita della popolazione
|
2,8% |
|
Capitale |
KIGALI (900.000 abitanti)
|
|
Gruppi etnici |
Hutu (Bantu) 84%, Tutsi (Hamitic)15%; Twa (Pigmei) 1% |
|
Popolazione affetta da AIDS (2003) |
250.000 - Oltre all’AIDS, il Paese è particolarmente a rischio per quanto riguarda altre malattie infettive, qulai malaria, tifo, epatite A, diarrea batterica
|
|
Aspettativa di vita |
49 anni |
|
Religioni |
Cattolica (56,5%); Riformata (26%); Avventista (11%); Mussulmana (4,6%) |
Cariche dello Stato
|
|
|
Presidente della Repubblica e Capo del Governo
|
PAUL KAGAME (dal 22 aprile 2000) |
|
Presidente della Camera dei deputati
|
ALFRED MUKEZAMFURA (dal 10 ottobre 2003)
|
|
Presidente del Senato |
VINCENT BIRUTA (dal 10 ottobre 2003)
|
|
Primo Ministro |
Bernard MAKUZA (dall’8 marzo 2000) |
|
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Regionale |
Charles MURIGANDE |
|
SCADENZE ELETTORALI
|
|
|
Presidenziali |
2010 |
|
Legislative |
2008 |
QUADRO POLITICO
|
Governo in carica
Nell’agosto 2003 Paul Kagame – che era già stato designato Presidente nel 2000 dai parlamentari e dal Governo provvisorio – ha vinto a larga maggioranza le prime elezioni presidenziali tenutesi dopo il genocidio del 1994. Il Ruanda si è mantenuto relativamente stabile sotto il governo di Kagame e del Fronte Patriottico Ruandese (RPF), anche se al partito sono state mosse accuse di essere intollerante nei confronti delle critiche. Kagame, che è un tutsi, si rifiuta di cedere ad alcuna distinzione di carattere etnico ed ama presentarsi come un semplice ruandese. Per cercare di amalgamare le due etnie, il governo Kagame ha ridelineato i collegi elettorali e le ripartizioni geo-politiche del Paese.
Quadro istituzionale
|
Sistema politico
Il Ruanda è una Repubblica presidenziale, indipendente dal 1962.
L’attuale Costituzione è stata approvata nel 2003 con un referendum. Nel testo è espressamente vietata lo svolgimento di qualsiasi attività politica che preveda discriminazioni su base etnica, razziale o religiosa. Anche il diritto al ritorno per i ruandesi sfollati tra il 1959 ed il 1994 (principalmente tutsi) è stato inserito nella nuova Costituzione. Nessun accenno si fa invece alla possibilità di ritorno per gli hutu che sono stati costretti a fuggire nella Repubblica Democratica del Congo a causa della grave crisi del 1994-1998. E questo malgrado la Costituzione garantisca che “tutte le persone originarie del Ruanda ed i loro discendenti hanno diritto, su loro richiesta, ad ottenere la nazionalità ruandese” e che “nessun ruandese sarà esiliato dal Paese”.
Capo dello Stato
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale per sette anni a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è rieleggibile. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro ed i membri del Governo. Le ultime elezioni presidenziali si sono tenute il 25 agosto 2003 ed hanno visto la vittoria di Paul Kagame che si è aggiudicato il 95,05% dei suffragi. Ha il potere di nominare 12 Senatori. Le nomine devono essere approvate dalla Corte Suprema.
Parlamento
Il Parlamento è bicamerale ed è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato.
La Camera dei deputati è composta da 80 membri (53 eletti direttamente dal popolo, 24 donne elette da ogni Provincia e dalla città di Kigali, 2 membri eletti dal Consiglio Nazionale della Gioventù ed un membro eletto dalla Federazione delle Associazioni dei Disabili) che durano in carica 5 anni. Le ultime elezioni si sono tenute il 29 settembre-2 ottobre 2003. Per legge, un terzo dei deputati deve essere costituito da donne. Le donne presenti in Parlamento sono 39, pari al 48, 75% del totale[3]. Il Presidente e lo Speaker del Parlamento devono essere di due partiti differenti.
Il Senato conta 26 membri, ognuno dei quali dura in carica 8 anni. Anche qui un terzo dei seggi deve essere assegnato a donne. Otto membri sono nominati dal Presidente, 12 sono eletti dalle 11 province e dalla città di Kigali. Altri quattro membri sono nominati dal Forum delle Organizzazioni Politiche (un’organizzazione che di fatto è uno strumento del partito dominante). Altri due membri sono eletti rispettivamente dalle Università pubbliche e private tra ricercatori e docenti. Sono inoltre membri di diritto del Senato tutti i passati Presidenti. Le donne presenti sono 9, pari al 34,62%.
Composizione della Camera (membri eletti):*
|
PARTITO |
SEGGI |
|
Fronte Patriottico del Ruanda (FPR) |
40 |
|
Partito Socialista Democratico (PSD) |
7 |
|
Partito Liberale (PL) |
6 |
|
TOTALE |
53 |
* fonte: UIP
Sistema giudiziario
Al vertice del sistema giudiziario sta la Corte Suprema, i cui 14 membri sono nominati dal Presidente e confermati dal Senato.
attualità politica
I problemi della riconciliazione
Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR - International Criminal Tribunal for Rwanda) di Arusha, Tanzania, iniziò a celebrare il primo processo nel gennaio 1997 e a settembre 2006 aveva emanato 25 giudizi riguardanti 31 accusati. Sin dall’inizio, i lavori del Tribunale sono stati particolarmente rilevanti, determinando importanti precedenti a livello internazionale; infatti, per la prima volta un tribunale internazionale è stato chiamato a precisare la definizione del crimine di genocidio contenuta nella relativa Convenzione del 1948 e per la prima volta un Capo di Governo, nel caso di specie l’ex Primo Ministro ruandese Jean Kambanda, peraltro dichiaratosi colpevole dinanzi alla Corte, è stato condannato per il crimine di genocidio. Il Tribunale ha anche definito il crimine di violenza sessuale, precisando che esso può rientrare nella definizione di genocidio allo stesso modo che qualsiasi altro atto di grave violenza fisica o mentale commesso con l’intenzione di distruggere un particolare gruppo.
Il 2007 è iniziato con l’apertura del processo contro l’ex colonnello e prefetto di Kigali, Tharcisse Renzaho, accusato di genocidio e crimini contro l’umanità; è iniziata la deposizione in videoconferenza dei tre ufficiali francesi, che determinerà la conclusione delle udienze del più importante processo dinanzi la Corte, quello contro il colonnello Théoneste Bagosora, ritenuto dall’accusa l’organizzatore principale del genocidio. Tuttavia, nonostante il procuratore generale dell’ICTR affermi che una buona parte di coloro che hanno architettato il massacro sono stati giudicati, restano numerosi passi da compiere per garantire la giustizia e facilitare il processo di unità e riconciliazione. Il numero delle persone coinvolte nella realizzazione del genocidio è enorme: basti pensare che nel 1996 vi erano circa 120.000 prigionieri nelle carceri ruandesi in attesa di processo. È stato pertanto stabilito che gli accusati di aver comandato e pianificato la tragedia ruandese siano giudicati dal Tribunale Internazionale, mentre gli esecutori materiali dai tribunali ordinari e le corti tradizionali “Gachacha”[4]. Sino ad ora, seimila casi di genocidio sono stati giudicati dai tribunali ordinari e trentamila dalle corti Gachacha.
Nel 2008 terminerà il mandato dell’ICTR. Questo significa che il tribunale non potrà iniziare nuovi processi ed entro il 2010 dovrà completare i casi in appello. E’ stato pertanto stabilito che le accuse e i giudizi pendenti dinanzi al Tribunale ONU saranno trasferiti ai tribunali nazionali. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 1503/2003, aveva richiesto collaborazione per sviluppare la capacità dei paesi disposti ad assumersi tali giudizi, ma al momento il Ruanda rimane l’unico Stato africano pronto a ricevere i casi dell’ICTR. A tal fine, il 17 gennaio 2007 il governo ruandese ha presentato un disegno di legge per l’abolizione della pena di morte, che, dopo l’approvazione da parte della Camera e del Senato di Kigali all'unanimità , è entrato in vigore il 25 luglio 2007. Circa 63.000 persone sospettate di aver partecipato al genocidio del 1994 sono ancora oggi detenute nel paese. Secondo la giustizia ruandese, circa il 9% della popolazione dovrà essere giudicata per il ruolo giocato nel massacro in cui almeno 800.000 Tutsi e Hutu moderati furono uccisi.
L’abolizione della pena di morte
Il 25 luglio 2007 è entrata in vigore la legge che abolisce la pena di morte in Ruanda.
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Louise Arbour, ha sottolineato la necessità che il Ruanda continui a cercare giustizia, formulando uno dei primi e più sentiti omaggi alla decisione del paese di abolire la pena di morte. La sete di giustizia è ancora “lontano dall’essere sedata”, ha ammesso, aggiungendo che “con la promulgazione della legge che vieta la pena di morte, il Ruanda ha fatto un passo importante verso la garanzia del rispetto del diritto alla vita, compiendo al tempo stesso ulteriori progressi nell’assicurare alla giustizia i responsabili degli atroci crimini del genocidio del 1994”.
Per la maggior parte delle nazioni, l’abolizione della pena di morte in Ruanda rappresenta un requisito indispensabile per consentire l’estradizione delle persone sospettate di genocidio verso questo paese dell’Africa centrale. Le ultime esecuzioni di persone accusate di aver avuto un ruolo nel genocidio del Ruanda sono avvenute nel 1998. Ventidue persone riconosciute colpevoli di aver contribuito a pianificare gli omicidi sono state fucilate pubblicamente.
Da allora, tutte le altre persone accusate di partecipazione nel genocidio si trovano nel braccio della morte in attesa di esecuzione. L’abolizione della pena di morte significa che queste persone - insieme a tutti gli altri condannati a morte per altri crimini - verranno ora risparmiate e sconteranno il carcere a vita. In totale, circa 650 persone eviteranno la pena capitale.
L'abolizione della pena di morte era una delle condizioni fissate dal Tribunale internazionale per il Ruanda per la consegna a Kigali degli incriminati per il genocidio del 1994.
Il genocidio del 1994 ha prodotto un elevato numero di rifugiati che sono fuggiti in diversi stati africani (Burundi, Malawi, Namibia, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Uganda e Zambia per citare i principali). Ancora oggi, il numero di rifugiati ruandesi è stimato a circa 60.000 suddivisi in 21 differenti paesi.
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) dal 2002 sta portando avanti operazioni di ritorno volontario, in collaborazione con i governi dei paesi ospitanti; tali operazioni prevedono campagne per incoraggiare il rimpatrio, assistenza nelle operazioni di ritorno e supporto per favorire la reintegrazione. Il risultato di queste operazioni non è sempre stato positivo, come ad esempio nel caso della Tanzania, fortemente criticata per le pressioni che si presume abbia esercitato sui rifugiati costringendoli a ritornare. L’ACNUR ha concluso sia accordi bilaterali con il governo ruandese che accordi trilaterali con i vari stati ospitanti prevedendo le modalità di realizzazione del ritorno volontario. Le motivazioni che, a distanza di tanti anni dal genocidio, frenano i ruandesi dal tornare in patria sono, in primo luogo, di ordine economico: il Ruanda è infatti tra i più piccoli Stati africani ma con la maggiore densità di popolazione. Questo naturalmente, per un paese la cui economia si basa sull’agricoltura e l’allevamento di bestiame, si traduce in mancanza di accesso alla terra e quindi di possibilità di sostentamento. A questo si è aggiunto il timore di essere coinvolti nei processi delle “corti Gachacha”: tra il 2005 ed il 2006, questo timore ha spinto circa 20.000 ruandesi a cercare rifugio nel vicino Burundi. Il governo di questo Stato ha, con il supporto dell’ACNUR, avviato le procedure individuali per la determinazione dello status di rifugiato, ma solo il 3% dei richiedenti ha ottenuto il riconoscimento, mentre la maggioranza è dovuta ritornare in Ruanda. Al fine di rendere possibile un rimpatrio “sostenibile”, l’ACNUR cerca sempre più di puntare su operazioni di reintegrazione a supporto degli obiettivi di unità e riconciliazione, opportunità economiche e accesso alle terre.
Per il 2007, ha in programma di favorire il rimpatrio di 5.000 ruandesi. Il governo, dal canto suo, collabora attivamente in tali attività e sta al momento compiendo notevoli sforzi nella definizione e attuazione del Piano Nazionale di Riduzione della Povertà, puntando sulla diversificazione dell’economia, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi di unità e riconciliazione. Negli ultimi mesi sono state portate avanti operazioni di ritorno dall’Uganda, da cui si attende per quest’anno uno dei maggiori movimenti, dalla Repubblica Democratica del Congo e dalla Tanzania, da cui anche è atteso il ritorno di un elevato numero di ruandesi, a causa delle azioni restrittive adottate dal questo paese in materia di immigrazione irregolare sul suo territorio. Nonostante l’assistenza dell’ACUNR, ci sono casi in cui i ruandesi lamentano di aver subito confische dei propri bestiami o addirittura di essere stati ostacolati dai ribelli ruandesi che si oppongono all’attuale governo.
|
QUADRO ECONOMICO In collaborazione con il MAE |
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2006
|
|
|
PIL a parità di potere d’acquisto |
13,7 miliardi dollari USA
|
|
PIL al cambio ufficiale |
1,968 miliardi di dollari
|
|
Composizione per settore |
agricoltura 39,4%; industria 23,3%; servizi 37,3%
|
|
Crescita del PIL |
5,8%
|
|
PIL pro capite a parità di potere d’acquisto |
1.600 (Italia: 29.700)
|
|
Popolazione sotto la soglia della povertà (2001) |
60% |
|
Inflazione |
6,7%
|
|
Debito estero |
1,4 miliardi di dollari
|
|
Fonte: CIA Worldfactbook.2007 |
|
La situazione economica ruandese, caratterizzata da un contesto di povertà di risorse naturali e di una forte dipendenza dalla produzione di caffè e the, si sta muovendo lungo direttrici di un’interessante ed articolata politica di sviluppo economico e sociale che può contare sul forte sostegno delle Istituzioni Finanziarie Internazionali e dei principali attori mondiali.
1. Andamento congiunturale
Il Ruanda è un Paese molto povero con circa il 90% della popolazione impegnato nell’agricoltura (principalmente di sussistenza, ben il 52% della popolazione del Ruanda continua ad avere un reddito inferiore ad un dollaro al giorno). Esso è inoltre il Paese africano più densamente popolato (337 abitanti/km²), non ha uno sbocco al mare, dispone di poche risorse naturali ed ha una struttura industriale minima.
I prodotti più importanti del Ruanda (che rappresentano anche le principali voci delle esportazioni) sono il caffè, il tè (rispettivamente 40% e 30% delle esportazioni) e la colombo-tantalite (coltan). Le esportazioni risentono chiaramente della fluttuazione delle quotazioni internazionali e delle condizioni climatiche.
Le modeste risorse minerarie consistono in giacimenti di ferro, tungsteno, colombo-tantalite, piretro, cassiterite e, in misura molto ridotta, oro.
Il Ruanda ha comunque compiuto importanti progressi verso la stabilizzazione e la riabilitazione della sua economia: nell’immediato dopo-genocidio il sostegno della comunità internazionale alla ricostruzione del Paese ha portato a tassi di crescita molto elevati (oltre il 10% del PIL negli anni compresi fra il 1995 ed il 2000).
Dopo il 2000 la crescita economica è continuata, anche se a tassi inferiori a quelli del quinquennio 1995/2000: nel 2005 si è registrata una crescita del PIL di circa il 6,3% e nel 2006 si stima che la crescita sia stata del 4,3%. Per il 2007-2008 ci si attende un aumento del PIL maggiore.
Tale crescita economica, che è ancora legata soprattutto alle produzioni agricole di caffè e tè, riceve una forte spinta anche dalle attività edilizie che negli ultimi anni stanno vivendo un’importante crescita a Kigali e nei maggiori centri del paese.
Come si è già accennato, i notevoli progressi economici del Ruanda sono anche il risultato dell’impegno delle Autorità ruandesi nel perseguire riforme strutturali volte alla stabilizzazione macroeconomica ed alla riduzione della povertà nel Paese.
Tale impegno ruandese è stato condotto sotto l’attenta guida delle Istituzioni Finanziarie Internazionali e, nel luglio 2002, il FMI ha adottato un programma di assistenza finanziaria PRGF (“Poverty Reduction and Growth Facility”) in favore del Ruanda per un ammontare di 5 milioni di dollari.
La piena realizzazione di tale programma ha permesso la concessione di nuovi finanziamenti da parte della Banca Mondiale (per un ammontare di circa 800 milioni di dollari) e l’inclusione del Paese nell’iniziativa per la cancellazione del debito (HIPC); inclusione raggiunta nell’aprile 2005 e che era stata a lungo frenata dal coinvolgimento del Ruanda nei conflitti della regione dei Grandi Laghi, in particolare in quello congolese.
Al fine di riportare il Paese nei parametri di stabilità previsti dall’iniziativa HIPC, il Club di Parigi ha deciso, nel maggio 2005, di cancellare il 100% del debito ruandese verso il Club.
Per attuare le riforme economiche necessarie a garantirsi il sostegno delle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), il Governo ruandese ha inoltre dato il via ad un ambizioso programma di privatizzazioni e liberalizzazioni, concordato con la Banca Mondiale, che dovrebbe coinvolgere tutti i principali settori produttivi del Paese, dalle coltivazioni di tè e caffè all’energia elettrica. Tale programma di privatizzazioni dovrebbe inoltre permettere un aumento degli investimenti esteri diretti in Ruanda.
Dalla capacità di perseguire questo obiettivo dipende buona parte del successo del “Poverty Reduction Strategy Paper” che è stato concordato con le IFI.
Oltre alle politiche di stabilizzazione macroeconomica, di riduzione della povertà, e volte a far crescere il settore privato, le Autorità ruandesi stanno puntando a sviluppare alcuni settori di eccellenza che possano servire da volano per lo sviluppo economico.
In tale prospettiva, il Governo ruandese ha ad esempio lanciato dei programmi volti allo sviluppo dei trasporti aerei, dell’informatica e delle nuove tecnologie.
E’ stata così avviata una collaborazione con imprese leader del settore tecnologico (come la CISCO SYSTEMS), sono stati organizzati eventi come la Conferenza su “Informazione e Comunicazione” che si terrà a Kigali il prossimo ottobre e sono stati avviati importanti progetti in campo tecnologico, come la costruzione di una centrale solare che sarà la più grande del continente africano.
Va poi segnalato il crescente avvicinamento, sul piano economico, fra le Autorità ruandesi e la Cina (di recente lo stesso Presidente Kagame si è recato in visita nel Paese), i cui aiuti economici, come è noto, non sono limitati dalle condizionalità poste per il sostegno economico proveniente dai Paesi occidentali.
Va infine sottolineato come il Ruanda annetta grande importanza all’integrazione regionale dell’Africa centrale. Il Paese ha aderito all’area di libero scambio COMESA (Common Market of Eastern and Southern Africa) e, a partire dal primo luglio 2007, è entrato a far parte, insieme al Burundi, dell’East African Community, che unisce i Paesi più sviluppati della regione (Kenia, Tanzania ed Uganda, oltre ai due suddetti).
|
POLITICA ESTERA a cura del MAE |
Piano regionale
I rapporti con l’Uganda, inizialmente alleato del Ruanda negli anni immediatamente successivi al 1994, si sono deteriorati nel corso del conflitto in Congo quando si verificarono, a più riprese fra la fine del 1999 ed il 2000, scontri fra gli eserciti dei due Paesi, causati da divergenze in merito all’uso delle risorse naturali congolesi.
Ulteriori motivi di frizione sono inoltre nati dal sostegno offerto dal Ruanda al candidato di opposizione alle elezioni presidenziali ugandesi del marzo 2001, Kizza Besigye.
Da allora i rapporti, che continuano a permanere tesi, sono comunque andati migliorando grazie anche ad alcuni incontri fra Kagame e Museveni. In particolare, molto apprezzata da parte ruandese è stata la partecipazione del Presidente Museveni alla cerimonia di investitura di Kagame, dopo la vittoria di quest’ultimo alle elezioni presidenziali del 2003, e alla commemorazione per il decennale del genocidio, svoltasi nell’aprile 2004.
Con la firma degli Accordi di Pretoria del 30 luglio 2002, il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo (RDC) si sono accordati reciprocamente per il ritiro delle truppe ruandesi dal Congo e per la neutralizzazione delle c.d. “forze negative”, ovvero le milizie Hutu, già appartenenti alle vecchie forze armate ruandesi, ingaggiate dal Congo per destabilizzare lo Stato confinante. Tale accordo ha sancito la fine del conflitto tra la RDC e il Ruanda, scoppiato nel 1999 allorquando Kigali ha preso le armi contro l’ex alleato Laurent Kabila, Presidente del Congo, che aveva cercato di sganciarsi dall’influenza del potente alleato ruandese.
Il 5 ottobre 2002 il Ruanda ha completato il ritiro delle proprie truppe dal territorio congolese secondo quanto stabilito dai predetti Accordi di Pretoria. Un ulteriore decisivo passo verso la normalizzazione dei rapporti fra Ruanda e Congo è stato compiuto con la formazione del nuovo Governo Transitorio di Unità Nazionale congolese, che ha al proprio interno personalità appartenenti alle fazioni filo-ruandesi.
Nonostante il riavvicinamento, il Ruanda ha continuato a nutrire l’ambizione di una sorta di ”droit de regard” su parte del Congo orientale.
Nel maggio 2004 si sono verificati nuovi scontri nel capoluogo congolese di Bukavu che hanno rinfocolato il contrasto tra la RDC ed il Ruanda. Infatti, il Governo ruandese è stato accusato da Kinshasa di ingerenze nella crisi della città di Bukavu, scoppiata quando il generale Nkunda, dell’etnia filo-ruandese Banyamulenge, ha occupato la città. Lo stesso presidente Joseph Kabila (figlio di Laurent) ha personalmente ribadito che dietro la ribellione del generale Nkunda vi è stato l’appoggio militare e logistico di Kigali. A tale conclusione è giunta anche l’inchiesta condotta dalle Nazioni Unite sui fatti di Bukavu.
Il nocciolo della questione consiste nel fatto che il Ruanda continua ad accusare Kinshasa di non fare abbastanza per neutralizzare e disarmare i gruppi di ribelli ruandesi rifugiatisi nel Congo orientale (gruppi in cui sono presenti anche alcuni dei responsabili del genocidio del 1994), mentre la RDC a sua volta accusa Kigali di agitare lo spauracchio di queste formazioni armate come pretesto per continuare a gestire i redditizi interessi economici avviati negli anni del conflitto congolese (1996-1999). Di fatto la questione degli ex-genocidari resta la minaccia maggiore alla pace nella regione dei Grandi Laghi.
Nei primi mesi del 2005 anche la Comunità di Sant’Egidio ha compiuti diversi passi per cercare, assieme ad esponenti del Governo congolese, di persuadere i ribelli ruandesi delle Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) presenti nel Congo orientale a disarmare e a fare rientro in Ruanda. Il 31 marzo le FDLR hanno emesso a Roma una dichiarazione in cui si impegnavano a rinunciare all’opzione armata ed a fare rientro nel loro Paese previa concessione di garanzie di sicurezza da parte di Kigali. Molte speranze erano state riposte su tale iniziativa, a seguito della quale però solo alcuni gruppi miliziani hanno fatto rientro nel proprio Paese.
Migliori risultati sono stati raggiunti dall’azione della missione delle Nazioni Unite in Congo, la MONUC, che si sta altresì occupando della questione; grazie all’opera dei caschi blu, negli ultimi tempi alcune migliaia di combattenti avrebbero fatto rientro in Ruanda (circa il 30/40% di una forza stimata in circa 10.000 unità).
In questi ultimi mesi, si è assistito ad un riacutizzarsi della tensione nelle regioni orientali del Congo, seguito ad un attacco di Nkunda alle FDLR, operazione che sarebbe stata sostenuta dal Governo di Kigali.
Si teme dunque una possibile escalation militare che vedrebbe le forze congolesi attaccare le truppe del Generale Nkunda, eventualmente con l’ausilio delle stesse FDLR e degli altri gruppi nazionalistici diffusi nelle travagliate aree di frontiera, come i Mai-Mai.
Per il moltiplicarsi dei segnali di tensione, il Consiglio di Sicurezza, lo scorso 23 luglio, ha adottato una Dichiarazione Presidenziale in cui si invitano gli attori coinvolti a cercare una soluzione politica alla crisi determinatasi nella regione.
Il Presidente congolese Kabila ha dal canto suo più volte indicato come egli non intenda per il momento fare ricorso alla forza, anche se lamenta vivamente l’insubordinazione di Nkunda e le ingerenze del Ruanda.
Una normalizzazione della situazione dovrà necessariamente passare attraverso un dialogo costruttivo con il Governo della RDC ed una trasparente presa di distanze del Ruanda nei confronti di settori renitenti dell’esercito congolese, come quello del Generale Nkunda.
In tale prospettiva, grandi speranze sono riposte sulla visita che il Ministro degli Esteri ruandese Murigande dovrebbe effettuare in Congo il 3 settembre prossimo.
Il sostegno dell’Unione Europea è stato fondamentale nella ripresa del Ruanda post-genocidio. Negli ultimi 4 anni la Commissione europea ha dato vita a dei programmi nel settore istituzionale volti a rafforzare l’apparato amministrativo ed a favorire il reinserimento degli ex combattenti nella società civile per un ammontare di circa 49 milioni di Euro. Oltre a ciò ha contribuito agli sforzi delle Autorità per l’organizzazione delle elezioni del 2003 e per l’istituzione dei tribunali “gachacha” (per un valore superiore ai 6 milioni di Euro negli anni 2002-2004).
Oltre alla cooperazione posta in atto dalla Commissione europea va segnalato il ruolo cruciale svolto dall’assistenza allo sviluppo prestata dai Paesi nordici (in particolare Svezia e Paesi Bassi) oltre alla Gran Bretagna. Quest’ultima resta l’alleato di riferimento del Ruanda, mentre specularmente cattivi sono i rapporti con la Francia, per il sostegno da questa offerto ai regimi hutu prima del genocidio. Durante le commemorazioni per il decennale del genocidio, nell’aprile 2004, il Presidente Kagame ha lanciato veementi accuse alla Francia dalla tribuna dello stadio di Kigali, tacciando Parigi di connivenza con gli autori del genocidio. Tali gravi affermazioni hanno provocato il rientro anticipato del Capo della delegazione francese alle commemorazioni, il Sottosegretario agli Affari Esteri Muselier.
Un ulteriore inasprimento delle relazioni con la Francia si è avuto dopo che, nel novembre 2006, il pubblico ministero francese Bruguiére (titolare dell’inchiesta sul decesso dei piloti francesi dell’aereo presidenziale su cui viaggiava il Presidente Habyarimana nell’aprile 1994) ha posto in stato d’accusa il Presidente Kagame per l’attentato che fu all’origine del genocidio del ’94. La reazione del Ruanda è stata, come al solito, molto aspra ed ha portato alla chiusura dell’Ambasciata a Parigi ed all’espulsione dei diplomatici francesi a Kigali. Allo stato attuale si può parlare di vera e propria rottura delle relazioni diplomatiche.
Va poi segnalato un crescente avvicinamento fra le Autorità ruandesi e Pechino (avvicinamento tradottosi in numerosi scambi di visite fra i due Paesi, fra cui una visita del Presidente Kagame in Cina). Tale avvicinamento si spiega, chiaramente, in termini economici: come è noto, la Cina è difatti sempre più presente economicamente nel continente africano, grazie anche al proprio aiuto economico che non è limitato dalle condizioni esistenti per gli aiuti provenienti dai Paesi occidentali.
Tale positivo tenore delle relazioni con la Cina si somma ai buoni rapporti intrattenuti dal Ruanda con un altro major player della regione: gli Stati Uniti.
Nell’insieme, il Ruanda post-genocidio ha assunto uno status ed una autorevolezza crescenti sia nel continente africano che (malgrado la controversia con la Francia) nei confronti dei Paesi donatori. Uno degli indicatori di tale rinnovato status è costituito dalla crescente presenza del Paese in seno agli organi dirigenti delle organizzazioni internazionali e regionali. In particolare, l’Ambasciatore Patrick Mazimhaka è Vice Presidente della Commissione dell’Unione Africana; l’Ambasciatore Signora Valentie Rugwabiza è uno dei quattro Vice Direttori Generali dell’Organizzazione Mondiale del Commercio; e, soprattutto, l’ex Ministro delle Finanze Donald Kaberuka è stato nominato nel luglio 2005 Presidente della Banca Africana di Sviluppo.
Partecipazione a principali Organizzazioni Internazionali
Unione Africana, Nazioni Unite e Agenzie Specializzate, WTO, Comunità Economica dei Paesi dei Grandi Laghi (CEPGL), Banca Mondiale, Banca Africana per lo Sviluppo, Comunità Economica degli Stati dell’Africa Centrale (CEEAC).
E’ presente con una missione militare in Sudan ed ha espresso la propria disponibilità ad entrare nella forza di pace ONU-UA, decisa nella Risoluzione ONU
|
RAPPORTI BILATERALI a cura del MAE |
I rapporti con il Ruanda sono positivi anche se sostanzialmente limitati alla cooperazione allo sviluppo e al piano squisitamente politico.
In questo contesto si collocano le visite nel Paese dell’ex Sottosegretario per gli Affari Esteri Alfredo Mantica che si è recato in Ruanda nell’aprile 2003 e nell’aprile del 2004 per guidare la delegazione italiana presente alle commemorazioni per il decennale del genocidio.
A fine novembre 2005 anche il Sindaco di Roma Veltroni ha visitato il Ruanda accompagnato da una folta delegazione di studenti romani, che si sono recati al Memoriale del Genocidio e sono stati ricevuti dal Presidente Kagame.
Sempre sul piano dei rapporti politici, nell’agosto 2003 il Governo ruandese ha assicurato il suo sostegno alla candidatura italiana al seggio non permanente del Consiglio di Sicurezza per il biennio 2007-2008.
L’Italia, dal canto suo, ha invece appoggiato il candidato ruandese alla Presidenza della Banca Africana di Sviluppo (BAD) nel ballottaggio del 21 luglio 2005 tenutosi a Tunisi. Grazie anche all’appoggio italiano, il Ministro delle Finanze di Kigali, Donald Kaberuka, è stato eletto Presidente della BAD.
L’Italia ha altresì assicurato il proprio sostegno al Ruanda nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale nel raggiungimento del “completion point” che sancisce il raggiungimento dell’obiettivo della cancellazione totale del debito estero. In passato il soddisfacimento di tale aspirazione ruandese era stata ritardata a causa del coinvolgimento del Paese nei conflitti dell’Africa Centrale, in particolare in Congo.
Un problema fortemente sentito in Ruanda ha riguardato l’adozione di 41 minori ruandesi in Italia nell’immediato post-genocidio, criticata da Kigali per l’asserita violazione delle norme ruandesi relative all’espatrio dei minori ed in particolare per una non adeguata valutazione dello stato di effettivo abbandono dei minori stessi. Negli ultimi tempi non si sono registrati ulteriori sviluppi al riguardo né nuove critiche di parte ruandese e pertanto si ritiene che la disputa stia via via sfumando.
Va poi segnalato che il Ruanda ha sottoscritto la Dichiarazione di associazione sulla messa in moratoria delle esecuzioni capitali e sull’abolizione della pena di morte presentata dall’UE all’Assemblea Generale ONU nel dicembre scorso ed ha comunicato all’Italia, in via bilaterale, la sua volontà di co-sponsorizzare la risoluzione sulla moratoria della pena di morte (si attende che il Ruanda fornisca analoga conferma alla Presidenza UE che presenterà il documento all’Assemblea Generale nel prossimo autunno).
L’interscambio tra l’Italia e il Ruanda si attesta su valori estremamente contenuti (circa 8 milioni di euro nel 2006). Le nostre esportazioni sono costituite essenzialmente da prodotti alimentari, prodotti in metallo, macchinari e abbigliamento. Importiamo invece principalmente pelli preparate, caffè e succedanei del caffè.
Il Paese presenta interessanti opportunità di partenariato, soprattutto in ragione delle politiche di sviluppo economico condotte dal Governo. I settori più interessanti sono certamente quello delle costruzioni, delle nuove tecnologie e dei trasporti. Più in particolare, in tale ultimo campo, vanno segnalati dei contatti fra le Autorità di Kigali e la compagnia aerea Meridiana che sarebbe interessata ad acquisire parte della Rwandair Express, la locale compagnia aerea.
L’Italia non vanta crediti di nessun genere nei confronti del Ruanda.
SACE
Il Ruanda è collocato in 7° categoria di rischio Paese. Per le operazioni a breve e medio - lungo termine la posizione della Sace è di chiusura.
Anche nel quadro del nuovo Programma Africa della SACE Kigali rientra in una delle categorie di rischio più elevate (categoria D), che prevede chiusura con l’eccezione di alcuni progetti da valutare, nel quadro di un Accordo di Protezione degli Investimenti (proposto al Ruanda nel corso del 2005).
Non sono segnalati al 31.12.2005 crediti SACE.
La collettività italiana nel Paese
La collettività italiana, in precedenza composta da circa 250 persone, si è attualmente ridotta a circa 110 unità, in maggior parte religiosi e volontari, che assieme a numerose ONG svolgono una importante azione umanitaria e di sostegno alla popolazione.
Dal marzo 1995 è ripresa l'attività del Consolato Onorario d'Italia in Kigali.
Al 31 dicembre 2004 erano regolarmente residenti in Italia 530 cittadini ruandesi.
Cooperazione allo sviluppo
Premessa
Il Ruanda è il Paese centro-africano con la più alta densità di popolazione (320 persone/Km2).
In considerazione della sua storia, segnata da duri conflitti interetnici, il Paese continua ad essere ancora fragile sul piano della coesione sociale.
Dal punto di vista degli indicatori sociali, si rileva una mediocre aspettativa di vita alla nascita, 49 anni, e un’altissima mortalità neonatale (198/1.000). Più in particolare, i critici indicatori sociali dipendono dalle sacche di povertà assoluta ancora presenti nel Paese e dall’elevata incidenza dell’HIV/AIDS.
La Gran Bretagna rappresenta attualmente il primo donatore bilaterale seguita dagli Stati Uniti. Il Ruanda è inoltre il maggior beneficiario della cooperazione belga con circa 20 milioni di euro annui (stanziati per il triennio 2002-2004) nei settori della salute, dell’educazione, delle infrastrutture e, soprattutto, della giustizia, con un forte appoggio al sistema dei gachacha (tribunali di villaggio). Importanti donatori sono anche i Paesi nordici e la Germania.
Nell’indice di Sviluppo Umano dell’ONU (2005) il Ruanda è al 154° posto su 177 mentre il reddito pro-capite, sempre nel 2005, è stato di 206 dollari (stime Banca Mondiale).
Quadro negoziale
Fra l’Italia ed il Ruanda è stato firmato, nel 1987, un “Accordo tecnico-economico e di cooperazione” e, nel luglio del 1991, è stato firmato un verbale di Commissione Mista che prevedeva, per il triennio 1991-1993, un pacchetto di iniziative del valore complessivo di 30 miliardi di lire.
L’Accordo di cooperazione era stato però firmato dal Governo Habyarimana e, dopo i tragici eventi del 1994, esso è stato considerato nullo dall’attuale Governo ruandese.
Ad oggi non esiste alcun nuovo accordo di cooperazione bilaterale ma solo una “strategia” concordata verbalmente fra la Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, il nostro Ambasciatore a Kampala (competente per il Ruanda) e i vari Ministeri “sociali” ruandesi.
Nell’ambito del sostegno dell’Unione Europea al Ruanda, i fondi assegnati al Paese dal 9° Fondo Europeo di Sviluppo (2001-2007) ammontano a 124 milioni di euro. I settori prioritari di intervento sono il sostegno macroeconomico e il sostegno alle politiche settoriali (in particolare l’agricoltura).
Settori prioritari e principali iniziative
L’Italia interviene in Ruanda soprattutto nel settore sanitario e in quello dello sviluppo rurale.
Dal 1995 al 1998 sono state realizzate nel Paese quasi unicamente attività di emergenza a favore delle vittime della guerra civile ed a sostegno del processo di reintegrazione dei rifugiati rientrati dai paesi limitrofi, iniziative che hanno raggiunto un valore complessivo di circa 20 miliardi di lire.
Nel 2006 è stato concluso il programma sanitario nella regione di Umutara, affidato alla ONG CUAMM, ed è stata avviata la componente Ruanda del programma di lotta all’AIDS (che interessa tre Paesi: Ruanda, Burundi ed Uganda) del valore complessivo di 2,7 milioni di euro realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Sempre nel 2006 è stato varato nella regione dell’Umutara (o Eastern Province) un programma di sviluppo agricolo integrato, del valore di circa 2 milioni di euro, realizzato in parte attraverso l’UNDP e in parte in gestione diretta.
In Ruanda è in corso un solo “programma promosso” da ONG (ONG AVSI) per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e per interventi nel settore socio-educativo e ambientale nella regione di Byumba (i “programmi promossi” vengono proposti dalle ONG e ricevono contributi dal Ministero degli Esteri).
Quanto alla cooperazione decentrata, il Ruanda beneficia di un nostro contributo alla FAO a sostegno di un intervento congiunto, FAO-Comune di Roma, per lo sviluppo agricolo nelle aree periurbane di Kigali, del valore di circa 800.000 euro (di cui 300.000 messi direttamente a disposizione dal comune di Roma). Il programma è stato rifinanziato nel 2006 con 200.000 euro.
Sul canale multilaterale, è stato finanziato nel 2003 un Progetto di assistenza tecnica per la formulazione dei Piani d’Azione Nazionali, completato nel marzo 2005 ed inserito nell’ambito del programma “Education for All”, promosso dall’UNESCO.
Al fine di favorire il processo di pace, e quindi una ritrovata stabilità nell’intera Regione dei Grandi Laghi, il Ruanda è altresì fra i Paesi che beneficiano delle attività del Programma di Smobilitazione Multi-Country Demobilization and Reintegration Programme (MDRP) della Banca Mondiale (contributo italiano di 1.500.000 euro). Il Paese beneficia anche del Programma di assistenza Tecnica AFRITAC del Fondo Monetario Internazionale (contributo italiano 2.100.000 euro).
Il Ruanda (assieme a Etiopia, Sudan, Uganda, Kenya, Egitto, Tanzania, RDC e Burundi) ha beneficiato del programma di gestione delle risorse del bacino del Nilo“Capacity Building for Nile Basin Water Resources Management”, realizzato dalla FAO tra il 1999 e la fine del 2002, con un contributo della Cooperazione allo Sviluppo italiana (DGCS) di 5.250.000 di dollari. Il programma si inserisce ora nel più vasto progetto “Nile Basin Initiative” promosso dalla Banca Mondiale.
Va segnalato altresì che il Ruanda è stata inserito nell’ iniziativa multilaterale (la cui esecuzione è stata affidata all’UNDESA) di assistenza ai Parlamenti africani; il programma, iniziato in Kenya nel settembre 2005, prevede un assistenza tecnica alle dotazioni informatiche dei Parlamenti di Angola, Camerun, Ghana, Kenya, Mozambico, Ruanda, Uganda e Tanzania ed è stato recentemente rifinanziato con 3,5 milioni di euro, il cui stanziamento è stato approvato dal Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo nel luglio 2007.
Prospettive
Quanto ai nuovi progetti di cooperazione che dovrebbero essere avviati dall’Italia in Ruanda, si prevede un nuovo intervento nel settore oftalmico, che dovrebbe iniziare al principio del 2008, per un importo di circa 2 milioni di euro.
Nell’anno in corso continueranno inoltre gli interventi di sviluppo agricolo integrato nella Eastern Province e verrà completato l’intervento, nel settore della lotta all’AIDS, avviato nel 2006 dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Il Ruanda rientra nell’iniziativa regionale di sicurezza alimentare e modernizzazione dell’agricoltura iniziata nei primi mesi del 2007 e da noi finanziata attraverso la FAO con 3 milioni di dollari.
DATI STATISTICI BILATERALI
|
|
|
|
PRINCIPALI ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI ITALIANE (2006)
ESPORTAZIONI |
IMPORTAZIONI |
|
1. Macchine ed apparecchi per l’industria alimentare |
1. Cuoio e pelli preparate |
|
2. Manufatti in metalli comuni |
2. Caffè e succedanei del caffè |
|
3. Macchine e apparecchi speciali per industrie particolari |
3. Prodotti chimici diversi |
|
4. Macchine ed apparecchi per riscaldamento e refrigerazione |
4. |
|
5. Autoveicoli per trasporto merci e per usi speciali |
5. |
|
6. Apparecchiature per taglio, sezionamento. Protezione, diramazione, raccordo dei circuiti elettrici |
6. |
|
Fonte: ISTAT |
|
|
QUOTE DI MERCATO (2004) |
|||
|
PRINCIPALI FORNITORI |
% su import |
PRINCIPALI ACQUIRENTI |
% su export |
|
1. Kenya |
24,4 |
1. Indonesia |
64,2 |
|
2. Germania |
7,4 |
2. Cina |
3,6 |
|
3. Belgio |
6,6 |
3. Germania |
2,7 |
|
4. Uganda |
6,3 |
4. Malesia |
1,7 |
|
5. Francia |
5,1 |
5. Stati Uniti |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
Italia |
1,82 |
Italia |
0,38 |
|
Fonte: EIU – ISTAT |
|||
|
SACE 30.09.2006–( milioni di Euro) |
|
Categoria di rischio |
7 chiusura |
|
Impegni in essere (a) |
0 |
|
Indennizzi erogati da recuperare (b) |
0 |
|
Esposizione complessiva (a+b) |
0 |
Fonte: SACE