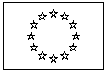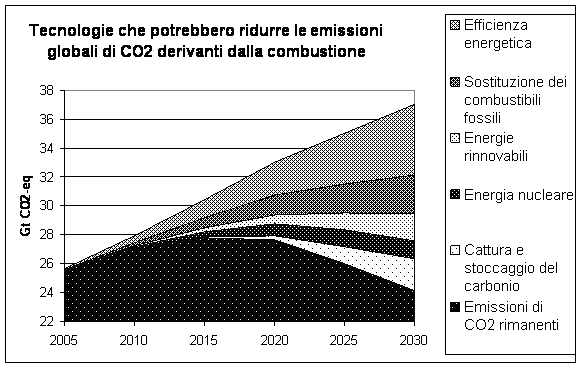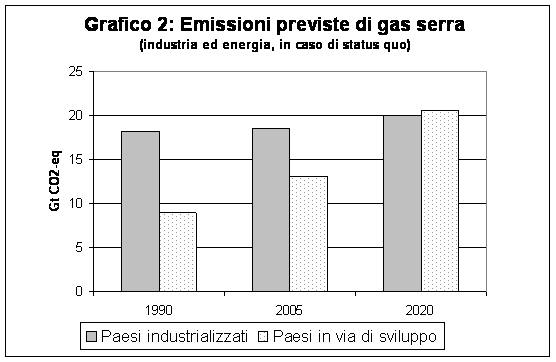Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
|
|---|
| Autore: |
Servizio Studi - Dipartimento ambiente
|
| Altri Autori: |
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
|
| Titolo: |
G8+5 Climate Change Dialogue Forum dei legislatori - Berlino 3-4 giugno 2007
|
| Serie: |
Documentazione e ricerche
Numero:
75
|
| Data: |
31/05/2007
|
| Descrittori: |
| CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI |
INQUINAMENTO ATMOSFERICO |
|
| Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
|
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
|
servizio studi
|
segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue
|
Documentazione e
ricerche
G8 + 5 Climate Change Dialogue
Forum dei legislatori
(Berlino, 3-4 giugno 2007)
n. 75
31 maggio 2007
Dipartimento Ambiente
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. La
Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge.
File: Am0079.doc
Il Protocollo di Kyoto
impegna i Paesi industrializzati ed i Paesi con economia in transizione a
ridurre le emissioni di gas in grado di alterare l’effetto serra del
pianeta entro il 2012.
Per garantire
un’attuazione flessibile del Protocollo e una riduzione di costi gravanti
complessivamente sui sistemi economici dei paesi soggetti al vincolo sono stati
introdotti i seguenti meccanismi
flessibili:
§
l’emission trading (commercio dei diritti di emissione), in base al quale i paesi soggetti al vincolo
che riescano ad ottenere un surplus nella riduzione delle emissioni possono
“vendere” tale surplus ad altri paesi soggetti a vincolo che - al
contrario - non riescano a raggiungere gli obiettivi assegnati;
§
la joint implementation(attuazione congiunta degli obblighi
individuali), secondo cui gruppi di paesi soggetti a
vincolo, fra quelli indicati dall’Annex
I, possono collaborare per raggiungere gli obiettivi fissati accordandosi
su una diversa distribuzione degli obblighi rispetto a quanto sancito dal
Protocollo, purchè venga rispettato l'obbligo complessivo. A tal fine
essi possono trasferire a, o acquistare da, ogni altro Paese “emission reduction units”(ERUs)
realizzate attraverso specifici progetti di riduzione delle emissioni;
§
i clean development mechanisms(meccanismi per lo sviluppo pulito) , il cui fine è quello di fornire
assistenza alle Parti non incluse nell’Annex I negli sforzi per la riduzione delle emissioni. I privati o
i governi dei paesi dell’Annex I
che forniscono tale assistenza possono ottenere, in cambio dei risultati
raggiunti nei paesi in via di sviluppo grazie ai progetti, “certified emission reductions”
(CERs) il cui ammontare viene calcolato ai fini del raggiungimento del target.
|
Protocollo di Kyoto
Impegni
assunti[5]
|
Riduzione
(entro il 2008-2012) dei gas serra rispetto ai livelli del 1990
|
|
Stati membri UE
|
8%
|
|
USA
|
7%
|
|
Giappone
|
6%
|
|
Canada
|
6%
|
|
Totale paesi Annex I
|
5,2%
|
Il
Protocollo di Kyoto riconosce all’Unione europea (che ha provveduto a
ratificarlo in data 31 maggio 2002) la facoltà di ridistribuire tra i suoi
Stati membri gli obiettivi ad essa imposti, a condizione che rimanga invariato
il risultato finale. Con la decisione politica nota come accordo sulla
ripartizione degli oneri (raggiunto nel Consiglio Ambiente del 16-17 giugno
1998) sono state fissate le seguenti percentuali di riduzione:
|
Austria
|
-13%
|
|
-6,5%
|
|
Belgio
|
-7,5%
|
Lussemburgo
|
-28%
|
|
Danimarca
|
-21%
|
Paesi
Bassi
|
-6%
|
|
Finlandia
|
0%
|
Portogallo
|
+27%
|
|
Francia
|
0%
|
Regno
Unito
|
-12,5%
|
|
Germania
|
-21%
|
Spagna
|
+15%
|
|
Grecia
|
+25%
|
Svezia
|
+4%
|
|
Irlanda
|
+13%
|
|
|
Il protocollo è diventato vincolante a livello internazionale il
16 febbraio 2005 in seguito al deposito dello strumento di ratifica da parte
della Russia, con notevole ritardo rispetto alla firma del protocollo medesimo,
causato dall'uscita dal Protocollo degli USA, che rappresentano da soli il 36%
delle emissioni dei Paesi industrializzati.
Si ricorda, infatti,
che l’art. 24 del Protocollo ne ha previsto l’entrata in vigore 90
giorni dopo la ratifica da parte di almeno 55 paesi firmatari della
Convenzione, comprendenti un numero di paesi dell’Annex I a cui sia riferibile almeno il 55% delle emissioni
calcolate al 1990.
La ratifica
dell’Italia
Per quanto riguarda
l’Italia, la ratifica del
protocollo di Kyoto è avvenuta con la legge 1° giugno 2002, n. 120, la quale reca anche una serie di
disposizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas serra.
L’art. 2, comma
1, dispone, infatti, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 30 settembre 2002, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati,
è tenuto a presentare al CIPE un piano di azione nazionale per la
riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro
assorbimento ed una relazione contenente lo stato di attuazione e la proposta
di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998.
Nel medesimo comma
viene previsto, inoltre, che la suddetta relazione debba riguardare anche lo
stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999,
n. 500 e del D.M. ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché dei programmi
pilota previsti dal successivo comma 3, in cui si prevede che il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno,
individui, con proprio decreto e di concerto con i ministri interessati e con la Conferenza unificata
Stato-regioni-città, i programmi pilota da attuare a livello nazionale
ed internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni
forestali per l'assorbimento del carbonio e che (comma 4) entro il 30 novembre di ogni
anno il Ministro dell’ambiente trasmetta al Parlamento una relazione
sulla loro attuazione.
In attuazione di tali
disposizioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha
provveduto ad elaborare il Piano nazionale
per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra:
2003-2010 (per consentire all'Italia di rispettare gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il
2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto), nonché la proposta di
revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, recante le
“linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra”.
Tali documenti, approvati con la delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, contengono, secondo quanto previsto dalla
legge di ratifica, l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate
al contenimento ed alla riduzione delle emissioni di gas serra.
Nella legge di ratifica
viene specificato che tali azioni devono tendere al raggiungimento dei migliori
risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento
dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore
utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, all'aumento degli assorbimenti di
gas serra derivanti dalle attività e dai cambiamenti di uso del suolo e
forestali, alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di
Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi
industrializzati (joint implementation)
e con quelli in via di sviluppo (clean
development mechanism), e, infine, all’accelerazione delle iniziative
di ricerca e sperimentazione per l’introduzione dell’idrogeno quale
combustibile e per la realizzazione di impianti per la produzione di energie
alternative pulite (biomasse, biogas, combustibile derivato dai rifiuti,
impianti eolici, fotovoltaici, solari).
Per il finanziamento
di tali misure è da ultimo intervenuto l’art. 1, commi 1110-1115, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007),
che ha istituito presso la Cassa
depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo
rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti
pubblici o privati) di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo
di Kyoto, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2007-2009.
In particolare, il comma
1112 dispone che, per il triennio considerato, siano finanziate
prioritariamente le seguenti misure:
a) installazione di
impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di
impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la
generazione di elettricità e calore;
c) sostituzione dei
motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta
efficienza;
d) incremento
dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
e) eliminazione delle
emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di
ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse
emissioni o ad emissioni zero
La direttiva 2003/87/CE
Un’importante
iniziativa in tal senso è stata intrapresa dall’Unione europea con
l’emanazione della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità -
denominato Emission Trading System
(ETS) - al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri
di efficacia dei costi ed efficienza economica.
Tale direttiva, che
rappresenta la prima fase attuativa del Programma europeo sul cambiamento
climatico (European Climate Change Programme
- ECCP) lanciato nel giugno del 2000 dalla Commissione Europea, prevede
l’istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea a partire
dal 2005 da affiancare all’emission
trading previsto su scala globale dal Protocollo.
La direttiva si applica
alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai
gas a effetto serra elencati nell'allegato II. In particolare alle emissioni di
anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica,
produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione di prodotti
minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.
Gli obblighi previsti per gli impianti da
essa regolati sono:
1)
possedere un permesso all’emissione in
atmosfera di gas serra;
2)
rendere alla fine dell’anno un numero di
quote (o diritti) d’emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate
durante l’anno.
Le quote
d’emissioni vengono rilasciate dall’autorità nazionale
competente (ANC) all’operatore di ciascun impianto regolato dalla
direttiva sulla base di un piano di
allocazione nazionale; ogni quota (cd. European
Unit Allowance – EUA) dà diritto al rilascio di una tonnellata
di biossido di carbonio equivalente.
Il piano di
allocazione nazionale (redatto in conformità ai criteri previsti
dall’allegato III della direttiva) prevede l’assegnazione di quote
a livello d’impianto per periodi di tempo predeterminati (il primo
è individuato dalla direttiva nel triennio 2005-2007, mentre i
successivi nei quinquenni 2008-2012, 2013-2017, ecc).
Esso, inoltre, deve
essere coerente con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di
crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di
tutela della concorrenza.
Una volta rilasciate,
le quote possono essere vendute o acquistate. Tali transazioni devono poi essere registrate
nell’ambito di un registro nazionale.
La restituzione delle
quote d’emissione avviene attraverso il registro nazionale ed è
effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle
emissioni reali certificate da un soggetto terzo accreditato dall’ANC.
Con la Decisione della Commissione n. 156 del 29 gennaio
2004 sono state fissate le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE.
Si ricorda, inoltre,
che la direttiva 2004/101/CE (cd.
direttiva linking) ha riconosciuto i
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Joint Implementation e Clean
Developmnet Mechanism) all’interno dell’ETS, stabilendo la
validità dei crediti di emissione (ottenuti grazie all’attuazione
di tali progetti) per rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni.
L’attuazione
nell’ordinamento italiano e l’assegnazione delle quote di emissione
Per quanto riguarda
l’Italia, con il decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono state recepite nell’ordinamento nazionale sia la direttiva 2003/87/CE, sia
la direttiva 2004/101, ed inoltre si è provveduto ad inglobare nel
testo, al fine di predisporre un quadro normativo unitario, le disposizioni
dettate dal D.L. n. 273/2004. Tale ultimo provvedimento era stato emanato
(nelle more del recepimento della direttiva 2003/87/CE) per consentire
l’avvio a partire già dal 2005 del sistema previsto dalla
direttiva stessa.
Il campo di applicazione del decreto (art.
2) riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate
nell’allegato A e relative ai gas-serra elencati nell’allegato B
I punti salienti del citato decreto sono:
§
l’obbligo di autorizzazione per gli
impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, in linea con
le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva;
§
la disciplina procedurale per il rilascio, da
parte dell’ANC per l’attuazione della direttiva,
dell’autorizzazione ad emettere gas serra (artt. 5-6);
§
l’individuazione di una procedura che, in
linea con le disposizioni della direttiva, conduce dall’approvazione del
Piano nazionale di assegnazione (PNA) all’assegnazione e al successivo
rilascio delle quote di emissioni ai singoli impianti (artt. 10-11);
§
l’istituzione, presso la Direzione RAS del
Ministero dell’ambiente, del “Comitato nazionale di gestione e
attuazione della direttiva 2003/87/CE”, cui vengono affidate le funzioni
di ANC (art. 8);
§
l’istituzione del Registro nazionale delle
emissioni e delle quote d’emissioni presso la succitata direzione RAS,
che svolge le funzioni di amministratore del registro (art. 14);
In data 23 febbraio
2006 il Ministero dell'ambiente, dopo un lungo iter, ha emanato il decreto DEC/RAS/074/2006,
recante l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO2
per il periodo 2005-2007 sulla base della Decisione
di assegnazione delle quote di CO2
per il periodo 2005-2007 (allegata al medesimo decreto) che rappresenta la versione
definitiva e revisionata del piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione (PNA), come risultante a seguito delle integrazioni e delle
prescrizioni dettate dalla Commissione europea, che individua il numero di
quote complessivo, a livello di settore e di impianto, per l’attuazione
della direttiva.
Il 18 dicembre 2006 i ministri
dell'ambiente e dello sviluppo economico hanno approvato (con decreto
DEC/RAS/1448/2006) il PNA delle quote di
CO2 per il
periodo 2008-2012.
In
tale piano si legge che “La decisione di ratifica del Protocollo di Kyoto
impone all’Italia di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra
del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, ciò implica che le emissioni
medie nel periodo 2008-2012 non potranno superare 485,7 MtCO2eq/anno.
L’inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra relativo
all’anno 2006 evidenzia che al
2004 le emissioni totali di gas ad effetto serra (580,7 MtCO2eq)
sono aumentate del 11,8% rispetto ai
livelli del 1990 (519,5 MtCO2eq). Pertanto la distanza che
al 2004 separa il Paese dal raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto
è pari a 95,0 MtCO2eq”.
Di conseguenza nello
stesso piano si afferma che “l’assegnazione delle quote nel periodo
2008-2012 dovrà essere parte del più generale impegno di
riduzione delle emissioni e le quote
assegnate dovranno essere ridotte rispetto a quelle del periodo 2005-2007” e che tale approccio è conforme con quanto
indicato dalla Commissione europea nella Comunicazione “Orientamenti
complementari sui Piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio
2008-2012 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione
della UE”.
Viene altresì
indicata in 209,0 MtCO2/anno la quantità totale
media annua che si intende assegnare nel periodo 2008-2012 (tale valore
rappresenta una riduzione di 14,1 MtCO2/anno rispetto
all’assegnazione 2005-2007) che viene ritenuta coerente con
l’obiettivo di Kyoto.
Tale piano è
stato trasmesso alla Commissione europea, che ha
espresso il prescritto parere ai
fini della predisposizione del successivo schema di decisione di assegnazione,
che dovrà essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari
competenti.
Nella nota rilasciata
dalla Commissione europea in data 15
maggio 2007 si legge che “la Commissione ha accolto il
piano nazionale dell’Italia a condizione che vi siano apportati
cambiamenti, tra i quali la riduzione del quantitativo totale di quote di
emissione proposto. L’assegnazione annua autorizzata di quote di
emissione è pari a 195,8 milioni di tonnellate di CO2,
il 6,3% in meno di quanto proposto dall’Italia” (pari a 13,2
milioni di tonnellate di CO2 equivalente anno).
Nella stessa nota la
Commissione “invita l’Italia ad apportare altri cambiamenti al
piano in relazione ai seguenti punti:
- l’Italia
dovrebbe fornire maggiori informazioni sul trattamento che riserverà ai
nuovi soggetti che entreranno nel sistema di scambio delle quote di emissione;
- l’Italia
dovrebbe inserire nel piano gli impianti di combustione (ad esempio gli
impianti di cracking), come fatto da
tutti gli altri Stati membri;
- è necessario
eliminare diversi adeguamenti ex-post previsti;
- il quantitativo
massimo totale dei crediti di emissione concessi a titolo di progetti che rientrano
nel protocollo di Kyoto, eseguiti in paesi terzi sulla base delle norme di
detto protocollo e che gli operatori possono utilizzare per rispettare i propri
impegni in materia di emissioni, non devono superare più del 15% circa
del totale annuo.
L’approvazione
della Commissione dovrà considerarsi automatica una volta che
l’Italia abbia apportato gli opportuni cambiamenti”.
Si ricorda,
infine, che il 2 aprile 2007 è stato avviato il Mercato volontario delle unità di emissione di CO2, gestito dal Gestore del
mercato elettrico (GME), che va ad aggiungersi alle altre “borse
delle emissioni” istituite nel territorio europeo (Exaa- Austria, Ecx-
Olanda, Eex- Germania, Powernext- Francia e Nordpool- Norvegia).
L’Italian Carbon Fund (ICF)
Si segnala, infine, che
anche la Banca mondiale ha intrapreso un programma di emission trading
attraverso l’istituzione del Community Development Carbon Fund, con il
quale verranno acquistati - nei Paesi in via di sviluppo – certificati
legati alla riduzione delle emissioni di gas serra generate da progetti
selezionati e monitorati dalla Banca stessa. Secondo alcuni, con questa
operazione la Banca
Mondiale “si candida a giocare un ruolo centrale nel
futuro commercio mondiale dei certificati di emissione della CO2”.
Tale iniziativa si
affianca ad altre analoghe tra cui quella che nell’ottobre 2003 ha portato alla
stipula di un accordo tra il Ministero dell’ambiente e la Banca Mondiale
volto ad istituire l’Italian Carbon Fund per l’acquisto di crediti
di emissione da progetti che generino riduzioni di emissioni di gas serra
(compatibili con i meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto e con
il nuovo sistema europeo di emission trading) ed apportino benefici
all’ambiente globale, promuovendo nel contempo la diffusione di
tecnologie moderne ed energia pulita in paesi in via di sviluppo e con economie
in transizione.
Tale fondo è un
partenariato pubblico-privato (dal 1° gennaio 2004 il Fondo è aperto
alla partecipazione di aziende private ed agenzie pubbliche italiane)
amministrato dalla Banca Mondiale e dotato di un capitale iniziale di 15
milioni di dollari messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio. L’attuale capitalizzazione ha quasi
raggiunto i 155 milioni di dollari.
L’impegno
finanziario profuso dal Ministero dell’ambiente nell’ICF si
affianca a quello risultante dalla partecipazione dell’Italia al citato Community Development Carbon Fund per un
importo di 7,7 milioni di dollari.
In
Kenya, a Nairobi, si è tenuta, dal 6 al 17 novembre 2006, la dodicesima
Conferenza delle Parti (COP12) e la Seconda Conferenza,
dall'entrata in vigore del Protocollo, delle Parti che lo hanno ratificato
(COP/MOP2).
Nella
stessa sede hanno avuto luogo anche le seconde sessioni dei cd. gruppi ad hoc per i nuovi impegni che i paesi
industrializzati dovranno assumere dopo il 2012 (AWG-COM) e per il dialogo a
lungo termine sull'obiettivo ultimo della UNFCCC (AWG-DIAL).
Durante
lo svolgimento della COP-12 gli argomenti
discussi hanno riguardato essenzialmente la gestione dei meccanismi e delle
attività previste nella Convenzione UNFCCC. Sono stati altresì
affrontati argomenti quali la lotta alla deforestazione, spesso illegale, nei
paesi in via di sviluppo, di cui non si tiene conto nel protocollo di Kyoto;
nonché le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto aereo e
marittimo, attualmente non conteggiate nel Protocollo.
La COP/MOP2 ha invece affrontato alcuni
problemi critici per l'attuazione del Protocollo di Kyoto tra cui la
definizione delle procedure sanzionatorie per i paesi che al 2012 risulteranno
inadempienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di riduzione.
Il
principale argomento in discussione è stato tuttavia quello (affrontato
nell’ambito dell’AWG-COM)
della modifica dell'attuale protocollo di Kyoto (in base all'art. 9 dello
stesso protocollo) in una versione emendata che contenga nuovi impegni e nuove
modalità di attuazione per il periodo successivo al 2012, quando l'attuale protocollo di Kyoto sarà
scaduto. Dopo lunghe ed accese discussioni si è tuttavia convenuto di
rinviare la questione al 2008, successivamente all’acquisizione del
quarto rapporto dell'IPCC (che sarà pubblicato nel corso del 2007) e le
prime conclusioni sulle strategie a lungo termine che il gruppo di lavoro ad
hoc sul dialogo (AWG-DIAL) avrà raggiunto.
È stato inoltre concordato che
il nuovo protocollo che entrerà in vigore successivamente al 2012
dovrà contenere chiari obiettivi per l'adattamento ai cambiamenti
climatici comprese le modalità di cooperazione, in questo campo, tra
paesi sviluppati ed in via di sviluppo.
Nell’ambito
del gruppo relativo al dialogo a lungo termine (AWG-DIAL) la discussione è partita dal recente Rapporto
Stern sui possibili danni alle economie nazionali e al prodotto lordo
internazionale causati dai cambiamenti del clima. La discussione
proseguirà prossimamente su due punti prioritari: le questioni
dell'adattamento ai cambiamenti climatici, e le questioni delle nuove
tecnologie per combattere i cambiamenti del clima.
Il Rapporto Stern
Tale rapporto, coordinato da Nicholas Stern, economista ed
attuale consigliere del Governo Britannico, evidenzia come il costo degli
effetti del cambiamento climatico possa far supporre una caduta del PIL
mondiale tra il 5% ed il 20% e come l’attuazione di misure finalizzate ad
evitare un aumento di più di due gradi centigradi della temperatura
media, rappresenterebbe appena l’1% del PIL mondiale. Questo Rapporto
elenca anche quali potrebbero essere le conseguenze del cambiamento climatico
in diverse regioni del mondo, se si arrivasse a superare il suddetto aumento di
temperatura, limite che si considera come massimo affinché siano ancora
possibili forme di “contenimento”.
Si
segnala, inoltre, che nel corso del Meeting
ad alto livello dei ministri e capi di stato sono state evidenziate alcune
priorità, tra cui l’urgenza di procedere dopo il 2012 a riduzioni più
drastiche delle emissioni di gas serra.
Si
ricorda, in proposito, che nel corso della Conferenza è stato presentato
un documento che afferma che, per essere stabilizzate, le emissioni nella
atmosfera debbono essere ridotte di almeno il 50% rispetto al 2000, sebbene non
indichi in che data. La
Germania ha proposto una riduzione del 30% entro il 2020,
mentre la Finlandia
a nome della UE ha ribadito la sua proposta di una riduzione fino al 60% entro
il 2050. Altri paesi, tra cui gli USA, pur riconoscendo la necessità di
raggiungere importanti obiettivi di riduzione non ritengono che la strada dei
vincoli e degli obblighi sia percorribile.
Il
14 e il 15 febbraio 2007 si è tenuto a Washington il Secondo Forum dei
legislatori del Dialogo sul cambiamento climatico dei Paesi G8 (Canada,
Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti)+ 5
(Cina, India, Messico, Brasile e Sud Africa). Il Dialogo si pone l'obiettivo di
discutere un accordo sui cambiamenti climatici «post 2012», ovvero
sul periodo successivo alla prima scadenza del Protocollo di Kyoto sulla
riduzione delle emissioni dei gas serra, al fine di stabilire la più
ampia convergenza sugli obiettivi ambientali a livello mondiale.
Il
Forum di Washington, al quale hanno preso parte sessantaquattro parlamentari,
provenienti da tutti i paesi G8+5, ed otto parlamentari europei, aveva
l'obiettivo di presentare una piattaforma comune sul cambiamento climatico al
prossimo Vertice del G8, che si terrà a Heiligendamm, in Germania, nel
giugno 2007, sotto la
Presidenza tedesca.
Il
Forum poneva come punto di partenza della discussione le conclusioni della
prima parte del quarto “Assessment Report” dell’IPCC pubblicata il 2 febbraio 2007, che ha
accertato - con una probabilità del 95% - come siano state le
attività dell'uomo condotte dalla rivoluzione industriale ad oggi a
determinare il riscaldamento del pianeta.
Il Quarto Rapporto
dell’IPCC
L’approvazione definitiva del quarto “Assessment
Report” (AR4) dell’IPCC è prevista al termine della sessione
che si terrà a Valencia, in Spagna, dal 12 al 16 novembre 2007. Una
volta completato, tale rapporto costituirà la base scientifica del
negoziato che si terrà, nel dicembre 2007, alla Conferenza Onu di Bali,
in cui si dovrà decidere il futuro del Protocollo di Kyoto dopo la
scadenza del 2012.
Tale rapporto sarà composto principalmente di tre parti,
risultato di gruppi di lavoro specifici, che sono già state approvate ed
ora consultabili sul sito internet del Comitato.
Nella prima parte,
intitolata “I principi fisici di
base”, viene sottolineato che le concentrazioni atmosferiche attuali
di anidride carbonica e degli altri gas serra sono le più alte mai
verificatesi negli ultimi 650.000 anni e che l’aumento
dell’anidride carbonica atmosferica osservatosi negli ultimi 200 anni
(pari ad oltre il 35%) è causato dallo squilibrio complessivo tra
emissioni globali di anidride carbonica provenienti dalle attività umane
ed assorbimenti globali naturali da parte del suolo degli oceani e degli
ecosistemi terrestri e marini. In altre parole, rispetto all’effetto
serra naturale è stato introdotto un effetto serra aggiuntivo. Per
quanto riguarda l’evoluzione futura, secondo l’IPCC,
l’ipotesi più probabile appare quella secondo cui l’aumento
della temperatura media globale sarà compreso fra 0,6 e 0,7°C al
2030 e raggiungerà circa 3°C o poco più nel 2100. Tale ultimo
innalzamento, se si verificasse, determinerebbe un innalzamento del livello del
mare tra i 28 ed i 43 cm, purché, però, non si inneschino
fenomeni non lineari o di destabilizzazione del sistema climatico
(velocità del riscaldamento medio globale superiore a 0,4° C per
decennio). In tal caso, infatti, i ghiacci della Groenlandia e quelli della
penisola Antartica, potrebbero collassare e l’innalzamento del livello
del mare potrebbe arrivare perfino a 7 metri, anche se ciò
avverrà nei secoli successivi al 2100. Si segnala, inoltre, che la
calotta polare artica (quella formata dai ghiacci galleggianti) potrebbe, nel
2100, scomparire durante i mesi estivi o comunque ridursi al 10% della attuale
estensione e che gli estremi climatici quali le ondate di calore, le
precipitazioni intense ed alluvionali delle medie ed alte latitudini,
prolungati periodi di siccità alle medie e basse latitudini,
diventeranno sempre più frequenti ed intensi.
Nella seconda parte,
intitolata “Impatti, adattamento e
vulnerabilità”, vengono descritte le conseguenze
dell’effetto serra sulle popolazioni e sull’ambiente e viene
sottolineato il rischio di spostamenti geografici di specie, perdite totali di
biodiversità, riduzione della produttività agricola e delle
risorse idriche in vaste aree. Oltre agli effetti fisici, il rapporto dell'IPCC
prefigura anche scenari preoccupanti per quanto riguarda la salute soprattutto
delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.
Il rapporto precisa che “alcune mosse per l'adattamento
sono in corso, ma ancora molto limitate” e che “gli impatti sono
destinati a crescere insieme alle temperature. E sebbene i primi impatti del
cambiamento climatico possano essere arginati con misure di adattamento, queste
avranno un minor impatto e un maggior costo via via che la temperatura
aumenta”.
La conclusione della seconda parte è, dunque, che gli
impatti negativi saranno inevitabili, che le vulnerabilità saranno
aggravate dalla povertà e che le iniziative di adattamento vanno
accompagnate da misure di mitigazione, ovvero di contenimento delle emissioni,
sullo stile del Protocollo di Kyoto.
Nella terza parte,
intitolata “Mitigazione dei
cambiamenti climatici” e pubblicata all’inizio di maggio,
l’IPCC – sottolinea che l'effetto serra si può contrastare
senza costi esorbitanti (circa lo 0,12% nella crescita del PIL mondiale da qui
al 2030), ma saranno cruciali i prossimi 20-30 anni e le emissioni dei gas
responsabili devono cominciare a calare già dal 2015, per poi ridursi
gradualmente e arrivare nel 2050 a un 50-85% in meno rispetto ai livelli del
2000. Un obiettivo giudicato realistico grazie alle innovazioni tecnologiche e
che permetterebbe di contenere l'aumento della temperatura tra i 2 e i 2,4
gradi, soglia sopra la quale gli esperti ritengono si corrano gravissimi rischi
per l'ambiente.
Nel rapporto viene ricordato, inoltre, che le emissioni di gas
serra sono aumentate del 70% dal 1970 e che, senza un cambiamento di rotta
sull'impiego dei combustibili fossili, cresceranno del 90% nei prossimi 25
anni. Per attuare tale cambiamento di rotta il rapporto suggerisce, tra
l'altro, l'importanza delle energie rinnovabili, di frenare la deforestazione e
di migliorare l'efficienza energetica, nonché di far aumentare il costo
dei combustibili fossili, anche agendo sulla leva fiscale.
Il
Forum è stato caratterizzato da due
aspetti di particolare importanza nella politica relativa al cambiamento
climatico.
Il
primo è rappresentato dal radicale
mutamento nell'orientamento americano rispetto al cambiamento climatico,
annunziato dalla maggior parte dei rappresentanti statunitensi. Il tema del
cambiamento climatico rappresenterebbe una priorità assoluta per gli
USA, rispetto alla quale essi intenderebbero assumere la leadership mondiale.
Il
secondo passaggio di particolare rilievo politico è stato rappresentato
dalla posizione in merito ai gas serra
dell'Europa. Al riguardo è intervenuta in videoconferenza la Cancelliera tedesca
Angela Merkel, che ha ricordato che già nella primavera 2007 l'Unione europea
dovrà sviluppare un programma post 2012 per i paesi industrializzati. In
tale prospettiva, il conseguimento dell'obiettivo posto dall'Unione europea di
prevedere interventi volti a fare in
modo che la temperatura mondiale non aumenti più di 2 gradi centigradi
rispetto ai livelli preindustriali è il primo risultato da
conseguire e la riduzione delle emissioni di CO2
nei Paesi UE del 20% da qui al 2020, il primo passo da compiere. Tre sono gli
elementi chiave che possono portare al conseguimento di tali risultati: un
aumento globale dell'efficienza energetica; un sempre maggiore ricorso alle
energie rinnovabili; l'utilizzo di incentivi economici. Anche per la Merkel, come già per
i senatori americani, il sostegno di nuove politiche energetiche creerà
nuovi mercati, nuovi incentivi produttivi e, infine, nuovi posti di lavoro.
Il
Commissario europeo per l'ambiente Stravos Dimas, ha richiamato la risoluzione
del Parlamento europeo che prevede la riduzione delle emissioni in tutti i
paesi industrializzati del 30 per cento in comparazione con il livello di
emissioni del 1990 entro il 2020 al fine di conseguire una riduzione tra il 60
ed l'80 per cento entro il 2050.
L'obiettivo che si intende perseguire a livello mondiale
è quello di conseguire una
riduzione di gas serra del 50 per cento nei paesi in via di sviluppo e tra il
60 e l'80 per cento nei paesi sviluppati. Ovviamente per far ciò ci
vuole un accordo mondiale. I paesi industrializzati devono dare l'esempio perché
nel 2020 i paesi in via di sviluppo influiranno sulla produzione di gas serra
più dei paesi OCSE. I mezzi per conseguire tali obiettivi sono: in primo
luogo, l'uso del mercato, attraverso il sistema di scambio di emissioni, che può
diventare il nucleo portante; in secondo luogo, lo sviluppo della ricerca; in
terzo luogo la lotta alla deforestazione, che contribuisce circa per il 20%
all'aumento dei gas serra.
Anche
la Cina, l'India
ed il Brasile hanno manifestato l'intenzione di puntare quanto più possibile
(la priorità per queste economie rimane pur sempre la lotta alla
povertà) su forme di energia pulita e di favorire lo sviluppo
sostenibile. Inoltre, hanno sostenuto la necessità di azioni congiunte
tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo dirette soprattutto al
trasferimento di tecnologia.
Il
Forum di Washington si segnala anche per alcuni interventi di carattere tecnico
di particolare rilievo. Tra questi si richiama, in primo luogo, quello di Sir Nicholas Stern, economista ed attuale
consigliere del Governo britannico, coordinatore del già citato
rapporto, il quale ha ricordato come in esso si evidenzi chiaramente che i costi dell'inazione saranno di gran lunga
superiori a quelli dell'azione. Da qui la necessità di un'azione
urgente per ridurre le emissioni, che rappresenta l'unico modo per garantire
una crescita a lungo termine di tutte le economie-sviluppate, emergenti e
povere.
Lo
stesso Presidente della Banca Mondiale,
Paul Wolfowitz, si è soffermato sui costi economici dell'inazione a
fronte del fenomeno del cambiamento climatico ed ha annunciato che la Banca Mondiale sta
studiando misure volte a sostenere le
economie dei Paesi in via di sviluppo che coniughino lotta alla povertà
ed efficienza energetica.
Si
è inoltre prestata attenzione alla questione dell'adeguamento agli
inevitabili impatti del cambiamento climatico. La Banca Mondiale
calcola, infatti, che questo fenomeno richiederà un'ulteriore somma compresa tra i 10 e i 40 miliardi di dollari l'anno.
Si è evidenziato che, se non si interverrà subito per ridurre le
emissioni, questa cifra aumenterà in modo impressionante e si
determineranno gravi impatti sulla sanità pubblica e sulla
disponibilità di risorse, inclusa l'acqua.
A
conclusione del Forum è stata approvata una dichiarazione finale nella quale si chiede ai Governi dei Paesi del
G8+5 di concordare, nel prossimo Vertice G8, sugli aspetti chiave di un quadro
post 2012 e di richiedere che i negoziati globali su tale quadro includano una
serie di indicazioni, tra cui si ricordano: obiettivi a lungo termine per i
Paesi sviluppati; obiettivi adeguati per le economie in via di sviluppo;
incentivi per misure volte a ridurre la deforestazione; incentivi per politiche
e misure di sviluppo sostenibili nei Paesi in via di sviluppo; programmi
concentrati sulla formazione di capacità, sull'accesso alle tecnologie e
sugli incentivi economici, per aiutare i Paesi in via di sviluppo a investire
in tecnologie più efficienti e a basso impiego di carbonio.
Un importante
contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo
può venire dallo sviluppo del settore delle energie alternative. Il
Rapporto Energia e Ambiente 2006 dell’ENEA evidenzia il ruolo fondamentale
delle fonti rinnovabili, che potranno
contribuire nel 2020 alla riduzione delle emissioni nella misura del 27 per
cento.
L’intervento in
questo settore passa attraverso una prima fase di forte impulso alla diffusione
delle tecnologie già oggi disponibili sul mercato (con un’incisiva
promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e per
gli usi termici nel settore civile e per il ricorso a biocarburanti nel settore
dei trasporti) e una successiva fase che prevede un utilizzo generalizzato ed
economico di una seconda generazione delle rinnovabili, frutto della ricerca e
dello sviluppo tecnologico. Le potenzialità delle energie rinnovabili e
la velocità di diffusione delle tecnologie saranno accresciute dal
contestuale sviluppo dei sistemi di generazione distribuita dell’energia
che, oltre a concorrere all’efficienza complessiva del sistema
energetico, incrementano la quota di energia da fonti diffuse sul territorio.
Si segnala, inoltre, che il Rapporto ENEA evidenzia che, in uno scenario di
riduzione delle emissioni di anidride carbonica, accanto ai tradizionali
interventi sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica, si
prospettano altre soluzioni innovative nell’ambito della comunità
scientifica internazionale come quelle che riguardano nuove generazioni di
tecnologie per le fonti rinnovabili, per la produzione e l’utilizzo di
idrogeno e per un uso sicuro ed economico della fonte nucleare.
Nell’ambito
delle fonti rinnovabili, il principale riferimento normativo comunitario
è costituito dalla direttiva
2001/77/CE relativa all’energia elettrica da fonti rinnovabili volta
a favorire un aumento del contributo delle fonti energetiche rinnovabili nella
produzione di elettricità e porre le basi di un quadro comunitario in
materia che consenta di contemperare le due esigenze di garantire la sicurezza
e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e la tutela
dell'ambiente.
Con tale
direttiva, l’Unione europea ha stabilito per ogni Stato membro gli
obiettivi da raggiungere nell’ambito della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili; per
l’Italia l’obiettivo da raggiungersi entro il 2010 è fissato
al 25% di energia elettrica prodotta.
Con la circolare emanata nel 2002 dal Ministro delle attività produttive avente per oggetto Obiettivi indicativi nazionali
di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili per
il periodo 2003-2012 e misure adottate o previste a livello nazionale per
conseguire i medesimi obiettivi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
direttiva 2001/77/CE è stato precisato che gli obiettivi indicati nel Piano nazionale per la riduzione delle
emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010
(consistenti nel raggiungimento, entro il 2010, di una quota di produzione
pari a 75TWh) “sono coerenti
con le indicazioni dell’allegato alla direttiva, e dunque il disposto
della direttiva medesima è soddisfatto”.
La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che ha ulteriormente
innalzato l’obbligo - stabilito dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 (cd. decreto Bersani) - di immettere nella rete nazionale una quota di
energia generata in nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed ha definito
nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime.
Ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, di tale provvedimento, per fonti rinnovabili si intendono: «le fonti energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani».
Il decreto, oltre alla
definizione degli obiettivi indicativi nazionali e delle misure di promozione
da adottare ai fini dello sviluppo della produzione di energia dalle suddette
fonti, contiene disposizioni specifiche relative a singole fonti energetiche,
norme di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi,
la previsione di una campagna di informazione e comunicazione a favore delle
predette fonti, nonché l’inclusione dei rifiuti tra le fonti
energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.
Il provvedimento, che
mira a favorire una crescita significativa, a medio termine, della quota di
elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili prevede, in
particolare:
un incremento pari
annualmente a 0,35 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, della quota minima di energia da fonti
rinnovabili che gli importatori o produttori di energia da fonti non
rinnovabili hanno l’obbligo di immettere sul mercato (quota fissata nel
2% dall'art. 11, D.Lgs. n. 79/99);
la garanzia di origine
dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili rilasciata dal GRTN in
presenza di una produzione annua, ovvero produzione imputabile, non inferiore a
100 MWh;
la semplificazione
delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
il rilascio di autorizzazione unica, da parte della regione o di altro soggetto
istituzionale delegato dalla medesima per la costruzione e l’esercizio
degli impianti di produzione dei energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili;
la partecipazione al
mercato elettrico ed il collegamento degli impianti alla rete elettrica ;
l’ammissione dei
rifiuti a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresa la
frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti;
disposizioni sui
certificati verdi.
Gli incentivi
Il principale
meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da
rinnovabili è costituito dai cd. certificati
verdi, introdotto nell’ordinamento nazionale dall’art. 11 del
d.lgs. n. 79 del 1999, con il quale è stato previsto il
superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip 6.
Tale meccanismo
incentivante consiste nell’obbligo,
posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da
fonti non rinnovabili, di immettere
nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati
a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. La
quota, inizialmente fissata nel 2%, è applicata sulla produzione e sulle
importazioni dell’anno precedente, decurtate
dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di
centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh
successivamente ridotta a 50 GWh. L’elettricità prodotta da fonti
rinnovabili viene immessa in rete godendo della precedenza nel dispacciamento.
Il nuovo strumento di
incentivazione è stato esteso dal comma 71, art. 1, della legge 239/04
di riordino del settore energetico, all’energia elettrica prodotta
mediante utilizzo di idrogeno e quella prodotta da impianti statici con
l’utilizzo dell’idrogeno ovvero con celle a combustibile,
nonché all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
In attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 71 sono stati emanati il DM 24 ottobre 2005
recante “Direttive per la regolamentazione della emissione dei
certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma
71, della legge 23 agosto 2004, n. 239”, e il decreto 24 ottobre 2005,
recante “Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo
11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, che ha
ulteriormente rafforzare l’incentivazione dei rifiuti di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03.
Il GSE (Gestore
dei Servizi Elettrici) ha il compito di qualificare gli impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), una volta accertato il possesso dei
requisiti previsti.
In particolare,
possono ottenere la qualificazione IAFR gli impianti entrati in esercizio
successivamente al 1°aprile 1999 a seguito di nuova costruzione,
potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione e gli impianti che
operano in co-combustione entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 che
rispettino le condizioni specifiche previste per la qualificazione degli
impianti nel suddetto decreto MAP 24/10/2005 .
La qualificazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è necessaria per poter
riconoscere successivamente al produttore, a determinate condizioni, una quota
di Certificati Verdi proporzionale all'energia prodotta, con i quali i soggetti
sottoposti all’obbligo della quota minima comprovano l’adempimento.
Per i soggetti che
non rispettano l’obbligo, la cui verifica di adempienza è affidata
al GSE, sono previste sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso
al mercato complessivo dell’energia elettrica.
Il meccanismo dei
certificati verdi non rappresenta l’unica forma nazionale di sostegno al
settore delle energie rinnovabili.
In attuazione del
disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 387/03, il DM 28 luglio 2005 del
Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero
dell’ambiente (come integrato dal DM 6 febbraio 2006 e, da ultimo, dal DM 19 febbraio 2007), definisce criteri di incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte
solare coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/54/CE,
introducendo una nuova modalità di incentivazione per la produzione di
energia da impianti fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1000 kW di
potenza elettrica. Si prevede, in particolare, , il ricorso al cosiddetto
“conto energia”, in sostituzione
del precedente sistema di incentivazione basato esclusivamente su contributi in
conto capitale - erogati a livello regionale, nazionale o comunitario sotto
varie forme - e idoneo a finanziare il 50-75 % del costo di investimento.
Si segnalano, in
tema di incentivazione delle fonti rinnovabili, anche l’emanazione del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio
2005 di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di
altri carburanti rinnovabili nei trasporti, nonché l’istituzione
per il 2005 (prevista dall’art. 1,
comma 248, della legge n. 311/2004 - legge finanziaria 2005) di un Fondo per la promozione delle risorse
rinnovabili, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro,
finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche relative all’utilizzo
del vettore idrogeno, prodotto a partire da fonti rinnovabili,
nell’ambito di nuovi sistemi di locomozione atti a ridurre le emissioni
inquinanti al fine del miglioramento della qualità ambientale, in particolare
all’interno dei centri urbani.
Per quanto
riguarda la produzione normativa più recente, si richiama la legge n.
296 del 2006 (finanziaria 2007).
Relativamente alle
fonti rinnovabili, i commi da 1117 a 1120
dell’articolo 1 hanno escluso la possibilità di qualificare
e rilasciare Certificati Verdi ai rifiuti e ai combustibili da rifiuti,
prevedendo in particolare che i finanziamenti
e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione
delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica vengano concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi
concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata
concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge, ivi comprese le convenzioni CIP6 e destinate al sostegno alle
fonti energetiche assimilate. Le medesime disposizioni hanno escluso la possibilità
di qualificare e rilasciare Certificati Verdi agli impianti di cogenerazione
abbinati al teleriscaldamento, agli impianti alimentati a idrogeno ed a celle a
combustibile (comma 1120, lettera. g)
La stessa legge
finanziaria prevede altre disposizioni per incrementare la produzione di
energia da fonti rinnovabili:
§ per gli edifici di
nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire è stato
vincolato all’installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kilowatt per ciascuna
unità abitativa (comma 350);
§ le prestazioni di
fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento sono assoggettate all’aliquota IVA
agevolata (comma 384).
Si segnala, inoltre, il
bando emanato dal Ministero dell’ambiente, congiuntamente con MCC S.p.A., per la
promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o
termica tramite agevolazioni alle piccole e medie imprese, sulla base delle
risorse di cui all’art. 5 del D.M. n. 337/2000, pari a circa 25,8 milioni
di euro.
In materia di bioenergie, vengono modificate una
serie di disposizioni relative all’immissione in consumo e alla
tassazione dei biocarburanti (commi da 367 a 379), viene esentato dall’accisa
l’olio vegetale puro
utilizzato a fini energetici nel settore agricolo (commi 380 e 381) e, al fine
di incentivare l’impiego di
prodotti di origine agricola e zootecnica, viene demandata a un decreto
ministeriale la revisione della disciplina dei certificati verdi (commi 382 e 383).
Si segnala che,
all’inizio di quest’anno, il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali ha presentato il primo contratto quadro nazionale sui
biocarburanti, che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una
filiera nazionale delle agro-energie. L’intesa raggiunta rende possibile
l’obiettivo, nel 2007, di 70 mila ettari di terreno per la coltivazione
di semi oleosi a fini energetici e, quindi, di 70 mila tonnellate di bio-diesel
da integrare nel normale carburante, produzione che si spera di triplicare
entro il 2010, raggiungendo i 240 mila ettari (si veda in proposito anche il
comma 1083 della legge n. 296/2006).
Sono inoltre
prorogate al 31 dicembre 2007 le agevolazioni fiscali relative alle emulsioni
stabilizzate, al metano per usi industriali, al gasolio da riscaldamento nelle
zone montane, alle imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con
biomassa ed energia geotermica, al gas metano per usi civili, al gasolio e GPL
per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate nelle
zone climatiche E, al gasolio per autotrazione nelle province di Trieste e
Udine, al gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra (commi 394 e 395).
In tema di compensazioni ambientali, i commi da 362 a 365 hanno disposto la
destinazione ad un fondo del maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza
dell'IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera,
dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di
riferimento previsto dal DPEF per gli anni 2007-2011. Tali risorse possono
essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale a favore
dei cittadini residenti nei territori interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche, anche ai fini
della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con
esclusione dei tributi erariali. Il Fondo è inizialmente dotato, per il
triennio 2007-2009, di 50 milioni annui. La ratio
di questa norma è da ricercarsi nella difficoltà pratica a
costruire nuove infrastrutture, a causa delle proteste delle popolazioni
interessate e degli enti locali, ispirate al celebre principio NIMBY (Not In My Back Yard).
Per
efficienza energetica si intendono
tutte quelle misure ed interventi che rendono disponibile un livello di
servizio energetico uguale o superiore, attraverso l’utilizzo di una
quantità di energia inferiore.
La promozione
dell’efficienza energetica nei consumi è spesso indicata come
l’unica opzione che sia in grado di dare una risposta, anche se parziale,
ai tre principali problemi della politica energetica: sicurezza degli
approvvigionamenti, tutela dell’ambiente, contenimento dei costi.
La forte attenzione per
la protezione dell’ambiente, la crescente dipendenza energetica dai paesi
esportatori e, infine, i forti aumenti del prezzo del petrolio e la sua
instabilità hanno reso sempre più necessaria una politica di uso
efficiente delle risorse energetiche. Il miglioramento dell’efficienza
energetica negli usi finali rappresenta infatti uno strumento fondamentale per
rispettare gli impegni assunti con la ratifica del protocollo di Kyoto, per
incrementare la competitività e l’occupazione e per garantire per
la sicurezza degli approvvigionamenti.
Nel quadro della mitigazione delle cause del riscaldamento
globale, il Rapporto Enea Energia e Ambiente 2006 ha evidenziato la necessità
di promuovere interventi finalizzati a un massiccio ricorso
all’efficienza energetica negli usi finali, con un diffuso impiego di
tecnologie a basso consumo nel civile, nell’industria e nei trasporti.
Inoltre, nel lungo periodo (dopo il 2020), sempre secondo Enea, è
necessaria la diversificazione del mix di combustibili per la generazione
termoelettrica, anche mediante un maggiore ricorso al carbone, reso
ambientalmente sostenibile con l’impiego delle tecnologie per il
sequestro e il confinamento della CO2.
Secondo lo studio
dell’Enea, gli interventi per
l’efficienza negli usi finali potranno
contribuire in misura del 42% alla riduzione della CO2 nel 2020. Includendo
gli interventi di miglioramento dei processi di conversione dall’energia
primaria agli usi finali (pari al 15%) la percentuale complessiva dovuta a
interventi per l’efficienza cresce fino al 57 per cento.
La riduzione della
domanda di energia conseguita attraverso un sistema energetico più
efficiente viene visto, quindi, come il primo obiettivo per una politica di
contenimento delle emissioni. Significativo è l’effetto che si
riscontra nel settore residenziale, in particolare per quanto riguarda il
riscaldamento che costituisce quasi l’80% dei consumi finali, dove le
tecnologie efficienti per l’edificio e l’impianto producono una
riduzione della domanda nel lungo periodo compresa tra il 16 e il 23 per cento.
In questo quadro vanno inseriti gli interventi introdotti dall’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
che prevedono, rispettivamente, che gli obblighi connessi al servizio di
distribuzione dell’energia elettrica includano quello di perseguire
l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali, e gli
obblighi connessi al servizio di distribuzione del gas naturale includano
quello di perseguire l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, secondo obiettivi quantitativi e modalità da definirsi in successivi
decreti ministeriali.
A queste previsioni normative è stata data una prima attuazione
con i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’agricoltura e del Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001.
Oltre all’individuazione
degli obiettivi quantitativi di cui ai d.lgs n. 79/99 e n. 164/00 per il
quinquennio 2002-2006, i decreti ministeriali 24 aprile 2001 introducevano un
meccanismo basato sull'imposizione ai distributori di energia elettrica e di
gas naturale di maggiori dimensioni di obblighi annuali di risparmio energetico
da realizzare attraverso progetti attuati presso i clienti finali, propri o
altrui, e definivano le modalità con cui i distributori soggetti agli
obblighi di risparmio energetico potevano conseguire tali obblighi.
Il meccanismo
proposto prevede in particolare la creazione di un mercato dei titoli di efficienza energetica (i c.d.
certificati bianchi), attestanti gli
interventi realizzati, per certi versi simile a quello dei certificati verdi
adottato per la promozione delle fonti rinnovabili di energia nella generazione
elettrica.
I decreti affidano
inoltre all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il
compito di definire la regolazione attuativa del meccanismo e di gestirne
l’attuazione.
Il contenuto dei decreti ministeriali 24 aprile
2001 è stato rivisto con la pubblicazione dei nuovi decreti ministeriali 20 luglio 2004, che hanno abrogato e sostituito i precedenti,
confermandone ampliamente l’impostazione e facendo salvi i procedimenti
avviati dall’Autorità, quelli in corso e quelli emanati in
attuazione dei decreti 24 aprile 2001.
Le
principali novità previste hanno riguardato:
§
il posticipo della data di avvio del meccanismo
e degli obblighi in esso contenuti al 1 gennaio 2005;
§
la rimodulazione degli obiettivi di risparmio
energetico da ottenersi nel quinquennio di applicazione;
§
la previsione di un programma di iniziative di
accompagnamento (campagne informative e diagnosi energetiche) gestito dal
Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio;
§
la revisione del meccanismo sanzionatorio
previsto in caso di inadempienza agli obblighi;
§
l’introduzione di alcune specifiche
disposizioni relative agli interventi di risparmio energetico ammissibili ai
fini del conseguimento degli obiettivi e alla possibilità di erogare un
contributo tariffario per la copertura dei costi sostenuti dai distributori per
il conseguimento degli obiettivi;
§
l’introduzione di specifiche misure
relative al ruolo delle Regioni e delle Province autonome in materia di
determinazione di obiettivi di risparmi energetico e relative modalità
di raggiungimento.
I decreti ministeriali 20 luglio 2004 determinano obiettivi quantitativi nazionali di
miglioramento dell’efficienza energetica per il quinquennio 2005-2009,
espressi in unità di energia primaria (tonnellate equivalenti di
petrolio) e definiti su base annuale, così riassumibili:
|
Anno
|
Decreto Elettrico
[Mtep]
|
Decreto Gas
[Mtep]
|
|
2005
|
0,1
|
0,1
|
|
2006
|
0,2
|
0,2
|
|
2007
|
0,4
|
0,4
|
|
2008
|
0,8
|
0,7
|
|
2009
|
1,6
|
1,3
|
Il sistema introdotto dai decreti 20 luglio 2004 prevede dunque che i
distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati
obblighi quantitativi di risparmio di energia primaria, per il quinquennio
2005/2009, a partire dal 1° gennaio 2005.
Per adempiere a questi obblighi e ottenere il risparmio energetico
prefissato i distributori possono:
§
attuare progetti a favore dei consumatori finali che migliorino l'efficienza energetica
delle tecnologie installate o delle relative pratiche di utilizzo. I progetti
possono essere realizzati direttamente, oppure tramite società
controllate, o ancora attraverso società operanti nei settori dei
servizi energetici (le cosiddette ESCO-energy
services companies),
§
acquistare da
terzi "titoli di efficienza energetica" o "certificati bianchi" attestanti il
conseguimento di risparmi energetici.
I titoli di efficienza energetica o certificati
bianchi sono emessi dal Gestore del mercato elettrico a favore dei soggetti
(distributori, società da essi controllate e di società operanti
nel settore dei servizi energetici) che hanno conseguito i risparmi energetici
prefissati. L'emissione dei titoli viene effettuata sulla base di una
comunicazione dell'Autorità che certifica i risparmi conseguiti.
L'Autorità infatti verifica e controlla che i progetti siano stati
effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti
e delle regole attuative definite dall'Autorità stessa.
La compravendita di questi titoli avviene tramite contratti bilaterali o
in un mercato apposito istituito dal Gestore del mercato elettrico e regolato
da disposizioni stabilite dal Gestore stesso d'intesa con l'Autorità.
La possibilità
di scambiare titoli di efficienza energetica consente ai distributori che
incorrerebbero in costi marginali relativamente elevati per il risparmio di
energia attraverso la realizzazione diretta di progetti, di acquistare titoli
di efficienza energetica da quei soggetti che invece presentano costi marginali
di risparmio energetico relativamente inferiori e che pertanto hanno
convenienza a vendere i propri titoli sul mercato.
Il meccanismo
garantisce che il costo complessivo di raggiungimento degli obiettivi fissati
risulti più contenuto rispetto ad uno scenario alternativo in cui
ciascuno dei distributori fosse obbligato a soddisfare gli obblighi di
risparmio energetico sviluppando in proprio progetti per l'uso razionale dell'energia.
L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas nel primo "rapporto annuale" sul funzionamento in Italia del meccanismo
dei certificati bianchi ha sottolineato che l’esperienza italiana
è la prima al mondo di applicazione di questo strumento di mercato alla
promozione dell’efficienza energetica negli usi finali. Successivamente
all’introduzione in Italia, la struttura del meccanismo e della relativa
regolazione attuativa sono stati oggetto di approfonditi studi e analisi da
parte della Commissione Europea, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia e di
un numero crescente di Paesi, sia europei, sia extraeuropei (Stati Uniti,
Australia, Giappone, Corea). Nel luglio 2006 la Francia ha introdotto un
sistema di certificati bianchi che ricalca quello italiano, soprattutto dal
punto di vista della regolazione attuativa.
Nell’analisi dei
risultati conseguiti nei primi diciassette mesi di funzionamento del meccanismo,
l’Autorità evidenzia che sono circa 286.000 le tonnellate
equivalenti di petrolio (tep) risparmiate, equivalenti al consumo domestico
annuo di una città di circa 380.000 abitanti o alla produzione elettrica
annua di una centrale di 160 MW di potenza; le emissioni evitate grazie a
questi risparmi ammontano ad oltre 750.000 tonnellate di anidride carbonica.
Grazie alle iniziative
intraprese tra il 2001 e il maggio di quest'anno dai distributori di energia
elettrica e gas naturale, e da circa il 10% delle quasi 600 società di
servizi energetici (ESCO) accreditatesi finora presso l'Autorità, gli
obiettivi nazionali di risparmio fissati per il primo anno sono stati
ampiamente superati.
Tra il gennaio 2005 e
la fine di maggio 2006 l’Autorità ha certificato il conseguimento
di un risparmio energetico complessivo pari a 286.837 tep, richiedendo al GME
l’emissione di titoli di efficienza energetica così ripartiti:
- 214.244 di tipo I
(attestanti la riduzione dei consumi di energia elettrica);
- 62.826 di tipo II
(attestanti la riduzione dei consumi di gas naturale);
- 9.767 di tipo III (attestanti
la riduzione dei consumi di combustibili solidi, liquidi e di altri
combustibili gassosi).
Nel complesso, il
numero di TEE di cui è stata richiesta l’emissione al GME è
dunque risultato ampiamente superiore (il 184%) rispetto alla somma degli obiettivi
assegnati dai due decreti ministeriali.
Gli oltre mille
interventi valutati dall'Autorità coprono diversi ambiti di applicazione
delle tecnologie efficienti; tra quelli che hanno prodotto la maggior parte dei
risparmi spiccano:
§
l'incremento d'efficienza dei sistemi di
illuminazione sia pubblica che privata,
§
l'estensione di reti di teleriscaldamento,
§
l'installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda.
I dati dimostrano,
secondo l'Autorità, l'apprezzamento degli operatori di questo nuovo
mercato per lo sforzo compiuto nella direzione della semplificazione delle
procedure amministrative, considerato che il 90% dei Titoli di Efficienza
Energetica (TEE) è stato certificato tramite le procedure di valutazione
dei risparmi basate su schede tecniche.
Caratteristica
essenziale e peculiare del meccanismo è la possibilità di
scambiare i certificati bianchi ottenuti: l'entrata in funzione del registro e
del mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), organizzati dal GME
(Gestore del Mercato Elettrico), ha contribuito a garantire l'efficienza
economica del sistema. Le riduzioni dei consumi energetici ottenute grazie agli
interventi di risparmio hanno garantito agli utenti finali un beneficio
economico tra 6 e 10 volte superiore al prezzo medio dei certificati bianchi
scambiati sul mercato e al valore del contributo di 100 euro erogato
dall'Autorità per ogni tep risparmiata.
Non solo al beneficio
economico diretto dei consumi evitati è legata l'importanza per il
nostro Paese del sistema dei certificati bianchi; rilevante è infatti il
contributo che questo meccanismo ha iniziato a dare anche per la crescita di
sensibilità degli utenti alle tematiche del risparmio energetico, la
nascita di nuove imprese, l'innovazione tecnologica e dunque nel complesso per
il rispetto dei vincoli ambientali e per la competitività della nostra
economia.
Si richiama
l’intensa produzione normativa più recente in materia
di’efficienza energetica.
La legge finanziaria per il 2007 contiene
varie norme che vanno nella direzione indicata dall’ENEA nel suo
Rapporto.
Diverse tipologie
di incentivi per la rottamazione di
autoveicoli, autocarri e motocicli, sono previste dai commi da
224 a 241, in particolare al fine
di incentivare la rottamazione di veicoli classificati “euro 0” o “euro 1” e
l’eventuale sostituzione con veicoli classificati “euro 4” o “euro 5”, ovvero con
alimentazione a gas metano, GPL, elettrica o ad idrogeno.
In materia di efficienza energetica dell’edilizia,
i commi da 344 a
349 prevedono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione
dall’imposta lorda, per interventi di adeguamento degli edifici volti a
garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione
perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione
del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici).
Inoltre, i commi 351 e 352 recano disposizioni volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante
risparmio energetico, prevedendo il diritto ad un contributo per la
realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici che rispettino
particolari parametri di efficienza energetica, pari al 55 per cento dei
maggiori costi sostenuti. A tal fine è costituito un Fondo di 15 milioni
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Sempre in materia
di edifici, si segnala che il 29 dicembre 2006 è stato emanato il D.Lgs.
n. 311 che introduce modifiche ed integrazioni al D.Lgs.
n. 192/2005, recante l’attuazione della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia,
adottato sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306
(Legge comunitaria 2003).
La
direttiva da ultimo richiamatala l’obiettivo del miglioramento della
prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per
quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo
dei costi.
Per quanto riguarda
l’efficienza degli
elettrodomestici, il comma 353 dispone l’erogazione di contributi,
sotto forma di detrazioni di imposta, per la sostituzione di apparecchi
domestici (frigoriferi, congelatori e loro combinazioni) con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
Sul fronte delle
imprese, i commi da 354 a
356 riconoscono ai soggetti esercenti attività di impresa agevolazioni
fiscali per la sostituzione di apparecchi
illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, fluorescenti, ovvero
ad alto rendimento ottico.
Infine, per quanto
riguarda il comparto dell’industria, i commi da 358 a 360 prevedono
l’erogazione di contributi, sotto forma di detrazioni di imposta, per motori industriali ad alta efficienza.
Con il DM 19 febbraio 2007 è stata data attuazione a questa
disposizione.
Il decreto legge n. 262 del 2006 (decreto
fiscale collegato alla legge finanziaria per il 2007), in tema di razionalizzazione dell’uso
delle risorse energetiche e contenimento della spesa pubblica, ha invece provveduto
ad autorizzare gli enti pubblici ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel
rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per
l’individuazione di società
alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti
finalizzati all’ottenimento di riduzioni di costi di acquisto
dell’energia, sia termica che elettrica. Il corrispettivo delle
società assegnatarie del servizio deriva esclusivamente dalla vendita di
eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza
dell’attività svolta.
Si segnala,
inoltre, che è stato di recente emanato un decreto legislativo sulla promozione della cogenerazione (D.Lgs.
n. 20 dell'8 febbraio 2007), adottato in attuazione della delega contenuta
nell’art. 21 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) e
volto a recepire la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la
direttiva 92/42/CEE.
Il provvedimento
definisce misure in grado di promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto
rendimento, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia
elettrica ed energia termica che, rispetto alla produzione separata delle
stesse quantità di energia elettrica e calore comporta:
un risparmio economico
dovuto al minor consumo di combustibile;
una riduzione
dell’impatto ambientale;
minori perdite di
trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico, derivanti dalla
localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza;
la
sostituzione di modalità produttive di calore poco efficaci e
maggiormente inquinanti.
Si segnala,
infine, il primo “Progetto di
Innovazione Industriale per l'Efficienza Energetica” appena lanciato dal Governo, che ha come
obiettivo il rilancio della competitività del sistema industriale,
migliorando l'efficienza energetica del Paese.
Tale
Piano si muove nell’ottica che l’efficienza energetica si raggiunge
favorendo la nascita e il radicamento di una ecoindustria, attraverso il
finanziamento di iniziative volte a realizzare investimenti industriali:
- nel settore delle
energie rinnovabili (per esempio, collettori solari per produrre acqua calda
nelle case, piccole centrali elettriche a cogenerazione alimentate a biomasse,
solare fotovoltaico, eolico per la produzione di aerogeneratori, tecnologie di
produzione stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno, solare ad alta temperatura,
biocarburanti);
- finalizzati alla
riqualificazione dei comparti industriali esistenti verso nuovi prodotti a
basso impatto ambientale e capaci di far risparmiare energia (per esempio,
mattoni ad alto isolamento termico, frigoriferi A+, vetri che riducono le
emissioni termiche);
- innovativi dei
processi produttivi in modo da ridurre l’intensità energetica
delle lavorazioni (esempi: motori con inverter, tecniche di riutilizzo del
calore di scarto all’interno dei processi produttivi).
Le conclusioni del Consiglio europeo
dell’8 e 9
marzo 2007 contengono uno
specifico paragrafo dedicato alla politica
climatica ed energetica integrata, nel quale si sottolinea la
necessità di un intervento urgente ed efficace per affrontare le sfide
poste dal cambiamento climatico, le cui conseguenze a lungo termine, incluse
quelle relative allo sviluppo economico,
sono state riesaminate nella loro gravità da recenti studi in materia[50].
Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che
la lotta al cambiamento climatico costituisce, in particolare in relazione allo
sviluppo delle tecnologie ambientali e
alle ecoinnovazioni, un importante
contributo al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla strategia di Lisbona.
Il Consiglio europeo, infine, ha
sottolineato il ruolo guida
dell’UE nella protezione internazionale del clima, ribadendo la
necessità di un intervento concordato su scala planetaria. A tal fine,
ritiene necessario che, in occasione della Conferenza
internazionale sul clima, prevista per la fine del 2007 sotto l’egida
delle Nazioni Unite, vengano avviati i negoziati relativi a un accordo globale
e completo sulla lotta contro il
riscaldamento del pianeta dopo il 2012, basato sull’ampliamento dell’architettura del protocollo di Kyoto[51]e che tali negoziati si concludano
entro il 2009.
In questa cornice, il Consiglio europeo ha
pienamente accolto la comunicazione
“Limitare il surriscaldamento
dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius – La via da percorrere
fino al 2020 e oltre” (COM(2007)2), presentata dalla Commissione il 10 gennaio 2007.
In particolare, le conclusioni considerano gli impegni di riduzione delle
emissioni di gas serra prospettati dalla Commissione come un obiettivo
strategico fondamentale, da realizzare mediante un approccio integrato e completo della politica energetica e della
politica ambientale dell’Unione.
La comunicazione[52]
propone che l’UE persegua, nell’ambito di negoziati internazionali,
un obiettivo di riduzione dei gas serra pari al 30% rispetto ai valori del 1990,
che i paesi industrializzati dovranno conseguire entro il 2020: in tal modo dovrebbe essere possibile contenere
l’aumento della temperatura entro il limite dei 2°C in tutto il
mondo.
Secondo la Commissione,
fino a che non sarà concluso un accordo internazionale, e fatta salva la
posizione che assumerà nell’ambito dei negoziati multilaterali,
l’UE dovrebbe assumersi, fin
d’ora, l’impegno risoluto e unilaterale di abbattere le emissioni
dei gas serra di almeno il 20% entro il
2020, ricorrendo al sistema UE di scambio delle quote di emissione (vedi infra), ad altre politiche in materia di
cambiamenti climatici nonché a interventi nel contesto della politica
energetica. Dopo il 2020 le emissioni prodotte dai paesi in via di sviluppo
supereranno quelle dei paesi industrializzati; nel frattempo, il tasso di
crescita delle emissioni complessive dei paesi in via di sviluppo dovrebbe cominciare
a rallentare e, a partire dal 2020, dovrebbe verificarsi un calo in termini
assoluti.
Il percorso prospettato dalla Commissione
prevede che, entro il 2050, le emissioni
globali siano abbattute fino al 50%
rispetto al 1990; ciò significa che i paesi industrializzati dovranno
ridurle del 60-80%, ma le emissioni dovranno diminuire sensibilmente anche in
molti paesi in via di sviluppo.
La comunicazione ribadisce che gli strumenti di mercato,
come il sistema UE di scambio delle
quote di emissione, saranno un elemento
determinante per far sì che l’Europa e altri paesi conseguano
gli obiettivi previsti al più basso costo possibile. La Commissione ritiene,
infine, auspicabile che l’UE e gli Stati membri decidano di incrementare
sensibilmente gli investimenti destinati alle attività di ricerca e sviluppo nei settori della produzione
di energia e del risparmio energetico.
Il
cambiamento climatico nella Politica energetica per l’Europa (PEE)
Nell’ambito dell’approccio
integrato tra le politiche dell’Unione in tema di ambiente ed energia, il
Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo ha individuato i tre obiettivi che la politica energetica per l’Europa
(PEE) dovrà perseguire:
·
aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento;
·
garantire la competitività delle economie europee e la
disponibilità di energia a prezzi accessibili;
·
promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro il cambiamento
climatico.
Gli obiettivi dovranno essere perseguiti
rispettando il mix energetico scelto dagli Stati membri e la loro
sovranità sulle fonti di energia primaria.
Il Consiglio europeo ha altresì
adottato un piano d’azione sulla
politica energetica per l’Europa, per il 2007-2009 (allegato alle
conclusioni del Consiglio europeo) che si basa sulla comunicazione “Una
politica energetica per l’Europa” (COM(2007)1), presentata
dalla Commissione il 10
gennaio 2007.
Il piano d’azione sarà
riesaminato regolarmente nel contesto dell’esame annuale, effettuato dal
Consiglio europeo, dell’attuazione delle politiche dell’UE nel
settore energetico e in materia di cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo
ha invitato, quindi, la
Commissione a presentare, all'inizio del 2009, un aggiornamento dell'analisi strategica della
politica energetica, che servirà di base per il nuovo piano d'azione
in materia di energia per il periodo dal 2010 in poi, destinato ad
essere adottato dal Consiglio europeo di primavera del 2010.
Per quanto riguarda, in particolare, la
lotta al cambiamento climatico, il piano d’azione prevede:
·
il rafforzamento
del partenariato e della cooperazione, basandosi sui dialoghi bilaterali in
materia di energia, con gli USA, la
Cina, l'India, il Brasile e le altre economie emergenti,
incentrandosi sulla riduzione di gas a effetto serra, sull'efficienza
energetica, sulle energie rinnovabili e sulle tecnologie energetiche a bassa emissione, segnatamente la cattura e
lo stoccaggio dell'anidride carbonica;
·
Il riesame del sistema comunitario di scambio di quote di emissioni da parte della
Commissione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas
serra a lungo termine dell'UE. Tale revisione dovrebbe fornire un metodo basato
sul mercato ed efficiente in termini di costi, per ottenere valori di emissione
ridotti a costi minimi - anche per quanto riguarda industrie ad alta
intensità energetica;
·
lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili;
·
il tempestivo riesame da parte della Commissione
della disciplina degli aiuti di Stato
per la tutela dell’ambiente, e
di altri pertinenti strumenti comunitari in grado di dare incentivi, al fine di
renderli più idonei a sostenere gli obiettivi comunitari in materia di
energia e cambiamenti climatici.
Il
pacchetto energia
La
citata comunicazione “Una politica
energetica per l’Europa” presenta il riesame strategico della politica energeticadell’Unione europea e contiene un piano d’azione energetico articolato in dieci punti. Il
“pacchetto energetico” così delineato è inteso a creare le condizioni per il raggiungimento
del nuovo obiettivo strategico, già
richiamato, di ridurre
almeno del 20 %, entro il 2020,le emissioni di gas serra derivanti
dal consumo di energia nell’UE rispetto ai livelli del 1990,
all’interno di un’azione internazionale volta a raggiungere
l’obiettivo di ridurre del 30% le emissioni di gas serra a livello
globale.
Il
riesame strategico intende definire
una politica energetica forte ed efficace, capace di fornire soluzioni alle
sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla crescente dipendenza dalle
importazioni e dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, di fronte
alle quali gli Stati membri sono sempre più interdipendenti.
Sulla base dei risultati della consultazione sul Libro
verde “energia”[54], la
comunicazione sottolinea che una politica energetica europea incentrata su
un’azione immediata per ridurre i
gas serra consentirebbe di
ottenere un minor consumo energetico, di usare energia più pulita, di
limitare la crescente esposizione della UE alla volatilità e al rialzo
dei prezzi del petrolio e del gas, di creare un mercato energetico comunitario
più competitivo e di stimolare l’innovazione tecnologica e
l’occupazione.
Il
piano d’azione contenuto nella
comunicazionepresenta, in dieci
punti, un primo pacchetto di misure che intendono contribuire a trasformare
l’Europa in un’economia dal profilo energetico altamente efficiente
e a basse emissioni di CO2. In particolare, l’UE dovrebbe
assumere la leadership mondiale e
catalizzare una nuova rivoluzione
industriale che acceleri il passaggio ad una crescita economica con basse
emissioni, aumentando drasticamente la produzione e il consumo di energia
locale a basse emissioni.
La
nuova politica energetica proporrà di integrare gli aspetti energetici di altre politiche e sarà
aggiornata, ogni due anni, da una relazione della Commissione sul riesame
strategico energetico.
Ricollegandosi alla comunicazione “Limitare il
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius”,
già richiamata in precedenza, il “pacchetto energetico”
riafferma la validità delmeccanismo
di scambio dei diritti di emissione in quanto meccanismo chiave per incentivare le riduzioni di emissioni di
carbonio e tale da poter essere utilizzato come base per le iniziative
internazionali di lotta ai cambiamenti climatici. La revisione
del sistema per lo scambio delle quote di emissione viene quindi
considerata fondamentale perconseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni
di gas serra fissati dal pacchetto energia.
Nel quadro degli
interventi previsti dal piano d’azione adottato dal Consiglio europeo di
primavera, il 28
marzo 2007 la Commissione europea ha
presentato un Libro verde sugli
strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale ed energetica
(COM (2007)140). Il documento ribadisce che strumenti di mercato quali il
sistema scambio di emissioni, le
tasse ambientali e i sussidi mirati possono svolgere un ruolo importante
nel conseguimento degli obiettivi di protezione del clima individuati dal
Consiglio, scoraggiando le azioni indesiderabili e premiando i comportamenti
positivi, come il risparmio energetico e le attività rispettose
dell’ambiente, sia a livello comunitario che nazionale.
Il Libro verde
intende, in particolare, aprire un confronto di opinioni in previsione della
modifica della direttiva sulla tassazione dell’energia[55], invitando le altre istituzioni dell’UE,
gli Stati Membri, le parti interessate e il pubblico a fornire, entro il 31 luglio 2007, le proprie osservazioni sul tema.
Tra
le iniziative strategiche previste dal Programma legislativo e di lavoro per il
2007, la Commissione
preannunzia la presentazione del Libro
verde sul cambiamento climatico dopo
il 2012, su cui verrà avviata una consultazione pubblica. Il
documento contribuirà ad individuare gli ambiti in cui è
necessario intervenire a livello comunitario per favorire l’adeguamento
dell’Unione europea alle sempre maggiori ripercussioni dei cambiamenti
climatici.
Il
Programma legislativo prevede, inoltre, a conclusione della consultazione sul
Libro verde, la presentazione del Libro bianco “Verso un programma
europeo di adattamento al cambiamento climatico”. La Commissione, anche
tenendo conto dei risultati della consultazione, individuerà le azioni specifiche da adottare in
materia di adattamento ai cambiamenti. Parallelamente alle iniziative volte ad
invertire il senso del processo di cambiamento climatico in corso attraverso la
riduzione delle emissioni di gas serra, la Commissione sottolinea
la necessità di azioni urgenti per adattarsi ai cambiamenti previsti per
la regione europea.
Entro
la fine del 2007 la
Commissione intende inoltre lanciare una consultazione sul contributo futuro del settore marittimo alla lotta
contro il cambiamento climatico, in vista dell’eventuale inclusione
dei trasporti marittimi per il 2011, nel sistema di scambio di quote di
emissione di gas ad effetto serra.
In
seguito alla comunicazione della Commissione “Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a
+2 gradi Celsius – La via da percorrere fino al 2020 e oltre” (COM(2007)2)
e in vista del Consiglio europeo di primavera, il Parlamento europeo, il 14 febbraio 2007,
ha approvato una risoluzione che sottolinea
l’urgenza di prendere iniziative concrete a livello mondiale per
affrontare i cambiamenti climatici.
In particolare, il Parlamento ritiene che entro il
2050 la maggioranza del fabbisogno energetico dell’ Unione europea debba
essere coperta da fonti prive di carbonio o con tecnologie prive di emissioni
di gas serra, e invita la
Commissione a fissare obiettivi in tal senso. Osservando come
l’efficienza energetica possa influire positivamente sulla riduzione
delle emissioni, la risoluzione sollecita interventi della Commissione e degli
Stati membri in questo settore. In particolare, la Commissione è
invitata a presentare proposte volte a porre rimedio all’attuale inefficienza di molte centrali elettriche,
imponendo agli Stati membri di sfruttare l’energia rilasciata quale
sottoprodotto della generazione di elettricità, mediante la tecnologia della cogenerazione di
elettricità e calore.
Il Parlamento chiede inoltre lo sviluppo di trasporti pubblici più integrati ed
ecologici che rispettino
l’ambiente e le risorse naturali e misure vincolanti per tale settore,
affinché consegua entro il 2020 riduzioni delle emissioni equivalenti a
quelle degli altri settori (introduzione di imposte sul cherosene a livello
dell’Unione europea e mondiale).
Il
21 maggio 2007 la dichiarazione scritta "sull'instaurazione di
un'economia verde all'idrogeno e una terza rivoluzione industriale in Europa
attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le
organizzazioni della società civile interessate", promossa tra gli altri dagli europarlamentari
italiani Vittorio Prodi e Umberto Guidoni,ha raccolto la firma della
maggioranza dei deputati e
sarà quindi trasmessa alla Commissione e agli Stati membri come
posizione ufficiale del Parlamento europeo.
Notando come il riscaldamento
globale e i costi dei combustibili fossili continuano ad aumentare, la
dichiarazione rileva che «una visione post-energia fossile e post-energia
nucleare dovrebbe costituire il prossimo progetto importante dell'Unione
europea»; inoltre, si sottolinea che i 5 fattori chiave per
l'indipendenza energetica sono: la massimizzazione dell'efficienza energetica,
la riduzione delle emissioni di gas che comportano un riscaldamento globale,
l'ottimizzazione dell'introduzione su scala commerciale di energie rinnovabili,
la messa a punto di una tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno per
immagazzinare energie rinnovabili e la creazione di griglie di energia
intelligente per distribuire l'energia stessa.
Per tali motivi, la
dichiarazione invita le istituzioni dell'UE a perseguire entro il 2020 un
incremento del 20% dell'efficienza energetica, a ridurre del 30% (rispetto ai
livelli del 1990) entro il 2020 i gas ad effetto serra, a produrre entro il
2020 il 33% dell'elettricità e il 25% dell'energia globale ricorrendo a
fonti di energia rinnovabile e a sviluppare una tecnologia di immagazzinamento
delle celle a combustibile a idrogeno.
L'Unione europea è
anche invitata a sviluppare altre tecnologie di immagazzinamento per usi
portatili, impianti permanenti e fini di trasporto e a mettere a punto entro il
2025 in tutti i paesi membri dell'UE un'infrastruttura a idrogeno
decentralizzata, dal basso verso l'alto. I deputati, infine, chiedono di
rendere, entro il 2025, le griglie di energia «intelligenti ed indipendenti»
in modo che le regioni, le città, le piccole e medie imprese e i
cittadini possano produrre e condividere l'energia «con lo stesso accesso
aperto che esiste attualmente per quanto concerne Internet».
Nella
medesima data la Commissione Affari costituzionali
del Parlamento Europeo ha approvato una proposta di risoluzione sulla
roadmap per il processo costituzionale europeo (relatori on. Baron Crespo
PSE-SP; on. Brok PPE-DE), nella quale si sottolinea la necessità di
tenere in considerazione, nella discussione sul futuro del Trattato
costituzionale, la definizione di un approccio
comune e adeguati mezzi di azione in alcune aree prioritarie tra cui figura
la lotta al cambiamento climatico. La proposta di risoluzione dovrebbe essere
esaminata nella sessione plenaria del 6 giugno 2007, in vista del Consiglio
europeo del 21 e 22 giugno.
Si
segnala infine che il 6 e 7 novembre prossimi si terrà a Bruxelles una Conferenza interparlamentare sul
cambiamento climatico, organizzata dal Parlamento europeo e dal Parlamento
portoghese.
Commissione temporanea sul
cambiamento climatico
Il
25 aprile 2007 il Parlamento europeo ha deliberato la costituzione di una commissione temporanea sul cambiamento climatico. La durata dei
lavori della commissione, composta da 60 deputati, dovrebbe essere di 12 mesi a
partire da maggio 2007.
La
commissione avrà i seguenti compiti:
·
formulare proposte sulla politica climatica integrata
dell’Unione europea e coordinare la posizione del Parlamento europeo in relazione ai negoziati
sulla politica internazionale sui cambiamenti
climatici post 2012;
·
analizzare e
valutare i dati più recenti in
materia di cambiamento climatico e proporre
adeguate risposte politiche a tutti i livelli, tenendo conto dell’impatto
finanziario e dei costi di un eventuale mancato intervento;
·
predisporre un inventario il più possibile completo
dei nuovi e potenziali sviluppi nel campo della lotta al cambiamento
climatico, così da fornire al Parlamento un’analisi dettagliata
che lo metta in condizione di far fronte alle sue responsabilità
politiche;
·
esaminare le implicazioni ambientali, legali,
economiche, sociali, geopolitiche, regionali di questi nuovi e potenziali sviluppi;
·
analizzare e
valutare il recepimento della legislazione
comunitaria in queste materie, prendendo a tal fine contatto e svolgendo
audizioni con gli Stati Membri, i parlamenti e i governi di Stati terzi, le
istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, i rappresentati della
comunità scientifica ed economica e della società civile, ivi
incluse le autorità locali e regionali.
Il
22 maggio 2007 la Commissione temporanea ha tenuto la riunione costituente, in
cui ha proceduto all’elezione del Presidente, il deputato italiano Guido
Sacconi (Gruppo socialista al Parlamento europeo), e di tre dei quattro
vicepresidenti. La prossima riunione è fissata per il 7 giugno.
Sistema UE di scambio di quote di
emissione
Dal
1° gennaio 2005 è in vigore il sistema europeo di scambio delle
quote di emissione, disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE, nell’ambito
del quale gli Stati membri sono stati chiamati a presentare il piano nazionale
di assegnazione relativo al periodo 2008-2012.
I piani nazionali di assegnazione fissano per ciascuno
Stato membro il limite dei quantitativi totali di anidride carbonica che
possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema UE di scambio
delle quote di emissione (EU ETS) e specificano il numero di quote di emissione
di CO2 spettanti a ciascun impianto.
La Commissione, responsabile della valutazione dei
piani nazionali proposti dagli Stati membri sulla base di 12 criteri indicati
nella citata direttiva, può accettare un piano parzialmente o
integralmente. I criteri di valutazione sono finalizzati a garantire, tra
l’altro, che i piani siano coerenti: con il rispetto da parte della UE e
degli Stati membri degli obiettivi del protocollo di Kyoto; con il livello
reale delle emissioni accertate indicato dalla Commissione nelle relazioni
annuali sullo stato di avanzamento; con le potenzialità tecnologiche di
riduzione delle emissioni. Altri criteri di valutazione riguardano aspetti
quali la non discriminazione, la concorrenza all’interno dell’UE e
le norme sugli aiuti di Stato, oltre ché aspetti tecnici.
Il 15 maggio 2007 la Commissione ha concluso
la valutazione del piano nazionale
dell’Italia e lo ha accolto, a condizione
che vi siano apportati alcuni cambiamenti. Il più importante di essi
riguarda la riduzione del
quantitativo totale di quote di emissione proposto: l’assegnazione annua
autorizzata è infatti pari a 195,8
milioni di tonnellate di CO2, il 6,3% in meno di quanto proposto
dall’Italia (vale a dire 209 milioni di tonnellate). Inoltre, secondo la
Commissione:
- l’Italia dovrebbe fornire maggiori informazioni sul
trattamento che riserverà ai nuovi soggetti che entreranno nel
sistema di scambio delle quote di emissione;
- l’Italia dovrebbe inserire nel piano gli impianti di
combustione (ad esempio gli impianti di cracking), come fatto da tutti gli altri Stati membri.
- è necessario eliminare diversi adeguamenti ex-post previsti;
- il quantitativo massimo di crediti di emissione - concessi alle
imprese che partecipano a progetti di abbattimento delle emissioni di CO2
in paesi terzi e che tali imprese possono utilizzare per rispettare i
propri impegni in materia di emissioni - non deve superare il 15% circa del totale annuo.
Il
13 novembre 2006 la
Commissione ha adottato, ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2003/87/CEE[57], una
comunicazione sulla creazione di un mercato mondiale del carbonio, in cui si prevede una revisione del
sistema di scambio di quote che dovrebbe essere applicato a partire dal
2013.
Gli assi portanti della
revisione prevista dalla Commissione sono:
·
l’ampliamento
del campo di applicazione del sistema ad altri settori, come quello
dell’aviazione, nonché ad altri gas a effetto serra diversi dal CO2,
come il protossido di azoto (N2O) indotto della produzione di
ammoniaca e il metano prodotto da miniere di carbone;
·
l’armonizzazione
del sistema per la tipologia degli impianti coperti dagli scambi di quote, per
il trattamento da riservare ai nuovi impianti immessi sul mercato e a quelli
che cessano l’attività;
·
un controllo
rigoroso dell’applicazione del sistema attraverso l’elaborazione di
indirizzi in materia di sorveglianza.
La
comunicazione sottolinea la necessità che il sistema UE di scambio,
inteso come strumento di mercato, sia semplificato ed ampliato per poter
ridurre le emissioni di gas serra all’insegna dell’efficacia
economica e far sì che funga da modello per sistemi analoghi in altre
regioni del mondo.
La Commissione intende
presentare la proposta di revisione della direttiva 2003/87/CE durante il secondo semestre 2007, al
termine di un’ampia consultazione pubblica.
Impatto del trasporto aereo sui
cambiamenti climatici
Il
20 dicembre 2006
la Commissione
ha presentato una proposta di direttiva
che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra
(COM(2006)818.
La proposta di direttiva fa seguito ad una
comunicazione del settembre 2005[58], nella quale la Commissione concludeva
che il modo migliore per far fronte alle emissioni del settore aereo, da un
punto di vista economico ed ambientale, era quello di includerlo nel sistema
europeo di scambio delle quote di emissione. Questa posizione era stata
successivamente avallata anche dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
La
proposta della Commissione intende garantire parità di trattamento a tutti gli operatori aerei, siano
essi comunitari o stranieri. A partire dal
2011 rientreranno nel sistema tutti i voli nazionali ed internazionali
effettuati tra aeroporti dell’UE
e dal 2012 il sistema sarà
esteso anche a tutti i voli internazionali in
arrivo ed in partenza dagli aeroporti dell’UE. Per contenere il
rapido aumento delle emissioni dovute al trasporto aereo, il numero totale
delle quote di emissione assegnate sarà limitato ad un tetto massimo,
pari al livello medio delle emissioni registrate nel periodo 2004-2006. Gli
Stati membri potranno vendere all’asta una parte delle quote, ma la
maggior parte di esse sarà rilasciata a titolo gratuito. La proposta di
direttiva rientra in un approccio globale che punta ad affrontare il problema
delle emissioni del trasporto aereo e che comprende anche attività di
ricerca su tecnologie più pulite nonché una migliore gestione del
traffico aereo.
La proposta, che segue la procedura di
codecisione, è attualmente
all’esame, in prima lettura, della Commissione ambiente
del Parlamento europeo, che dovrebbe concludere i propri lavori il 3 ottobre 2007, in vista della
sessione plenaria del 23 ottobre 2007.
Sulla proposta di direttiva il Consiglio ha svolto un dibattito preliminare il
20 febbraio 2007.
Lo
scambio di opinioni in seno al Consiglio ha contemplato principalmente le
questioni seguenti :
- l'inclusione nello scambio delle quote dei voli all'interno
dell'UE, a decorrere dal 2011, e l'estensione del sistema, dal 2012, a tutti i voli in
arrivo o in partenza dall'UE, come misura appropriata per ridurre le
emissioni nel trasporto aereo senza comportare svantaggi concorrenziali;
- strategia da seguire nell'interazione con i paesi terzi;
- misure non discriminatorie opportune per affrontare gli aspetti
regionali e le situazioni particolari degli Stati membri;
- l'approccio riguardo ad un tetto che consideri sia la crescita del
settore che la necessità di stabilizzare il clima;
- l'approccio riguardo ad una metodologia di assegnazione delle
quote armonizzata a livello dell'UE;
- la necessità di affrontare tramite l'azione comunitaria
anche gli effetti del trasporto aereo sul cambiamento climatico diversi da
quelli derivanti dalle emissioni di CO2.
Veicoli leggeri
Nel
quadro degli obiettivi fissati dall’UE in materia di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra e di limitazione dell’aumento della
temperatura globale, la Commissione ha rilevato la necessità di
intervenire anche nel settore del trasporto su strada, che è il secondo
settore dell’UE per emissioni di gas ad effetto serra ed uno dei pochi
nei quali le emissioni continuano ad aumentare.
In
tale contesto, il 7 febbraio 2007 la Commissione ha presentato le comunicazioni
“Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni
di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri” (COM(2007)19) e “Un
quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo”(COM (2007) 22).
Come sottolineato nelle due comunicazioni, la
Commissione ha scelto un approccio integrato per perseguire l’obiettivo
comunitario di ridurre le emissioni dei veicoli leggeri a 120 grammi di
anidride carbonica per chilometro entro il 2012.Secondo
la Commissione,tale obiettivo può essere raggiunto facendo
leva su una combinazione di interventi dell'UE e degli Stati membri.
A
questo scopo, la Commissione proporrà, se possibile già nel 2007
e al più tardi a metà del 2008, un quadro legislativo inteso
a conseguire l'obiettivo indicato puntando a riduzioni obbligatorie delle
emissioni di CO2 per raggiungere l'obiettivo di
130 g CO2/km per il nuovo parco auto
medio, grazie a miglioramenti tecnologici apportati al motore dei
veicoli, e ad un ulteriore abbattimento di 10 g CO2/km,
o equivalente se tecnicamente possibile, grazie ad altri miglioramenti tecnologici
e ad un maggiore uso dei biocarburanti. In particolare si tratterà
delle seguenti misure:
·
definizione di
requisiti minimi di efficienza per gli impianti di condizionamento;
·
installazione
obbligatoria di sistemi precisi di controllo della pressione dei pneumatici;
·
definizione di
limiti massimi di resistenza al rotolamento dei pneumatici applicabili nell'UE
per i pneumatici delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri;
·
impiego di
indicatori di cambio marcia, per stabilire in che misura i consumatori
utilizzano questi dispositivi nelle condizioni reali di guida;
·
miglioramenti in
termini di risparmio del carburante nei veicoli commerciali leggeri (furgoni),
con l'obbligo di raggiungere l'obiettivo di 175 g CO2/km entro il
2012 e di 160 g CO2/km entro il 2015;
·
incremento
dell'uso di biocarburanti, massimizzandone le prestazioni ambientali.
Le comunicazioni sottolineano che, al di
là del quadro legislativo, la strategia per abbattere ulteriormente le
emissioni di CO2 dovrebbe anche promuovere un impegno supplementare per
quanto riguarda gli altri mezzi di trasporto su strada (veicoli pesanti ecc.) da
parte degli Stati membri (tassa sul CO2 e altri incentivi fiscali,
appalti pubblici ecologici, gestione del traffico, infrastrutture, ecc.) e
da parte dei consumatori (scelta informata al momento dell'acquisto,
comportamento di guida responsabile ecc.).
Su tali proposte la Commissione ha avviato una
consultazione pubblica rivolta a tutti i soggetti interessati, che si
concluderà il 30 giugno 2007. La consultazione è intesa a raccogliere opinioni
sull'attuazione della strategia proposta dalla Commissione, come pure
contributi e idee delle parti interessate sulle diverse opzioni possibili per
definire il futuro quadro legislativo, compresi gli aspetti economici, sociali
e ambientali di tali opzioni.
Il
21 settembre 2006,
in esito all’esame della relazione del Governo sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2005, la Camera dei deputati ha
approvato la risoluzione n. 6-00001
(on. Gozi e altri). Con riferimento alla politica
ambientale, la risoluzione impegna il Governo “a seguire con
particolare attenzione l'esame della strategia
a medio e lungo termine sui cambiamenti climatici, considerando il delicato equilibrio che la tematica
presenta tra le esigenze dì protezione ambientale e quelle del sistema
produttivo, con particolare attenzione all'osservanza degli accordi di Kyoto e
degli obiettivi di riduzione dei gas serra da essi prodotti”.
Per
quanto riguarda la politica energetica,
la risoluzione impegna il Governo “a sostenere la creazione di una reale
politica energetica dell'Unione europea, anche in considerazione
dell'importanza strategica e degli effetti positivi per il nostro Paese,
centrata sulla promozione del risparmio, dell'efficienza energetica, delle
fonti rinnovabili e dell'innovazione tecnologica nel settore” e ad adoperarsi “affinché
siano individuate in modo rapido ed adeguato le misure volte a dare attuazione
ai tre obiettivi fondamentali: la sostenibilità,
attraverso la diversificazione del mix energetico che deve poter tenere
conto di tutte le diverse fonti di energia, la competitività, innanzitutto attraverso la piena
realizzazione di un mercato interno dell'elettricità e del gas, la sicurezza
dell'approvvigionamento”.
Il
21 marzo 2007 la Commissione ha inviato
all’Italia una lettera di messa in
mora,ex
art 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), per non
aver presentato, entro i termini previsti, la relazione richiesta ai sensi
della Decisione 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le
emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il
protocollo di Kyoto.
L’art 3(1) della decisione, infatti, prevede
l’obbligo per gli Stati membri di presentare, entro il 15 gennaio di ogni
anno, una relazione contenente i dati sulle emissioni di gas ad effetto serra,
per consentire alla Commissione la valutazione dei progressi effettivi e la
preparazione delle relazioni annuali sulle
emissioni comunitarie, in applicazione della convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VIII Commissione
permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Mercoledì 28 febbraio 2007
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Mercoledì 28 febbraio 2007. - Presidenza del presidente
Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 14.05.
Sulla missione a Washington in occasione del
Forum dei legislatori dei Paesi del G8+5 sui cambiamenti climatici (14-15
febbraio 2007).
Ermete REALACCI, presidente, avverte che
è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata
mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne
dispone l'attivazione.
Comunica, quindi, che una delegazione della VIII Commissione,
composta dai deputati Francescato e Mereu (designati dal Presidente della Camera
su indicazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei
gruppi), si è recata a Washington, dal 14 al 15 febbraio 2007, per
partecipare al Forum dei legislatori dei Paesi del G8+5 sui cambiamenti
climatici. Fa presente che, in esito allo svolgimento della missione, i
deputati Francescato e Mereu hanno depositato una relazione finalizzata ad
illustrare alla Commissione l'andamento dei lavori del Forum (vedi allegato
1), unitamente alla dichiarazione finale approvata dai partecipanti all'iniziativa,
sia nella versione in lingua originale (vedi allegato 2), sia in una
traduzione non ufficiale in lingua italiana (vedi allegato 3). Ritiene,
peraltro, che l'odierna discussione sulle comunicazioni in titolo e la
documentazione depositata possano costituire utili elementi di integrazione
della base conoscitiva a disposizione della Commissione ai fini della
predisposizione della prevista relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo
143, comma 1, del Regolamento, sulle tematiche relative ai cambiamenti
climatici.
Grazia FRANCESCATO (Verdi), nel ringraziare per
la disponibilità e la collaborazione all'organizzazione dell'evento sia
la presidenza della Commissione sia gli uffici della Camera, con particolare
riferimento alle strutture che si occupano delle relazioni internazionali,
illustra i principali elementi emersi dal Forum di Washington, nato
dall'iniziativa britannica del luglio 2005 e che già prevede una
prossima tappa a Berlino, sotto il patrocinio della Presidenza tedesca. Osserva
che l'incontro ha registrato la partecipazione di rappresentanti del mondo
politico, ma anche di esperti, tecnici e, soprattutto, economisti, il che ha
consentito di conferire al Forum un taglio di forte integrazione tra il tema
dei cambiamenti climatici - che costringe tutti a riflettere
sull'attualità dei rischi che il pianeta corre - e le prospettive di
natura economica ad esso collegate. In tal senso, fa presente che il
«punto chiave» emerso da tale iniziativa interparlamentare è
costituito dalla chiara svolta intrapresa dagli Stati Uniti sul problema dei
cambiamenti climatici, che ha visto - in una logica assolutamente bipartisan,
fatte salve talune limitate eccezioni - la trasformazione di questo problema in
una nuova priorità della politica nazionale; gli Stati Uniti, infatti,
pur ribadendo la volontà di non partecipare agli attuali meccanismi del
Protocollo di Kyoto, hanno tuttavia acquisito la consapevolezza che il problema
del Climate Change esiste, manifestando la decisa intenzione di assumere
la leadership mondiale di questo nuovo corso. In questa logica,
peraltro, va letta - a suo avviso - la partecipazione all'iniziativa dell'ex
candidato democratico alle ultime elezioni presidenziali, senatore Kerry, che
ha fornito una visione molto preoccupata circa l'urgenza di intervenire in
questo settore; allo stesso tempo, segnala l'opportunità di riflettere
sulle dichiarazioni del Presidente della Banca Mondiale, Paul Wolfowitz, in
passato un «falco» della politica america, che si è soffermato
sui costi economici dell'inazione a fronte del fenomeno del cambiamento
climatico ed ha annunciato che la Banca Mondiale sta studiando misure volte a
sostenere le economie dei Paesi in via di sviluppo che coniughino lotta alla
povertà ed efficienza energetica.
Sottolinea che un altro punto politico di rilievo emerso dal Forum
è rappresentato dalla intenzione di Cina, India e Brasile di puntare
sullo sviluppo sostenibile e sull'energia pulita, a condizione che - in questo
percorso - siano forniti dai Paesi industrializzati i necessari strumenti per
il sostegno allo sviluppo tecnologico e all'adattamento del sistema energetico
e produttivo. L'incontro interparlamentare, inoltre, ha registrato una chiara
posizione dell'Unione europea, non soltanto attraverso il deciso intervento in
videoconferenza della Cancelliera tedesca Angela Merkel, ma anche mediante le
dichiarazioni rese dal Commissario europeo per l'ambiente. Evidenzia, infine,
che un punto nodale del Forum è stato rappresentato da quello che
definisce un «tentativo di matrimonio» tra ambiente ed economia,
nel cui ambito sono stati segnalati i potenziali effetti che il ruolo del
settore economico può produrre sui cambiamenti climatici, unitamente
alle opportunità che lo stesso sviluppo sostenibile può
presentare per il mondo del business.
In conclusione, ritiene che la dichiarazione finale che il Forum
dei legislatori ha adottato al termine dei lavori sia sufficientemente forte da
costituire una buona base di riflessione per i Governi dei Paesi interessati e
per lo sviluppo delle future azioni che i Parlamenti nazionali possono porre in
essere per affrontare nelle giuste dimensioni il problema dei cambiamenti
climatici.
Antonio MEREU (UDC), nell'associarsi ai
ringraziamenti già formulati dal deputato Francescato e nel rinviare
alla sua esposizione in ordine all'andamento dei lavori del Forum dei
legislatori di Washington, ritiene che la missione sia stata particolarmente
utile anche per rilanciare un confronto politico a livello nazionale. Rileva,
quindi, che la nuova posizione che sembra emergere dagli indirizzi illustrati
dai rappresentanti degli Stati Uniti porta a rafforzare l'attenzione sul
problema dei cambiamenti climatici, ponendo alla base dell'analisi su tale tema
il riconoscimento dell'insostenibilità di uno sviluppo produttivo che
non sia adeguatamente governato. Fa presente, peraltro, che il dibattito in
sede internazionale ha dimostrato come gli interventi sui fattori climatici
possano rappresentare anche un importante terreno di dialogo comune tra Paesi
sviluppati e Paesi collocati in aree di crisi internazionale, contribuendo a
rafforzare una cooperazione in grado di favorire la possibile pacificazione di
determinate situazioni di conflitto.
Osserva inoltre che la richiesta, proveniente dai Paesi in via di
sviluppo, di aiuto per l'adattamento tecnologico del sistema energetico, da
affrontare con realismo, può rappresentare un modello applicabile anche
a specifiche situazioni esistenti sul territorio nazionale, come ad esempio la Sardegna, nella quale
esiste un problema concreto legato alle nuove prospettive di utilizzo della
risorsa carbonifera. Su questi temi, a suo giudizio, occorre ragionare in
Parlamento e nel Paese, in uno spirito di confronto aperto e collaborativo,
tenendo presente che, accanto alle ragioni dell'ambientalismo, esiste anche
l'esigenza di garantire il benessere delle popolazioni; il segnale politico
prioritario che emerge dal Forum interparlamentare, infatti, è
costituito dall'invito a dialogare senza atteggiamenti di antagonismo ideologico
ed in un'ottica di comprensione globale di tutti i fattori coinvolti.
In ragione delle considerazioni espresse, segnala la
necessità di dare certezza alla legislazione nazionale in campo
ambientale, evitando di produrre continui cambiamenti nella disciplina
normativa della materia. Solo così, a suo giudizio, si creano i
necessari presupposti per l'avvio di una politica credibile in materia di
cambiamenti climatici, che sia in grado di garantire una effettiva
stabilità delle regole per le imprese cheinvestono nel settore. Ritiene
che, in questa logica, lo stesso Forum di Washington possa rappresentare una
solida base per lo sviluppo della futura attività della Commissione, in
un quadro che individui soluzioni unitarie ed ispirate al dialogo e al confronto
politico.
Aurelio Salvatore MISITI (IdV), nell'esprimere
apprezzamento per la relazione depositata dai deputati Francescato e Mereu,
segnala altresì l'esigenza di mantenere un atteggiamento prudente e, se
del caso, critico su taluni degli elementi che emergono nelle sedi
internazionali. In particolare, giudica essenziale che le riflessioni sugli
aspetti economici legati ai cambiamenti climatici non trascurino il rischio,
certamente attuale, di un approfondimento del gap tra Paesi
industrializzati e Paesi in via di sviluppo, sostenendo conseguentemente di non
poter concordare - sotto questi profili - con gli interventi sinora svolti.
Dichiara, inoltre, di non condividere le previsioni di lungo periodo basate su
modelli astratti, che sono fortemente suscettibili di creare previsioni errate;
al contrario, ritiene necessario procedere con interventi mirati per la
riduzione delle emissioni, senza farsi trascinare dai pericolosi richiami che,
negli ultimi periodi, stanno provenendo dal mondo economico.
Grazia FRANCESCATO (Verdi), intervenendo per
una precisazione, intende riconoscere l'opportunità di procedere con
prudenza sugli scenari futuri. Giudica al contempo necessario, peraltro, che vi
sia la massima consapevolezza degli esatti termini del problema,
affinché si possa intervenire prontamente per la soluzione dei rischi
attuali ed urgenti; in tal senso, ritiene che la strada indicata dalla
dichiarazione finale adottata dal Forum dei legislatori sia quella giusta.
Ermete REALACCI, presidente, osserva
preliminarmente che il dibattito mondiale sul tema dei cambiamenti climatici si
è spostato da una riflessione sull'esistenza o meno del fenomeno ad una
analisi della quantificazione della consistenza del fenomeno stesso, che ormai
tutti accettano come reale. A questo punto, pertanto, occorre che la politica
si faccia carico di questi sviluppi e proponga le più adeguate
soluzioni. Per tali motivi, ritiene che anche la missione a Washington abbia
dimostrato l'utilità della partecipazione a questi incontri
internazionali, al fine di riportare in Parlamento le riflessioni su problemi
di forte attualità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la
discussione sulle comunicazioni in titolo.
La seduta termina alle 14.30.
ALLEGATO 1
Missione
a Washington in occasione del Forum dei legislatori dei Paesi del G8+5 sui
cambiamenti climatici (14-15 febbraio 2007).
RELAZIONE
DEPOSITATA DAI DEPUTATI FRANCESCATO E MEREU
Dal
14 al 15 febbraio 2007 si è tenuto a Washington, presso la sede del
Senato americano, il Secondo Forum dei legislatori del Dialogo sul cambiamento
climatico dei Paesi G8+ 5. Il G8 + 5 è un Dialogo a livello parlamentare
sui cambiamenti climatici che vede coinvolti rappresentati legislativi dei
paesi del G8 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia,
Stati Uniti) insieme a 5 paesi in fase di avanzato sviluppo (Cina, India,
Messico, Brasile e Sud Africa). Il Dialogo si pone l'obiettivo di discutere un
accordo sui cambiamenti climatici «post 2012», ovvero
successivo alla prima scadenza del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle
emissioni dei gas serra, al fine di stabilire la più ampia convergenza
sugli obiettivi ambientali a livello mondiale.
In
tale prospettiva, il Dialogo intende concludere i propri lavori presentando una
piattaforma comune sul cambiamento climatico al vertice dei Capi di Stato del
G8 che si terrà in Giappone nel 2008.
L'iniziativa,
promossa dall'Organizzazione globale dei legislatori per l'equilibrio
ambientale (Globe), avente sede presso il Parlamento inglese (House of
Commons), con il patrocinio della Banca mondiale, è stata lanciata a
seguito del Dialogo a livello governativo (a sua volta voluto dal Premier
britannico Tony Blair), cui si è dato avvio con l'approvazione, al
Vertice G8 di Gleneagles del luglio 2005, del Piano d'azione del G8 su
cambiamenti climatici, energia pulita e sviluppo sostenibile.
Il
primo Forum si era tenuto a Bruxelles dal 7 al 9 luglio 2006 e si era concluso
con una dichiarazione finale rivolta ai Capi di Stato del G8 di San Pietroburgo
dello scorso luglio, al Presidente della Banca Mondiale e al Direttore
esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA). Successivamente, il
26 ed il 27 ottobre 2006, si è svolta a Pechino la riunione dei quattro
gruppi di lavoro (sviluppo e trasferimento di tecnologia; meccanismi di mercato
ed economia; adeguamento e risposta al cambiamento climatico; uso efficiente
delle risorse energetiche) finalizzata a predisporre la base di lavoro per il
Forum di Washington. A nessuno dei due eventi, al termine dei quali è
stata espressa l'esigenza di inserire il cambiamento climatico come
priorità nell'agenda dei lavori del G8 sia per il 2007 (presidenza
tedesca), sia per il 2008 (presidenza giapponese), nonché di inserirlo
nell'ambito dei Millenium goal dell'UNDP (United Nations Development
Programme), la Camera
dei Deputati aveva potuto partecipare perché impegnata nei lavori
parlamentari.
Il
Forum di Washington, al quale hanno preso parte sessantaquattro parlamentari,
provenienti da tutti i paesi G8+5, ed otto parlamentari europei, aveva
l'obiettivo di presentare una piattaforma comune sul cambiamento climatico al
prossimo Vertice del G8, che si terrà a Heiligendamm, in Germania, nel
giugno 2007, sotto la Presidenza
tedesca.
La Camera dei Deputati era
rappresentata dagli onorevoli Grazia Francescato, del Gruppo dei Verdi, per la
maggioranza, che fa parte dell'Advisory Board (di cui fanno parte tutti i paesi
del G8+5 ed è responsabile della direzione strategica del dialogo), ed
Antonio Mereu, del Gruppo dell'UDC, per l'opposizione. Invece, la delegazione
del Senato della Repubblica, composta dai senatori Mario Baccini, del Gruppo
dell'UDC, Vice Presidente del Senato, membro della III Commissione Affari
esteri e della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, e Edo Ronchi, del
Gruppo dell'Ulivo, Vice Presidente della XIII Commissione Territorio, Ambiente,
Beni ambientali, non ha potuto partecipare al Forum. Infine, va segnalata la
presenza nella delegazione del Parlamento europeo del parlamentare italiano
Vittorio Prodi.
Il
Forum di Washington, che poneva come punto di partenza della discussione le
conclusioni della relazione del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici
(IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change), pubblicata il 2 Febbraio
2007, che ha accertato - con una probabilità del 95 per cento - come
siano state le attività dell'uomo condotte dalla rivoluzione industriale
ad oggi a determinare il riscaldamento del pianeta, è stato
caratterizzato da due aspetti di particolare importanza nella politica riguardo
al cambiamento climatico.
Il
primo è rappresentato dal radicale mutamento nell'orientamento americano
rispetto al cambiamento climatico. Sono infatti intervenuti al Forum
parlamentari di primo piano quali il senatore repubblicano John McCain, in
corsa per le Presidenziali del 2008, il senatore John Forbes Kerry, candidato
per i democratici alle Presidenziali del 2004, il senatore democratico Joe
Lieberman, Presidente della Commissione per la Sicurezza nazionale, la
senatrice democratica Barbara Boxer, Presidente della Commissione Ambiente del
Senato americano, il senatore democratico Jeff Bingaman, Presidente della
Commissione Energia e Risorse naturali, il senatore democratico Joe Biden,
Presidente della Commissione Affari esteri, ma anche la repubblicana Olympia
Snowe, della Commissione Finanze, e il deputato democratico Jay Inslee; tutti
hanno manifestato l'intenzione di mutare orientamento riguardo al cambiamento
climatico, che rappresenterebbe una priorità assoluta per il Paese,
rispetto alla quale gli USA intenderebbero assumere la leadership mondiale. Lo
stesso senatore McCain ha definito il cambiamento climatico una questione di interesse
nazionale. Unica voce fuori dal coro è stata quella del senatore
repubblicano Larry Craig, che ha dichiarato il Protocollo di Kyoto morto. I
parlamentari americani hanno richiamato anche i contenuti della mozione
Bingaman, che dovrà essere sottoposta al voto del Senato americano, e
hanno ricordato come gli USA con solo il 5 per cento della popolazione mondiale
siano responsabili per il 20 per cento dell'effetto serra e come si sia ormai
raggiunta una massa critica scientifica che impone di prendere urgentemente dei
provvedimenti, dal momento che il fattore tempo non gioca a favore. La
rilevanza della questione deve indurre ad assumere accordi bypartisan, lanciando
un piano per una strategia comune, un piano globale che contempli, da un lato,
incentivi fiscali alle imprese per favorire il risparmio energetico,
dall'altro, stanziamenti significativi nella ricerca sulle fonti energetiche al
fine di diminuire la dipendenza dell'economia statunitense dai carburanti
fossili. Si è inoltre ricordato il caso della California, Stato virtuoso
dal punto di vista energetico.
Il
secondo passaggio di particolare rilievo politico è stato rappresentato
dalla posizione in merito ai GHG (greenhouse gas) dell'Europa. A
riguardo è intervenuta in videoconferenza la Cancelliera tedesca
Angela Merkel, che presiederà il vertice G8 di Heiligendamm di giugno. La Merkel, che insieme a Tony
Blair sostiene il Forum sui cambiamenti climatici, ha dichiarato che
studierà le conclusioni del Forum ed ha ricordato come la questione del
cambiamento climatico abbia rappresentato una priorità già al
Forum economico mondiale di Davos del gennaio scorso. Già nella
primavera 2007 l'Unione
europea dovrà sviluppare un programma post 2012 per i paesi
industrializzati. In tale prospettiva, il conseguimento dell'obiettivo posto
dall'Unione europea di prevedere interventi volti a fare in modo che la
temperatura mondiale non aumenti più di 2 gradi centigradi
rispetto ai livelli preindustriali è il primo risultato da conseguire e
la riduzione delle emissioni di CO2 nei Paesi UE del 20 per cento da
qui al 2020, il primo passo da compiere. Tre sono gli elementi chiave che
possono portare al conseguimento di tali risultati: un aumento globale
dell'efficienza energetica; un sempre maggiore ricorso alle energie rinnovabili;
l'utilizzo di incentivi economici. Anche per la Merkel, come già per
i senatori americani, il sostegno di nuove politiche energetiche creerà
nuovi mercati, nuovi incentivi produttivi e, infine, nuovi posti di lavoro.
È
quindi intervenuto il Commissario europeo per l'ambiente Stravos Dimas, che ha
ricordato come il cambiamento climatico fosse il punto più importante
del Forum di Davos. Ha richiamato la risoluzione del Parlamento europeo che
prevede la riduzione delle emissioni in tutti i paesi industrializzati del 30
per cento in comparazione con il livello di emissioni del 1990 entro il 2020 al
fine di conseguire una riduzione tra il 60 ed l'80 per cento entro il 2050. Si
tratta di una decisione unilaterale dell'Unione europea che verrà discussa
dal Consiglio nella prossima primavera. L'obiettivo che si intende perseguire a
livello mondiale è quello di conseguire una riduzione di gas serra del
50 per cento nei paesi in via di sviluppo e tra il 60 e l'80 per cento nei
paesi sviluppati. Ovviamente per far ciò ci vuole un accordo mondiale. I
paesi industrializzati devono dare l'esempio perché nel 2020 i paesi in
via di sviluppo influiranno sulla produzione di gas serra più dei paesi
OCSE. I mezzi per conseguire tali obiettivi sono: in primo luogo, l'uso del
mercato, attraverso il sistema di scambio di emissioni, che può
diventare il nucleo portante; in secondo luogo, lo sviluppo della ricerca; in
terzo luogo la lotta alla deforestazione, che contribuisce circa per il 20 per
cento all'aumento del GHG.
Anche
la Cina, l'India
ed il Brasile hanno manifestato l'intenzione di puntare quanto più
possibile su forme di energia pulita e di favorire lo sviluppo sostenibile.
Inoltre, hanno sostenuto la necessità di azioni congiunte tra i Paesi
sviluppati e quelli in via di sviluppo dirette soprattutto al trasferimento di
tecnologia. Il Giappone e la Cina,
ad esempio, hanno già iniziato una collaborazione finalizzata al
risparmio energetico. La priorità per queste economie rimane pur sempre
la lotta alla povertà (risulta, ad esempio, che in Cina si stia
costruendo una centrale a carbone di vecchio tipo alla settimana). In generale,
le azioni da intraprendere per contrastare il cambiamento climatico dovranno
tener conto delle diverse caratteristiche che distinguono le economie
sviluppate, quelle in via di sviluppo e quelle povere. Da un lato, infatti,
occorre riconoscere il bisogno di crescita economica e di accesso all'energia
per alleviare la povertà, dall'altro, bisogna tuttavia considerare che,
per ogni anno di ritardo nell'azione di controllo delle emissioni, aumenta il
rischio di impatti che richiederanno riduzioni più drastiche nel futuro,
con costi economici più alti e maggiori squilibri sociali. Impatti che
saranno probabilmente esacerbati da meccanismi di feedback paralleli al
riscaldamento del clima.
In
particolare, è stata esposta dalla senatrice Serys Sihessarenko, prima,
e dal deputato Antônio Palocci Filho, ex ministro delle finanze del
Brasile nel periodo 2003-2006, poi, l'esperienza brasiliana nel campo dei
biocombustibili ricavati dalla canna da zucchero.
Il
Forum di Washington si segnala anche per alcuni interventi di carattere
maggiormente tecnico di particolare rilievo.
Tra
questi si richiama, in primo luogo, quello di Sir Nicholas Stern, economista ed
attuale consigliere del Governo britannico, coordinatore del famoso rapporto,
il quale ha ricordato come nel rapporto da lui redatto si evidenzi chiaramente
che i costi dell'inazione saranno di gran lunga superiori a quelli dell'azione.
Da qui la necessità di un'azione urgente per ridurre le emissioni, che
rappresenta l'unico modo per garantire una crescita a lungo termine di tutte le
economie-sviluppate, emergenti e povere. Infatti, secondo il rapporto Stern il
costo degli effetti del cambiamento climatico fa supporre una caduta del PIL
mondiale tra il 5 per cento ed il 20 per cento, mentre l'attuazione di misure
finalizzate ad evitare un aumento di più di due gradi centigradi della
temperatura media comporta in termini di costi una cifra pari all'1 per cento
del PIL mondiale. L'obiettivo deve consistere nello stabilizzare le emissioni
ad un livello compreso tra 450 e 550 parti per milione di equivalente di CO2,
non essendo ipotizzabile una stabilizzazione ad un livello superiore al 550,
pur riconoscendo che il conseguimento dell'obiettivo posto dall'Unione europea
dell'aumento di 2 gradi Celsius richiederebbe una stabilizzazione al livello
più basso di questa scala. Secondo Stern, la riduzione del CO2
è un costo che il mondo sviluppato si deve assumere e gli strumenti per
conseguire tale risultato sono: un accordo sul versante degli scambi
internazionali che intervenga anche sul prezzo del carbonio; lo sviluppo della
tecnologia; l'arresto delle deforestazione. Al riguardo ha rilevato che in
Cina, ad esempio, si sta rimboschendo e che le auto americane non si vendono in
quel paese perché non corrispondono alle norme in vigore. Uno strumento
al quale si potrebbe fare ricorso, secondo il professor Stern, potrebbe essere
la tassa sull'esportazione di prodotti ad uso intensivo di energia.
Per
conseguire questo complesso di obiettivi sarebbe necessaria una combinazione di
vincoli inseriti in un contesto garantito dalle Nazioni Unite e siglati da
tutte le principali economie, insieme ad un partenariato bilaterale e multilaterale,
che riconosca la responsabilità dei paesi sviluppati ad assumere al
guida.
Il
professor Hans Joachim Schnellnhuber, direttore del Potsdam Institute e
consigliere capo del Governo tedesco per la Presidenza G8 sul
Cambiamento climatico, ha riferito in merito agli studi svolti dal Potsdam
Institute in questi anni ed ha segnalato che, sulla base delle ricerche
effettuare finora, se il pianeta continuerà a riscaldarsi a questi
ritmi, si produrranno i seguenti effetti: 1) la foresta amazzonica rischia di
scomparire entro la fine del secolo in ragione del cambiamento delle piogge
tropicali; 2) la barriera corallina scomparirà nel 2050; 3) la calotta
polare scomparirà entro cinquant'anni, il che a sua volta
provocherà un quarto effetto, vale a dire un considerevole innalzamento
del livello dei mari, ed un quinto effetto, la acidificazione degli oceani.
Inoltre, tutti questi fenomeni potrebbero determinare una spirale degenerativa
i cui effetti devastanti per il pianeta non sono preventivabili da parte degli
studiosi. Anche limitare l'aumento a due gradi può essere eccessivo per
alcuni valori. Ad ogni modo per arrivare ad un incremento di 2 gradi centigradi
della temperatura occorre ridurre dell'80 per cento le emissioni di CO2
rispetto ai valori attuali.
Lars
Josefsson, del CEO Vattenfall Group e consigliere capo del Governo tedesco per la Presidenza G8 sul
Cambiamento climatico, ha richiamato il rapporto ONU sul cambiamento climatico
e ha sostenuto la necessità di porre un prezzo alle emissioni.
Lo
stesso Presidente della Banca Mondiale, Paul Wolfowitz, si è soffermato
sui costi economici dell'inazione a fronte del fenomeno del cambiamento
climatico ed ha annunciato che la Banca Mondiale sta studiando misure volte a
sostenere le economie dei Paesi in via di sviluppo che coniughino lotta alla
povertà ed efficienza energetica.
Sono
inoltre intervenuti esponenti del mondo finanziario ed imprenditoriale, quali
Richard Branson, proprietario della Virgin, Rick Lazio, vicepresidente
esecutivo della JP Morgan Chase, Jim Rogers della Duke/Cinergy e Roger
Fergusson, della Swiss Re Amercia Corp.
Da
tutti i partecipanti è stato ribadito il ruolo vitale delle tecnologie e
dell'innovazione. L'Agenzia Internazionale per l'Energia calcola che nel 2050
la maggior parte dell'energia del mondo probabilmente continuerà a
provenire ancora dagli idrocarburi insieme al supporto delle energie
rinnovabili, dei biocarburanti sostenibili e delle tecnologie finalizzate
all'efficienza energetica. Ne deriva la particolare importanza di tecnologie
come la cattura e l'immagazzinamento del carbonio (CCS) per decarbonizzare i
combustibili fossili. Il modo più efficace e potente per stimolare gli
investimenti privati nella ricerca, nello sviluppo e nell'utilizzo delle
tecnologie nuove e di quelle esistenti consiste nell'adottare politiche che
fissino a lungo termine un valore di mercato per le emissioni di gas serra. La
determinazione di un prezzo globale del carbonio stimolerà una
rivoluzione tecnologica e l'adozione di misure di efficienza energetica, con
compensi per le imprese che per prime svilupperanno tecnologie avanzate, e
aiuterà a fornire incentivi per ridurre la deforestazione. Tuttavia, il
prezzo del carbonio è necessario ma non sufficiente. Si devono
realizzare forme di partenariato pubblico-privato per sostenere programmi di
ricerca e di sviluppo che portino nuove tecnologie al mercato. È inoltre
necessario intervenire maggiormente sul versante della cooperazione
internazionale per favorire il trasferimento delle tecnologie esistenti. Gran
parte degli interventi hanno altresì ribadito che l'efficienza
energetica è il modo più vantaggioso sul piano economico per
ridurre le emissioni di gas serra. Si è, inoltre, prestata attenzione
alla questione dell'adeguamento agli inevitabili impatti del cambiamento
climatico. La Banca
Mondiale calcola infatti che questo fenomeno
richiederà un'ulteriore somma compresa tra i 10 e i 40 miliardi di
dollari l'anno. Si è evidenziato che, se non si interverrà subito
per ridurre le emissioni, questa cifra aumenterà in modo impressionante
e si determineranno gravi impatti sulla sanità pubblica e sulla
disponibilità di risorse, inclusa l'acqua. Si è concordato nel
ritenere che l'adeguamento deve riguardare primariamente le politiche di
sviluppo e dovrebbe essere legato agli Aiuti per lo Sviluppo d'Oltremare (Overseas
Development Aid) e dovrebbe essere sostenuto da meccanismi finanziari
integrati.
Nella
seconda giornata di lavoro si sono esaminate ed approvate le conclusioni cui
sono giunti i quattro gruppi di lavoro, coordinati, il primo - Sviluppo e
Trasferimento di Tecnologia, dall'eurodeputato svedese Anders Wiman, il secondo - Meccanismi di Mercato ed Economia, dal
parlamentare inglese Stephen Byers, il terzo - Adeguamento al cambiamento
climatico, dal parlamentare indiano Suresh Prabhu, ed il quarto - Uso
efficiente delle risorse energetiche, dal parlamentare giapponese Yosuke
Shinoda.
Più
specificamente, il primo gruppo di lavoro - Sviluppo e Trasferimento di
Tecnologia, ha incentrato la propria attenzione sugli strumenti normativi e
politici per agevolare la produzione di energie a bassa emissione, sia nei
paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo, evidenziando gli ostacoli
che si riscontrano allo sviluppo delle energie pulite e valorizzando le
soluzioni più idonee a superarli, con particolare attenzione alla
partnership pubblico-privato. Una particolare attenzione è stata data
all'esigenza di conciliare la riduzione dei gas nocivi con il fabbisogno
energetico e le priorità economiche e sociali di molti paesi in via di
sviluppo e di intensificare le politiche per il trasferimento tecnologico.
Il
secondo gruppo di lavoro - Meccanismi di Mercato ed Economia, ha incentrato la
propria attenzione sugli strumenti finanziari e fiscali per incentivare il
mercato e le imprese a investire sulle tecnologie pulite. In particolare, sono
stati illustrati i vantaggi e le criticità dei cdm (clean development
mechanism), il sistema che permette alle imprese dei paesi sviluppati con
vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle
emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione,
generando crediti di emissione che potranno essere utilizzati per l'osservanza
degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto.
Il
terzo gruppo di lavoro - Adeguamento al cambiamento climatico, ha affrontato il
problema dell'impatto del cambiamento climatico sul contesto economico e
sociale degli stati nazionali, in particolare nei paesi meno sviluppati, e
delle relative politiche di adattamento. In particolare, si è rilevato
che l'aumento costante della temperatura sta gravemente compromettendo in
alcune aree del mondo gli obiettivi di sviluppo e di riduzione della
povertà. Gli interventi hanno sottolineato soprattutto la necessità
dell'informazione per aumentare la consapevolezza dei rischi del cambiamento
climatico nei decisori politici, nelle imprese e nella società civile al
fine di facilitare le azioni di adattamento e di mitigazione dei fenomeni
estremi.
Il
quarto gruppo di lavoro - Uso efficiente delle risorse energetiche, ha ribadito
che il risparmio energetico è uno dei fattori chiave per facilitare la
riduzione delle emissioni nocive. Sono state illustrate alcune linee di azione
che i parlamenti possono intraprendere in questo campo sia dal lato
dell'offerta che dal lato della domanda. In particolare: la razionalizzazione
dell'utilizzo delle energie inquinanti, la diffusione di prodotti energetici
basati sul risparmio, la diffusione di un sistema di trasporti pubblico non inquinante,
standard edilizi sostenibili e via seguitando.
A
conclusione del Forum di Washington è stata approvata una dichiarazione
finale nella quale si chiede ai Governi dei Paesi del G8 e a quelli del +5 di
concordare, nel Vertice G8 di Heiligendamm, sugli aspetti chiave di un quadro post
2012 e di richiedere che i negoziati globali su tale quadro includano:
obiettivi a lungo termine per i Paesi sviluppati; obiettivi adeguati per le
economie in via di sviluppo; incentivi per misure volte a ridurre la deforestazione;
incentivi per politiche e misure di sviluppo sostenibili nei Paesi in via di
sviluppo; programmi concentrati sulla formazione di capacità,
sull'accesso alle tecnologie e sugli incentivi economici - per aiutare i Paesi
in via di sviluppo a investire in tecnologie più efficienti e a basso
impiego di carbonio; per i Paesi in via di sviluppo più vulnerabili, un
crescente accesso ai dati sul clima, ricerca cooperativa sulle tecnologie
chiave per l'adeguamento in agricoltura e salute, dando la priorità alla
prevenzione dei disastri e migliorando la capacità di far fronte alla
variabilità climatica.
ALLEGATO 2
Missione
a Washington in occasione del Forum dei legislatori dei Paesi del G8+5 sui
cambiamenti climatici (14-15 febbraio 2007).
DICHIARAZIONE
FINALE (IN LINGUA ORIGINALE)


ALLEGATO
3
Missione
a Washington in occasione del Forum dei legislatori dei Paesi del G8+5 sui
cambiamenti climatici (14-15 febbraio 2007).
DICHIARAZIONE
FINALE (TRADUZIONE NON UFFICIALE)
DICHIARAZIONE
DEL FORUM DEI LEGISLATORI DI WASHINGTON 14-15 FEBBRAIO 2007
1.
Mai come ora, a seguito della pubblicazione della relazione del Gruppo di
Lavoro 1 del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici e della
Revisione Stern, comprendiamo gli aspetti scientifici ed economici dei
cambiamenti climatici. In quanto rappresentanti dei parlamenti di Paesi che
producono circa due terzi delle emissioni globali di gas serra, sottoponiamo
all'attenzione dei leader dei Paesi G8+5 la seguente dichiarazione:
2.
La relazione del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici,
pubblicata il 2 febbraio 2007, conclude che è stato accertato - con una
probabilità superiore al 90 per cento - che le attività dell'uomo
condotte dal 1750 hanno determinato il riscaldamento del pianeta. A nostro
avviso le prove che l'uomo stia cambiando il clima sono attualmente
inoppugnabili.
3.
Oggi è anche chiaro che i costi dell'inazione saranno superiori a quelli
dell'azione. Vi è la necessità di un'azione urgente per ridurre
le emissioni: questo sarebbe l'unico modo sicuro per garantire una crescita
sostenibile di tutte le economie.
4.
Ogni anno di ritardo nell'azione di controllo delle emissioni aumenta il
rischio di impatti che richiederanno riduzioni più drastiche nel futuro,
con costi economici più alti e maggiori squilibri sociali. Tali impatti
saranno probabilmente aggravati da meccanismi di «feedback positivo»
paralleli al riscaldamento del clima.
5.
Le azioni intraprese per contrastare i cambiamenti climatici devono tener conto
delle diverse caratteristiche che distinguono le economie sviluppate, quelle in
via di sviluppo e quelle povere, riconoscendo le necessità di crescita
economica e di accesso all'energia al fine di alleviare la povertà. Ma
dobbiamo ricordare che i cambiamenti climatici sono una questione globale e
tutti noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa in base alle nostre
capacità e responsabilità storiche.
6.
Sottolineiamo l'importanza dell'azione non solo per aumentare la sicurezza
climatica, ma per aumentare la nostra sicurezza energetica, migliorare la
qualità dell'aria e la nostra salute, sostenere la biodiversità.
7.
Ormai sappiamo che disponiamo oggi delle tecnologie per ridurre le nostre
emissioni, con le misure politiche giuste e i giusti incentivi. Per muoverci in
modo informato e mirato abbiamo bisogno di generare un consenso internazionale
sulle misure necessarie per stabilizzare il clima. Chiediamo ai governi dei
Paesi G8+5 di individuare, al vertice G8 di Heiligendamm, un obiettivo a lungo
termine - misurabile - per stabilizzare le concentrazioni di gas serra
nell'atmosfera. Riteniamo che tale obiettivo debba consistere nello
stabilizzare le concentrazioni a un livello compreso tra 450 e 550 parti per
milione di CO2 equivalente, nella consapevolezza che l'obiettivo di
2 gradi Celsius della UE richiederebbe una stabilizzazione sul valore
più basso di questa fascia.
8.
Per raggiungere quest'obiettivo avremo bisogno di una cornice ONU vincolante,
siglata da tutte le principali economie, insieme a partenariati bilaterali e
multilaterali, riconoscendo la responsabilità primaria dei paesi
sviluppati. Noi apprezziamo il lavoro svolto dal Dialogo di Gleneagles, il
Partenariato Asia-Pacifico, le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui
la banca Mondiale e le banche di sviluppo multilaterali, l'Agenzia
Internazionale per l'Energia (IEA). Ma abbiamo bisogno che si faccia di
più. Esortiamo il G8 e gli altri governi ad agire rapidamente a livello
nazionale e internazionale nei seguenti settori politici chiave:
9.
Le tecnologie e l'innovazione hanno un ruolo vitale. L'Agenzia Internazionale
per l'Energia calcola che nel 2050 la maggior parte dell'energia del mondo
probabilmente continuerà a provenire ancora dagli idrocarburi. Da qui
deriva la particolare importanza di tecnologie come la cattura e
l'immagazzinamento del carbonio (CCS) per decarbonizzare i combustibili fossili
accanto al sostegno alle energie rinnovabili, i biocarburanti sostenibili e le
tecnologie di efficienza energetica. Il modo più efficace e potente per
stimolare gli investimenti privati nella ricerca, nello sviluppo e
nell'utilizzo delle tecnologie nuove e di quelle esistenti consiste
nell'adottare politiche che fissino a lungo termine un valore di mercato per le
emissioni di gas serra. La determinazione di un prezzo globale del carbonio
stimolerà una rivoluzione tecnologica e l'adozione di misure di
efficienza energetica, premiando quelle imprese che per prime svilupperanno
tecnologie avanzate, e contribuirà a fornire incentivi per ridurre la deforestazione.
Il prezzo del carbonio è necessario, ma non è sufficiente. Sono
determinanti anche dei partenariati tra pubblico e privato per sostenere i
programmi R&D che portano nel mercato le nuove tecnologie. Resta ancora
molto, troppo da fare, a livello di cooperazione internazionale, per
condividere le tecnologie esistenti.
10.
Plaudiamo ai progressi conseguiti nell'ambito dell'ETS (Sistema Europeo di
Scambio delle Quote di Emissione), allo sviluppo della Iniziativa Regionale sui
Gas Serra (Regional Greenhouse Gas Iniziative) negli Stati Uniti e agli
altri programmi previsti in California, New Mexico e in Australia. Chiediamo ai
leader di sviluppare e rafforzare l'ETS, e di prevedere un ampliamento di tale
schema, includendovi altri settori. Esortiamo i leader ad adoperarsi
perché si crei un mercato globale del carbonio, ove sia possibile,
collegando lo schema europeo con gli altri che emergono nel mondo, a un mercato
più profondo e più liquido, contribuendo a ridurre le emissioni
al minor costo possibile.
11. L'efficienza energetica
è il modo più vantaggioso sul piano economico per ridurre le
emissioni di gas serra. L'Agenzia Internazionale per l'Energia calcola che, da
soli, i miglioramenti sul piano dell'efficienza energetica nel 2050 potranno ridurre
la domanda mondiale di energia di una quantità equivalente a quasi il 50
per cento dell'odierno consumo globale di energia, se i governi saranno pronti
ad attuare misure che incoraggino gli investimenti in tecnologie ad efficienza
energetica. Esiste anche un potenziale per l'introduzione di misure di
risparmio energetico nelle aziende e nelle abitazioni.
12.
La Banca Mondiale
calcola che l'adattamento agli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici
richiederà un'ulteriore spesa compresa tra i 10 e i 40 miliardi di
dollari l'anno. Se non ci muoviamo adesso per ridurre le emissioni, questa
cifra aumenterà in modo impressionante e ci saranno impatti gravi sulla
sanità pubblica e sulla disponibilità delle risorse essenziali,
inclusa l'acqua. L'adattamento deve riguardare primariamente le politiche di
sviluppo e dovrebbe essere legato all'Aiuto per lo sviluppo ai paesi terzi (Overseas
Development Aid) e sostenuto da meccanismi finanziari integrati.
13.
Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo a lungo termine,
esortiamo i governi del G8 e dei paesi +5 affinché, in occasione del
Vertice G8 a Heiligendamm, concordino sugli elementi principali di un quadro post
2012 e chiedano che i negoziati mondiali su tale quadro siano avviati alla
riunione di Bali del UNFCCC a novembre, per essere conclusi nel 2009.
Proponiamo che questi elementi comprendano quanto segue:
a)
obiettivi a lungo termine per i Paesi sviluppati;
b)
obiettivi adeguati per le economie in via di sviluppo;
c)
incentivi per le misure che riducano la deforestazione;
d)
incentivi per politiche e misure di sviluppo sostenibile nei Paesi in via di
sviluppo;
e)
programmi concentrati sul rafforzamento delle capacità, sull'accesso
alle tecnologie e sugli incentivi economici per aiutare i Paesi in via di
sviluppo a investire in tecnologie più efficienti e a basso impiego di
carbonio;
f)
per i più vulnerabili tra i paesi in via di sviluppo, un maggiore
accesso ai dati sul clima, alla ricerca cooperativa sulle tecnologie essenziali
per l'adeguamento nei settori agricolo e sanitario, dando priorità alla
prevenzione dei disastri naturali e una maggiore rispondenza alla
variabilità climatica.
|
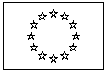
|
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
|
Bruxelles, 10.1.2007
COM(2007) 1definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO E AL PARLAMENTO EUROPEO
UNA POLITICA ENERGETICA PER L'EUROPA
{SEC(2007) 12}
INDICE
1. Le sfide................................................................................................................................ 61
1.1........ Sostenibilità.................................................................................................................. 61
1.2........ Sicurezza dell'approvvigionamento................................................................................ 62
1.3........ Competitività................................................................................................................ 62
2. Un obiettivo
strategico per guidare la politica energetica dell'Europa....................................... 63
3. Piano d'azione....................................................................................................................... 64
3.1........ Il mercato interno dell'energia........................................................................................ 64
3.2........ Solidarietà tra Stati
membri e sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio, gas e
elettricità69
3.3........ L'impegno a lungo termine per la
riduzione delle emissioni di gas serra e il sistema comunitario di scambio di
diritti di emissione.................................................................................................................. 70
3.4........ Un programma ambizioso di misure
a favore dell'efficienza energetica a livello comunitario, nazionale, locale e
internazionale................................................................................................................ 70
3.5........ Un obiettivo a più lungo termine
per le fonti di energia rinnovabili.................................... 71
3.6........ Un piano strategico europeo per
le tecnologie energetiche.............................................. 74
3.7........ Verso un uso di combustibili
fossili a basse emissioni di CO2.......................................... 75
3.8........ Il futuro dell'energia nucleare......................................................................................... 76
3.9........ Una politica energetica
internazionale che persegue attivamente gli interessi dell'Europa... 77
3.10...... Monitoraggio e notifiche efficaci.................................................................................... 79
4........... Portare avanti il lavoro.................................................................................................. 80
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO E AL PARLAMENTO EUROPEO
UNA POLITICA ENERGETICA PER L'EUROPA
"A
tal fine, i ministri hanno convenuto i seguenti obiettivi:…….
mettere a disposizione delle economie europee una quantità maggiore di
energia a prezzi più convenienti …."
Dichiarazione
di Messina, 1955
1.1. Le sfide
L'energia
costituisce un elemento fondamentale per il funzionamento dell'Europa. Purtroppo
i giorni dell'energia a buon mercato sembrano essere finiti. Tutti i membri
dell'Unione europea devono adesso affrontare le sfide poste dai cambiamenti
climatici, dalla crescente dipendenza dalle importazioni e dai prezzi
più elevati dell'energia. Inoltre l'interdipendenza degli Stati membri
comunitari, in materia di energia come in numerosi altri settori, non fa che
aumentare - un'interruzione dell'approvvigionamento di energia in un paese ha
immediate conseguenze in altri paesi.
L'Europa deve agire adesso
per garantire un'energia sostenibile, sicura e competitiva. Così facendo
l'UE ritornerebbe alle sue origini. Nel 1952 con il trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e nel 1957 con il trattato Euratom, gli
Stati membri fondatori avvertirono l'esigenza di adottare un approccio comune
nel settore dell'energia. I mercati energetici e le considerazioni geopolitiche
sono notevolmente cambiati da allora, ma l'esigenza di un'azione comunitaria
è più pressante che mai. Se l'UE non agisce, anche i suoi
obiettivi in altre aree, tra cui la Strategia di Lisbona e gli Obiettivi di sviluppo
del millennio, saranno più difficili da conseguire. La nuova politica
energetica europea deve essere ambiziosa, competitiva e a lungo termine –
a beneficio di tutti gli europei.
1.1.1.1
Sostenibilità
1.2.L'energia è all'origine dell'80% di tutte
le emissioni di gas serra nell'UE[61], ed è alla base dei cambiamenti climatici
e, in massima parte, dell'inquinamento atmosferico. L'UE si è impegnata
ad affrontare questa problematica - riducendo le emissioni nell'UE e a livello
mondiale per portarle ad un valore che limiterebbe l'aumento delle temperature
mondiali a 2°C
rispetto ai livelli preindustriali. Tuttavia, con le politiche vigenti in
materia di energia e trasporti, le emissioni di CO2 nell'UE, invece
di diminuire, aumenterebbero di circa il 5% da qui al 2030 e le emissioni
mondiali aumenterebbero del 55%. Le attuali politiche energetiche dell'Unione
europea in materia di energia non sono sostenibili.
1.2 Sicurezza dell'approvvigionamento
L'Europa
dipende sempre più dalle importazioni di idrocarburi. Se si manterranno
le tendenze attuali la sua dipendenza dalle importazioni di energia passerebbe dal
50% del consumo energetico totale attuale dell'UE al 65% nel 2030. La
dipendenza dalle importazioni di gas dovrebbe aumentare dal 57% all'84% entro
il 2030 e dalle importazioni di petrolio dall'82% al 93%.
Questa
dipendenza comporta rischi politici ed economici in quanto la pressione sulle
risorse energetiche mondiali è particolarmente forte. L'Agenzia
internazionale dell'energia (AIE) prevede che la domanda mondiale di petrolio
aumenterà del 41% da qui al 2030. Non si sa come questa domanda
sarà soddisfatta: l'AIE nell'edizione del 2006 del suo "World
Energy Outlook" dichiara che la capacità e la volontà dei
maggiori produttori di gas e petrolio di aumentare gli investimenti per far
fronte alla crescente domanda sono del tutto incerte[62]. Aumenta il rischio di un'interruzione
dell'approvvigionamento
Oltretutto
non esistono ancora i meccanismi che garantiscono la solidarietà tra gli
Stati membri qualora si verifichi una crisi energetica e vari Stati membri
dipendono, in larga misura o completamente, da un unico fornitore di gas.
Nello
stesso tempo, la domanda di energia elettrica dell'UE, ipotizzando una
situazione stabile, aumenta di circa 1,5% l'anno. Anche in presenza di
un'adeguata politica in materia di efficienza energetica, per la sola
produzione saranno necessari, nei prossimi 25 anni, investimenti pari a 900
miliardi di euro. La prevedibilità e i mercati interni del gas e
dell'elettricità efficaci, che ancora non esistono, sono indispensabili
per realizzare gli investimenti a lungo termine necessari.
1.3.1.3
Competitività
L'UE
risente sempre più degli effetti della volatilità dei prezzi,
degli aumenti di prezzo nei mercati energetici internazionali e delle
conseguenze della graduale concentrazione delle riserve di idrocarburi nelle
mani di pochi. I potenziali effetti sono considerevoli: se, per esempio, il
petrolio aumentasse a 100 $ il barile nel 2030, la fattura delle importazioni
totali di energia dell'UE-27 aumenterebbero di circa 170 miliardi, equivalente
ad un aumento annuo pari a 350 euro per ciascun cittadino dell'UE[63]. Solo una minima parte di questo trasferimento di
ricchezza risulterebbe in posti di lavoro supplementari nell'Unione europea.
Previa
l'istituzione della politica e dei quadri legislativi adeguati, il mercato
interno dell'energia potrebbe incentivare prezzi e risparmi energetici equi e
competitivi, nonché maggiori investimenti. Tuttavia, non sono ancora
riunite tutte le condizioni necessarie e ciò impedisce ai cittadini e
all'economia dell'Unione europea di beneficiare pienamente dei vantaggi della
liberalizzazione dell'energia. Occorre stabilire un orizzonte di più
lungo termine per le restrizioni sulle emissioni di carbonio al fine di
incentivare gli investimenti necessari nel settore dell'elettricità.
Il
rafforzamento degli investimenti, in particolare a favore dell'efficienza
energetica e delle energie rinnovabili, dovrebbe creare posti di lavoro e
promuovere l'innovazione e l'economia
della conoscenza nell'UE. L'Unione europea è già il leader
mondiale nel settore delle energie rinnovabili con un fatturato di 20 miliardi
di euro e 300 000 posti di lavoro[64]. Possiede il potenziale per guidare il mercato
mondiale delle tecnologie energetiche a basse emissioni carbonio in rapida
crescita. Nel settore dell'energia eolica, ad esempio, le imprese UE dominano
il 60% del mercato mondiale. La volontà dell'Europa di continuare a
guidare la lotta mondiale contro i cambiamenti climatici offre la
possibilità di orientare meglio i programmi di ricerca mondiali. Occorre
mantenere tutte le opzioni al fine di garantire lo sviluppo di tecnologie
emergenti.
Nello
stesso tempo, in tutte le fasi della concezione e dell'attuazione delle singole
misure, si deve tenere conto della dimensione sociale della politica energetica
europea. Questa politica dovrebbe contribuire in generale alla crescita e
all'occupazione in Europa sul lungo termine, ma potrebbe avere un impatto
considerevole su alcuni prodotti e processi del commercio internazionale, in
particolare per i settori industriali ad alta intensità energetica.
2.2 Un obiettivo
strategico per guidare la politica energetica dell'Europa
Il
punto di partenza di una politica energetica europea comporta tre aspetti
diversi: lotta contro i cambiamenti climatici, limitazione della vulnerabilità
esterna dell'UE nei confronti delle importazioni di idrocarburi e promozione
dell'occupazione e della crescita, in modo da fornire ai consumatori un'energia
sicura a prezzi accessibili.
Alla
luce dei numerosi contributi pervenuti durante il periodo di consultazione sul
suo Libro verde[65], la Commissione propone, nella presente analisi
strategica della situazione energetica, che la politica energetica si fondi
sugli elementi seguenti:
·un obiettivo per l'Unione europea, nei negoziati
internazionali, di ridurre del 30% le emissioni di gas serra dal qui al 2020
(rispetto ai livelli del 1990); inoltre le emissioni di gas serra a livello
mondiale dovranno, da qui al 2050, essere ridotte del 50% rispetto al 1990 e
ciò presuppone riduzioni che vanno dal 60 all'80% nei paesi
industrializzati nello stesso periodo;
·un impegno da parte dell'UE di conseguire comunque
una riduzione di almeno 20% dei gas serra nel 2020 rispetto ai valori del 1990.
Questi
elementi sono al centro della comunicazione della Commissione "Limiting Climate Change to 2° - Policy
Options for the EU and the world for 2020 and beyond"[66].
Il
rispetto dell'impegno preso dall'UE di agire subito sui gas serra dovrebbe essere
al centro della nuova politica energetica europea per tre motivi: (i) le
emissioni di CO2 dovute all'utilizzazione dell'energia costituiscono
l'80% delle emissioni di gas serra nell'UE, ridurre le emissioni significa
utilizzare meno energia e utilizzare più energia pulita prodotta a
livello
locale;
(ii) limitare la crescente esposizione dell'UE alla volatilità e
all'aumento dei prezzi del petrolio e del gas e (iii) promuovere l'istituzione
di un mercato energetico più competitivo a livello dell'UE, incentivare
l'innovazione e le tecnologie e promuovere l'occupazione.
Considerati
nell'insieme, questo obiettivo strategico e le misure concrete per conseguirlo
(illustrate qui di seguito) rappresentano il nucleo centrale di una nuova politica energetica europea.
3.3. Piano d'azione
Per
conseguire l'obiettivo strategico summenzionato occorre trasformare l'Europa in
un'economia ad elevata efficienza energetica e basse emissioni di CO2,
favorendo una nuova rivoluzione
industriale che acceleri la transizione verso una crescita a basse
emissioni di carbonio e producendo, nel corso degli anni, un aumento
spettacolare della quantità di energia locale a basse emissioni prodotta
ed utilizzata. La sfida consiste nel farlo in un modo che ottimizzi gli incrementi
di competitività potenziali per l'Europa e limiti i potenziali costi.
Le
misure esistenti in settori come l'energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili, i biocarburanti, l'efficienza energetica e il mercato interno
dell'energia hanno già prodotto risultati importanti, ma non sono
sufficientemente coerenti per garantire la sostenibilità, la sicurezza
dell'approvvigionamento e la competitività. Nessun elemento della
politica può apportare da solo tutte le risposte e per questo i vari
aspetti devono essere considerati nel loro insieme. Ad esempio, come già
menzionato, occorre tenere conto della dimensione sociale in tutte le fasi di
concezione e attuazione delle singole misure[67]; inoltre sarà necessario sviluppare
ulteriormente lo sfruttamento dei mari e degli oceani per conseguire gli
obiettivi energetici dell'UE, dato il loro potenziale di sostegno alla
produzione di energia e alla diversificazione delle vie e dei modi di trasporto
dell'energia[68]. In primo luogo si tratterà per gli Stati
membri di approvare una visione strategica e un piano d'azione per i prossimi
tre anni al preciso scopo di procedere verso un'alleanza internazionale di
paesi sviluppati al fine, quanto meno, di ridurre le emissioni globali dei gas
serra del 30% entro il 2020 e contribuire in modo significativo alla riduzione
delle emissioni dei gas serra nell'UE di 20% da qui al 2020. Questo approccio
comporterà un attento monitoraggio e l'elaborazione di relazioni sui
progressi realizzati nonché uno scambio efficace di buone pratiche e una
costante trasparenza – attraverso la presentazione regolare, da parte
della Commissione, di un aggiornamento dell'analisi strategica della politica
energetica.
Le
misure presentate qui di seguito non solo metteranno l'UE sulla strada che le
consentirà di diventare un'economia della conoscenza a basse emissioni
di carbonio, ma renderanno più sicuro l'approvvigionamento energetico e
contribuiranno a rafforzare gradualmente la competitività.
3.1.3.1 Il
mercato interno dell'energia
Un
vero mercato interno dell'energia è indispensabile per conseguire i tre
obiettivi dell'Europa in materia di energia presentati qui di seguito.
·§
Competitività:
un mercato competitivo permetterà di ridurre i costi per i cittadini e
le imprese e favorirà l'efficienza energetica e gli investimenti.
·§
Sostenibilità:
un mercato competitivo è essenziale affinché gli strumenti
economici producano i loro effetti, in particolare il sistema di scambio di
quote di emissione. I gestori delle reti di trasporto, inoltre, devono avere
interesse a promuovere il collegamento a fonti rinnovabili, la produzione
combinata di calore ed energia elettrica e la produzione su piccolissima scala
che incentiverebbero l'innovazione ed incoraggerebbero le piccole imprese e i
cittadini a prendere in considerazione fonti di approvvigionamento non
tradizionali.
·§
Sicurezza
dell'approvvigionamento: l'esistenza di un mercato interno dell'energia
efficace e competitivo può offrire notevoli vantaggi in termini di
sicurezza dell'approvvigionamento e di servizio pubblico dotato di norme
rigorose. La separazione effettiva delle reti dalle parti aperte alla
concorrenza nei settori del gas e dell'elettricità incentiva
concretamente le imprese ad investire in nuove infrastrutture e in nuove capacità
di interconnessione e produzione, e consente pertanto di evitare nuovi
black-out e impennate dei prezzi immotivate. Un vero mercato unico favorisce la
diversità.
La CE ha già adottato una serie di misure[69] destinate ad istituire un mercato interno
dell'energia che offra veramente delle opzioni a tutti i consumatori dell'UE,
cittadini o imprese, nuovi sbocchi alle imprese e più scambi
transfrontalieri.
La comunicazione sul mercato interno dell'energia[70] e la relazione finale sull'indagine settoriale in
materia di concorrenza[71] dimostrano che le regole e le misure attuali non
hanno ancora consentito di conseguire questi obiettivi. Questa assenza di
progressi sembra indurre gli Stati membri ad imporre massimali generalizzati
dei prezzi dell'elettricità e del gas. In funzione dei livelli di questi
massimali e della loro portata generale o meno, possono impedire al mercato
interno dell'energia di funzionare ed eliminano anche qualsiasi segnale di
prezzo circa l'esigenza di nuove capacità, determinando sottoinvestimenti
e futuri problemi di approvvigionamento. Inoltre possono ostacolare la
penetrazione nel mercato dei nuovi operatori, ivi compresi quelli che offrono
energia pulita.
Alla luce delle numerose osservazioni pervenute nel
periodo di consultazione sul Libro verde, la Commissione ritiene
che questa situazione debba cambiare. Occorre adottare una serie coerente di
misure al fine di istituire entro tre anni una Rete europea del gas e
dell'elettricità e istituire un mercato energetico veramente
concorrenziale su scala europea.
A
tal fine, la Commissione
ha stabilito i requisiti seguenti.
3.1.1.3.1.1
Separazione (unbundling)
La
relazione sul mercato interno e l'indagine settoriale indicano che esiste un
rischio di discriminazione e abuso quando le imprese controllano nello stesso
tempo le reti energetiche e la produzione o la vendita di energia, proteggendo
i mercati nazionali e impedendo la concorrenza. Una situazione di questo tipo
scoraggia anche le imprese verticalmente integrate ad investire adeguatamente
nelle loro reti, in quanto aumentando la capacità della rete la
concorrenza che esiste sul loro "mercato domestico" aumenta e i
prezzi di mercato scendono.
La
Commissione ritiene
che si possano considerare due opzioni per porre rimedio a tale situazione: il
ricorso ad un operatore di rete del tutto indipendente (sistema in cui
l'impresa verticalmente integrata rimane proprietaria degli attivi di rete e
percepisce per questi una remunerazione regolamentata, ma non ne assicura l'esercizio,
la manutenzione o lo sviluppo) o la separazione della proprietà (il
famoso unbundling) (in cui le imprese
di rete sono completamente separate dalle imprese di distribuzione e
produzione)[72].
Le
informazioni economiche disponibili suggeriscono che la separazione della
proprietà costituisce il mezzo più efficace per garantire una
scelta ai consumatori e incentivare gli investimenti, in quanto crea una rete
di imprese che non sono condizionate da interessi legati alla fornitura/produzione
che condizionano le loro decisioni in materia di investimenti; la separazione
non richiede una regolamentazione dettagliata, complessa e vincolante e non
impone modifiche amministrative sproporzionate.
L'approccio
che prevede un gestore di rete indipendente sarebbe preferibile allo statu quo, ma la sua realizzazione
comporta una regolamentazione dettagliata, complessa e vincolante ed è
meno efficace per eliminare gli elementi che scoraggiano gli investimenti nelle
reti.
Inoltre
è opportuno riesaminare le disposizioni relative alla separazione delle
attività di distribuzione, che attualmente esentano i distributori con
meno di 100 000 clienti dalla maggior parte dei requisiti di separazione.
3.1.2.3.1.2
Regolamentazione efficace
Innanzitutto
occorre armonizzare i livelli di potere e di indipendenza dei regolatori
dell'energia, sulla base del massimo (e non del minimo) denominatore comune
dell'UE. In seguito occorre affidare loro il compito di promuovere non solo
l'adeguato sviluppo del loro mercato nazionale, ma anche quello del mercato
interno dell'energia.
Si
devono altresì armonizzare le norme tecniche necessarie per consentire
l'adeguato funzionamento del commercio transfrontaliero. Su questo aspetto si
sono fatti pochissimi passi avanti. L'istituzione dell'ERGEG (Gruppo europeo
dei regolatori per il gas e l'elettricità) e la regolamentazione
dell'elettricità e del gas non hanno garantito la governance necessaria. La maggior parte delle norme tecniche
pertinenti differiscono ancora da uno Stato membro all'altro, rendendo gli
scambi transfrontalieri difficili, se non impossibili. Tre opzioni meritano di
essere considerate.
·§
Evoluzione progressiva dell'approccio attuale: rafforzare la collaborazione tra i regolatori
nazionali imponendo agli Stati membri di assegnare ai regolatori nazionali un
obiettivo comunitario e introdurre un meccanismo che consenta alla Commissione
di esaminare alcune decisioni dei regolatori nazionali che hanno un impatto sul
mercato interno dell'energia[73].
·§
Rete europea di regolatori indipendenti
(“ERGEG+”): nell'ambito
di questo sistema, sarebbe ufficializzato il ruolo dell'ERGEG che dovrebbe
strutturare delle decisioni vincolanti per i regolatori e gli operatori del
mercato interessati, come gli operatori di rete, le borse elettriche o i
generatori di energia, riguardanti aspetti tecnici particolari e meccanismi
relativi alle questioni transfrontaliere.
·§
Istituzione
di un nuovo organo unico a livello
comunitario incaricato, in particolare, di adottare decisioni individuali
per il mercato comunitario del gas e dell'elettricità riguardanti
aspetti tecnici e di regolamentazione importanti per consentire un
funzionamento efficace egli scambi transfrontalieri[74].
Esiste
una relazione tra separazione e regolazione. I mercati in cui non si è
arrivati alla separazione della proprietà richiedono una
regolamentazione più dettagliata, complessa e prescrittiva. In tali
situazioni i regolatori nazionali devono disporre di poteri più
vincolanti ed ampi per evitare qualsiasi discriminazione. Tuttavia, i
regolatori non potranno mai eliminare completamente gli ostacoli che
scoraggiano gli investimenti adeguati nelle reti in cui non vige la separazione
della proprietà.
Per
quanto riguarda le tre opzioni, la Commissione ritiene che la prima, ossia
l'evoluzione progressiva dell'approccio attuale, non basterebbe, soprattutto
perché i progressi continuerebbero a basarsi su un accordo volontario
tra i 27 regolatori nazionali i cui interessi sono spesso divergenti. Pertanto
l'approccio minimo in grado di determinare progressi rapidi e reali
nell'armonizzazione degli aspetti tecnici necessari per l'adeguato
funzionamento del commercio transfrontaliero sarebbe l'approccio ERGEG+.
In
attesa che sia presa e attuata una decisione ufficiale, i regolatori dovrebbero
essere incoraggiati a collaborare più strettamente per utilizzare i
poteri di cui beneficiano in un modo più efficace, su base volontaria.
3.1.3.3.1.3
Trasparenza
La
trasparenza è indispensabile per un corretto funzionamento del mercato. Attualmente
gli operatori di reti di trasporto comunicano informazioni di vari livelli,
rendendo la concorrenza per i nuovi operatori più agevole in alcuni
mercati rispetto ad altri. Inoltre, alcuni regolatori impongono ai produttori
una maggiore trasparenza per quanto concerne la disponibilità di
produzione rispetto ad altri; tale obbligo può contribuire ad evitare la
manipolazione dei
prezzi.
Occorre stabilire requisiti minimi che tutte le imprese UE dovranno rispettare,
simili a quelli adottati nel settore delle telecomunicazioni[75].
3.1.4.3.1.4
Infrastrutture
Il
piano di interconnessione prioritario[76] stabilisce cinque priorità:
·§
individuare
le infrastrutture mancanti più importanti da qui al 2013 e garantire un sostegno
politico paneuropeo per colmare le lacune;
·§
nominare
quattro coordinatori europei per seguire quattro dei più importanti
progetti prioritari: il collegamento della rete elettrica tra Germania, Polonia
e Lituania; i collegamenti con i parchi eolici off-shore in Europa
settentrionale; le interconnessioni elettriche tra Francia e Spagna; e il
gasdotto Nabucco, che trasporta gas dal Mar Caspio all'Europa centrale;
·§
stabilire
di comune accordo un periodo massimo di 5 anni entro il quale le procedure di
pianificazione e approvazione dovranno essere completate per i progetti
definiti "di interesse europeo" nell'ambito degli orientamenti
relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia;
·§
valutare
la necessità di aumentare il finanziamento delle reti transeuropee di
energia, in particolare per agevolare l'integrazione nella rete
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili; e
·§
istituire
un nuovo meccanismo e una nuova struttura comunitari per gli operatori di reti
di trasporto (TSO) responsabili della pianificazione coordinata delle reti.
3.1.5.3.1.5
Sicurezza delle reti
Per
rafforzare l'affidabilità del sistema elettrico dell'UE e prevenire i
black out, le esperienze recenti hanno evidenziato la necessità di norme
di sicurezza comuni minime e vincolanti per le reti dell'Unione europea. Uno
dei compiti del nuovo meccanismo e della nuova struttura comunitari per gli
operatori delle reti di trasporto dovrebbe essere proprio proporre norme di questo
tipo che diventerebbero vincolanti, previa l'approvazione dei regolatori di
energia.
3.1.6.3.1.6
Adeguamento delle capacità di produzione di elettricità e di
approvvigionamento di gas
Nel
corso dei prossimi 25 anni, l'Europa dovrà investire 900 miliardi di euro
in nuove capacità di produzione elettrica. Il gas rimane un ottimo
combustibile, visto la sua elevata efficienza energetica, ma richiederà
anch'esso degli investimenti pari a 150 miliardi di euro destinati alle
centrali elettriche a gas e 220 miliardi di euro supplementari destinati alle
infrastrutture. Per garantire un livello adeguato di nuovi investimenti,
occorre innanzitutto fare in modo che il mercato interno dell'energia funzioni
correttamente e lanci adeguati segnali in materia di investimento. Inoltre,
è necessario anche un controllo accurato
dell'equilibrio
tra offerta e domanda al fine di individuare eventuali carenze. Si
tratterà di un ruolo fondamentale del nuovo ufficio dell'Osservatorio
dell'energia (cfr. qui di seguito).
3.1.7.3.1.7
L'energia in qualità di servizio pubblico
L'energia
è essenziale per tutti i cittadini europei. La legislazione europea in
vigore prevede già il rispetto di oneri di servizio pubblico. L'Unione
europea deve però compiere passi avanti nella lotta contro la
"povertà energetica". La Commissione
elaborerà una Carta del cliente nel settore dell'energia che si
prefiggerà quattro grandi obiettivi:
·§
contribuire
all'istituzione di regimi di aiuto per consentire ai cittadini dell'UE
più vulnerabili di far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia;
·§
migliorare
il livello minimo di informazione di cui dispongono i cittadini per aiutarli a
scegliere tra i vari fornitori e le opzioni di approvvigionamento;
·§
ridurre
le formalità amministrative che i clienti devono svolgere per cambiare
fornitore;
·§
proteggere
i clienti dalle pratiche di vendita sleali.
3.2.3.2
Solidarietà tra Stati membri e sicurezza dell'approvvigionamento di
petrolio, gas e elettricità
Il
mercato interno dell'energia rafforza l'interdipendenza degli Stati membri in
materia di approvvigionamento di elettricità e di gas. Nonostante gli
obiettivi stabiliti in materia di efficienza energetica e di utilizzazione di
fonti di energia rinnovabili, il petrolio e il gas continueranno a soddisfare
oltre la metà del fabbisogno energetico dell'Unione, determinando una
forte dipendenza dalle importazioni in entrambi i settori (oltre il 90% per il
petrolio e circa l'80% per il gas nel 2030). La produzione di elettricità
si baserà in larga misura sul gas. In assenza di progressi tecnologici
straordinari, il petrolio manterrà una posizione dominate nel settore
dei trasporti. La sicurezza dell'approvvigionamento di questi due combustibili
resterà, pertanto, fondamentale per l'economia dell'UE.
L'Unione
europea vanta solidi e fruttuosi rapporti con i fornitori di gas tradizionali
all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), in particolare la Norvegia, all'esterno, in
particolare la Russia
e l'Algeria, e confida nel rafforzamento di tali rapporti in futuro. Tuttavia
per l'UE è importante promuovere la diversità in termini di fonti
di approvvigionamento, fornitori, itinerari di trasporto e metodi di trasporto.
Occorre inoltre istituire meccanismi adeguati per garantire la
solidarietà tra Stati membri in caso di crisi energetica, tanto
più che vari Stati membri dipendono, in larga misura o completamente, da
un unico fornitore di gas.
La
sicurezza energetica dovrebbe essere incentivata in diversi modi:
·§
Occorrono
misure per aiutare gli Stati membri, che dipendono in misura eccessiva da un
unico fornitore di gas, a diversificare le loro fonti di approvvigionamento. La Commissione
controllerà l'attuazione della direttiva sulla sicurezza
dell'approvvigionamento di gas[77], da poco recepita negli ordinamenti nazionali, e
ne valuterà l'efficacia. Occorrerà elaborare progetti per
trasportare il gas proveniente da altre regioni, istituire nuovi
"hub" (snodi) del gas in Europa centrale e nei paesi Baltici,
avvalersi in modo più adeguato delle possibilità di stoccaggio
strategico ed agevolare la costruzione di nuovi terminali di gas naturale
liquefatto. Si dovrebbero anche esaminare le modalità per rafforzare i
meccanismi di solidarietà in caso di crisi, come la rete di "corrispondenti
dell'energia" e il gruppo di coordinamento per il gas. D'altra parte
l'istituzione di riserve strategiche di gas contribuirebbe a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento. I considerevoli investimenti in
capacità di stoccaggio e condotte nuove, necessarie per garantire un
livello più elevato di sicurezza, devono essere valutati rispetto ai
costi che ciò comporterebbe per i consumatori.
·§
Il
meccanismo dell'UE in materia di riserve petrolifere strategiche, coordinato con
le riserve di altri paesi dell'OCSE attraverso l'AIE, funziona adeguatamente e
dovrebbe essere mantenuto. Si potrebbe tuttavia migliorare il modo in cui l'UE
gestisce il suo contributo a questo meccanismo. I requisiti imposti agli Stati
membri in materia di rendicontazione dovrebbero essere rinforzati; occorrerebbe
analizzare più da vicino l'adeguatezza delle riserve e garantire un
miglior coordinamento quando l'AIE invita a sbloccare delle riserve. La Commissione
analizzerà queste problematiche nel 2007.
·Le interconnessioni elettriche (cfr. il punto
3.1.4) e delle norme rigorose e vincolanti in materia di affidabilità
costituiranno il terzo elemento di questo approccio, in particolare per
affrontare i problemi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento di
elettricità.
3.3.3.3 L'impegno a lungo termine per la riduzione delle
emissioni di gas serra e il sistema comunitario di scambio dei diritti di
emissione
L'UE
è tradizionalmente a favore del ricorso a strumenti economici per internalizzare
i costi esterni, in quanto consentono al mercato di stabilire le
modalità di reazione più efficaci e meno costose. In particolare,
nella comunicazione Limiting Climate
Change to 2° - Policy Options for the EU and the world for 2020 and beyond,
la Commissione
ha spiegato che il meccanismo di scambio dei diritti di emissione è e
deve rimanere un meccanismo chiave per incentivare le riduzioni di emissioni di
carbonio e che potrebbe essere utilizzato come base per le iniziative
internazionali di lotta contro i cambiamenti climatici. La Commissione sta
attualmente riesaminando il sistema comunitario di scambio dei diritti di
emissione affinché tutte le sue possibilità possano essere
sfruttate in modo ottimale: ciò è fondamentale per creare gli
incentivi necessari per indurre dei cambiamenti nei modi di produzione e di
consumo dell'energia in Europa.
3.4.3.4 Un
programma ambizioso di misure a favore dell'efficienza energetica a livello
comunitario, nazionale, locale e internazionale
Per
i cittadini europei, l'efficienza energetica è l'elemento saliente di
una politica energetica europea. Il miglioramento dell'efficienza energetica
può contribuire notevolmente allo sviluppo sostenibile, alla
competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento.
Il
19 ottobre 2006 la
Commissione ha adottato un piano d'azione per l'efficienza
energetica[78] le cui misure specifiche dovrebbero permettere
all'UE di imboccare la strada giusta per conseguire l'obiettivo chiave
consistente a ridurre, da qui al 2020, del 20% il consumo globale
di energia primaria. In caso di successo, l'UE dovrebbe riuscire a consumare
quasi il 13% di energia in meno rispetto a oggi, con un risparmio di 100
miliardi di euro e di circa 780 miliardi di tonnellate di CO2
l'anno. Ciò richiederà sforzi notevoli in termini di cambiamento
di comportamenti, ma anche di investimenti supplementari.
Le
misure principali sono:
·§
incentivare
l'impiego di veicoli efficienti sotto il profilo dei consumi, fare un uso
migliore dei trasporti pubblici e garantire che i consumatori sostengano i
costi reali dei trasporti[79];
·§
introdurre
norme più rigorose e una migliore etichettatura delle apparecchiature;
·§
migliorare
rapidamente il rendimento energetico degli edifici esistenti dell'UE e
impegnarsi affinché nella costruzione di nuovi edifici le "case a
bassissimo consumo energetico" diventino la norma;
·§
garantire
un uso coerente della politica fiscale per favorire un uso più
efficiente dell'energia;
·§
migliorare
l'efficienza della produzione, del trasporto e della distribuzione di calore e
elettricità;
·§
concludere
un nuovo accordo internazionale sull'efficienza energetica al fine di
incoraggiare l'impegno comune.
Un nuovo accordo internazionale sull'efficienza
energetica
Un accordo di
questo tipo potrebbe riunire i paesi dell'OCSE e i principali paesi in via di
sviluppo (come la Cina,
l'India e il Brasile) al fine di limitare l'utilizzo di prodotti che non
soddisfano dei criteri minimi e stabilire approcci comuni per i risparmi energetici.
Nel 2007 l'UE
potrebbe presentare ufficialmente una proposta che potrebbe essere discussa e
portata avanti nell'ambito di una grande conferenza internazionale
sull'efficienza energetica durante la presidenza tedesca del G8. L'obiettivo
potrebbe essere firmare l'accordo durante le Olimpiadi di Pechino. Le
potenzialità di risparmio energetico e di riduzione della CO2
sono enormi – secondo l'AIE il miglioramento dell'efficienza energetica
da solo consentirebbe una riduzione pari a circa il 20% delle attuali emissioni
mondiali di CO2 .
3.5.3.5 Un
obiettivo a più lungo termine per le fonti energetiche rinnovabili
Nel
1997 l'Unione
europea ha iniziato a adottare misure affinché la percentuale di energia
derivante da fonti rinnovabili arrivasse, entro il 2010, al 12% dell'insieme di
fonti energetiche utilizzate, percentuale che costituiva un raddoppio rispetto
ai livelli del 1997. Da allora la produzione di energia da fonti rinnovabili
è aumentata del 55%, ma l'UE probabilmente non conseguirà
l'obiettivo che si era prefissata. Verosimilmente la quota dell'energia da
fonti rinnovabili non supererà il 10% nel 2010. Il motivo principale del
mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti in materia di energia rinnovabile
- oltre ai costi attualmente più elevati delle fonti di energia
rinnovabili rispetto alle fonti di energia "tradizionali" –
è l'assenza di un quadro strategico coerente ed efficace nell'Unione
europea e di una visione di lungo termine stabile. Per questi motivi, solo
pochi Stati membri hanno realizzato veri progressi in questo settore, e non
è stato possibile conseguire la massa critica necessaria per
generalizzare la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili che
adesso è confinata in alcuni settori economici.
L'UE
deve accelerare il ritmo per offrire una visione a lungo termine credibile del
futuro delle fonti energetiche rinnovabili nel suo territorio, basandosi sugli
strumenti esistenti, in particolare la direttiva sulle fonti di energia
rinnovabili. Si tratta di un passo fondamentale per conseguire gli obiettivi
attuali[80] e suscitare ulteriori investimenti, innovazione e
nuovi posti di lavoro. La politica in materia di energie rinnovabili deve
raccogliere una sfida: occorre trovare il giusto equilibrio tra installare,
oggi, grandi capacità di produzione e attendere che i ricercatori
trovino, domani, soluzioni adeguate per ridurne i costi. Nella ricerca di
questo equilibrio occorre tenere conto dei fattori seguenti:
·§
oggi
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili è generalmente più
costoso dell'uso degli idrocarburi, ma lo scarto si sta riducendo –
soprattutto se tiene conto anche dei costi dei cambiamenti climatici;
·§
le
economie di scala possono determinare una riduzione dei costi delle energie
rinnovabili ma ciò richiede oggi importanti investimenti;
·§
le
energie rinnovabili contribuiscono a migliorare la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico dell'UE aumentando la parte di energia
"domestica", diversificano il mix energetico e le fonti delle
importazioni, aumentano la quota di energie provenienti da regioni
politicamente stabili e creano nuovi posti di lavoro in Europa;
·§
le
fonti di energia rinnovabili emettono una quantità ridotta di gas serra
o non ne emettono affatto e la maggior parte di esse apportano notevoli
benefici in termini di qualità dell'aria.
Alla
luce delle informazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica e
della valutazione d'impatto, la
Commissione propone nella sua Tabella di marcia per le fonti
di energia rinnovabili[81] di assumere l'impegno di portare la quota delle fonti di energia rinnovabili nel mix energetico
complessivo dell'UE da meno 7 % (attualmente) a 20% entro il 2020. Gli obiettivi per il dopo 2020 sarebbero
valutati alla luce dei progressi tecnologici realizzati.
Come fare?
Il conseguimento dell'obiettivo del 20% presuppone
una fortissima crescita nei tre settori delle energie rinnovabili: energia
elettrica, biocarburanti, riscaldamento e raffreddamento. In tutti i settori, i
quadri strategici istituiti in alcuni paesi hanno consentito di ottenere
risultati che dimostrano che ciò è possibile.
Le fonti
rinnovabili possono potenzialmente fornire circa un terzo
dell'elettricità dell'UE da qui al 2020. L'energia eolica
copre attualmente circa il 20% del fabbisogno di elettricità in
Danimarca, 8% in Spagna e 6% in Germania. Quanto ad altre energie nuove –
energia fotovoltaica, energia solare termica, energia maremotrice e energia
delle onde – il loro costo dovrebbe diminuire rispetto agli elevati
livelli attuali.
Nel settore del riscaldamento e del
raffreddamento, si prevedono dei progressi per una serie di tecnologie. La Svezia, ad esempio,
possiede oltre 185 000 pompe di calore geotermiche. La Germania e l'Austria sono
state le prime a ricorrere in modo significativo all'energia solare per il
riscaldamento. Se altri paesi raggiungessero livelli analoghi, la quota
dell'energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento
arriverebbe al 50%.
Per quanto riguarda i biocarburanti, il bioetanolo
rappresenta già il 4% del mercato degli idrocarburi in Svezia, e la Germania è il
numero uno mondiale del biodiesel con il 6% del mercato diesel. Entro il 2020 i
biocarburanti potrebbero costituire fino al 14% dei carburanti destinati ai
trasporti.
Questo
obiettivo del 20% è veramente ambizioso e richiederà un grande
impegno da parte di tutti gli Stati membri. Il contributo di ciascun Stato
membro per il conseguimento di tale obiettivo dovrà tenere conto delle
varie situazioni e dei punti di partenza nazionali, ivi compresa la tipologia
dei mix energetici. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un margine di
manovra per promuovere le energie rinnovabili più adatte al loro
potenziale e alle loro priorità specifiche. Le modalità di
conseguimento degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbero essere
definite nei piani d'azione nazionali notificati alla Commissione. Questi piani
dovrebbero presentare gli obiettivi e le misure settoriali corrispondenti agli
obiettivi nazionali globali concordati. Concretamente, nell'attuazione dei loro
piani, gli Stati membri dovranno stabilire per l'elettricità, i
biocarburanti, il riscaldamento e il raffreddamento i loro obiettivi che
saranno esaminati dalla Commissione al fine di garantire che l'obiettivo
globale sia conseguito. Nel 2007 la Commissione illustrerà questa struttura in
un nuovo pacchetto legislativo sulle fonti energetiche rinnovabili.
Una
caratteristica particolare di questo quadro è la necessità di uno
sviluppo minimo e coordinato dei biocarburanti nell'insieme dell'UE. Anche se
oggi i biocarburanti sono più cari di altre forme di energia rinnovabile
e lo resteranno anche nel prossimo futuro, costituiscono per i prossimi 15 anni
l'unico strumento disponibile per ridurre notevolmente la dipendenza nei
confronti del petrolio nel settore dei trasporti. Nella sua tabella di marcia
per le energie rinnovabili e nella sua relazione sull'attuazione della
direttiva "Biocarburanti"[82], la Commissione propone pertanto di stabilire un obiettivo
minimo vincolante per i biocarburanti che dovrebbero rappresentare il 10% dei
carburanti destinati ai veicoli da qui al 2020 e fare in modo che i
biocarburanti utilizzati siano, per loro natura, sostenibili sia nel territorio
dell'UE che altrove. L'UE dovrebbe invitare i paesi terzi e i loro produttori a
conseguire tale obiettivo. Il pacchetto legislativo del 2007 sulle fonti di
energia rinnovabili comprenderà inoltre delle misure specifiche
destinate ad agevolare la penetrazione nel mercato dei biocarburanti e dei
sistemi di riscaldamento e raffreddamento alimentati da energie rinnovabili. La Commissione
proseguirà e rafforzerà l'uso delle energie rinnovabili
nell'ambito di altre politiche e misure di accompagnamento, al fine di
istituire un vero mercato interno delle energie rinnovabili nell'Unione
europea.
Quanto costerà?
Per giungere ad una
percentuale del 20% per le energie rinnovabili, occorrerà sostenere un
costo annuo medio supplementare di circa 18 miliardi di euro, vale a dire un
aumento pari a circa 6% della fattura totale delle importazioni di energia
dell'UE prevista per il 2020. Questo calcolo si basa su un prezzo del petrolio
di 48 dollari il barile nel 2020; qualora il costo dovesse aumentare a 78
dollari il sovraccosto medio annuo scenderebbe a 10,6 miliardi di euro. Se si
tiene conto del prezzo della tonnellata di carbonio di oltre 20 euro,
l'obiettivo del 20% avrebbe un costo praticamente pari a quello che
comporterebbe il ricorso a fonti energetiche "tradizionali", ma consentirebbe
di creare numerosi posti di lavoro in Europa e sviluppare nuove imprese
tecnologiche europee.
3.6.3.6 Un
piano strategico europeo per le tecnologie energetiche
L'Europa persegue due
obiettivi principali in materia di tecnologie energetiche: ridurre il costo delle
energie pulite e fare in modo che l'industria europea conquisti una posizione
di punta nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in rapida
crescita. Per realizzare questi obiettivi la Commissione
proporrà nel 2007 un piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche[83]. Questo piano si baserà su una visione a
lungo termine al fine di raccogliere la sfida di passare ad un sistema
energetico a basse emissioni di carbonio, tutelando nel contempo la
competitività.
–-
Da
qui al 2020, le tecnologie dovranno consentire di realizzare l'obiettivo del
20% di energia prodotta da energie rinnovabili, con un considerevole aumento
della quota delle energie rinnovabili meno costose (ivi compresi i parchi
eolici off-shore e i biocarburanti di seconda generazione).
–-
Da
qui al 2030, l'energia
elettrica e il calore dovranno essere prodotti in più larga misura da
fonti a basse emissioni di carbonio e in grandi centrali elettriche alimentate
da combustibili fossili ad emissioni ridottissime, dotate di sistemi di cattura
e stoccaggio del CO2. I trasporti dovranno gradualmente essere
adattati ai biocarburanti di seconda generazione e alle celle a combustibile a
idrogeno.
–-
Per
il 2050 e oltre, il passaggio del sistema energetico europeo alle tecnologie a
basse emissioni di carbonio larga misura da fonti energetiche rinnovabili,
dall'utilizzo sostenibile del carbone, del gas e dell'idrogeno e, per gli Stati
membri che lo desiderano, dalla fissione nucleare di quarta generazione.
Immaginiamo
per il futuro un'Europa che vanta un'economia energetica fiorente e
sostenibile, che ha sfruttato tutte le opportunità legate ai pericoli
dei cambiamenti climatici e della mondializzazione, che gode di una posizione
di primo piano in un insieme diversificato di tecnologie energetiche, pulite ed
efficaci e a basse emissioni ed è diventata un motore di
prosperità, crescita e creazione di posti di lavoro. Affinché
questa visione diventi realtà, l'Unione europea deve agire rapidamente e
in maniera concertata, concordando e attuando un piano strategico europeo per
le tecnologie energetiche, dotato di risorse realistiche. Nell'ambito del
Settimo programma quadro di ricerca, nell'UE la spesa annuale per le ricerche
nel settore dell'energia dovrebbe aumentare del 50% nel corso dei prossimi
sette anni, ma ciò non basterà a garantire i progressi necessari.
Il piano tecnologico deve essere ambizioso, deve coordinare meglio le spese a
livello comunitario e nazionale e stabilire obiettivi chiari, con tabelle di
marcia (roadmaps) e tappe fondamentali
(milestones) ben definite. Dovrebbe
avvalersi di tutti gli strumenti comunitari disponibili, tra cui le
"iniziative tecnologiche congiunte" e l'Istituto europeo della
tecnologia.
Una
tale iniziativa mirata potrebbe perseguire le priorità seguenti:
–-
migliorare
l'efficienza energetica di edifici, apparecchiature, attrezzature, processi
industriali e sistemi di trasporto;
–-
sviluppare
i biocarburanti, in particolare quelli di seconda generazione, per farne delle
alternative perfettamente competitive con gli idrocarburi;
–-
garantire
in tempi brevi la competitività dei grandi parchi eolici off-shore e
preparare la creazione di una super-rete europea off-shore competitiva;
–-
rendere
l'energia fotovoltaica competitiva al fine di sfruttare l'energia solare;
–-
utilizzare
le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno e sfruttarne i
vantaggi nei trasporti e per la produzione decentrata di energia;
–-
sviluppare
tecnologie per l'uso sostenibile del gas e dell'elettricità , in
particolare la cattura e lo stoccaggio del carbonio (vedi qui di seguito);
–-
l'UE
dovrebbe mantenere la sua leadership tecnologia nel settore dei reattori
nucleari di quarta generazione e nella futura tecnologia di fusione, al fine di
incentivare la competitività, la sicurezza interna ed esterna
dell'energia nucleare e di ridurre il livello dei rifiuti.
Questi
obiettivi settoriali dovrebbero essere completati da tappe fondamentali
specifiche e da un aumento delle spese di ricerca nel settore dell'energia. La Commissione
proporrà un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche per
il Consiglio europeo che si svolgerà nella primavera del 2008.
3.7.3.7 Verso un futuro di combustibili fossili a
basse emissioni di CO2
Il carbone e il gas garantiscono
il 50% dell'approvvigionamento di elettricità nell'UE e costituiranno
indubbiamente una parte fondamentale del nostro mix energetico. Le riserve a
lungo termine sono considerevoli, ma, rispetto al gas, il carbone produce circa
il doppio di emissioni di CO2. Occorrerà mettere a punto
tecnologie del carbone molto meno inquinanti e tecnologie per l'abbattimento
della CO2. Inoltre lo sviluppo di tecnologie pulite per il carbone e
di cattura e stoccaggio del carbonio è fondamentale a livello internazionale.
L'AIE prevede, da qui al 2030, il raddoppio dell'elettricità prodotta
dal carbone con il conseguente rilascio di circa 5 miliardi di tonnellate di CO2,
pari al 40% dell'aumento previsto delle emissioni di CO2 legate
all'energia a livello mondiale. Oltre al piano tecnologico strategico europeo
per le tecnologie energetiche, saranno necessarie altre iniziative per
catalizzare le azioni e le attività di ricerca internazionali
riguardanti la cattura e lo stoccaggio di CO2.
Per svolgere un ruolo di leadership
a livello mondiale, l'UE deve elaborare una visione chiara per l'introduzione
delle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2, istituire un
quadro regolamentare propizio al loro sviluppo e investire più e meglio
nella ricerca, lanciando anche iniziative a livello internazionale. In futuro
il sistema comunitario di scambio dei diritti di emissione dovrà anche
integrare la cattura e lo stoccaggio.
Come indicato nella
comunicazione sulla produzione di elettricità sostenibile[84], la Commissione nel 2007 avvierà dei lavori
per:
·§
progettare
un meccanismo destinato a incentivare la costruzione e l'esercizio, entro il
2015, di al massimo 12 dimostratori, su grande scala, per tecnologie
sostenibili di combustibili fossili per la produzione commerciale di
elettricità nell'UE[85];
·§
dare
una chiara indicazione sulle date a partire delle quali le centrali elettriche
a carbone e gas dovranno dotarsi di sistemi di cattura e stoccaggio del CO2.
In base alle informazioni disponibili, la Commissione ritiene
che, in linea di massima, entro il 2020 tutte le nuove centrali elettriche al
carbone dovranno essere dotate di tali sistemi, mentre le centrali esistenti
sarebbe equipaggiate in seguito progressivamente. Benché sia troppo
presto per pronunciarsi con certezza in merito, la Commissione spera di
essere grado di formulare delle raccomandazioni rigorose non appena possibile.
3.8.3.8 Il
futuro dell'energia nucleare
Attualmente
circa un terzo dell'elettricità e 15% dell'energia consumata nell'UE
proviene dal nucleare che costituisce una delle principali fonti di energia a
non produrre biossido di carbonio (CO2) in Europa. L'energia
nucleare è stato uno degli strumenti di riduzione delle emissioni di CO2
nell'UE e potrebbe anche far parte, per gli Stati membri che lo
desiderino, di uno scenario energetico, per i prossimi decenni, in cui
sarà imperativo ridurre considerevolmente le emissioni
L'energia
nucleare è meno sensibile alle fluttuazioni del prezzo del combustibile
rispetto alla produzione di energia dal carbone e dal gas, in quanto l'uranio
rappresenta una piccola parte del costo totale della produzione di energia
elettrica, mentre le riserve disponibili bastano per vari decenni e sono
presenti nell'insieme del pianeta.
Come
indicato nella tabella allegata al presente documento, che descrive i vantaggi
e gli inconvenienti delle varie fonti energetiche, l'energia nucleare è
una delle fonti di energia a basse emissioni di carbonio meno costose
attualmente disponibili nell'Unione europea e i suoi costi sono relativamente
stabili[86]. La prossima generazione di reattori nucleari
dovrebbe permettere di ridurre ulteriormente questi costi.
Spetta
ad ogni Stato membro decidere se ricorrere all'energia nucleare. Tuttavia,
qualora il livello di energia nucleare diminuisse nell'UE, questa riduzione
deve assolutamente essere sincronizzata con l'introduzione di altre fonti
energetiche a basse emissioni di carbonio per la produzione di
elettricità, altrimenti l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas
serra e di miglioramento della sicurezza di approvvigionamento non potrà
essere conseguito.
Nel contesto energetico
attuale, l'AIE prevede un aumento del consumo di elettricità di origine
nucleare nel mondo da 368 GW nel 2005
a 416 GW nel 2030. Mantenere e sviluppare la posizione
di leadership dell'UE in questo settore comporta pertanto dei vantaggi
economici.
Come risulta dal nuovo
programma nucleare indicativo[87], a livello di UE, si dovrebbe sviluppare
ulteriormente, conformemente alla legislazione comunitaria, il quadro
più avanzato per l'energia nucleare negli Stati membri che optano per
questo tipo di energia, nel rispetto delle norme più rigorose di
sicurezza e protezione e di non proliferazione, come previsto dal trattato
Euratom. L'energia nucleare, tuttavia, solleva anche problematiche importanti
in materia di rifiuti e di smantellamento, è opportuno pertanto
includere la gestione dei rifiuti nucleari e la questione dello smantellamento
nei futuri lavori comunitari. L'UE dovrebbe inoltre impegnarsi affinché
queste norme così rigorose siano rispettate a livello internazionale.
Per fare dei passi avanti in materia, la Commissione propone di istituire un gruppo ad
alto livello sulla sicurezza e la protezione nucleari incaricato di elaborare
progressivamente una posizione comune e, in un secondo tempo, delle nuove
regole comunitarie in materia di sicurezza e protezione nucleari.
3.9.3.9 Una
politica energetica internazionale che persegue attivamente gli interessi
dell'Europa
L'Unione europea non può conseguire da sola gli obiettivi fissati
in materia di energia e di cambiamenti climatici. In futuro l'UE sarà
all'origine solo del 15% delle nuove emissioni di CO2 e, da qui al
2030, secondo i nuovi obiettivi, l'UE consumerà meno del 10%
dell'energia mondiale. Pertanto le sfide della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e dei cambiamenti climatici non potranno
essere raccolte dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri
individualmente. L'UE deve collaborare con i paesi sviluppati e quelli in via
di sviluppo, nonché con i consumatori e i produttori di energia, per
garantire un'energia competitiva, sostenibile e sicura.
L'Unione europea e gli Stati membri devono perseguire questi obiettivi
esprimendosi con "una voce sola" e istituendo delle vere e proprie
partnership per tradurre questi obiettivi in una politica esterna coerente.
L'energia deve in effetti diventare un elemento centrale di tutte le relazioni
esterne dell'Unione europea; si tratta infatti di un fattore cruciale di
sicurezza geopolitica, stabilità economica, sviluppo sociale e un
elemento centrale delle attività internazionali destinate a lottare
contro i cambiamenti climatici. L'UE deve pertanto stabilire, nel settore
dell'energia, rapporti fruttuosi con tutti i suoi partner internazionali,
basati sulla fiducia reciproca, la cooperazione e l'interdipendenza. Ciò
presuppone rapporti di ampia portata geografica e profondi, sulla base di
accordi che comportano disposizioni importanti in materia energetica.
Il Consiglio europeo ha approvato la prospettiva di un quadro a lungo
termine per la dimensione energetica esterna stabilito congiuntamente dalla
Commissione e dal Consiglio[88]
e ha convenuto di istituire una rete di corrispondenti per la sicurezza
energetica che garantirà un sistema di allarme tempestivo e
rafforzerà la capacità dell'Unione europea di reagire prontamente
nelle situazioni esterne di pressione sulla sicurezza energetica.
L'UE si esprime già con una sola voce nei negoziati di accordi
internazionali, in particolare nel settore del commercio. Gli attuali e futuri
accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, possono essere utilizzati
più efficacemente per stabilire impegni giuridicamente vincolanti.
Questi impegni possono riguardare persino la liberalizzazione reciproca delle
condizioni degli scambi o degli investimenti nei mercati a monte e a valle,
nonché la concessione dell'accesso alle condotte da parte di paesi
situati lungo le catene di transito e di trasporto. D'altra parte possono servire
a promuovere il commercio internazionale di biocarburanti prodotti con
procedimenti sostenibili o di beni ambientali, o la tariffazione delle
emissioni di carbonio a livello internazionale.
Adesso l'Unione europea deve passare dalla teoria alla pratica. Il primo
passo per "parlare con una voce sola" consiste nello stabilire
obiettivi chiari e i mezzi per un coordinamento efficace. Le analisi
strategiche regolari nel settore dell'energia costituiranno il quadro generale
per dibattiti frequenti su questioni energetiche esterne in seno alle
istituzioni dell'UE. Una politica energetica esterna efficace dell'UE, nei
prossimi tre anni, deve incentrarsi in via prioritaria sugli aspetti elencati
qui di seguito.
·§
La Comunità
europea e i suoi Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo propulsore
nell'elaborazione degli accordi internazionali, tra cui il futuro trattato
sulla Carta dell'energia e il regime applicabile alla politica climatica nel
periodo post-2012.
·§
I
rapporti tra l'Unione europea e i suoi vicini nel settore dell'energia sono
fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell'Europa. L'Unione
europea deve mirare a creare intorno a sé una vasta rete di paesi,
agendo sulla base di regole o principi condivisi derivanti dalla sua politica
energetica.
·§
Il
rafforzamento dei rapporti con i nostri fornitori di energia esterni,
sviluppando ulteriormente partnership globali basate sull'interesse reciproco,
la trasparenza, la prevedibilità e la reciprocità.
·§
Proseguimento
di rapporti energetici più stretti con altri grandi consumatori,
nell'ambito dell'AIE e del G8 o nel quadro di una cooperazione bilaterale
rafforzata.
·§
Lo
sviluppo dell'utilizzazione di strumenti finanziari, nell'ambito di una
cooperazione rafforzata con la BEI
e la BERS e
dell'istituzione di un fondo di investimento per la politica di vicinato, al
fine di migliorare la sicurezza energetica dell'Unione europea.
·§
Il
miglioramento delle condizioni d'investimento in progetti internazionali,
impegnandosi, ad esempio, per istituire un quadro giuridico chiaramente
definito e trasparente e nominare dei coordinatori europei incaricati di
rappresentare gli interessi dell'Unione europea in progetti internazionale di
rilievo.
·§
La
promozione della non proliferazione nonché della sicurezza e della
protezione nucleari, in particolare nell'ambito di una cooperazione consolidata
con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
Le modalità d'azione dettagliate per il conseguimento di questi
obiettivi, discusse attentamente dal Consiglio europeo nel corso del vertice di
Lahti e del Consiglio europeo di dicembre 2006, sono riportate nell'allegato
della presente analisi. La
Commissione, tuttavia ritiene opportuno realizzare anche le
due azioni prioritarie illustrate qui di seguito.
–-
Un
partenariato energetico globale Africa-Europa. L'importanza dell'Africa in
quanto fornitore di energia si è considerevolmente rafforzata nel corso
negli ultimi anni, ma il suo potenziale è ancora ampio. Il dialogo
dovrebbe vertere anche sulla sicurezza dell'approvvigionamento, il trasferimento
tecnologico nel campo delle energie rinnovabili, lo sfruttamento sostenibile
delle risorse, la trasparenza dei mercati energetici e il rispetto dei principi
di una buona governance. Il dialogo
dovrebbe essere avviato mediante un evento congiunto di altissimo livello.
–-
Come
già indicato, un accordo internazionale nel settore dell'efficienza
energetica.
3.9.1.3.9.1
L'integrazione delle politiche dell'Unione europea nei settori dell'energia e
dello sviluppo: una soluzione vantaggiosa per tutti
I prezzi elevati
dell'energia penalizzano in particolar modo i paesi in via di sviluppo. Alcuni
paesi ne traggono vantaggio in quanto produttori, ma altri vedono il beneficio
degli aiuti allo sviluppo che ricevono annullato dall'aumento del costo delle
importazioni di energia[89]. L'Africa e altre regioni del mondo in via di
sviluppo hanno assolutamente interesse, come l'Europa, a rafforzare la
diversificazione e migliorare l'efficienza energetica – ciò
può contribuire notevolmente agli Obiettivi di sviluppo per il millennio.
L'Unione europea si impegna pertanto ad aiutare i paesi in via di sviluppo a
promuovere un approvvigionamento e un consumo energetico sostenibili e sicuri.
Per concretizzare tale impegno, l'Unione europea deve privilegiare la
fornitura di servizi energetici poco costosi, affidabili e sostenibili ai meno
abbienti, ricorrendo in particolare alle energie rinnovabili e allo sviluppo di
tecnologie pulite ed efficienti per la produzione di gas e petrolio. L'Africa
offre una possibilità straordinaria di utilizzare, in modo competitivo,
delle tecnologie legate alle energie rinnovabili. Può infatti saltare la
fase della costruzione di costose reti di trasporto dell'energia e passare
"con un solo balzo" alla nuova generazione di fonti e tecnologie
pulite, decentralizzate e a basse emissioni di carbonio, come è
già avvenuto per le telecomunicazioni mobili. Si tratta di una soluzione
vantaggiosa per tutti che consente di rafforzare la penetrazione dell'energia
rinnovabile e pulita e portare l'energia elettrica ad alcune delle
comunità più povere del pianeta. Nell'Africa subsahariana, in cui
le percentuali di accesso all'energia elettrica sono tra le più basse
del mondo, sarà necessario un particolare sforzo.
L'UE si avvarrà a tal fine dei vari strumenti di cui dispone,
ossia il 10° Fondo di sviluppo europeo, il partenariato UE-Africa per le
infrastrutture che riguarda progetti regionali in materia di produzione e
trasporto dell'energia, lo strumento ACP-UE per l'energia, il programma CE
COOPENER e il suo successore e infine il programma EUROSOLAR per l'America
Latina.
3.10.3. 10
Monitoraggio e notifiche efficaci
Il
monitoraggio, la trasparenza e la notifica saranno gli elementi fondamentali
dello sviluppo progressivo di una politica energetica europea efficace. La Commissione propone di
istituire un Ufficio dell'osservatorio
dell'energia in seno alla Direzione generale dell'energia e dei trasporti.
Questo ufficio dovrebbe svolgere funzioni essenziali in relazione all'offerta e
alla domanda di energia in Europa, in particolare rafforzando la trasparenza
per quanto riguarda le future esigenze di investimenti nell'UE per le
infrastrutture e gli impianti di produzione di elettricità e gas.
Inoltre, mediante esercizi di valutazione comparativa e scambi di buone pratiche,
garantirà il successo degli Stati membri nel loro impegno per modificare
il loro mix energetico, al fine di contribuire efficacemente al conseguimento
degli obiettivi energetici dell'Unione europea.
La
Commissione
definirà le responsabilità specifiche dell'osservatorio e
proporrà nel 2007 una base giuridica per il finanziamento delle sue
attività. Nel contempo esaminerà e semplificherà gli
obblighi vigenti (per sé stessa e gli Stati membri) in materia di
informazione e notifica nel campo dell'energia.
4.4. Portare avanti il lavoro
La
presente analisi strategica illustra una serie di misure necessarie per
realizzare gli obiettivi di un'energia sostenibile, sicura e competitiva. La
prima tappa consiste nell'ottenere decisioni chiare dal Consiglio europeo e dal
Parlamento europeo per quanto concerne l'approccio strategico e un piano
d'azione per consentire all'Unione di conseguire obiettivi ambiziosi, ampi e di
lungo termine. Le future analisi strategiche possono aiutare l'Unione europea a
perfezionare e aggiornare il suo piano d'azione in modo da tenere conto delle
evoluzioni – in primo luogo, ovviamente, i progressi tecnologici e
l'azione internazionale di lotta contro i cambiamenti climatici. La riduzione
delle emissioni in Europa e nel mondo è indissociabile dalla politica
energetica europea.
Se
l'Unione conseguisse gli obiettivi specifici proposti per quanto concerne
l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, sarebbe sulla buona strada
per ridurre le emissioni di gas serra del 20% entro il 2020 e, su questa scia,
per ridurle drasticamente entro il 2050, conformemente agli obiettivi
stabiliti. Un'azione risoluta oggi consentirà di progredire per ottenere
la stabilizzazione della nostra dipendenza dalle importazioni, investimenti in
tempo utile, nuovi posti di lavoro e un progresso nelle tecnologie a basse
emissioni di carbonio. L'UE guiderebbe
così il mondo verso una nuova rivoluzione industriale.
La
Commissione invita
pertanto il Consiglio europeo e il Parlamento a:
·§
approvare,
nei negoziati internazionali, l'obiettivo per l'UE di ridurre del 30% le
emissioni dei gas serra entro il 2020 (rispetto ai livelli del 1990);
·§
approvare
sin d'ora l'impegno da parte dell'UE di conseguire, in ogni caso, una riduzione
di almeno il 20% delle emissioni di gas serra dei paesi sviluppati da qui al
2020 (rispetto ai livelli del 1990);
·§
confermare
la necessità di misure supplementari affinché i vantaggi
potenziali dei mercati interni del gas e
dell'elettricità diventinouna
realtà per l'insieme dei cittadini e delle imprese europei. In
particolare:
·§
impegnarsi
a separare ulteriormente per rafforzare la concorrenza, aumentare gli
investimenti ed ampliare le opzioni disponibili per i consumatori, mediante la
separazione della proprietà o il gestore indipendente della rete. Alla
luce degli elementi di cui dispone, la Commissione ritiene cha la separazione della
proprietà sia il modo più efficace di garantire una scelta ai
consumatori e di incoraggiare gli investimenti. Sulla base delle conclusioni
del Consiglio europeo del 9 marzo e della posizione del Parlamento europeo, la Commissione
presenterà rapidamente una proposta legislativa.
·§
Garantire
una regolamentazione efficace in ogni Stato membro mediante l'armonizzazione
dei poteri e dell'indipendenza dei regolatori dell'energia, sulla base del
massimo denominatore comune nell'Unione europea, e l'affidamento ai regolatori
del compito di sviluppare il mercato interno dell'energia e i mercati
nazionali.
·§
Accelerare
l'armonizzazione delle norme tecniche necessarie per consentire l'adeguato
funzionamento del commercio transfrontaliero e garantire la promozione del
mercato europeo istituendo un organismo unico a livello comunitario o,
perlomeno, mediante una rete europea di regolatori indipendenti che dovrebbe
tenere adeguatamente conto degli interessi europei e vedrebbe un'adeguata
partecipazione della Commissione.
·§
Istituire
nel 2007 un nuovo meccanismo e una nuova struttura comunitari per gli operatori
di reti di trasporto responsabili della pianificazione coordinata delle reti,
che riferisce anche ai regolatori nazionali e alla Commissione; questi
operatori dovrebbero anche essere tenuti a proporre norme di sicurezza minime
per la rete che, una volta approvate dai regolatori e dalla Commissione,
diventerebbero giuridicamente vincolanti.
·§
Approvare
la presentazione nel 2007, da parte della Commissione, di norme minime in
materia di trasparenza.
·§
Accogliere
favorevolmente una nuova Carta del cliente nel settore dell'energia.
·§
Realizzare
ulteriori progressi nella costruzione di nuove interconnessioni fondamentali;
sottolineare la necessità di nominare dei coordinatori europei per
seguire i progetti prioritari più problematici e invitare la Commissione a
presentare, nel 2007, una proposta legislativa ufficiale che fissi un periodo
massimo di 5 anni nel corso del quale le procedure di pianificazione e
approvazione dovranno essere portate a termine per i progetti di interesse
europeo.
·§
Appoggiare
la necessità di realizzare ulteriori progressi per garantire la
solidarietà tra gli Stati membri in caso di crisi energetica o di
interruzione dell'approvvigionamento. Occorre a tal fine istituire meccanismi
efficaci. Accogliere favorevolmente l'intenzione della Commissione di
presentare nel 2007 una comunicazione sulle riserve strategiche che preveda,
qualora opportuno, misure più rigorose.
·§
Sottolineare
che l'Unione deve innanzitutto intensificare i suoi sforzi a favore di
un'azione mondiale contro i cambiamenti climatici. Accogliere con favore l'intenzione
della Commissione di approfittare di tutte le occasioni, nei negoziati
internazionali, bilaterali o multilaterali, per promuovere la lotta contro i
cambiamenti climatici, coordinare le politiche energetiche e intensificare la
cooperazione in materia di tecnologie pulite.
·Approvare l'obiettivo di ridurre, in modo
efficiente rispetto ai costi, il consumo di energia dell'Unione europea del 20%
entro il 2020, conformemente al piano d'azione della Commissione
sull'efficienza energetica e appoggiare l'intenzione della Commissione di
adottare misure concrete per conseguire questo obiettivo, in particolare:
–-
stabilire
ed aggiornare regolarmente dei requisiti minimi di efficienza per le
apparecchiature che consumano energia,
–-
realizzare
ulteriori risparmi energetici negli edifici, avvalendosi e sviluppando il
quadro fornito dalla direttiva sul rendimento energetico degli edifici;
–-
valorizzare
il considerevole potenziale di efficienza energetica dei trasporti, utilizzando
varie misure, anche legislative se del caso;
–-
migliorare
il comportamento di tutti i consumatori di energia sul piano dell'efficienza e
dei risparmi energetici, dimostrando in particolare i vantaggi offerti dalle
tecnologie disponibili o dai comportamenti;
–-
continuare
a migliorare l'efficienza della produzione di elettricità, in
particolare promuovendo le tecnologie di produzione combinata di calore e
elettricità ad elevata efficienza.
·§
Approvare
l'obiettivo vincolante del 20% per la quota delle energie rinnovabili nel consumo
energetico globale dell'Unione europea da qui al 2020 e di almeno 10% per i
biocarburanti. Invitare la
Commissione a presentare una nuova direttiva che traduca
questi obiettivi in pratica nel 2007 e fissi obiettivi nazionali e la procedura
di sviluppo dei piani d'azione nazionali per realizzarli.
·§
Sottolineare
l'esigenza di un piano strategico ambizioso e mirato per le tecnologie
energetiche e sostenere l'intenzione della Commissione di proporre
ufficialmente questo piano nel 2007.
·§
Confermare
che urge disporre di una prospettiva chiara su quando i dispositivi di cattura
e stoccaggio della CO2 dovranno essere installati nelle centrali a
carbone e a gas dell'Unione europea; istituire un meccanismo per incentivare la
costruzione e l'utilizzo di al massimo 12 dimostratori su grande scala di
tecnologie sostenibili dei combustibili fossili per la produzione commerciale
di elettricità nell'Unione europea.
·§
Appoggiare
l'intenzione della Commissione di istituire un gruppo comunitario ad alto
livello sulla sicurezza e la protezione nucleari incaricato di sviluppare
progressivamente una posizione comune e, in un secondo tempo, delle regole
comunitarie nuove in materia di sicurezza e protezione nucleari, a sostegno
degli sforzi degli Stati membri che hanno scelto di continuare ad avvalersi
dell'energia nucleare.
·§
Ribadire
l'importanza di "parlare con una voce sola" sulle questioni
energetiche internazionali. Oltre alla necessità di concretizzare le
conclusioni del vertice di Lahti e del Consiglio europeo di dicembre 2006, (i)
approvare la proposta di un partenariato energetico globale e sostenere
l'intenzione della Commissione di avviarlo con un evento congiunto di altissimo
livello nel corso del 2007 e (ii) accogliere favorevolmente l'intenzione della
Commissione di concludere un accordo internazionale sull'efficienza energetica
e presentare al Consiglio e al Parlamento la base di un accordo di questo tipo
nel primo semestre del 2007.
·§
Approfittare
dei negoziati internazionali per promuovere metodi sostenibili di produzione e
il commercio internazionale di beni e servizi ambientali ed energetici.
·§
Rallegrarsi
dell'intenzione della Commissione di presentare una nuova analisi strategica
della politica energetica ogni due anni e proporre, nel 2007, una base giuridica
ufficiale per finanziare i lavori di un Ufficio dell'osservatorio dell'energia
in seno alla Commissione, incaricato di coordinare e migliorare la trasparenza
dei mercati energetici dell'UE.
Allegato 1: Priorità della politica
energetica internazionale dell'UE
Allegato 2: Vantaggi e inconvenienti delle diverse
fonti di energia elettrica, sulla base dei prezzi attuali del petrolio, del gas
e del carbone
Allegato 3: Vantaggi e inconvenienti delle diverse
fonti di energia per il riscaldamento
Allegato 4: Vantaggi e inconvenienti delle diverse
fonti di energia per il trasporto stradale
Le
fonti delle cifre contenute negli allegati sono indicate nel documento di
lavoro dei servizi della Commissione: dati della politica energetica
dell'Unione europea[90].
Allegato 1
4.1.4.1 Priorità della politica energetica
internazionale dell'Unione europea
La
politica energetica esterna dell'UE nei prossimi tre anni deve incentrarsi in
via prioritaria sugli aspetti elencati qui di seguito:
·§
La promozione di accordi internazionali, in
particolare il regime applicabile alla politica climatica nel periodo post-2012, l'estensione dello
scambio dei diritti di emissione ai partner mondiali, il futuro trattato sulla
Carta dell'energia, nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie
pulite per le energie rinnovabili. Ciò presuppone il rafforzamento del
coordinamento tra l'UE e gli Stati membri nei consessi internazionali e di
migliorare la collaborazione con l'Agenzia internazionale dell'energia. L'UE
parteciperà anche ad iniziative multilaterali, tra cui la partnership
della Banca mondiale mirante alla riduzione del gas flaring (pratica, nell'estrazione del greggio, che consiste nel
bruciare del gas naturale a cielo aperto) e l'iniziativa a favore della
trasparenza delle industrie estrattive. Per rafforzare la coerenza, l'UE
dovrebbe anche impegnarsi, se del caso, a aderire alle organizzazioni
internazionali pertinenti.
·§
L'istituzione di rapporti energetici con i
paesi confinanti dell'Unione europea, sulla scia della recente proposta
della Commissione relativa allo sviluppo della politica europea di vicinato
(PEV)[91] anche nel settore
dell'energia, con un eventuale trattato energetico UE-PEV cui, a lungo termine,
potrebbero aderire tutti i paesi vicini interessati. Il trattato che istituisce
la Comunità
dell'energia costituisce già la base di un mercato energetico regionale
che dovrebbe mirare ad estendersi progressivamente al di fuori del territorio
dell'Unione e dei Balcani occidentali, per integrare dei paesi limitrofi come la Moldova, la Norvegia, la Turchia e l'Ucraina.
Occorre migliorare i rapporti energetici con l'Egitto ed altri fornitori e
paesi di transito del Mashrek/Maghreb, nonché con la Libia. Sia la Norvegia che l'Algeria
meritano una particolare attenzione e rapporti definiti su misura.
·§
La riduzione delle minacce di eventuali
interruzioni di approvvigionamento o di una distruzione fisica di
infrastrutture energetiche critiche al di fuori del territorio dell'Unione
europea mediante uno scambio di migliori pratiche con tutti i partner
dell'Unione e le organizzazioni internazionali interessate, sulla base delle
azioni relative alle infrastrutture interne menzionate nella recente
comunicazione della Commissione su un programma europeo di protezione delle
infrastrutture.
·§
Il rafforzamento delle relazioni con la Russia mediante la
negoziazione di un nuovo accordo quadro solido e completo che istituisca, a
vantaggio di entrambe le parti, un vero partenariato nel settore dell'energia
per creare le condizioni necessarie per nuovi investimenti. Questo accordo
dovrebbe porre l'accento sui vantaggi reciproci che la Russia e l'Unione europea
ne trarranno a lungo termine e integrare i principi del mercato, del trattato
sulla Carta dell'energia e del progetto di protocollo sul transito.
·§
L'approfondimento del dialogo e delle relazioni
con i principali produttori di energia e i paesi di transito,
nell'ambito di organizzazioni come l'OPEP e il Consiglio di cooperazione del
Golfo o mediante la completa attuazione dei protocolli di accordo con
l'Azerbaigian e il Kazakistan. Stabilimento di
nuovi contatti con altri importanti produttori dell'Asia centrale come il
Turkmenistan e l'Uzbekistan. Inoltre occorre assolutamente agevolare il
trasporto delle risorse energetiche del mar Caspio verso l'Unione europea. La Commissione
presenterà anche una comunicazione sulla cooperazione con il mar Nero
nel corso della primavera del 2007. Questo aspetto della strategia dovrebbe
contemplare anche paesi molto più distanti (America latina e Caraibi, ad
esempio) per ottimizzare la diversificazione geografica dell'approvvigionamento
energetico. Si dovrebbero inoltre esaminare nuove fonti di energia, avviando il
dialogo con il Brasile per integrare i biocarburanti, e organizzando nel 2007
una conferenza internazionale sui biocarburanti.
·§
Istituzione
di una nuova partnership Africa-Europa nel settore dell'energia.
L'importanza dell'Africa in quanto fornitore di energia continua ad aumentare e
i rapporti devono passare attraverso un dialogo globale che comprenda la
sicurezza dell'approvvigionamento, il trasferimento tecnologico nelle energie
rinnovabili, lo sfruttamento sostenibile delle risorse, la trasparenza dei
mercati energetici e il rispetto dei principi di una buona governance. Il dialogo dovrebbe essere avviato mediante un evento
congiunto di altissimo livello.
·§
Il
miglioramento dei rapporti con altri importanti consumatori di energia. In
particolare, i rapporti con partner come gli Stati Uniti dovrebbero continuare
a riguardare settori come la promozione di mercati mondiali dell'energia aperti
e competitivi, l'efficienza energetica, la cooperazione nel campo della
regolamentazione e la ricerca. Le misure già adottate nei confronti
della Cina dovrebbero essere ulteriormente sviluppate ponendo l'accento sulle
tecnologie avanzate del carbone a "bassissime emissioni", i risparmi
energetici e le energie rinnovabili. Sarebbe opportuno adottare un approccio
analogo con l'India.
·§
La
promozione della non proliferazione, e della sicurezza e della protezione
nucleari, in particolare nell'ambito di una cooperazione rafforzata con
l'Agenzia dell'energia atomica e con il nuovo strumento per la cooperazione in
materia di sicurezza nucleare.
§
La realizzazione di questi
obiettivi presuppone la ridefinizione dei rapporti con questi partner per porre
l'energia in una posizione centrale. Oltre al dialogo e ai negoziati
internazionali per difendere i suoi obiettivi strategici, l'Unione europea
dispone di una serie di strumenti che dovrebbe utilizzare al meglio, tra cui:
·§
Nei
negoziati commerciali, l'UE parla già "con una voce sola" e la
sua competenza è incontestabile. Gli accordi internazionali in materia
commerciale e di investimenti, bilaterali o multilaterali, possono essere
utilizzati più efficacemente per stabilire strumenti giuridicamente
vincolanti. Possono contribuire alla creazione delle condizioni necessarie per
un aumento degli investimenti e una produzione e una concorrenza più
sostenibili. Forte degli strumenti e dei mandati adeguati, l'Unione europea
sarà in grado, ad esempio, di operare meglio a favore della
liberalizzazione reciproca delle condizioni degli investimenti e degli scambi
sui mercati a monte e a valle, ed eventualmente per ottenere l'accesso alle
condotte. Lo stesso vale per la promozione di una tariffazione internazionale
delle emissioni di carbonio o del commercio dei biocarburanti.
·§
Miglioramento
della cooperazione con la BEI
e la BERS per
utilizzare strumenti finanziariche consentiranno di sostenere i partenariati energetici mediante
azioni concrete, finanziando progetti importanti quali il corridoio energetico
che attraversa la regione del Mar Caspio o i progetti Africa subahariana–Maghreb–UE.
I progetti energetici potrebbero costituire un elemento fondamentale nei fondi
di investimento proposti a favore della politica di vicinato, concepiti per
mobilitare da 4 a
5 volte l'importo del finanziamento disponibile nell'ambito dello strumento
europeo per la politica di vicinato.
·§
La
promozione di condizioni più favorevoli per gli investimenti nei
progetti internazionali, grazie ad un quadro chiaramente definito e
trasparente e con il sostegno dei coordinatori europei. Innanzitutto si dovrebbe
nominare un coordinatore europeo per il gasdotto Nabucco, dal Bacino del Mar
Caspio fino all'Austria e all'Ungheria. In futuro si potrebbe pensare di
nominare dei coordinatori per dei progetti riguardanti il trasporto di energia
da paesi partner come la
Turchia, l'Asia centrale e l'Africa del Nord.
Allegato 2: Vantaggi e inconvenienti delle varie
fonti di energia elettrica
|
Fonti energetiche
|
Tecnologia considerata per
la stima dei costi
|
Costo nel 2005
(euro/MWh)
|
Costo previsto per il 2030
(euro/MWh)
|
Emissioni di gas serra
(Kg CO2eq/MWh)
|
Dipendenza dell'UE-27 dalle
importazioni
|
Efficienza
|
Sensibilità al
prezzo del combustibile
|
Riserve accertate
/
Produzione annua
|
|
Fonte AIE
|
2005
|
2030
|
|
Gas naturale
|
Turbina a gas a ciclo
aperto
|
45 – 70
|
55-85
|
440
|
57%
|
84%
|
40%
|
Molto elevata
|
64 anni
|
|
Turbina a gas a ciclo combinato (CCGT)
|
35 - 45
|
40-55
|
400
|
50%
|
Molto elevata
|
|
Petrolio
|
Motore diesel
|
70 - 80
|
80-95
|
550
|
82%
|
93%
|
30%
|
Molto elevata
|
42 anni
|
|
Carbone
|
Combustibile polverizzato con desolforazione dei gas di scappamento
|
30 - 40
|
45-60
|
800
|
39%
|
59%
|
40-45%
|
Media
|
155 anni
|
|
Combustione a letto fluido circolante (CFBC)
|
35 - 45
|
50-65
|
800
|
40-45%
|
Media
|
|
Gassificazione integrata a ciclo combinato (IGCC)
|
40 - 50
|
55-70
|
750
|
48%
|
Media
|
|
Energia nucleare
|
Reattore ad acqua leggera
|
40 - 45
|
40 - 45
|
15
|
Quasi 100% per il minerale d'uranio
|
33%
|
Bassa
|
Riserve ragionevoli: 85 anni
|
|
Biomassa
|
Centrale a biomassa
|
25 - 85
|
25 - 75
|
30
|
nessuna
|
30 - 60%
|
Media
|
Energie rinnovabili
|
|
Energia eolica
|
Terrestre
|
35 - 175
|
28 - 170
|
30
|
95-98%
|
Nessuna
|
|
35 – 110
|
28 – 80
|
|
Off shore
|
50 - 170
|
50 - 150
|
10
|
95-98%
|
|
60 – 150
|
40 – 120
|
|
Idroelettricità
|
Grande
|
25 - 95
|
25 - 90
|
20
|
95-98%
|
|
Piccola (<10MW)
|
45 - 90
|
40 - 80
|
5
|
95-98%
|
|
Energia solare
|
Fotovoltaica
|
140 - 430
|
55 -260
|
100
|
/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato 3: Vantaggi e inconvenienti delle varie
fonti di energia per il riscaldamento
|
Fonti energetiche
|
Quota di mercato dell'UE-25 per fonte energetica
|
Prezzo di mercato
(euro/tep )
|
Costo del ciclo di vita
(euro/tep )
|
Emissioni di gas serra
(t CO2eq/tep )
|
Dipendenza dell'UE dalle importazioni
|
|
2005
|
2030
|
|
Combustibili fossili
|
Gasolio da riscaldamento
|
20%
|
525
(0,45 euro/l)
|
300-1300
|
3.1
|
82%
|
93%
|
|
Gas naturale
|
33%
|
230 – 340
(20-30 euro/MWh)
|
2.1
|
57%
|
84%
|
|
Carbone
|
1,8%
|
70
(100 euro/tec)
|
4
|
39%
|
59%
|
|
Biomassa
|
Trucioli
|
5,7%
|
280
|
545-1300
|
0.4
|
0
|
?
|
|
Pellet
|
540
|
630-1300
|
0.4
|
0
|
?
|
|
Energia elettrica
|
31%
|
550 - 660
(50-60 euro/MWh)
|
550 - 660
|
0 to 12
|
<1%
|
?
|
|
Energia solare
|
0,2%
|
/
|
680-2320
|
Ridottissime
|
0
|
0
|
|
Energia geotermica
|
0,4%
|
/
|
230-1450
|
Ridottissime
|
0
|
0
|
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI
Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti
climatici a +2 gradi Celsius
La via da percorrere fino al 2020 e oltre
1. Sintesi
I cambiamenti climatici sono una realtà e occorre intervenire con
urgenza per limitarli in modo che siano gestibili. L'UE deve adottare i
provvedimenti necessari al proprio interno e assumere una posizione leader in
ambito internazionale per garantire che l'innalzamento della temperatura media
a livello mondiale non superi di oltre 2 °C i livelli dell'era
preindustriale.
La presente comunicazione e la
scheda d'impatto che l'accompagna indicano che si tratta di un obiettivo
realizzabile sotto il profilo tecnico ed economicamente sostenibile, a
condizione che i principali responsabili delle emissioni agiscano
tempestivamente. I benefici, infatti, superano di gran lunga i costi.
La presente comunicazione
è destinata al Consiglio europeo di primavera del 2007, che dovrebbe
decidere in merito ad un approccio integrato e completo nell'ambito delle
politiche dell'UE nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici. Fa
seguito alla comunicazione del 2005 "Vincere la battaglia contro i
cambiamenti climatici", che proponeva raccomandazioni concrete sulle
politiche climatiche dell'UE e definiva i principali elementi che dovevano
costituire la futura strategia climatica dell'UE. Nel definire le prossime fasi
della nostra politica sui cambiamenti climatici, il Consiglio europeo dovrebbe
adottare decisioni che favoriscano l'instaurazione delle condizioni necessarie
a raggiungere un nuovo accordo globale che faccia seguito ai primi impegni
derivanti dal protocollo di Kyoto dopo il 2012.
La presente comunicazione propone
che l'UE persegua, nell'ambito di negoziati internazionali, un obiettivo di
riduzione dei gas serra pari al 30% rispetto ai valori del 1990, che i paesi
industrializzati dovranno conseguire entro il 2020: in questo modo sarà
possibile contenere l'aumento della temperatura entro il limite dei 2 °C in
tutto il mondo. Fino a che non sarà concluso un accordo internazionale,
e fatta salva la posizione che assumerà nell'ambito dei negoziati
internazionali, l'UE dovrebbe fin d'ora assumersi l'impegno risoluto e
unilaterale di abbattere le emissioni dei gas serra di almeno il 20% entro il
2020 ricorrendo al sistema UE di scambio delle quote di emissione, ad altre
politiche in materia di cambiamenti climatici e a interventi nel contesto della
politica energetica. Questo approccio permetterà all'UE di dimostrare la
propria posizione di leader a livello internazionale nelle questioni
riguardanti il clima, oltre a segnalare all'industria che il sistema UE di
scambio delle quote andrà avanti anche oltre il 2012, incoraggiando
così gli investimenti nelle tecnologie per l'abbattimento delle
emissioni e le alternative a basse emissioni di carbonio.
Dopo il 2020 le emissioni
prodotte dai paesi in via di sviluppo supereranno quelle dei paesi
industrializzati; nel frattempo, il tasso di crescita delle emissioni
complessive dei paesi in via di sviluppo dovrebbe cominciare a rallentare e, a
partire dal 2020, dovrebbe verificarsi un calo in termini assoluti. Questo
obiettivo potrà essere raggiunto senza compromettere la crescita
economica e la lotta alla povertà, grazie ad un'ampia rosa di misure nei
settori dei trasporti e dell'energia, che presentano notevoli
possibilità di riduzione delle emissioni e potranno, di per sé,
anche apportare benefici immediati sotto il profilo sociale ed economico.
Entro il 2050 le emissioni
globali dovranno essere abbattute fino al 50% rispetto al 1990; ciò
significa che i paesi industrializzati dovranno ridurle del 60-80%. Ma le
emissioni dovranno diminuire sensibilmente anche in molti paesi in via di
sviluppo.
Gli strumenti di mercato come il
sistema UE di scambio delle quote di emissione saranno un elemento determinante
per far sì che l'Europa e altri paesi conseguano gli obiettivi previsti
al più basso costo possibile. La disciplina che entrerà in vigore
dopo il 2012 dovrebbe consentire di collegare tra loro sistemi analoghi di
scambio dei diritti di emissione in vigore in vari ambiti nazionali e in questo
contesto il sistema di scambio dell'UE dovrebbe rappresentare il fulcro del
futuro mercato globale del carbonio. Il sistema UE continuerà ad
accettare i crediti derivanti dai progetti nell'ambito del meccanismo di
sviluppo pulito (CDM) e dell'attuazione congiunta (JI) previsti dal protocollo
di Kyoto, anche dopo il 2012.
È auspicabile che l'UE e
gli Stati membri decidano di incrementare sensibilmente gli investimenti
destinati alle attività di ricerca e sviluppo nei settori della
produzione di energia e del risparmio energetico.
2. La sfida del clima: realizzare l'obiettivo dei 2 °C
Dati scientifici affidabili dimostrano che è ormai
imprescindibile intervenire con urgenza per far fronte ai cambiamenti
climatici. Studi recenti, come il rapporto Stern, ribadiscono che la mancanza
di intervento avrà costi molto ingenti, non solo economici, ma anche
sociali e ambientali, che ricadranno in particolare sulle fasce più
povere della popolazione, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli
industrializzati. L'inazione avrà inoltre gravi implicazioni in termini
di sicurezza, sia in ambito locale che mondiale. Gran parte delle soluzioni
possibili esiste già, ma ora i governi sono chiamati ad adottare le
politiche necessarie per metterle in atto. Sotto questo profilo, oltre al fatto
che i costi correlati sono gestibili, si può affermare che la lotta ai
cambiamenti climatici avrà anche notevoli benefici sotto altri aspetti.
L'UE si pone l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media
mondiale entro 2 °C
prendendo come riferimento i valori preindustriali. Ciò limiterà gli
effetti dei cambiamenti climatici e l'eventualità di sovvertimenti
massicci e irreversibili dell'ecosistema mondiale. Il Consiglio ha sottolineato
che, per ottenere tale risultato, le concentrazioni dei gas serra in atmosfera
dovranno rimanere al di sotto delle 550 ppmv di CO2 equivalente: se
si stabilizzano le concentrazioni sul lungo termine a circa 450 ppmv di CO2
equivalente, c'è il 50% di probabilità di riuscita. A tal fine,
da qui al 2025 le emissioni dei gas serra dovranno stabilizzarsi, per poi ridursi
fino al 50% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050. Il Consiglio ha
concordato sul fatto che i paesi industrializzati dovranno proseguire sulla
strada intrapresa e ridurre le proprie emissioni del 15-30% per il 2020. Il
Parlamento europeo, a sua volta, ha proposto un obiettivo di riduzione del CO2
per l'UE del 30% per il 2020 e del 60-80% entro il 2050.
La presente comunicazione individua le possibili soluzioni finalizzate
ad adottare misure efficaci e realistiche all'interno dell'UE e su scala mondiale
che permettano di conseguire l'obiettivo dei 2 ºC. L'andamento delle
emissioni dei gas serra presentato nella valutazione d'impatto rappresenta uno
scenario economicamente efficace per realizzare l'obiettivo, partendo dal
presupposto che entro il 2020 i paesi industrializzati riducano del 30% le
proprie emissioni rispetto ai valori del 1990. La valutazione dimostra inoltre
che le riduzioni ottenute dai paesi industrializzati, da sole, non basteranno.
Secondo i dati disponibili, infatti, nel 2020 le emissioni dei paesi in via di
sviluppo supereranno quelle del mondo industrializzato e tale aumento
renderà vane le riduzioni conseguibili nei paesi industrializzati oltre
quella data. Per un intervento efficace contro i cambiamenti climatici sarà
dunque necessario diminuire l'incremento delle emissioni di gas serra prodotte
dai paesi in via di sviluppo e invertire la tendenza per le emissioni connesse
alla deforestazione.
Una politica sostenibile ed efficace a favore delle foreste rafforza
inoltre il contributo che queste danno alla riduzione complessiva delle
concentrazioni di gas serra.
3. I
costi dell'inazione e dell'azione
Nella comunicazione del 2005 "Vincere la battaglia contro i
cambiamenti climatici" la
Commissione ha dimostrato che i benefici derivanti dal
contenimento dei cambiamenti climatici sono superiori ai costi degli interventi
necessari. Studi recenti hanno confermato che i cambiamenti climatici hanno
vaste ripercussioni, dall'agricoltura alla pesca, dalla desertificazione alla
biodiversità, dalle risorse idriche alla mortalità legata alla
calura o al clima rigido, dalle zone costiere ai danni derivanti dalle
alluvioni.
L'impatto dei cambiamenti climatici sarà probabilmente
disomogeneo; alcune regioni dell'UE saranno particolarmente colpite.
Nell'Europa meridionale, ad esempio, i cambiamenti climatici faranno
verosimilmente diminuire la resa delle colture, aumentare la mortalità
dovuta alla calura e avranno ripercussioni negative sul turismo nella stagione
estiva.
Il rapporto Stern stabilisce che i cambiamenti climatici sono il
risultato del più ampio fallimento del mercato mai registrato a livello
mondiale. Il fatto di non aver considerato i costi dei cambiamenti climatici
nei prezzi di mercato che determinano il nostro comportamento economico implica
enormi costi economici e sociali. Secondo il rapporto, i costi dell'inazione
– che possono variare dal 5 al 20% del PIL mondiale – ricadranno
esageratamente sui ceti più poveri, che hanno anche minori
capacità di adattamento, e ciò acuirà l'impatto sociale
dei cambiamenti climatici.
Nel 2030 il PIL mondiale dovrebbe essere circa doppio rispetto al 2005.
La crescita del PIL nei paesi in via di sviluppo maggiormente responsabili
delle emissioni rimarrà più elevata di quella dei paesi
industrializzati. La valutazione d'impatto mostra che l'intervento contro i
cambiamenti climatici a livello mondiale è pienamente compatibile con la
crescita su scala mondiale. Nel periodo 2013-2030 gli investimenti in
un'economia a basse emissioni di carbonio richiederanno circa lo 0,5% del PIL
mondiale totale, il che ridurrà la crescita di quest'ultimo soltanto
dello 0,19% annuo fino al 2030, una percentuale relativa del tasso di crescita
previsto del PIL (+2,8%). Si può affermare che si tratti di una sorta di
premio assicurativo da versare per ridurre sensibilmente il rischio di danni
irreversibili conseguenti ai cambiamenti climatici. Occorre inoltre
sottolineare un fattore ancora più importante e cioè che tali
cifre sovrastimano molto l'impegno richiesto, perché non tengono conto
dei benefici sanitari connessi, della maggiore sicurezza energetica e della
riduzione dei danni dovuti al fatto di aver evitato i cambiamenti climatici.
4. I
benefici dell'azione, legame con altre politiche
Negli ultimi tre anni il prezzo del petrolio e del gas è
raddoppiato e quello dell'elettricità lo ha seguito a ruota; il prezzo
dell'energia dovrebbe rimanere elevato e aumentare nel tempo. Il Piano d'azione
per l'efficienza energetica che la Commissione ha presentato di recente dimostra che
c'è una valida motivazione economica per adottare politiche che
migliorino l'efficienza complessiva dell'uso delle risorse, anche senza tener
conto delle riduzioni delle emissioni che ne deriverebbero.
La valutazione d'impatto mette in luce che l'intervento dell'UE per
combattere i cambiamenti climatici dovrebbe aumentare notevolmente la sicurezza
energetica dell'UE: basti pensare che, per il 2030, le importazioni di petrolio
e di gas dovrebbero ridursi del 20% circa ciascuna rispetto alla situazione di status
quo. La possibilità di integrare le politiche energetiche con quelle sui
cambiamenti climatici garantirà, pertanto, che queste si rafforzino a
vicenda.
L'azione contro i cambiamenti climatici riduce, inoltre, l'inquinamento
atmosferico. Se, ad esempio, nell'UE le emissioni di CO2
diminuissero del 10% entro il 2020, i benefici in termini sanitari sarebbero
enormi (le stime parlano di importi compresi tra 8 e 27 miliardi di euro). Tali
politiche dovrebbero pertanto agevolare il conseguimento degli obiettivi
fissati nella strategia dell'UE sull'inquinamento atmosferico.
Benefici di questo tipo riguardano anche altri paesi: secondo le stime,
nel 2030 gli Stati Uniti, la Cina
e l'India dovrebbero importare come minimo il 70% del petrolio che consumano.
Potrebbero inoltre insorgere tensioni geopolitiche dovute allo scarseggiare
delle risorse. Al contempo, l'inquinamento atmosferico è in aumento,
soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ridurre le emissioni dei gas serra in
altri paesi migliorerà la loro sicurezza sotto il profilo energetico e
la qualità dell'aria.
5. Interventi
in ambito UE
(a) Fissare
obiettivi di riduzione delle emissioni
Nell'UE il potenziale per ridurre le emissioni di gas serra è
ancora enorme. Il riesame strategico della politica energetica dell'UE propone
interventi per sfruttare gran parte di tale potenziale. Inoltre, le misure
adottate nell'ambito del Programma europeo per il cambiamento climatico e altre
iniziative in corso continueranno a ridurre le emissioni dopo il 2012.
L'UE potrà conseguire gli obiettivi che si è fissata in
termini di cambiamenti climatici solo attraverso un accordo internazionale. Gli
interventi all'interno dell'UE hanno dimostrato che è possibile tagliare
le emissioni di gas serra senza compromettere la crescita economica e che le
tecnologie e gli strumenti politici necessari a tal fine esistono già.
L'UE continuerà ad intervenire al proprio interno per combattere i
cambiamenti climatici e questo le permetterà di dare l'esempio nel
contesto dei negoziati internazionali.
Sarebbe opportuno che il Consiglio decidesse che l'UE e gli Stati membri
propongano, per il 2020, una riduzione del 30% delle emissioni dei gas serra da
parte dei paesi industrializzati; tale proposta dovrebbe inserirsi in un
accordo internazionale finalizzato a contenere il surriscaldamento del pianeta
a 2 ºC al di sopra dei livelli preindustriali. Fino a che non si
arriverà ad un accordo internazionale, e fatta salva la posizione che
assumerà nell'ambito dei negoziati internazionali, l'UE dovrebbe fin
d'ora assumersi l'impegno risoluto e unilaterale di abbattere le emissioni dei
gas serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 facendo
ricorso al sistema UE di scambio delle quote di emissione, ad altre politiche
in materia di cambiamenti climatici e a interventi nel contesto della politica
energetica. In questo modo verrà lanciato un segnale all'industria
europea, che potrà contare sul fatto che ci sarà una forte
domanda di quote anche dopo il 2012, e saranno incentivati gli investimenti
nelle tecnologie di abbattimento delle emissioni e nelle alternative a basse
emissioni di carbonio.
(b) Azioni
derivanti dalla politica energetica dell'UE
In linea con il riesame strategico della politica energetica dell'UE,
l'adozione delle misure concrete illustrate di seguito permetterà di
disporre di un sistema energetico competitivo, più sostenibile e sicuro,
con una forte riduzione delle emissioni dei gas serra prodotti dall'UE nel
2020. Sarà auspicabile:
migliorare del 20% l'efficienza energetica dell'UE
entro il 2020;
incrementare la percentuale dell'energia ricavata
da fonti rinnovabili fino al 20% entro il 2020;
adottare una politica sulla cattura e lo stoccaggio
del carbonio (Carbon Capture and Storage
- CCS) che sia sicura sotto il profilo ambientale e che comprenda la
costruzione di dodici impianti dimostrativi di vasta scala in Europa entro il
2015.
(c)
Rafforzare il sistema UE di scambio delle quote di emissione
Il 45% delle emissioni di CO2 dell'UE rientra nel sistema UE
di scambio delle quote; a partire dal 2013 tale percentuale dovrebbe aumentare.
Nell'ambito del riesame del sistema UE di scambio sarebbe opportuno valutare
almeno le soluzioni indicate di seguito che mirano a rafforzarne il ruolo.
L'assegnazione delle quote dovrebbe riguardare un
periodo superiore ai cinque anni attuali: in tal modo si garantirebbe la
prevedibilità necessaria per poter prendere decisioni sugli investimenti
a lungo termine.
Il sistema dovrebbe essere esteso ad altri gas e
settori.
Le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio
devono essere riconosciute e ammesse nel sistema di scambio.
Occorre armonizzare il processo di assegnazione
delle quote tra i vari Stati membri, anche attraverso un più ampio
ricorso alle aste, per evitare distorsioni della concorrenza in Europa.
È opportuno collegare il sistema UE di
scambio delle quote ad altri sistemi analoghi a carattere vincolante (ad
esempio quelli esistenti in California e in Australia).
(d)
Limitare le emissioni dei trasporti
Le emissioni del settore dei trasporti dell'UE hanno continuato ad
aumentare, annullando buona parte dei risultati ottenuti nei settori dei
rifiuti, dell'industria manifatturiera e dell'energia. Segue un elenco degli
interventi per il comparto.
Sarebbe opportuno che il Consiglio e il Parlamento
adottassero la proposta della Commissione che mira ad includere il trasporto
aereo nel sistema UE di scambio delle quote.
Il Consiglio dovrebbe adottare la proposta della
Commissione per correlare le tasse automobilistiche ai livelli di emissione del
CO2.
Per affrontare il problema delle emissioni di CO2
prodotte dalle auto, nella comunicazione di prossima pubblicazione riguardante
il conseguimento dell'obiettivo di emissione fissato dall'UE per il 2012, pari
a 120 g
CO2/km secondo un approccio coerente e completo, verranno proposte
altre misure. Sarà inoltre valutata la possibilità di ottenere
ulteriori riduzioni dopo il 2012.
Occorre rafforzare le misure che incidono sulla domanda,
come quelle definite nel Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino
al 2010 e nel riesame della stessa.
È opportuno contenere maggiormente le
emissioni di gas serra prodotte dal trasporto merci su strada e per via
navigabile, tenuto conto della dimensione internazionale.
È necessario ridurre le emissioni di CO2
rilasciate nell'intero ciclo di vita dei carburanti da trasporto, ad esempio
accelerando lo sviluppo dei biocarburanti sostenibili ed in particolare di
quelli di seconda generazione.
(e)
Riduzione delle emissioni di gas serra in altri settori
Edilizia residenziale e
commerciale
Il consumo di energia degli edifici potrà essere ridotto fino al
30% se si amplierà il campo di applicazione della direttiva sul
rendimento energetico degli edifici e se si introdurranno requisiti UE di
prestazione che incentivino un'edilizia a bassissimo consumo di energia (e che
ne favoriscano l'espansione entro il 2015). Poiché i cambiamenti
climatici colpiranno le fasce più sfavorite della società, i governi
dovrebbero prevedere politiche energetiche specifiche per l'edilizia popolare.
Gas diversi dal CO2
Per affrontare il problema delle emissioni dei gas diversi dal CO2,
che rappresentano il 17% delle emissioni dell'UE, sarebbe opportuno proporre
vari interventi, quali:
una migliore attuazione delle misure previste dalla
politica agricola comune e dal piano d'azione dell'UE per le foreste, in modo
da ridurre le emissioni prodotte dalle attività agricole dell'UE e da
promuovere il sequestro biologico;
la definizione di limiti di emissione per il metano
prodotto dai motori a gas e dovuto alla produzione di carbone, petrolio e gas o
l'inclusione di tali emissioni nel sistema UE di scambio delle quote;
l'ulteriore limitazione o il divieto di utilizzo
dei gas fluorurati;
la riduzione delle emissioni di protossido di azoto
derivanti dalla combustione e l'inclusione delle emissioni di N2O
prodotte dai grandi impianti nel sistema UE di scambio delle quote.
(f) Ricerca
e sviluppo tecnologico
Nell'ambito del Settimo programma quadro comunitario, i finanziamenti
destinati alla ricerca nei settori dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti
nel periodo 2007‑2013 sono aumentati, passando a 8,4 miliardi di euro.
Tali finanziamenti dovrebbero essere utilizzati al più presto, per
incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite nel campo dell'energia e dei
trasporti da diffondere il più rapidamente possibile e per accrescere
ancora le conoscenze sui cambiamenti climatici e i relativi impatti. Dopo il
2013 il bilancio destinato a tali attività dovrebbe aumentare ancora e
sarebbe opportuno intraprendere iniziative analoghe in ambito nazionale. Il
piano d'azione strategico per le tecnologie energetiche e il piano d'azione per
le tecnologie ambientali dovrebbero avere piena attuazione; occorre infine
promuovere maggiormente i partenariati pubblico-privato.
(g)
Politica di coesione
Gli orientamenti strategici in materia di coesione, adottati
nell'ottobre del 2006, incentivano i trasporti e l'energia sostenibili
nonché le tecnologie e le innovazioni ambientali attraverso le
sovvenzioni erogate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione. Questi
provvedimenti dovrebbero essere inseriti nei programmi operativi.
(h) Altri
provvedimenti
L'UE dovrebbe valutare tutte le soluzioni possibili per ridurre le
emissioni di gas serra e garantire che le misure da adottare sia tra loro
coerenti sotto il profilo economico e ambientale. Nel secondo rapporto del
Gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente, si
proponeva di analizzare la praticabilità di tutti i potenziali
interventi che potrebbero offrire gli incentivi necessari per incoraggiare i
partner commerciali dell'UE ad intraprendere misure efficaci per l'abbattimento
delle emissioni dei gas serra[94].
L'UE dovrebbe incentivare anche la sensibilizzazione del pubblico in
generale alle ripercussioni che le proprie azioni hanno in termini di
cambiamenti climatici e coinvolgere i cittadini nell'impegno a limitare tali
impatti.
6. Interventi
in ambito internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici
La battaglia contro i cambiamenti climatici si può vincere solo
con un intervento di scala planetaria, ma per raggiungere l'obiettivo dei
2 ºC il dibattito internazionale deve andare oltre la retorica e
arrivare a negoziati in cui si discuta di impegni concreti. Per l'UE il
raggiungimento di un accordo in questo senso dovrebbe essere la priorità
internazionale a tutti i livelli: per esercitare tutto il suo peso dovrebbe
organizzarsi e presentare, negli anni, una posizione e una politica unitaria
dell'UE e un approccio coerente e convincente, come richiede un impegno di
questa portata. Tutto ciò renderà necessari metodi di lavoro
diversi in termini di coordinamento e di azione internazionale.
Un accordo del genere si può raggiungere solo così. In
paesi come gli Stati Uniti e l'Australia, che non hanno ratificato il
protocollo di Kyoto, aumenta la consapevolezza dei pericoli insiti nei
cambiamenti climatici e ciò ha dato vita a iniziative regionali per
contenere le emissioni dei gas serra. Le imprese, più che alcuni
governi, stanno facendo propria una visione di lungo termine e stanno
diventando l'elemento trainante nella lotta ai cambiamenti climatici; a tal
fine chiedono un quadro politico coerente, stabile ed efficiente che orienti le
decisioni in materia di investimenti. Molte delle tecnologie di riduzione delle
emissioni di gas serra esistono già o sono in fase avanzata di sviluppo
e sono in grado di abbattere le emissioni (cfr. grafico 1). Ciò che
serve ora è l'appoggio dei principali responsabili delle emissioni per
giungere ad un accordo di lungo termine che ne garantisca un maggiore sviluppo
e diffusione.
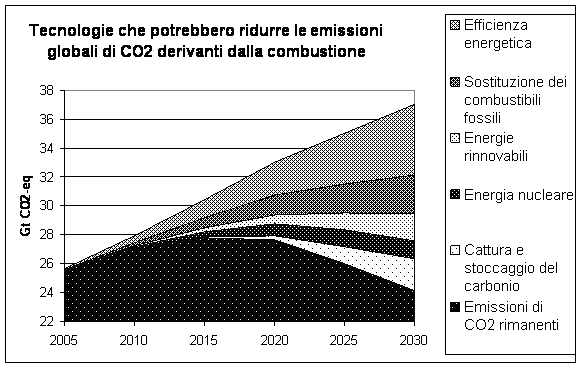
Fonte: CCR-IPTS,
POLES
6.1 Come
devono intervenire i paesi industrializzati
I paesi industrializzati sono responsabili del 75% dell'attuale
concentrazione di gas serra di origine industriale nell'atmosfera e del 51% se
si tiene conto della deforestazione (concentrata in massima parte nei paesi in
via di sviluppo). Essi hanno inoltre la capacità tecnologica e
finanziaria per ridurre le proprie emissioni: per questo dovrebbero dare il
contributo maggiore nei prossimi dieci anni.
Il potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra dei paesi industrializzati
che non hanno ratificato il protocollo di Kyoto è ancora superiore a
quello dell'UE. Al fine di conseguire l'obiettivo dei 2 °C, e
nel contesto di un accordo internazionale che si applichi dopo il 2012, l'Unione europea
dovrebbe proporre ai paesi industrializzati d'impegnarsi a ridurre del 30% le
proprie emissioni rispetto ai valori del 1990 entro il 2020.
I sistemi di scambio delle emissioni saranno uno strumento cruciale per
consentire ai paesi sviluppati di realizzare i traguardi fissati in maniera
economicamente efficace. Sistemi analoghi a quello dell'UE sono in fase di
preparazione anche in altri paesi. I vari sistemi nazionali di scambio con
livelli comparabili di rigorosità dovrebbero essere connessi tra loro,
per ridurre i costi legati all'adempimento degli obblighi.
Il regime che entrerà in vigore dopo il 2012 deve prevedere norme
vincolanti ed efficaci per verificare e far applicare gli impegni assunti: in
tal modo verrà a crearsi un clima di fiducia nel fatto che tutti i paesi
manterranno i rispettivi impegni e che non ci saranno inversioni di rotta come
quelle rilevate di recente.
6.2 Interventi
nei paesi in via di sviluppo
Nel futuro immediato è opportuno che i paesi industrializzati
intervengano in maniera decisa per abbattere le proprie emissioni. Ma le
economie dei paesi in via di sviluppo e, di conseguenza, le emissioni prodotte
crescono in termini assoluti e relativi ed entro il 2020 rappresenteranno
più del 50% delle emissioni globali (cfr. grafico 2). Ne consegue che
un'azione anche più incisiva, ma intrapresa solo dai paesi
industrializzati, non solo perderà di efficacia, ma non sarà
semplicemente sufficiente, anche se questi paesi riusciranno ad abbattere
drasticamente le proprie emissioni. È pertanto indispensabile che anche
i paesi in via di sviluppo, e soprattutto le principali economie emergenti,
comincino a ridurre al più presto l'aumento delle proprie emissioni e ad
abbattere le emissioni in termini assoluti
dopo il 2020. Occorre inoltre agire con incisività per arrestare le
emissioni risultanti dalla deforestazione. Questo obiettivo è
perfettamente realizzabile senza compromettere in alcun modo la crescita
economica e la lotta alla povertà. Crescita economica e lotta alle
emissioni di gas serra sono due elementi perfettamente compatibili. Nella
valutazione d'impatto si stima che il PIL complessivo dei paesi in via di
sviluppo "che dispongono di una politica climatica" nel 2020 dovrebbe
risultare leggermente inferiore (-1%) rispetto al PIL generato in assenza di
una politica climatica. In realtà, la differenza è ancora
più esigua, se non addirittura inesistente, perché le stime non
tengono conto dei danni connessi ai cambiamenti climatici che vengono evitati.
Nello stesso periodo, si prevede che il PIL di Cina e India raddoppierà
e che quello del Brasile aumenterà del 50% circa. Lo sforzo di
coinvolgere i paesi in via di sviluppo a fare qualcosa sarà più
convincente se tutti i principali paesi industrializzati che producono le
emissioni ridurranno sensibilmente le proprie.
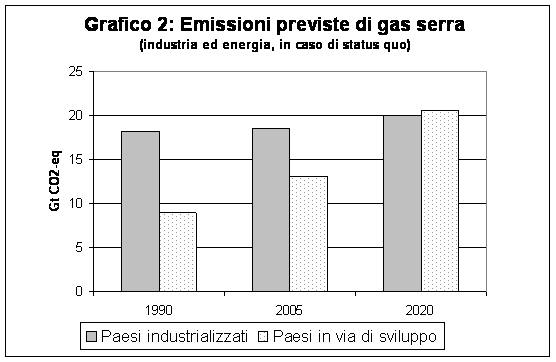
Fonte: CCR-IPTS,
POLES
Molti paesi in via di sviluppo stanno già intervenendo per
ridurre sensibilmente la crescita delle emissioni di gas serra che producono
attraverso politiche a livello di economia, sicurezza o ambiente locale e hanno
a loro disposizione molte soluzioni che presentano benefici superiori ai costi.
L'aumento della produttività legata
all'utilizzo dell'energia, oggi bassa, consente di dare una risposta alle
crescenti preoccupazioni per i costi dell'energia e la sicurezza.
Le politiche
riguardanti le energie rinnovabili sono spesso efficaci sotto il profilo economico,
in particolare per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle zone
rurali.
Le politiche
in materia di qualità dell'aria presentano vantaggi per la salute delle persone.
Il metano emesso dalle discariche, dai letti di carbone, dai
rifiuti organici in decomposizione e da altre fonti e poi recuperato è
una fonte di energia a basso costo.
Tutte queste politiche possono essere rafforzate con uno scambio di
buone pratiche in fase di elaborazione e pianificazione e di cooperazione
tecnologica. In tal modo i paesi in via di sviluppo saranno in grado di
svolgere un ruolo di maggiore peso nell'ambito delle attività di abbattimento
delle emissioni su scala mondiale. L'UE continuerà le proprie
attività di cooperazione in questo senso, approfondendole.
Ci sono varie soluzioni possibili per coinvolgere i paesi in via di
sviluppo in un'azione più incisiva.
(a) Un nuovo
approccio al meccanismo CDM
Il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) del protocollo di Kyoto deve
essere razionalizzato ed esteso. Per il momento, genera crediti nel caso di
investimenti in progetti di abbattimento delle emissioni che si realizzano nei
paesi in via di sviluppo; tali crediti possono essere utilizzati dai paesi
industrializzati per rispettare i propri obiettivi di riduzione e in tal modo
si creano importanti flussi di capitali e di tecnologie. Il CDM potrebbe essere
esteso a interi settori nazionali, generando crediti di emissione se tutto il
settore nazionale fosse in grado di superare uno standard predefinito di
emissione. Un meccanismo di portata più ampia potrà però
funzionare unicamente in presenza di una maggiore domanda di crediti e ciò
accadrà solo se tutti i paesi industrializzati si assumeranno
consistenti impegni di riduzione.
(b) Migliore
accesso ai finanziamenti
Nei paesi in via di sviluppo le previsioni indicano che, per sostenere
la crescita economica, gli investimenti per la generazione di nuova elettricità
dovrebbero superare i 130 miliardi di euro l'anno; gran parte di queste risorse
proverrà dai principali paesi in via di sviluppo medesimi. I nuovi
impianti saranno operativi per decine d'anni e determineranno le emissioni dei
gas serra dopo il 2050. Per questo dovrebbero essere impianti all'avanguardia;
questa è dunque un'occasione unica per ridurre le emissioni nei paesi in
via di sviluppo.
Per abbattere drasticamente le emissioni di CO2 nel settore
dell'energia elettrica serviranno altri investimenti pari a circa 25 miliardi
di euro l'anno. Questo divario non potrà essere colmato con il CDM,
anche se questo avesse una portata più ampia come proposto in
precedenza, e nemmeno con gli aiuti allo sviluppo. Sarà invece necessaria
una combinazione di CDM, aiuti allo sviluppo, meccanismi di finanziamento
innovativi (come il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie
rinnovabili proposto dall'UE), prestiti mirati di istituti finanziari
internazionali e l'impegno dei paesi in via di sviluppo che hanno i mezzi per
contribuire. Più rapidamente verrà colmato il divario e meno
aumenteranno le emissioni dei paesi in via di sviluppo.
(c) Approcci
settoriali
Un'altra soluzione potrebbe essere l'introduzione di scambi di emissione
a livello di imprese di tutto un settore, laddove esista la capacità di
monitorare le emissioni e di garantire il rispetto degli impegni, soprattutto
per i settori ad alto consumo energetico come la produzione di energia
elettrica, gli impianti di lavorazione dell'alluminio, del ferro, dell'acciaio,
del cemento, le raffinerie e l'industria della carta e della pasta per carta,
che sono in massima parte soggetti alla concorrenza internazionale. Tali
sistemi di scambio potrebbero essere di scala nazionale o mondiale: nel caso di
regimi nazionali, nei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere collegati con
quelli esistenti nei paesi industrializzati e gli obiettivi definiti per
ciascun settore partecipante dovrebbero essere gradualmente inaspriti fino ad
avvicinarsi a quelli dei paesi industrializzati. Un approccio di questo tipo
servirebbe anche a limitare il trasferimento di impianti ad alte emissioni da
paesi che impongono obblighi di riduzione verso paesi che non lo fanno.
(d) Limiti di
emissione quantificati
I paesi che raggiungono un grado di sviluppo paragonabile a quello dei
paesi industrializzati dovrebbero assumersi impegni di riduzione sulla base del
rispettivo grado di sviluppo, delle emissioni pro capite, del potenziale di
riduzione delle emissioni e della propria capacità tecnica e finanziaria
di attuare altre misure di limitazione e riduzione delle emissioni.
(e) Assenza di
impegni per i paesi meno sviluppati
I paesi meno sviluppati saranno quelli che subiranno maggiormente le
conseguenze dei cambiamenti climatici. Poiché emettono quantità
ridotte di gas serra non dovrebbero essere vincolati a ridurre le proprie
emissioni. L'UE rafforzerà ancora la propria cooperazione con i paesi
meno sviluppati per aiutarli ad affrontare i problemi posti dai cambiamenti
climatici, in particolare attraverso iniziative volte a migliorare la sicurezza
alimentare, la capacità di monitorare i cambiamenti climatici, la
gestione del rischio di catastrofi, la loro preparazione e risposta in caso di
disastri. Oltre agli aiuti allo sviluppo necessari per affrontare le
problematiche dei cambiamenti climatici, serviranno altri finanziamenti per
permettere ai paesi più vulnerabili di adattarsi al fenomeno. L'UE e
altri paesi dovrebbero infine aiutarli a partecipare maggiormente ai progetti
nell'ambito del CDM.
Altri elementi
In un futuro accordo internazionale dovrebbero figurare anche gli
elementi descritti di seguito.
§
Il cambiamento
tecnologico necessita una maggiore cooperazione
internazionale a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. L'UE dovrebbe
accelerare fortemente la propria cooperazione in ambito tecnologico e di
ricerca con i paesi terzi, anche istituendo progetti di dimostrazione di vasta
scala in determinati paesi in via di sviluppo, in particolare per la cattura e
lo stoccaggio geologico del carbonio. La cooperazione internazionale nel campo
della ricerca dovrebbe servire anche a quantificare gli impatti dei cambiamenti
climatici in ambito regionale e locale e a predisporre le opportune strategie
di adattamento e mitigazione degli effetti. Le attività di ricerca
dovrebbero infine approfondire aspetti quali le interazioni tra gli oceani e i
cambiamenti climatici.
§
Le emissioni
derivanti dalla perdita netta di copertura forestale devono cessare
definitivamente nel giro di vent'anni e successivamente ci deve essere
un'inversione di tendenza. Tra le possibili soluzioni per combattere la deforestazione vi sono politiche forestali efficaci
(di scala internazionale e nazionale) abbinate ad incentivi economici. Servono
rapidamente dei sistemi pilota di vasta scala che consentano di esaminare quali
siano gli approcci più efficaci in grado di abbinare gli interventi in
ambito nazionale al sostegno internazionale.
§
Le iniziative
finalizzate a favorire l'adattamento alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti
climatici dovranno essere parte integrante del futuro accordo mondiale sul
clima. La necessità di adeguarsi agli impatti del fenomeno dovrebbe
essere un elemento da considerare nelle decisioni sugli investimenti pubblici e
privati. Partendo dall'attuazione del piano d'azione UE su cambiamenti
climatici e sviluppo, che dovrà essere riesaminato nel 2007, l'UE dovrebbe
rafforzare il processo di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per
quanto riguarda le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione
dei relativi effetti.
§
La conclusione
di un accordo internazionale su norme di
efficienza energetica che coinvolga i principali paesi produttori di
apparecchiature avrà vantaggi in termini di accesso al mercato e
servirà ad abbattere le emissioni di gas serra.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 10.1.2007 SEC(2007)7
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI
DELLA COMMISSIONE
Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti
climatici a +2 gradi Celsius
La via da percorrere fino al 2020 e oltre
Sintesi
della valutazione d'impatto
{COM(2007) 2 def.}
1SEC(2007) 8}
1 INTRODUZIONE
Nella comunicazione del 2005 dal
titolo "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici" venivano illustrate le
problematiche che si sarebbero presentate nella lotta a questo fenomeno_ Sia il Consiglio europeo che il
Parlamento hanno confermato l'obiettivo di contenere l'innalzamento della
temperatura media mondiale ad un massimo di 2 °C rispetto ai
valori dell'epoca preindustriale. Il Consiglio europeo ha evidenziato la
necessità di prendere in esame strategie in grado di ridurre le
emissioni come richiesto ed ha invitato la Commissione europea a
svolgere un'analisi più approfondita. La presente comunicazione fa
seguito a tale invito.
2.
BILANCIO DELLE
RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NELLA COMUNICAZIONE DEL 2005
L'UE dovrebbe riuscire a
conseguire gli obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto_ Dalle proiezioni riguardanti le
politiche in vigore nell'UE-15 si evince che, nel 2010, le emissioni di gas serra saranno calate di
appena lo 0,6% rispetto ai livelli dell'anno di riferimento, attestandosi
cioè ben al di sopra dell'obiettivo collettivo di riduzione fissato
all'8% per il periodo 2008-2012. Misure supplementari potranno dimezzare il
divario e i meccanismi di Kyoto e la rimozione del carbonio tramite pozzi di
assorbimento faranno il resto. Questi dati sottolineano quanto sia importante
mettere in atto tutte le misure esistenti e quelle supplementari.
Nell'ottobre del 2005 è
partita la seconda fase del Programma europeo per il cambiamento climatico
(ECCP). Da allora la
Commissione europea ha presentato una proposta intesa a includere il trasporto aereo nel
sistema UE di scambio delle quote di emissione e nel corso del2007 presenterà una
comunicazione sulle emissioni delle automobili, una proposta riguardante la cattura e lo stoccaggio
geologico del carbonio (Carbon
Capture and Storage - CCS) e un Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici. E inoltre iniziato
il riesame del sistema UE di scambio delle quote e il Settimo programma quadro di ricerca e
sviluppo (2007-2013) aumenta il bilancio destinato ad ambiente, energia e
trasporti, che adesso ammonta a circa 8 miliardi di curo.
È stata incentivata anche
la cooperazione internazionale, ad esempio con contatti periodici con paesi che
rivestono posizioni chiave come la
Cina, l'India e gli Stati Uniti. È aumentata la
cooperazione in campo tecnologico, in particolare per quanto riguarda le
attività CCS, e il Settimo programma quadro la promuoverà ancora
di più. Viene inoltre favorito un maggiore accesso ai finanziamenti per
lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, ad esempio nell'ambito
del Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili
(GEEREF).
3.
ULTIMI DATI SCIENTIFICI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Gli studi più recenti
confermano che il clima sta effettivamente cambiando e, dalle indicazioni
disponibili, risulta che tali cambiamenti hanno subito un'accelerazione: basti
pensare che i 10 anni più caldi mai registrati si sono tutti verificati
dopo il 1990. Le concentrazioni odieme di metano e di CO2 in atmosfera hanno
raggiunto Iivelli mai rilevati negli ultimi 650 000 anni ed è stata osservata
anche un'accelerazione nell'innalzamento del livello dei mari. Anche
buona parte dei servizi
ecosistemici subirà le conseguenze del fenomeno, perché
verrà ridotta la copertura dei ghiacci e aumenterà }'acidificazione degli
oceani, con impatti potenzialmente drammatici sull'ambiente.
Diminuisce anche l'incertezza
sugli effetti dei cambiamenti climatici. In base ai dati disponibili è
possibile prevedere che, nel corso di questo secolo, quasi certamente verranno
raggiunte le temperature critiche che rischiano di determinare perturbazioni su
vasta scala, a conferma della necessità di contenere l'aumento della
temperatura entro 1 2
°C. Studi recenti evidenziano che, se la
concentrazione dei gas serra supererà le 450 parti per milione in volume
di CO2 equivalente (ppmv di C02 eq.), aumenterà il
rischio che la temperatura s'innalzi di oltre 2 °C.
4.
COSTO DELL'INAZIONE PER L'EUROPA
A causa di lacune nelle
metodologie e nei dati scientifici non è stato ancora possibile svolgere
un'analisi completa dei costi che potrebbero derivare dall'inazione. Lo studio
PESETA, attualmente in corso con il coordinamento del Centro comune di ricerca,
ha t'obiettivo di colmare in parte i dati mancanti per l'UE. Il progetto prende
in esame gli effetti dei cambiamenti climatici nei seguenti campi: agricoltura,
salute umana, turismo, bacini idrografici e sistemi costieri.
I risultati preliminari
disponibili mettono in evidenza che è previsto un calo della resa delle colture cerealicole nell'Europa meridionale a fronte
di un aumento nell'Europa settentrionale. Tra gli effetti sulla salute si può annoverare l'aumento
della mortalità e della morbilità (malattie) dovute alla calura
estiva; nella stagione invernale la tendenza è esattamente contraria.
Sempre dai risultati preliminari emerge anche che, senza un'acclimatazione, per
la fine del secolo l'aumento dei decessi dovuti alla calura potrebbe essere
superiore al calo della mortalità dovuta al freddo. 1 danni imputabili all'innalzamento del livello del mare all'interno dell'UE saranno molto gravi se non
si interverrà in termini di adattamento. Nel medio termine, gli interventi di adattamento
riescono a ridurre i costi anche del 50% e sul lungo termine fino al 70%. 1
risultati disponibili dimostrano i benefici derivanti dall'adozione tempestiva
di provvedimenti di adattamento come la costruzione di dighe e la ricostruzione
e la manutenzione delle spiagge, anche se i costi di tali interventi rimangono
elevati.
I fenomeni meteorologici estremi
come le alluvioni di grande portata dovrebbero aumentare. i risultati
preliminari riguardanti due bacini idrografici giungono a conclusioni analoghe.
I danni complessivi di un evento alluvionale di media probabilità (che
ricorre cioè ogni I00 anni) dovrebbero aumentare anche del 40% nel
bacino dell'Alto Danubio e fino al 14% nel bacino della Mosa. Dai dati
preliminari risulta anche che la zona nella regione del Mediterraneo, oggi
caratterizzata da ottime condizioni atmosferiche che favoriscono il turismo
balneare, tenderà a spostarsi verso Nord; d'altro canto, nella regione
miglioreranno le condizioni atmosferiche in primavera e in autunno.
L'intensità di tali impatti dipenderà dal grado di adattamento
dei turisti ai cambiamenti delle condizioni atmosferiche.
5.
BENEFICI DEGLI INTERVENTI SUL CLIMA IN
ALTRI SETTORI
Qualità dell'aria: Le
politiche sui cambiamenti climatici e sull'inquinamento atmosferico sono
strettamente correlate tra loro. L'abbattimento delle emissioni di CO2
determina un notevole calo di altri inquinanti atmosferici, soprattutto il
diossido di zolfo, le particelle e gli
ossidi di azoto. Riducendo le emissioni di CO2 di circa i122% rispetto al valore
di riferimento entro il 2020 sarà possibile contenere le ripercussioni sulla
salute umana, con un beneficio quantificabile tra 27,8 e 48,1 miliardi di euro
e una notevole riduzione dei costi connessi al raggiungimento degli obiettivi
riguardanti altri inquinanti atmosferici. Benefici correlati analoghi, se non
maggiori, sono previsti anche nei paesi in via di sviluppo.
Sicurezza energetica: Sviluppi recenti hanno riportato alla ribalta il problema
della volatilità dei mercati dell'energia. I1 G8 ha invitato a procedere
con le politiche per la lotta ai cambiamenti climatici e a favore dell'energia
pulita. Tale invito giunge in un momento nel quale gli investimenti nel sistema
energetico raggiungeranno livelli mai visti in precedenza: i dati dell'Agenzia
internazionale dell'energia parlano di investimenti di poco superori a 20 triliardi di dollari fino al
2030. Questi dati aprono delle prospettive. Scegliere la strada che porta ad un'economia a basse
emissioni di carbonio risulta meno oneroso dal punto di vista economico nel
momento in cui si devono sostituire o ampliare le infrastrutture. La Banca iondiale stima che per passare ad una
produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio nei paesi che non
fanno parte dell'OCSE occorrono investimenti incrementali che potranno
raggiungere i 25 miliardi di euro l'anno. Nessuna delle tecnologie che l'AIE ha
individuato come strumento per abbattere le emissioni potrà avere un
costo d'investimento incrementale superiore a 20 curo per tonnellata di C02
emesso, al momento della piena diffusione.
La sicurezza energetica è diventata un problema importante
all'interno dell'UE. Secondo le proiezioni ottenute con il modello PRIMES, le importazioni
di petrolio dovrebbero aumentare del 25% circa tra il 2000 e il 2030 e quelle di gas
naturale dovrebbero più che raddoppiare. Nel Libro verde del marzo 2006
"Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura"
vengono presentate tre politiche che potrebbero garantire la sicurezza
energetica e la realizzazione degli obiettivi riguardanti i cambiamenti
climatici: efficienza energetica, energie rinnovabili e attività CCS.
Una migliore efficienza energetica e una penetrazione più diffusa delle
energie rinnovabili dovrebbero avere effetti positivi consistenti e ridurre le emissioni di COZ rispetto ai valori del 1990,
arrivando ad un abbattimento del 21 % entro il 2020, a quella data, le
importazioni di petrolio e di gas potrebbero scendere di oltre il 15% rispetto
alla situazione che si verificherebbe in caso di status quo. La
possibilità di catturare e stoccare il carbonio rappresenta un'altra variante di
tecnologia a basse emissioni di carbonio_ Le proiezioni ottenute con il modello POLES sui
sistemi energetici di scala mondiale attribuiscono una funzione importante alle
attività CCS, che entro il 2030 dovrebbero essere in grado di
sequestrare circa il 30% delle emissioni di CO2 prodotte dalle
centrali elettriche a combustibili fossili, nell'UE e nel mondo, favorendo in
tal modo anche la sicurezza energetica.
Occupazione. La valutazione d'impatto del piano d'azione sulla biomassa stimava che
tale piano potesse creare da 250
000 a 300 000 nuovi posti di lavoro all'interno dell'US.
In Europa anche il settore dell'energia colica si sta espandendo rapidamente e
vanta già circa 120 000 addetti solo in Germania, Danimarca e Spagna_ La Confederazione
europea dei sindacati sta svolgendo uno studio sulla relazione tra politiche
climatiche e occupazione: dai risultati intermedi risulta che la maggior parte
degli studi disponibili concorda che, nel complesso, le politiche climatiche
possono avere ripercussioni positive sull'occupazione.
Fertilità del suolo: La materia organica presente nel suolo
è un elemento importante nel ciclo del carbonio: il suolo, infatti,
emette carbonio e lo trattiene. Recentemente nel Regno Unito sono state
rilevate ingenti perdite di carbonio dal suolo; se questi dati fossero
confermati in altre regioni dell'UE, si tratterebbe di un problema serio che
richiederebbe un ulteriore
intervento. L'incertezza al riguardo è elevata e occorre
proseguire con le ricerche. La
Strategiatematica per la protezione del suolo punta a combattere la perdita di
materia organica nei suoli europei, a conservare la fertilità del suolo o ad aumentare i
livelli di carbonio stoccati dal suolo.
6. STRATEGIE
INTERNAZIONALI PER OTTENERE RIDUZIONI CREDIBILI DELLE EMISSIONI ENTRO IL 2050
Profili delle emissioni
Studi recenti confermano che, riuscendo a stabilizzare le emissioni
attorno alle 450 ppmv di CO2 eq., le probabilità di
raggiungere l'obiettivo dei 2
°C sono del 50%: già adesso le concentrazioni
dei gas serra si avvicinano alle 430 ppmv e aumentano di circa 2 ppmv l'anno.
Per contenere la temperatura entro 1 2 °C le concentrazioni dei gas serra
dovranno ridursi a 450 ppmv di C02 eq. a lungo termine, dopo aver
superato tale limite nei prossimi venti o trent'anni. Si tratta del cosiddetto
scenario di superamento (overshooling),
simile a quello presentato nel rapporto Stern che ipotizza una
concentrazione pari a 500 ppmv di CO2 eq.
La Commissione europea ha realizzato una
valutazione d'impatto nel caso si verificasse tale scenario utilizzando il
modello POLES (modello di equilibrio parziale), il modello GEM E3 (modello di
equilibrio generale) e il modello DIMA (per la silvicoltura). Se si verificasse
lo scenario che prevede il superamento delle concentrazioni, la
possibilità di realizzare l'obiettivo dei 2 °C sarebbe del
50% e le emissioni globali dovrebbero raggiungere il picco e stabilizzarsi tra il 2015 e il
2020. Le emissioni dovute a cambiamenti di utilizzo del terreno, in particolare la deforestazione,
rappresentano il 20% circa delle emissioni globali e dovrebbero registrare
un'inversione di tendenza entro il 2020. D'altra parte, sarebbe necessario che
le emissioni di gas serra provenienti da altre fonti diminuissero di circa il
25% rispetto ai valori del 1990 entro il 2050.
Fino al 2050 è stato applicato il modello POLES per ottenere delle
previsioni sulle tecnologie future e sono state prodotte stime dei costi fino
al 2030. Lo scenario di riferimento comprende stime recenti (e dunque più
elevate) dei prezzi dell'energia e ipotizza che nell'ambito del sistema UE di
scambio delle quote di emissione il prezzo del carbonio sia piuttosto basso (5
curo/tonnellata di CO2). Nello scenario che prevede una riduzione
delle emissioni, le emissioni globali di gas serra si stabilizzano entro il
2020 e successivamente si riducono del 25% entro il 2050 rispetto al 1990.
Le politiche in materia di efficienza energetica sono attuate in tutti i
paesi motivati a far fronte all'aumento del prezzo dell'energia. Si ipotizza che i paesi
industrializzati s'impegnino a ridurre le emissioni. Le industrie ad alto
consumo energetico partecipano al mercato globale del carbonio che si fa sempre
più integrato. All'inizio i paesi in via di sviluppo
presentano un prezzo inferiore del carbonio, che simula la limitata
penetrazione del prezzo del carbonio a livello di azienda attraverso strumenti
come il meccanismo di sviluppo pulito (CDM). Nel 2030, però, il divario
è esiguo grazie alla presenza di un quadro normativo più adeguato
anche nei paesi in via di sviluppo, eccetto quelli a più basso reddito.
Altri settori non partecipano al mercato globale del carbonio, ma si presume
che nei paesi industrializzati siano in vigore politiche con effetti analoghi,
mentre nei paesi in via di sviluppo sono attuate solo politiche di efficienza
energetica.
Proiezioni
sulle emissioni di gas serra
In base allo scenario di riferimento, nel 2050 le emissioni planetarie di
gas serra dovrebbero aumentare dell'86% rispetto al 1990. Nel 2020 le emissioni
dei paesi in via di sviluppo dovrebbero superare quelle del mondo
industrializzato.
Considerando invece lo scenario che prevede un abbattimento delle
emissioni, nel 2020 le emissioni dei paesi industrializzati sarebbero
già inferiori a quelle del 1990 (-18%), con un ulteriore calo nel 2030
(-32%). Per ME-25, l'abbattimento
rispetto al 1990 dovrebbe aggirarsi attorno al 21% nel 2020 e al 36% nel 2030.
Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, le emissioni dovrebbero
stabilizzarsi tra il 2020 e i1 2025. Nel 2030 le emissioni globali dovrebbero
superare i livelli del 1990 di appena il M.
Fattibilità dal punto di vista tecnico
II sistema energetico deve cambiare fortemente. L'intervento
più importante è senz'altro quello diretto a contenere i consumi
energetici attraverso una maggiore efficienza. 1 settori residenziale e del
terziario sono quelli che risparmiano di più e che rispondono
maggiormente all'applicazione di norme di efficienza energetica. L'efficienza
delle centrali elettriche a combustibili fossili aumenta anche grazie alla
sostituzione delle tradizionali centrali elettriche a carbone con impianti a
tecnologia più avanzata. Nel 2030 l'UE dovrebbe ridurre del 60% le proprie
importazioni di carbone e del 20% quelle di petrolio e di gas, sempre rispetto
allo scenario di riferimento.
Il settore della generazione di energia elettrica rimane uno dei
più importanti per l'abbattimento delle emissioni. Secondo le
previsioni, tra il 2005 e il 2050 le energie rinnovabili, esclusa l'energia
idroelettrica, dovrebbero aumentare di 24 volte. Le tecnologie CCS saranno
un'importante tecnologia di transizione a livello mondiale, anche se il consumo
di carbone dovrebbe diminuire. Gli impianti a carbone saranno sostituiti da
tecnologie avanzate del carbone. Il gas naturale compenserà parzialmente
il carbone e nel 2025 rappresenterà il 33% della produzione mondiale di
elettricità. II nucleare sarà utilizzato di più nella produzione di energia
elettrica ma in termini assoluti occupa sostanzialmente la stessa posizione che
ha nello scenario di riferimento.
Costi e scambio delle quote di emissione
Secondo le proiezioni del modello POLES, il prezzo mondiale del carbonio
dovrebbe raggiungere i 37 curo per tonnellata di CO2 nel 2020 e i 64
curo per tonnellata nel 2030. 1 costì derivanti dagli investimenti
ìn tecnologie a basse emissioni di carbonio dovrebbero rappresentare
meno dello 0,5% del P1L mondiale annuo fino al 2030. La definizione di obiettivi di riduzione fino al 30%
per il 2020 e fino al 50% nel 2030 dovrebbero incentivare loscambio delle emissioni e in tal
modo sarà possibile abbattere le emissioni a livello planetario all'insegna dell'efficacia
economica. Se si conseguissero gli obiettivi di riduzione fissati per i paesi
industrializzati attraverso lo scambio delle quote, il costo globale
dell'abbattimento scenderebbe del 75%.
Non bisogna confondere i costi derivanti dagli investimenti supplementari
in tecnologie a basse emissioni di carbonio con l'impatto sulla crescita
economica. Quest'ultimo impatto è stato analizzato con il modello GEM E3
per l'intera economia. Ipotizzando che le emissioni seguano un andamento
compatibile con l'obiettivo dei 2 °C, il P1L mondiale risulterebbe comunque
quasi raddoppiato nei prossimi 25 anni: nel 2030 la sua crescita dovrebbe
essere inferiore a quella della situazione di riferimento di appena lo 0,19% in
termini annui. L'impatto sul PIL nazionale varia in funzione dei diversi
impegni di riduzione. Le differenze
registrate nel PIL, in termini annui, per l'UE sono maggiori rispetto a
quelle calcolate per il PIL mondiale e passano da -0,19% nel 2020 a - 0,24% nel 2030.
Anche nei grandi paesi in viadi sviluppo, che pur non devono adempiere a obblighi di riduzione nel
2020, il PIL subisce unleggero calo rispetto allo scenario di riferimento (da -0,06% in Brasile
e Cina fino a -0,1% in India, sempre in termini annui); tale calo è una conseguenza
degli scambi.
La valutazione dimostra che è possibile ridurre le emissioni
planetarie in modo da realizzare l'obiettivo dei 2 °C, ma deve
aumentare la partecipazione. Tutti i paesi devono migliorare la propria
efficienza energetica e abbattere le emissioni dei trasporti, del settore
residenziale e del terziario. 1 settori ad alto consumo energetico, soprattutto
quello dell'energia elettrica, devono gradualmente aderire a un mercato globale
del carbonio, garantendo l'efficacia dei costi. II gruppo dei paesi
industrializzati deve fissarsi obiettivi di riduzione decisi: - 30% circa rispetto al 1990 nel 2020 per
passare a -40/-55% nel 2030; devono inoltre partecipare integralmente al mercato globale
del carbonio. Realizzando tali obiettivi nel 2020 le emissioni nazionali dei paesi
industrializzati dovrebbero scendere del 20%. Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, le loro
emissioni dovrebbero cominciare a stabilizzarsi tra il 2020 e il 2025 per poi iniziare a calare.
Riduzione delle
emissioni all'interno dell'UE
L'abbattimento delle emissioni all'interno dell'UE avrebbe vari aspetti
positivi in termini di sicurezza energetica e minor inquinamento atmosferico, senza contare
l'effetto di promozionedi tecnologie competitive. I1 modello GEM E3 ha valutato l'impatto della
decisione unilaterale dell'UE di abbattere le proprie emissioni del 21% e del 31% entro il
2020, senza un'ampia partecipazione. Una decisione unilaterale di questo tipo avrebbe
indubbiamente un importantevalore sotto il profilo politico, ma darebbe un esiguo contributo alla
riduzione delle emissioni globali, che diminuirebbero solo del 5% rispetto al valore di
riferimento. Anche senza un'ampia partecipazione, sarà necessario accedere ai progetti CDM,
che fungono da valvola di sicurezza. Senza tali progetti, il prezzo del carbonio sarebbe da 8 a 11 volte più
elevato. Con l'accesso al CDM conseguire gli obiettivi di abbattimento
risulterebbe molto meno costoso rispetto a quanto avverrebbe secondo uno
scenario di riduzione che prevede una partecipazione di scala mondiale.
La possibilità di accedere pienamente al meccanismo CDM ridurrebbe
limitatamente le emissioni a livello interno e avrebbe scarsi benefici
collaterali, ma tali riduzioni e benefici potrebbero essere garantiti da
politiche energetiche comunitarie concomitanti.
Deforestazione_
invertire la tendenza
Le emissioni dovute alla deforestazione saranno un fattore decisivo per
realizzare l'obiettivo dei 2
°C. I1 modello DIMA (Dynamic Integrated Model of
Forestry and Alternative Land Use), un modello dinamico integrato per
la silvicoltura e l'uso alternativo del terreno, analizza le cause della deforestazione. Al
fine della presente valutazione d'impatto il modello ha considerato anche un incentivo
finanziario per tonnellata di COz simile al prezzo previsto nel modello POLES a ]]-vello
regionale. L'impatto che ne consegue è notevole: entro il 2020 ci
sarebbe infatti un'inversione netta e si passerebbe da una situazione in cui
c'è una fonte netta di emissioni ad una in cui si ottiene un effetto
netto di assorbimento. Invertire la tendenza in atto in questo modo sarà
una sfida.
Prima di introdurre incentivi finanziari per invertire l'attuale tendenza
alla deforestazione occorre un'attenta analisi. Gli incentivi previsti dal
modello D1MA potrebbero raggiungere
livelli astronomici se fossero concessi per evitare la
deforestazione di tutte le risorse forestali e boschive esistenti. Gli
incentivi in questo caso sono una soluzione complessa per molti aspetti. Il
degrado delle foreste è dovuto a svariati motivi; la governante e le
norme in materia di proprietà variano e spesso manca chiarezza in
merito. In un recente rapporto della Banca mondiale il finanziamento del
carbonio figura tra gli strumenti proposti, ma viene anche sottolineata la
necessità di attuare altri provvedimenti come finanziamenti alla
biodiversità, migliori attività di monitoraggio e valutazione,
una migliore normativa sui diritti di proprietà e procedure di
pianificazione più adeguate, ad esempio per la costruzione di strade.
Vari regimi di incentivi e altre
soluzioni analoghe sono già stati applicati ed esiste una certa esperienza in questo campo, che è tuttavia
difficile da trasferire in ambito internazionale. Uno dei prossimi passi
dovrebbe essere quello di acquisire esperienza pratica attraverso progetti
pilota.
Risoluzione del
Parlamento europeo sui cambiamenti climatici
PROV(2007)0038
Il Parlamento europeo ,
– vista la dodicesima sessione della
Conferenza delle Parti (COP 12) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCC) e la seconda sessione della Conferenza delle
Parti quale riunione delle Parti del Protocollo di Kyoto (COP/MOP 2) svoltasi a
Nairobi in Kenia dal 6 al 17 novembre 2006,
– viste le sue precedenti
risoluzioni sui cambiamenti climatici ed in particolare quelle delle 16
novembre 2005 su "Vincere la battaglia contro i cambiamenti
climatici"(1) e del 26 ottobre 2006 sulla "Strategia dell'Unione
europea per la Conferenza
di Nairobi" (COP 12 - COP/MOP 2)(2) ,
– vista la Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni su "Limitare il
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a più 2 gradi Celsius -
La via da percorrere fino al 2020 e oltre" (COM(2007)0002),
– vista la conclusione formale
approvata il 2 febbraio 2007
in occasione della 10a sessione del gruppo di lavoro I
dell'Intergovernmental Panel on climate change (IPCC) svoltasi a Parigi, quale
contributo alla quarta relazione di verifica dell'IPCC che descrive le attuali
conoscenze dei fattori umani e naturali all'origine dei cambiamenti climatici e
fornisce una stima delle proiezioni future di tali cambiamenti,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2,
del suo regolamento,
A.
considerando che i recenti episodi di estremo maltempo, quali la
devastante tempesta Kyrill, hanno intensificato le discussioni sui cambiamenti
climatici,
B.
considerando che anche se un singolo episodio di estremo maltempo non
può essere direttamente collegato ai cambiamenti climatici occorre
considerare che molti scienziati ritengono che l'aumentata intensità
degli episodi di maltempo estremo sia collegato ai cambiamenti climatici,
C.
considerando che recenti rapporti scientifici danno ragione di temere
che i processi di cambiamento climatico già in corso possano accelerare
a causa di varie forme di feedback positivo,
1.
sottolinea che è urgente prendere iniziative concrete a livello
mondiale per affrontare i cambiamenti climatici e che è necessaria una leadership
politica per portare avanti questo processo;
2.
si compiace in questo contesto del fatto che sia la Commissione che la Presidenza in carica
abbiano messo al centro della propria agenda politica i cambiamenti climatici;
3.
sollecita l'Unione europea a mantenere il proprio ruolo di guida nei
negoziati in vista di un quadro internazionale post-2012 sui cambiamenti
climatici conservando aspettative ambiziose nelle discussioni future con i suoi
partner internazionali;
4.
sollecita l'Unione europea a dimostrare la propria volontà di
affrontare i cambiamenti climatici con misure quantificabili riducendo le
proprie emissioni di gas serra (GHG) e rispettando i propri obiettivi nazionali
e internazionali per la riduzione delle emissioni;
5.
riconosce che la quota di emissioni UE di GHG, che secondo la quarta
relazione sulle comunicazioni nazionali della Comunità europea a norma
dell'UNFCC è pari al 14%, può apparire modesta; sottolinea
tuttavia che se misurata in termini di emissioni pro capite, la quota UE
è tra le più alte del mondo; al fine di diminuire queste
differenze ricorda alla Commissione e agli Stati membri i loro impegni nel
quadro del Protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakesh volti a garantire
la complementarietà dell'uso dei meccanismi flessibili;
6.
sottolinea la necessità di accelerare in modo significativo i
negoziati internazionali sul quadro post-2012 in modo da garantire
che non si creino lacune tra il primo e il secondo periodo di impegni nel
quadro del Protocollo di Kyoto e da lasciare il tempo alla comunità
internazionale di pianificare le misure necessarie; ribadisce il suo auspicio
di raggiungere un accordo entro il 2008 o al massimo entro il 2009;
7.
sottolinea che l'UE dovrebbe basare la sua strategia sul presupposto che
si raggiunga un accordo a livello internazionale sul quadro post-2012; ritiene
pertanto che sia prematuro nella fase attuale discutere una strategia di
ripiego qualora detto accordo internazionale non venga raggiunto;
8.
ricorda che, come indicato nelle sue risoluzioni del 16 novembre 2005 e
del 26 ottobre 2006 e come in parte ammesso dalla Commissione nella sua
comunicazione, la strategia UE sui cambiamenti climatici dovrebbe basarsi sui
seguenti obiettivi chiave:
i) limitare l'aumento della temperatura globale media a non più
di 2° centigradi rispetto ai livelli di preindustrializzazione,
ii) impegnarsi a raggiungere una riduzione complessiva delle emissioni
per tutti i paesi industrializzati del 30% entro il 2020 rispetto ai livelli di
emissioni del 1990, per giungere entro il 2050 ad una riduzione dell'ordine del
60-80%;
9.
si rammarica della mancanza di chiarezza del pacchetto "clima ed
energia" della Commissione rispetto all'obiettivo delle riduzioni delle
emissioni di GHG per il 2020; sottolinea che è necessaria una riduzione
complessiva del 30% per tutti i paesi industrializzati per poter avere una
possibilità ragionevole di raggiungere l'obiettivo UE di limitare
l'aumento della temperatura media a non più di 2° centigradi;
10.
insiste sul fatto che l'UE deve basare tutte le politiche e le misure
interne sull'obiettivo di riduzione del 30% entro il 2020, rispetto ai livelli
del 1990;
11.
sottolinea che al fine di raggiungere un accordo a livello
internazionale in merito ad una riduzione del 30% delle emissioni di GHG in
tutti i paesi industrializzati, l'Unione europea deve concentrarsi non solo
sulla politica ambientale ma anche sulla politica estera e degli scambi
internazionali nonché sulla possibilità di modificare la
richiesta di energia e delle altre risorse naturali; questo quadro più
ampio pertanto deve essere parte della discussione sulla strategia per giungere
all'obiettivo summenzionato;
12.
ritiene che gli Stati membri economicamente sviluppati abbiano esportato
gran parte delle proprie attività e tecnologie che consumano energie e
risorse naturali verso paesi meno sviluppati, nei quali la stessa
attività probabilmente produce emissioni di GHG più elevate;
sollecita pertanto la
Commissione e gli Stati membri a definire politiche per
impedire dette pratiche;
13.
insiste sulla specifica responsabilità dei paesi industrializzati
nell'affrontare a livello mondiale i cambiamenti climatici; invita pertanto le
Parti dell'Allegato I dell'UNFCCC a osservare i propri impegni attuali e a
prevedere obiettivi ambiziosi per un secondo periodo di impegni dopo il 2012;
invita inoltre i paesi industrializzati che non abbiano ratificato il
Protocollo di Kyoto a riconsiderare la propria posizione, a prendere energiche
misure interne e a svolgere un ruolo attivo nei futuri negoziati internazionali
in modo da partecipare al futuro regime sui cambiamenti climatici;
14.
invita la
Commissione e gli Stati membri a esaminare la
possibilità di adottare misure di aggiustamento frontaliero sugli scambi
in modo da neutralizzare eventuali vantaggi competitivi che possano affluire ai
produttori dei paesi industrializzati sui quali non gravano vincoli per le
emissioni di carbonio;
15.
ribadisce la sua proposta di riesaminare il sistema di scambio delle
quote di emissione (ETS) al fine di armonizzare il metodo di assegnazione
basato su un sistema di aggiudicazione all'asta e di valori di riferimento;
propone di ridurre l'assegnazione gratuita di certificati di emissione e
suggerisce agli Stati membri di restituire ai cittadini e alle imprese
interessate le somme derivanti ad esempio delle aste;
16.
concorda con la
Commissione che i paesi che non figurano all'Allegato I
dell'UNFCCC devono essere maggiormente coinvolti nel processo in parola, ma
sottolinea che i paesi in via di sviluppo non possono essere considerati come
un blocco unico e che le attività intraprese da o all'interno dei paesi
in via di sviluppo devono essere differenziate sulla base delle loro specifiche
situazioni nazionali; sottolinea inoltre che tra questi paesi quelli meno
sviluppati non dovrebbero essere obbligati a prendere impegni;
17.
invita la
Commissione e gli Stati membri, al fine di garantire una
situazione internazionale neutrale, a esaminare la proposta di obiettivi settoriali
per industrie di esportazione ad alta intensità di energia nei paesi non
gravati da impegni vincolanti per la riduzione delle emissioni, per integrare
gli obiettivi vincolanti per le emissioni dei paesi industrializzati;
18.
sottolinea che la politica energetica rappresenta un elemento cruciale
della strategia globale UE sui cambiamenti climatici e che la diversificazione
delle risorse energetiche rinnovabili e un passaggio alle tecnologie più
efficienti in termini energetici, prive o a bassa emissione di carbonio hanno
un grande potenziale nel quadro delle riduzioni delle emissioni, garantendo al
tempo stesso una minore dipendenza energetica da fonti esterne;
19.
è convinto che l'attuale inefficienza di molte centrali
elettriche contribuisca ad aggravare notevolmente il problema del riscaldamento
globale, ed invita la
Commissione a presentare proposte volte ad obbligare tutti
gli Stati membri a garantire che l'energia rilasciata quale sottoprodotto della
generazione di elettricità sia sfruttata mediante la tecnologia della
cogenerazione di elettricità e calore;
20.
ritiene che esista un ampio potenziale di riduzione delle emissioni nel
settore dell'efficienza energetica; invita la Commissione e gli
Stati membri a prendere misure e a fissare obiettivi ambiziosi in questo
settore esplorando la possibilità di superare l'obiettivo di riduzione
del 20% proposto dalla Commissione;
21.
ritiene che con sistemi nazionali bene equilibrati di imposizione e
prelievi fiscali si possa aumentare l'efficienza energetica negli Stati membri
impedendo un inutile consumo di energia;
22.
invita inoltre la
Commissione e gli Stati membri a esaminare la
possibilità di istituire un sistema d'imposizione a livello UE volto a
promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio, incentivando al riguardo
le tecnologie e i processi produttivi migliori a disposizione e favorendo
modelli di consumo più sostenibili;
23.
invita gli Stati membri ad adempiere ai propri impegni prendendo le
misure adeguate a garantire la veloce attuazione della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sull'efficienza
energetica degli edifici(3) , entrata in vigore il 4 gennaio 2003, i cui
risparmi a livello dei costi nel settore dell'edilizia sono stimati intorno al
22%; invita pertanto la
Commissione ad avviare le procedure contro gli Stati membri
che ancora non abbiano preso le necessarie misure di attuazione della direttiva
2002/91/CE;
24.
sottolinea che nel settore dei trasporti si sta registrando il più
elevato aumento dei consumi energetici e che il trasporto su strada
contribuisce per circa il 25% alle emissioni comunitarie di CO2; pertanto
chiede lo sviluppo dei trasporti pubblici e misure vincolanti per il settore
dei trasporti, incluso il settore dell'aviazione, affinché consegnua
entro il 2020 riduzioni delle emissioni equivalenti a quelle degli altri
settori, più integrati ed ecologici che rispettino l'ambiente e le
risorse naturali;
25.
sottolinea l'urgente necessità di ridurre le emissioni di CO2
prodotte dalle autovetture e insiste pertanto affinché la Commissione imponga un
obiettivo vincolante di 120
grammi per chilometro (gpk) entro il 2012 per le
autovetture nuove commercializzate nell'Unione europea;
26.
ribadisce che le emissioni del settore dell'aviazione e marittimo
dovrebbero essere incluse negli impegni internazionali di riduzione dei gas ad
effetto serra per il periodo post-2012 e chiede un nuovo impegno per
l'introduzione di imposte sul cherosene a livello dell'Unione europea e
mondiale;
27.
prende atto della proposta di stabilire un obiettivo vincolante di
aumento del livello dell'energia rinnovabile nel mix energetico UE al 20% entro
il 2020, e la considera un buon punto di partenza;
28.
prende atto dell'assenza di obiettivi vincolanti settoriali per le
energie rinnovabili; mette in rilievo che questi porterebbero ad un'effettiva
riduzione delle emissioni di GHG al fine di affrontare i cambiamenti climatici;
sollecita la Commissione
a proporre che gli Stati membri, oltre ad un obiettivo generale, presentino
obiettivi specifici settoriali per l'energia rinnovabile, in particolare per la
produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, tenendo conto
delle loro diverse situazioni, come proposto nella valutazione d'impatto della
Roadmap per l'energia rinnovabile (COM(2006)0848);
29.
ribadisce che le attività di riscaldamento e di raffreddamento
basate sull'energia rinnovabile offrono un ampio potenziale per la riduzione di
CO2 e della dipendenza dai combustibili fossili; si rammarica che la Commissione non abbia
presentato una proposta di direttiva a sostegno del riscaldamento e del
raffreddamento basato sull'energia rinnovabile come era stato promesso al
Parlamento europeo, ma nota che la Commissione sta ancora programmando misure
legislative in questo settore;
30.
ribadisce con forza le sue raccomandazioni sullo sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili ai fini di riscaldamento e raffreddamento contenute
nella sua risoluzione del 14 febbraio 2006(4) ;
31.
prende atto della proposta della Commissione di un obiettivo minimo
vincolante per i biocarburanti pari al 10% dei carburanti per autovetture nel
2020; ritiene che sarebbe realistico e auspicabile anche un obiettivo del
12,5%; sottolinea l'importanza della produzione sostenibile dei biocarburanti;
invita la Commissione
a introdurre un sistema di certificazione e delle norme (ad esempio una
legislazione tecnica) che consentano la produzione sostenibile di biocarburanti
e che si applichino sia ai biocarburanti prodotti nell'UE che a quelli
importati;
32.
prende atto che la
Commissione riconosce l'importanza a medio termine del ruolo
dei combustibili fossili e la possibilità di intraprendere ulteriori
studi per ridurre la loro intensità di carbonio in linea con l'obiettivo
dei 2°C
per la riduzione del CO2; ritiene che tali sviluppi debbano comprendere il
continuo ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza di tali
combustibili, lo sviluppo di una nuova generazione di impianti, l'ulteriore
sviluppo di un metodo efficiente ed economico per la cattura del carbonio e il
suo stoccaggio in relazione a carbone, gas e petrolio, in accordo con le
decisioni assunte dalla Piattaforma tecnologica europea per delle centrali elettriche
a combustibili fossili a emissioni zero (ZEP, Zero Emission Fossil Fuel Power
Plant), e l'eliminazione delle barriere create dalla legislazione dell'UE;
riconosce il ruolo delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio
nella riduzione delle emissioni di gas serra;
33.
sostiene la proposta di un partenariato energetico con l'Africa;
tuttavia, raccomanda vivamente di istituire un partenariato simile anche con la Cina e con l'India, tenendo
conto della rapidissima crescita delle emissioni di GHG in questi due paesi e
dell'urgente necessità di aiutarli a costruire la loro capacità
nonché i loro investimenti in tecnologie efficienti da un punto di vista
energetico e prive o a basso contenuto di carbonio (con particolare attenzione
alle energie rinnovabili), ribadendo comunque che l'UE coopera con le regioni
interessate per far cessare la deforestazione dei Tropici e per incoraggiare
invece i lavori di riforestazione e rimboschimento; propone, inoltre, di
rafforzare la cooperazione energetica con la Russia, l'Ucraina, i paesi del Nordafrica e della
regione del Mar Caspio;
34.
ritiene che importanti iniziative volte a ridurre le emissioni possano
andare di pari passo con lo sviluppo economico ed anzi rappresentino un
requisito di base per lo sviluppo economico sostenibile nei prossimi decenni;
ribadisce che le tecnologie ambientali possono dare all'Unione europea un
maggiore grado di competitività contribuendo enormemente alla riduzione
delle emissioni; nota pertanto che le tecnologie ambientali sono centrali ad
una strategia di sviluppo sostenibile, compatibile con gli impegni UE di Kyoto
e con la Strategia
di Lisbona;
35.
sottolinea i costi economici, sociali e sanitari di un'assenza di
iniziative, dimostrati fra l'altro dallo Studio STERN sulle conseguenze
economiche dei cambiamenti climatici; ricorda che la mancanza di iniziative
causerebbe un danno corrispondente al 5-20% del PNL globale annuo, mentre il
costo di una seria politica climatica e di investimenti nelle tecnologie pulite
è valutato a circa lo 0,5-1% del PNL globale annuo fino al 2050, senza
tenere conto dei benefici accessori in termini di ambiente e di salute;
riconosce che temporeggiare aumenterebbe il rischio di effetti ambientali
negativi e i costi necessari per mitigarne gli effetti;
36.
riconosce che il cambiamento climatico sta causando gravi problemi
ambientali che richiedono un'azione immediata a livello di UE e a livello
internazionale; ritiene che entro il 2050 la stragrande maggioranza del
fabbisogno energetico dell'UE dovrà essere coperta da fonti prive di
carbonio o con tecnologie prive di emissioni di gas serra, concentrando gli
sforzi sul risparmio energetico, l'efficienza e le energie rinnovabili, e che
vi sia pertanto la necessità di fissare una chiara tabella di marcia per
la realizzazione di tale obiettivo; invita la Commissione a fissare
obiettivi ambiziosi ma realistici per fare in modo che entro il 2020 il 60%
della domanda di elettricità nell'UE sia soddisfatto da tecnologie
energetiche ad emissioni di CO2 bassissime o nulle o CO2 neutre, a sostegno
degli obiettivi europei in materia di clima e di sicurezza
dell'approvvigionamento;
37.
ritiene che vada promossa la ricerca in questo campo e che dovrebbero
essere adottati chiari obiettivi ambientali per incoraggiare lo sviluppo e
l'uso di un maggiore numero di tecnologie dolci che rispettino l'ambiente;
38.
ritiene che la riduzione delle emissioni globali non debba portare ad
altre minacce quale quella di proliferazione nucleare o di terrorismo; pertanto
ritiene che il nucleare debba rimanere escluso dal meccanismo per lo sviluppo
pulito/attuazione congiunta o da altri meccanismi volti a compensare le
riduzioni di emissioni nei paesi in via di sviluppo;
39.
incoraggia un coinvolgimento molto più ampio nelle iniziative
volte a mitigare i cambiamenti climatici a livello dei cittadini europei;
chiede pertanto alla Commissione di intensificare le sue attività di
sensibilizzazione in merito all'urgenza della situazione allo scopo di
informare i singoli sul loro ruolo nel controllare i cambimenti climatici;
40.
invita ancora l'Unione europea e i suoi Stati membri ad adottare
un'ambiziosa politica di partenariato tecnologico e di trasferimenti di
tecnologie pulite nei confronti dei paesi in via di sviluppo, aiutandoli a
sviluppare la propria economia e ad aumentare il proprio benessere in un modo
più sostenibile;
41.
chiede alla Commissione di valutare le ripercussioni dei cambiamenti
climatici sull'aumento della temperatura a terra, sulla riduzione delle piogge,
sullo stato delle falde freatiche; ritiene specialmente importante studiare gli
effetti della riduzione delle superfici coltivabili quali fonti di biomassa e
di falde di carbonio; sottolinea l'importanza di talune pratiche di gestione
agricola;
42.
chiede che tutte le sue
commissioni e delegazioni competenti cooperino strettamente sui cambiamenti
climatici in modo che la sua politica industriale, energetica, dei trasporti,
dell'agricoltura, della ricerca e sviluppo e altre iniziative siano maggiormente
coordinate in vista degli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici ed in
modo che questo tema sia regolarmente sollevato a livello delle delegazioni
interparlamentari nel contesto del dialogo legislativo transatlantico;
43.
invita le tre presidenze (Germania, Portogallo e Slovenia) a far
sì che si acceleri l'interesse per i cambiamenti climatici e si aumenti
il livello dell'impegno politico e il numero di partner internazionali
nell'ambito del processo a livello mondiale;
44.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al
Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al
Segretariato dell'UNFCC, con la richiesta che sia fatta circolare a tutte le
parti contraenti che non sono membri dell'UE.
(1) GU C 280 del 18.11.2006, pag. 120.
(2) Testi adottati, P6_TA (2006)0460.
(3) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
(4) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 115.
|
Testi
approvati dal Parlamento
|
|
Martedì 22 mag
2007 - Strasburgo
|
Edizione provvisoria
|
Parlamento Europeo Dichiarazione
sull’Economia verde all'idrogeno in Europa P6_TA-PROV(2007)0197
|
 Dichiarazione
del Parlamento europeo sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e
una terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le
regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società
civile interessate Dichiarazione
del Parlamento europeo sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e
una terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le
regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società
civile interessate
|
|
Il Parlamento europeo ,
– visto l'articolo 116 del
suo regolamento,
A. considerando che il
riscaldamento globale e i costi dei combustibili fossili continuano ad
aumentare e tenendo conto del dibattito avviato dal Parlamento europeo e
dalla Commissione sul futuro della politica energetica e sul cambiamento
climatico,
B. considerando che una visione
post-energia fossile e post-energia nucleare dovrebbe costituire il prossimo
progetto importante dell'Unione europea,
C. considerando che i 5 fattori
chiave per l'indipendenza energetica sono: la massimizzazione dell'efficienza
energetica, la riduzione delle emissioni di gas che comportano un
riscaldamento globale, l'ottimizzazione dell'introduzione su scala
commerciale di energie rinnovabili, la messa a punto di una tecnologia delle
celle a combustibile a idrogeno per immagazzinare energie rinnovabili e la
creazione di griglie di energia intelligente per distribuire l'energia
stessa,
1. invita le istituzioni dell'UE:
- a perseguire
entro il 2020 un incremento del 20% dell'efficienza energetica,
- a ridurre del 30%
(rispetto ai livelli del 1990) entro il 2020 i gas a effetto serra,
- a produrre
entro il 2020 il 33% dell'elettricità e il 25% dell'energia globale
ricorrendo a fonti di energia rinnovabile,
- a sviluppare
una tecnologia di immagazzinaggio delle celle a combustibile a idrogeno, e
altre tecnologie di immagazzinaggio, per usi portatili, impianti permanenti e
fini di trasporto e a mettere a punto entro il 2025 in tutti i paesi
membri dell'UE un'infrastruttura a idrogeno decentralizzata, secondo un
approccio dal basso verso l'alto,
- a rendere entro
il 2025 le griglie di energia intelligenti ed indipendenti in modo che le
regioni, le città, le PMI e i cittadini possano produrre e condividere
l'energia con lo stesso accesso aperto che esiste attualmente per quanto
concerne internet;
2. incarica il suo Presidente di
trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei
firmatari, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Elenco dei firmatari
Adamou,
Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andria, Angelilli, Antoniozzi,
Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attwooll, Aubert, Auken, Badía i
Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli,
Becsey, Beer, Beglitis, Belohorská, Bennahmias, Beňová,
Berend, van den Berg, Berlinguer, Berman, Birutis, Bliznashki, Bösch,
Bonde, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Braghetto,
Brepoels, Breyer, Brie, van Buitenen,Buitenweg, Bullmann, Busk, Busquin,
Buzek, Capoulas Santos, Cappato,Carlotti, Carnero González, Casaca,
Cashman, Casini,Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Chatzimarkakis,
Chervenyakov,Chiesa, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei,Claeys,
Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny,
Cramer, Creţu C., Creţu G., Crowley, Daul, Davies, de Brún,
Degutis, De Keyser, Demetriou,De Michelis, Deprez, De Rossa, Désir,
Deva, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover,
Doyle, Drčar Murko, Duff, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves,
Estrela, Ettl, Evans Jillian, Evans Robert, Färm, Falbr, Fatuzzo, Fava,
Fazakas, Fernandes, Ferreira A., Ferreira E., Flasarová, Flautre,
Florenz, Foglietta, Ford, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gargani,
Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault,
Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi,Grabowska, Graefe zu Baringdorf,
Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Gruber, Guardans
Cambó, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon,
Handzlik, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis,
Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert,
Herczog, Holm, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld,
Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jensen,
Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer,
Juknevičienė, Kacin, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kelam, Kelemen,
Kinnock, Kirilov, Koch-Mehrin, Kónya-Hamar,
Kósáné Kovács, Koterec, Kratsa-Tsagaropoulou,
Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher,
Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax,
Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lewandowski,
Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Locatelli,
López-Istúriz White, Losco,Lucas, Lyubcheva,Maaten, McAvan,
McCarthy, Madeira, Manders, Maňka, Mann E., Mantovani, Marinescu,
Markov, Marques, Martin D., Martin H.-P., Martínez Martínez,
Masip Hidalgo, Maštálka, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Meijer,
Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu,
Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mohácsi, Moraes, Moreno
Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mulder, Musacchio, Muscardini,
Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Navarro, Newton-Dunn,
Neyts-Uyttebroeck, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto,
Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó'Neachtain, Onesta,
Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis,
Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov,
Papastamkos, Parish, Parvanova, Pflüger, Piecyk, Pinior, Pirilli,
Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poettering,
Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Prets, Prodi, Ransdorf, Rasmussen,
Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard,
Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure,
Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras,
Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi,
Sbarbati, Schapira, Scheele, Schlyter, Schmidt F., Schöpflin,
Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Severin,
Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner,
Søndergaard, Sofianski, Sonik, Sornosa Martínez, Staes,
Stănescu, Staniszewska, Šťastný, Sterckx, Stockmann,
Strož, Susta, Svensson, Swoboda, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi,
Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ticău, Titley,
Toia, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes,
Tzampazi, Uca, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Varvitsiotis, Veraldi, Vergnaud,
Vernola, Vincenzi, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Weisgerber, Westlund,
Wiersma, Wijkman, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zappala',
Ždanoka, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka
|
|
Ultimo aggiornamento: 24 mag 2007
|
Gli ulteriori incrementi
della quota minima d'obbligo per il triennio 2007-2009 e 2010-2012 saranno
stabiliti con decreti ministeriali.
[50] La gravità delle conseguenze dei cambiamenti
climatici è riaffermata nella relazione tecnica presentata dal Gruppo di
lavoro II dell’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) il 6 aprile 2007,
dal titolo “Climate change Impacts, Adaptation and Vulnerability”.
[51] Il Consiglio ambiente del 20 febbraio 2007 ha adottato conclusioni
sul tema “Obiettivi dell’UE per l’ulteriore sviluppo del
regime climatico internazionale oltre il 2012”, in cui ribadisce l’impegno
fermo ed indipendente dell’Unione europea nella riduzione
dell’emissioni di gas ad
effetto serra, da attuare attraverso politiche comunitarie e ripartizione
concordata degli oneri, e riafferma
il ruolo guida dell’UE nella ricerca di un accordo globale sui
cambiamenti climatici.