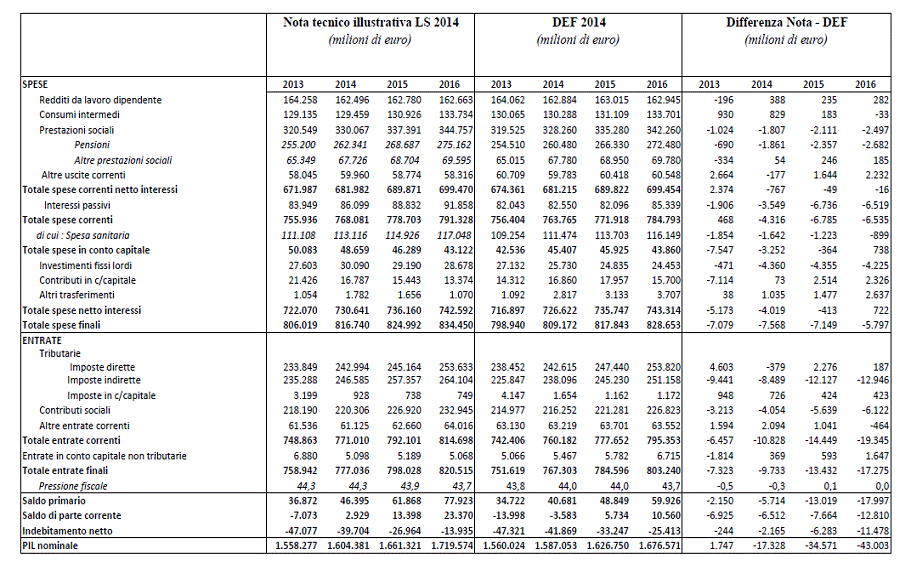Premessa
Ai sensi della legge di contabilità, il
Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di
programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una
prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento
delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse
politiche pubbliche, adottati dall’Italia per il rispetto del Patto di
Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita
intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020.
Il DEF enuncia, pertanto, le modalità e la tempistica attraverso le quali
l’Italia intende conseguire il risanamento strutturale dei conti pubblici e
perseguire gli obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione,
integrazione sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell’ambito
dell’Unione europea.
Il documento, che s’inquadra al centro del
processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati
membri dell’UE - il Semestre europeo – è presentato alle Camere, per le
conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di
esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile
per l’invio al Consiglio dell'Unione
europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile,
del Programma di Stabilità e del
Programma Nazionale di Riforma (PNR) contenuti,
rispettivamente, nella prima e nella terza sezione del Documento.
Quanto alla struttura, il DEF si compone di
tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione
espone lo schema del Programma di Stabilità, che dovrà contenere tutti
gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e,
in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di
stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica
economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.
La sezione contiene gli obiettivi e il quadro delle previsioni
economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo;
l’indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto,
per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosettori
della PA, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. La sezione
deve, inoltre, contenere le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità, nonché
le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito
rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del
prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo
primario.
Nella seconda sezione sono indicate
le regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni
pubbliche, in linea con l’esigenza, evidenziata in sede europea, di
individuare forme efficaci di controllo dell’andamento della spesa pubblica.
La sezione reca, tra l’altro, l'analisi del conto economico e
del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno
precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento; le previsioni
tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei
flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa;
l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, di regole
generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;
l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali
aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio successivo;
le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei
conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli
relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul
debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. All’interno
della sezione deve inoltre essere dato conto anche delle risorse destinate
allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali
addizionali. In allegato alla sezione è riportata una nota metodologica
che espone analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni
tendenziali.
Si
evidenzia, infine, che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della
legge n. 244 del 2012 (delega al Governo per la revisione dello strumento
militare nazionale e norme sulla medesima materia), alla II Sezione del DEF
devono altresì essere riportate, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti
nell'attuazione del processo di
riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del
recupero delle risorse realizzato delle misure di ottimizzazione organizzativa
e finanziaria previste dalla legge citata, e sulle previsioni di reindirizzo
delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del
Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo
La terza sezione reca, infine, lo
schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il
Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il
raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione
e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia “Europa 2020”. In tale ambito
sono indicati:
§ lo
stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione
dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
§ gli
squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica
che incidono sulla competitività;
§ le
priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi
previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi
programmatici indicati nel Programma di stabilità;
§ i
prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita
dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di
aumento dell'occupazione.
In allegato al DEF sono indicati gli
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,
da presentarsi alle Camere entro il mese di gennaio.
In base alla legge di contabilità nazionale,
in allegato al DEF devono essere riportate una serie d’informazioni
supplementari:
a)
una relazione di sintesi sugli interventi
realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, in cui è
evidenziato il contributo dei fondi nazionali addizionali, con particolare
riguardo alla coesione sociale, alla sostenibilità ambientale, nonché alla
ripartizione territoriale degli interventi;
b)
il Programma delle infrastrutture
strategiche, previsto dalla “Legge obiettivo”, nonché lo stato di
avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c)
un documento, predisposto dal Ministro
dell'ambiente, relativo allo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra derivanti dagli obblighi
internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi;
d)
un documento recante l’esposizione, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse del
bilancio dello Stato destinate alle singole regioni, con separata evidenza
delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto
capitale agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
e)
il rapporto sullo stato di attuazione della
legge di contabilità e finanza pubblica e sullo stato di attuazione delle
norme finalizzate all’armonizzazione delle regole contabili degli enti
territoriali, prevista dalla legge di attuazione del federalismo fiscale.
1. Il quadro
macroeconomico
1.1 La congiuntura internazionale
Il DEF 2014, nella prima sezione relativa al
Programma di Stabilità,
evidenza come nel 2013 il ritmo di crescita
dell'economia mondiale abbia registrato un leggero rallentamento rispetto
al 2012, attestandosi, secondo i dati forniti dal Fondo monetario
Internazionale (nel Word Economic
Outlook, di aprile 2014), ad un
tasso del 3,0 per cento, come evidenziato nella tabella che segue:
Tabella
1.1
Il
recupero del commercio mondiale
(variazioni percentuali)
|
FMI
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Commercio internazionale
|
2,8
|
3,0
|
4,3
|
5,3
|
5,6
|
5,7
|
5,6
|
|
PIL mondiale
|
3,2
|
3,0
|
3,6
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
Fonte: FMI, World Economic
Outlook, aprile 2014, Database.
In particolare, il DEF 2014 osserva che la
crescita globale nel 2013 è risalita
soprattutto nella seconda metà dell’anno: le economie avanzate hanno inciso per gran parte della ripresa, mentre
l’andamento della crescita, comunque sempre sostenuta nei mercati emergenti, risulta rallentata
rispetto ai ritmi di qualche anno fa.
Tra le economie avanzate, un importante
impulso è venuto dai paesi extra UE, in particolare dagli Stati Uniti, la cui economia è cresciuta su base annua più del
previsto, dell’1,9 per cento con un’ulteriore contrazione del tasso di
disoccupazione (al 7,4 per cento). Anche in Giappone il PIL è cresciuto nel 2013 dell’1,5 percento, sebbene –
si afferma nel DEF - non si sia ancora certi, nonostante il piano governativo e
gli indirizzi assunti dalla Banca giapponese, dell’uscita del paese dalla fase
deflazionistica.
La Cina
è cresciuta nel 2013 del 7,7 per
cento e l’India del 4,4 per cento.
I paesi emergenti continuano, dunque, nel
complesso ad avere tassi di crescita superiori a quelli dei paesi avanzati, ma
significativamente inferiori a quelli di qualche anno fa.
Le
osservazioni di fondo contenute nel documento governativo ricalcano, in
sostanza, le considerazioni contenute nel WEO
di aprile 2014 dell’FMI. Sulle economie emergenti - la cui evoluzione
dell’attività economica è stata, come detto, inferiore rispetto al passato – il
Fondo monetario rileva comunque che esse continuano in ogni caso a contribuire
per più di due terzi alla crescita globale. Peraltro, in proiezione, la
crescita del prodotto di tali economie dovrebbe essere aumentata dalle maggiori
esportazioni verso le economie avanzate. Nell’attuale quadro, i rischi al
ribasso delle prospettive di crescita globale, che pure sono state prospettate
nei precedenti rapporti dell’FMI, tendono a diminuire, con tre caveat: un eventuale rafforzarsi dei
rischi provenienti dai mercati emergenti, l’inflazione più bassa di quanto
atteso nei paesi emergenti, il riemergere di rischi di tipo geopolitico.
Analoghe considerazioni sul quadro macroeconomico
internazionale sono state avanzate dalla BCE,
nel Bollettino mensile di marzo 2014. Anche secondo la Banca centrale, a
livello congiunturale, la moderata espansione dell’attività economica mondiale
che si è manifestata sul finire del 2013 è stata caratterizzata da un’accelerazione
proveniente in gran parte dei paesi avanzati, grazie al miglioramento dei
bilanci del settore privato e all’orientamento accomodante delle politiche
economico finanziarie, e da un ritmo rallentato nei principali paesi emergenti,
determinato dai perduranti ostacoli di natura strutturale, dalle incertezze sul
piano delle politiche e di condizioni finanziarie volatili che hanno riguardato
specificamente i paesi con vulnerabilità interne.
La BCE, in
particolare, mette in evidenza le stime per il quarto trimestre del 2013: nei paesi del G20 il tasso di incremento
del PIL è stato pari allo 0,8 per cento sul periodo precedente,
significativamente inferiore rispetto al terzo trimestre. Tale dato cela
andamenti differenziati relativi agli specifici paesi. In particolare, negli Stati Uniti la crescita del PIL in
termini reali si è mantenuta robusta nel quarto trimestre del 2013 grazie al
vigore dei consumi privati, degli investimenti in settori diversi dall’edilizia
residenziale e delle esportazioni. In Giappone
il ritmo di espansione è stato rapido nella prima metà del 2013 e più lento
nella seconda, principalmente a causa della debolezza delle esportazioni e
degli investimenti delle imprese. Ci si attende tuttavia un lieve rafforzamento
nel primo trimestre del 2014, favorito dalla dinamica più robusta dei consumi
privati in previsione dell’aumento dell’imposta sui consumi.
Per contro,
in una serie di economie di mercato
emergenti, le recenti turbolenze nei relativi mercati finanziari hanno
lievemente acuito le incertezze circa le prospettive per l’economia mondiale,
ma le tensioni sono state principalmente circoscritte ai paesi con fondamentali
deboli e squilibri interni.
Tabella
1.2
Andamento
congiunturale del PIL 2013
in termini reali
(valori percentuali)
|
|
II trim.
|
III trim.
|
IV trim.
|
|
G20
|
0,8
|
1,2
|
0,8
|
|
Stati Uniti
|
0,6
|
1,0
|
0,6
|
|
Giappone
|
1,0
|
0,3
|
0,3
|
|
Area Euro
|
0,3
|
0,1
|
0,3
|
|
Brasile
|
1,8
|
-0,5
|
0,7
|
|
Cina
|
1,8
|
2,2
|
1,8
|
|
India
|
-0,2
|
5,8
|
0,1
|
|
Russia
|
-0,1
|
0,2
|
-
|
Fonte:
BCE, Monthly Bullettin, Marzo 2014. Per l’Area Euro, dati EUROSTAT.
Anche l’OCSE, nell’Interim economic assessment di marzo
2014 evidenzia, avendo riguardo agli ultimi dati congiunturali, nel
complesso, un rafforzamento di fondo del ritmo di crescita nelle principali
economie avanzate, aiutate dalla politica monetaria accomodante e dal ridotto
drenaggio fiscale. Vi sono, tuttavia, profili irregolari per la crescita del
PIL a breve termine. Mentre negli Stati Uniti la ripresa ciclica – afferma
l’Istituto - è relativamente ben stabilita, nell’Area dell'euro e in Giappone,
dove la ripresa si è meno netta e l'inflazione rimane sotto il target, gli stimoli di politica
monetaria dovrebbero essere mantenuti o addirittura aumentati. In tali aree è
inoltre necessario che continui l’azione di consolidamento fiscale, sebbene
l’OCSE, visti i progressi già compiuti in molti paesi, prospetti che il ritmo
del risanamento può essere portato avanti più lentamente rispetto al passato,
in modo da evitare un eccessivo freno alla crescita.
Per quanto concerne le principali economie emergenti
(EME), il quadro è variegato, secondo l’OCSE, con alcuni paesi che continuano a
crescere fortemente mentre altri, dove le vulnerabilità sottostanti sono stati
evidenziate da inversioni di afflussi di capitale, stanno vivendo una marcata perdita
di slancio. Dato che le economie emergenti rappresentano comunque, come
sottolineato anche dall’FMI, ben più della metà dell'economia mondiale, la performance economica delle principali
economie emergenti potrebbe comportare – secondo l’OCSE - che la crescita
globale resti moderata nel breve periodo.
Date le considerazioni sopra esposte, le prospettive di crescita dell’economia
mondiale per il 2014 si inseriscono in uno scenario di ripresa in cui un
maggiore contributo proviene, come detto, dalle economie sviluppate, rafforzate
della domanda interna, e in un contesto di ridotte tensioni sui mercati
finanziari.
Secondo le previsioni elaborate dal Fondo
Monetario Internazionale nell’Economic
Outlook di aprile, si prospetta una crescita
dell’economia globale nel 2014 del 3,6 per cento ed un’espansione del commercio mondiale del 4,3
per cento. In particolare, negli Stati
Uniti è prevista una crescita del 2,8 per cento e il Giappone dovrebbe crescere dell’1,4 per cento.
Per quanto riguarda l’Area dell’euro, il DEF 2014 evidenzia come l’evoluzione positiva
dell’economia nella seconda parte dell’anno non sia stata sufficiente ad
impedire una contrazione del PIL nel
2013, pari - secondo quanto indicato dalla Commissione europea a febbraio
2014 (nel Winter Forecast) - allo 0,4 per cento su base annuale e un incremento del tasso di disoccupazione all’12,1 per cento.
Il Governo osserva che le cause di tale
andamento del PIL nell’Area euro vanno riscontrate nella debolezza della
domanda interna, che ha risentito delle politiche
fiscali restrittive, e nella difficoltà di aumentare l’offerta di credito alle imprese nonostante la
politica monetaria espansiva adottata dalla BCE, difficoltà questa che ha reso
più difficile la ripresa economica e il rapido riassorbimento del livello di
disoccupazione. Ne è conseguito un aumento della disoccupazione di lungo
periodo.
Inoltre, poiché il livello di indebitamento
nell’Area resta elevato, ciò potrebbe richiedere l’adozione di ulteriori
politiche fiscali restrittive, con possibili conseguenze sulla crescita appena
avviata. Inoltre, i rischi di un processo deflazionistico, dovuto ad un livello
di inflazione sensibilmente inferiore al 2,0 per cento, possono incidere
negativamente sulle decisioni d’investimento.
La
Commissione europea, nel Winter Forecast
di febbraio 2014, osserva che dopo un primo trimestre negativo, si è assistito,
nell’Area dell’euro, all’uscita dalla
recessione nella primavera 2013 e nei tre trimestri successivi. Si
evidenzia al riguardo che la ripresa si è comunque dimostrata modesta a livello
complessivo e non omogenea.
Tabella
1.3
Andamento
congiunturale del PIL 2013
in termini reali nell’Area dell’euro
(valori
percentuali)
|
|
I trim.
|
II trim.
|
III trim.
|
IV trim.
|
|
Italia
|
-0,6
|
-0,3
|
0,0
|
0,1
|
|
Francia
|
-0,1
|
0,6
|
0,0
|
0,3
|
|
Germania
|
0,0
|
0,7
|
0,3
|
0,4
|
|
Spagna
|
-0,3
|
-0,1
|
0,1
|
0,2
|
|
AREA
EURO
|
-0,2
|
0,3
|
0,1
|
0,3
|
|
Regno
Unito
|
0,4
|
0,7
|
0,8
|
0,7
|
|
UE
– 28
|
-0,1
|
0,4
|
0,3
|
0,4
|
Con riferimento ai risultati congiunturali
relativi all’ultima parte dell’anno 2013, nel Bollettino di marzo 2014, la Banca Centrale Europea osserva che il
risultato positivo del secondo, terzo e
quarto trimestre del PIL in termini reali segna un’inversione di tendenza rispetto al protratto periodo di
decrescita osservato tra il quarto trimestre del 2011 e il primo del 2013. Tale
timida ripresa secondo gli analisti BCE riflette in ampia misura un’inversione
del ciclo della domanda interna, un migliorato clima di fiducia di imprese e
consumatori e un calo dell’incertezza. Il risultato del quarto trimestre del
2013 è inoltre riconducibile alle esportazioni nette, tornate positive,
soprattutto per effetto della debole crescita delle importazioni. Tali
andamenti sono stati in parte controbilanciati dal contributo negativo alla
crescita proveniente dalla variazione delle scorte.
Per il 2014, il DEF, in linea con quanto prospettato
dalla Commissione europea, stima un incremento del PIL nell’Area dell’euro dell’1,2
per cento.
La Commissione europea, in particolare, prospetta nel
2014 che la crescita del PIL in termini reali si attesti in media all'1,5% nell'UE e all'1,2% nella zona euro, per poi accelerare nel 2015 e raggiungere
il 2,0% nell'UE e l'1,8% nella zona euro.
Tabella
1.4
Previsioni
del prodotto interno lordo nell’Area dell’euro
(valori percentuali)
|
|
Cons.
|
Previsioni
|
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
Italia
|
-1,9
|
0,6
|
1,2
|
|
Francia
|
0,3
|
1,0
|
1,7
|
|
Germania
|
0,4
|
1,8
|
2,0
|
|
Spagna
|
-1,2
|
1,0
|
1,7
|
|
AREA EURO
|
-0,4
|
1,2
|
1,8
|
|
Regno Unito
|
1,9
|
2,5
|
2,4
|
|
UE – 28
|
0,1
|
1,5
|
2,0
|
Nel
Bollettino di marzo 2014, la Banca Centrale Europea afferma che gli
andamenti degli indicatori del clima di fiducia basati sulle indagini
congiunturali fino a febbraio sono coerenti con il protrarsi di una crescita
moderata anche nel primo trimestre di quest’anno. In prospettiva, ci si attende
che la ripresa in atto nell’Area euro prosegua, sebbene a un ritmo contenuto.
In particolare, si dovrebbe concretizzare un ulteriore miglioramento della
domanda interna, sostenuto dall’orientamento accomodante della politica
monetaria, da condizioni di finanziamento più favorevoli e dai progressi
conseguiti nel risanamento dei conti pubblici e nelle riforme strutturali.
Inoltre, i redditi reali sono sostenuti dai più bassi prezzi dell’energia.
L’attività economica dovrebbe altresì trarre vantaggio da un graduale rafforzamento
della domanda esterna per le esportazioni dell’area. Al tempo stesso, seppure
in fase di stabilizzazione, la disoccupazione resta elevata nell’area e i
necessari aggiustamenti di bilancio nei settori pubblico e privato
continueranno a pesare sul ritmo della ripresa.
Le
proiezioni macroeconomiche formulate
in marzo dagli esperti della BCE
confermano una crescita del PIL in termini reali per l’area dell’euro dell’1,2
per cento nel 2014, che aumenterebbe all’1,5 nel 2015 e all’1,8 nel 2016.
1.2 Lo scenario
macroeconomico nazionale
Il DEF 2014 espone l’analisi del quadro
macroeconomico italiano relativo all’anno 2013 e le previsioni per l’anno in
corso e per il periodo 2015-2018, che riflettono i primi segnali di graduale
ripresa dell’economia, nonostante gli elementi d’incertezza che ancora
caratterizzano le prospettive di crescita
globali.
I risultati nel 2013
Con riferimento all’anno 2013,
il DEF evidenzia come la recessione, manifestatasi nuovamente nella seconda
metà del 2011 - dopo i moderati segnali di ripresa di inizio anno – si sia
interrotta, in Italia, nell’ultimo trimestre del 2013, in cui il PIL ha
manifestato una inversione di tendenza, dopo nove trimestri consecutivi di
contrazione.
Nel complesso, nel 2013 il PIL
ha registrato una contrazione dell’1,9 per cento, a fronte della
contrazione del 2,4 per cento registrata nel 2012.
La contrazione del prodotto nel 2013 è
risultata sostanzialmente in linea
con le previsioni formulate all’interno del Documento Programmatico di Bilancio (-1,8 per cento), presentato
per la prima volta ad ottobre 2013,
con il quale sono state aggiornate le previsioni macroeconomiche e di finanza
pubblica contenute nella Nota di aggiornamento del DEF, presentata a settembre
2012.
Nonostante il risultato negativo, il DEF 2014
sottolinea che la fase recessiva, che ha interessato l’economia italiana a
partire dalla seconda metà del 2011, si è allentata nella fase finale
dell’anno. Nel quarto trimestre del 2013 si è,
infatti, registrata una inversione di tendenza dell’andamento dell’economia italiana, con una variazione positiva
del PIL dello 0,1 per cento sul
trimestre precedente.
Secondo
quanto rilevato nel Comunicato ISTAT
dell’11 marzo 2014, nel IV trimestre 2013 tutti i principali aggregati della
domanda interna hanno segnato variazioni positive. In particolare, rispetto al
trimestre precedente, fatta eccezione per i consumi finali nazionali che sono
rimasti invariati, gli investimenti fissi lordi sono aumentati dello 0,9 per
cento, le importazioni dello 0,2 per cento e le esportazioni dell’1,2 per
cento. Nell’ambito dei consumi finali, si rileva che la spesa delle famiglie
residenti è diminuita dello 0,1 per cento, mentre quella della PA e delle
Istituzioni Sociali Private (ISP) è aumentata dello 0,2 per cento.
Il recupero dell’attività economica dell’Italia nell’ultimo trimestre
dell’anno è risultato, tuttavia, meno
accentuato di quello verificatasi in media nell’Area dell’euro nello stesso periodo (+0,3 per cento) e, in
particolare, di quello registrato nei principali paesi europei, quali Germania
(+0,4 per cento), Francia (+0,3 per cento), Regno Unito (+0,7 per cento). Negli
Stati Uniti, nel quarto trimestre, il PIL è aumentato in termini congiunturali
dello 0,6%.
In termini tendenziali, tuttavia, nel quarto
trimestre del 2013 il prodotto interno lordo italiano risulta diminuito dello 0,9% nei confronti del
quarto trimestre del 2012, a
fronte di un aumento del 2,8% nel Regno Unito, dell’1,4% in Germania e dello
0,8% in Francia.
Dal
2007, salvo un breve intermezzo, la recessione ha comportato, nel
complesso, una diminuzione del prodotto interno lordo di 9 punti
percentuali rispetto ai livelli raggiunti prima della crisi. In volume, il
PIL si mantiene al di sotto del livello registrato nel 2009.
Tabella
1.5
Andamento
del PIL in volume
(valori concatenati – anno di riferimento
2005 – mld di euro)
|
o
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
PIL
|
1.475,4
|
1.394,3
|
1.418,4
|
1.424,8
|
1.391,0
|
1.365,2
|
|
Variazione %
|
-1,2
|
-5,5
|
1,7
|
0,4
|
-2,4
|
-1,9
|
Sul risultato negativo del 2013 ha inciso, in maniera
rilevante, il debole andamento della
domanda interna, il cui contributo negativo alla variazione del PIL è stato
particolarmente ampio, pari a -2,6 punti percentuali.
Un apporto
positivo è, invece, disceso dalla domanda
estera, seppure in misura più contenuta rispetto al 2012.
In
particolare, la diminuzione della spesa
delle famiglie residenti è stata intensa (-2,6 per cento), risentendo della
compressione del reddito disponibile.
Sul punto il
DEF evidenzia come nel 2013 sulle decisioni di spesa delle famiglie ha inciso
la perdurante debolezza del mercato del lavoro.
I consumi
delle famiglie, in calo dal 2011, hanno pertanto continuato a contrarsi in
tutte le componenti. Le misure di contenimento della spesa hanno comportato,
inoltre, una riduzione reale dei consumi
pubblici, che includono i redditi da lavoro e i consumi intermedi, dello
0,8 per cento.
Per quanto
concerne gli investimenti fissi lordi,
nel 2013, si è verificata nuovamente una flessione del 4,7 per cento, risultata
meno intensa nel comparto degli investimenti in macchinari, attrezzature e
mezzi di trasporto (-2,4 per cento) a seguito della ripresa, manifestatasi
nella seconda parte dell’anno, dell’attività industriale. Il DEF rimarca come
la caduta della produzione industriale si sia progressivamente ridotta
nell’arco dell’anno e nell’ultimo trimestre abbia avuto una variazione positiva
(+0,9 per cento) dopo dieci trimestri di contrazione.
Il settore
delle costruzioni registra, invece,
nel 2013, per il sesto anno consecutivo, un valore negativo, con una
contrazione ancora più accentuata rispetto al 2012, dell’8,7 per cento.
Come già
ricordato, la dinamica delle esportazioni
si è invece mantenuta positiva. Le esportazioni hanno
mostrato un profilo di crescita progressivo nel corso dell’anno supportate dal
favorevole andamento della domanda mondiale.
Il
rallentamento della domanda interna ha invece inciso sull’andamento delle importazioni, che risultano ridotte del 2,8 per cento. Il DEF
evidenzia peraltro che nella seconda parte dell’anno anche le importazioni sono
tornate a crescere, seppur in misura inferiore alle esportazioni, dopo dieci
trimestri di cali consecutivi.
Per quanto
concerne, in particolare, il commercio
con l’estero, il DEF evidenzia che nell’anno 2013 l’interscambio ha
mostrato un rallentamento, nonostante il commercio e la produzione industriale
globali abbiano mostrato un andamento positivo. Nel complesso, il saldo
commerciale è risultato in avanzo per circa 30,4 miliardi (2,2 per cento del
PIL), in miglioramento rispetto a quello registrato lo scorso anno (9,9
miliardi), risultando – illustra il DEF - tra i più elevati dell’Unione
europea. Il contributo al miglioramento del saldo è stato fornito, in particolare,
dai flussi verso l’area extra-europea.
In particolare, le esportazioni sono cresciute soprattutto verso i paesi
dell’area dell’OPEC, il Giappone, la Russia e la Cina. Tra i paesi europei, le
esportazioni sono aumentate solo verso il Regno Unito (1,9 per cento). Le
importazioni, che hanno subito in via generale una riduzione, hanno registrato
un lieve incremento solo dalla Russia e dall’India.
Sul piano
settoriale, il DEF evidenzia che le esportazioni dei prodotti farmaceutici
hanno registrato l’incremento più elevato, seguiti dai prodotti in legno e dai
mezzi di trasporto, dagli altri prodotti manufatti e dagli apparecchi
elettrici. Tale andamento è confermato nella tabella che segue che espone
l’andamento delle esportazioni dell’Italia nei principali settori negli ultimi
tre anni, in termini di valori FOB.
Scambi
dell’Italia per settore. Serie storica 2011-2013
(variazioni percentuali)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Prodotti
dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca
|
3,3
|
0,4
|
2,6
|
|
Prodotti
alimentari, bevande e tabacco
|
10,1
|
6,8
|
5,3
|
|
Prodotti
tessili, abbigliamento, pelli e accessori
|
12,4
|
2,7
|
4,3
|
|
Legno e
prodotti in legno; carta e stampa
|
4,9
|
1,8
|
1,7
|
|
Prodotti
delle altre attività manifatturiere
|
5,8
|
4,6
|
4,4
|
|
Sostanze e
prodotti chimici
|
10,4
|
1,7
|
0,7
|
|
Articoli
farmaceutici, chimico-medicinali e botanici
|
9,6
|
12,6
|
13,8
|
|
Articoli in
gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
|
8,0
|
0,4
|
2,7
|
|
Metalli di
base e prodotti in metallo, esclusi macchine ed impianti
|
23,0
|
5,1
|
-10,5
|
|
Computer,
apparecchi elettronici ed ottici
|
11,5
|
-2,1
|
-3,1
|
|
Apparecchi
elettrici
|
4,8
|
-1,8
|
1,4
|
|
Mezzi di
trasporto
|
5,8
|
-0,6
|
2,4
|
Fonte: Comunicato
ISTAT 18 marzo 2014, Commercio con l’estero. Valori FOB.
Con
riferimento specifico al settore
manifatturiero italiano, il DEF evidenzia, in un apposito focus, riprendendo i dati diffusi
dall’ISTAT nel recente Rapporto sulla Competitività dei settori produttivi
diffuso il 26 febbraio 2014, come la crisi economica del periodo 2010-2013
abbia riverberato i suoi effetti in modo differenziato nei diversi settori della
manifattura italiana (cfr.
Approfondimento n. 1).
Quanto al mercato del lavoro, il DEF rileva come
la recessione abbia avuto riflessi significativi sull’occupazione, la quale,
misurata in ULA (unità di lavoro standard) ha registrato nel 2013 una riduzione
dell’1,9 per cento. Il calo degli occupati ha riguardato in particolare il
settore delle costruzioni (-9,0 per cento, pari a circa 160 mila unità di
lavoro) e quello dei servizi privati (-1,4 per cento, pari a circa 186 mila
unità).
Segnali di
stabilizzazione sono emersi invece nel settore dell’industria in senso stretto
dove si è verificata una riduzione delle ore autorizzate di cassa integrazione
guadagni (CIG) nel corso dell’anno; il ricorso alla CIG è invece aumentato nel
settore dell’edilizia.
Unitamente
alla flessione degli occupati, il tasso
di disoccupazione è salito al 12,2 per cento; in particolare il tasso di
disoccupazione giovanile (15-24 anni) è aumentato al 40 per cento dal 35,3 per
cento del 2012.
Con
riferimento all’evoluzione dei prezzi,
l’indice armonizzato dei prezzi al consumo è aumentato all’1,3 per cento, in
forte decelerazione rispetto al 2012
a seguito del calo dei prezzi dei beni energetici e
delle telecomunicazioni. L’incremento dell’aliquota IVA non ha esplicato
visibilmente i suoi effetti sull’inflazione.
Le prospettive dell’economia italiana
Il
DEF 2014 sottolinea come l’economia italiana sia entrata in una fase di
ripresa, contrassegnata in prospettiva da dinamiche abbastanza favorevoli del
commercio estero e da una graduale stabilizzazione della domanda interna.
Il documento sottolinea come le prospettive di recupero dell’economia
italiana dipendano, sostanzialmente, dall’evoluzione dello scenario economico mondiale, che si prospetta
in graduale ripresa. La progressiva ripresa della domanda internazionale nella seconda metà del 2013, dovrebbe,
secondo il DEF, riflettersi positivamente sulla crescita delle esportazioni
italiane. Al contempo, il Governo prefigura un graduale superamento dei fattori
negativi che hanno condizionato finora l’andamento della domanda interna.
Gli indicatori congiunturali più recenti
evidenziano, secondo il DEF, la prosecuzione della fase ciclica moderatamente
espansiva emersa alla fine del 2013, prospettando un moderato aumento del PIL nel primo trimestre 2014 ed una ripresa più sostenuta nei trimestri successivi.
In particolare, il Governo evidenzia come
nei primi mesi dell’anno sia proseguito l’aumento
della fiducia delle imprese manifatturiere e come segnali positivi
provengono dal settore dei servizi. Anche la produzione industriale sarebbe
attesa in crescita nel primo trimestre.
Si
ricorda, in proposito, che l’ISTAT
ha diffuso, con Comunicato del 10 aprile
scorso, i dati mensili relativi alla produzione
industriale a febbraio 2014. Da tale comunicato risulta che nella media del
trimestre dicembre-febbraio l’indice destagionalizzato ha registrato un lieve
aumento (+0,1%) rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di
calendario, a febbraio 2014, l’indice è aumentato in termini tendenziali dello
0,4%. Nella media dei primi due mesi dell’anno la produzione registra un +0,8%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Per
quanto attiene al clima di fiducia delle
imprese, secondo il Comunicato ISTAT diffuso il 27 marzo 2014, esso cresce nello stesso mese a 89,5
rispetto a 88,2 di febbraio. In particolare, l'andamento dell'indice
complessivo rispecchia un miglioramento della fiducia delle imprese dei servizi
di mercato e, più lievemente, delle
imprese manifatturiere. Risulta invece in diminuzione la fiducia delle
imprese di costruzione e di quelle del commercio al dettaglio.
Anche
l'indice del clima di fiducia dei
consumatori registra un significativo incremento, raggiungendo il valore di
101,7 da 97,7 del mese precedente (Comunicato ISTAT, 26 marzo 2014).
Considerando peraltro l’effetto di
trascinamento lievemente negativo del risultato dell’anno scorso, pari a -0,1
per cento, le stime di crescita del PIL
per il 2014 sono fissate allo 0,8 per cento, al ribasso rispetto alla crescita dell’1,1 per cento prevista ad
ottobre 2013 nel Documento programmatico di bilancio (DPB).
La nuova stima di crescita per l’anno 2014
si allinea, di fatto, alle considerazioni espresse dalla Commissione europea
nel parere reso sul Documento programmatico di bilancio, in cui la Commissione
riteneva la previsione di crescita dell’1,1 per cento piuttosto ottimistica,
evidenziando i rischi al ribasso derivanti da fattori esogeni (quale la più
modesta espansione dei mercati d’esportazione e maggiore apprezzamento del
tasso di cambio) nonché dalla persistente stretta creditizia.
Secondo quanto illustrato nel DEF, infatti,
la revisione al ribasso della crescita è attribuibile, nel breve periodo,
proprio al persistere della restrizione nella concessione del credito
al settore privato.
Nel medio termine, tuttavia, vanno
considerati anche alcuni ritardi di
attuazione che non consentono ancora alle riforme intraprese di incidere in termini di crescita economica.
Sul punto, il DEF evidenzia – nella Sezione
I relativa al Programma di stabilità e con maggior dettaglio nella Sezione III
relativa al PNR - come l’impatto macroeconomico delle riforme avviate nel 2012
e 2013, vada rivisto rispetto alle ipotesi contenuto nel DEF dello scorso anno,
alla luce non solo del ritardo del processo di attuazione delle misure di
intervento ma anche del protrarsi della fase recessiva dell’economia italiana,
che ha attenuato gli effetti espansivi delle riforme medesime.
Tale revisione comporta nel breve termine un
minore incremento del prodotto, rispetto alle precedenti simulazioni, pari
mediamente a 0,3 punti percentuali, mentre nel medio termine (2020) essa si
attesta a 0,6 punti percentuali.
In particolare, l'impatto macroeconomico dell'insieme delle riforme strutturali varate dal Governo nel 2012
viene rivisto al ribasso, rispetto allo scenario di base, traducendosi in un incremento
del PIL pari a 0,7 punti percentuali nel 2015 (con uno
scostamento di 0.9 punti percentuali, rispetto all’incremento di 1,6 punti
prospettato nel precedente DEF) e pari a 2,5
punti nel 2020 (in luogo ai
3,9 punti previsti). Anche l’impatto macroeconomico del complesso delle misure varate nel 2013 è rivisto nel
DEF in esame, ad un valore pari a 0,1
punti percentuali di PIL nel 2015
e a 0,2 punti nel 2020.
Per gli anni successivi, il DEF prevede una
crescita del PIL nel 2015 pari all’1,3 per cento e pari in media dell’1,7 per cento nel triennio successivo.
Tabella
1.6
Confronto
sulle previsioni di crescita del PIL
(variazioni percentuali)
|
|
DPB
ott. 2013
|
Nota agg. DEF 2013
settembre 2013
|
DEF 2014
aprile 2014
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
PIL
|
1,1
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
0,8
|
1,3
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
Si consideri comunque che le prospettive di
crescita dell’economia italiana, non possono prescindere - come si rileva nella
terza sezione del DEF (nella parte del PNR relativa all’analisi approfondita
che la Commissione europea ha deciso di condurre nei confronti dell’Italia per
valutare la persistenza di squilibri
macroeconomici già rilevati nel 2013) - dall’adozione di urgenti azioni di policy (urgent policy
attention), volte a superare i
problemi strutturali che caratterizzano la nostra economica, messi in evidenza
dall’analisi della Commissione europea, tra i quali la perdita di competitività, derivante dal disallineamento tra salari
e produttività, da un elevato cuneo fiscale e dalla prevalenza d’imprese di
piccole dimensioni che non riescono a competere nel mercato globale. A causa
dell’andamento stagnante della produttività, la graduale riduzione della
dinamica salariale non si è tradotta in un miglioramento della competitività di
prezzo.
Anche le inefficienze presenti nella
Pubblica Amministrazione e nel sistema giudiziario vengono individuate quali
elementi di freno alla crescita economica, così come la corruzione e il sommerso.
Particolare enfasi viene data alla scarsa accumulazione di capitale umano.
Inoltre, l’elevato debito pubblico, accompagnato da una bassa crescita e dalla
bassa inflazione, pone rischi finanziari per l’economia Italiana e per tutta
l’area dell’euro. Alle azioni di riforma finalizzate a fronteggiare le predette
problematiche è appunto dedicata la parte del Documento che riguarda il
Programma Nazionale di Riforma.
Si ritiene utile, infine, riportare nella
tabella che segue un confronto tra le previsioni di crescita recate nel DEF e
quelle dei principali istituti di ricerca nazionali e internazionali, che
stimano per l’anno in corso una crescita del PIL tra 0,5–0,7 punti percentuali,
lievemente inferiore rispetto a quella del Governo (con l’eccezione di
Prometeia, che stima una crescita dello 0,8%). Per il 2015, le previsioni
disponibili degli istituti si presentano, in media, anch’esse leggermente
inferiori rispetto a quelle del Governo.
Per quanto concerne specificamente il
confronto con le stime della Commissione europea, nel DEF è espressamente
esplicitato che per il 2014 lo scostamento è riconducibile all’ipotesi,
sottostante le proiezioni del DEF, di un profilo di crescita congiunturale del
PIL lievemente più sostenuto a partire dal secondo trimestre dell’anno.
Previsioni degli istituti
nazionali e internazionali sulla crescita
del PIL italiano
(variazioni percentuali)
|
|
2014
|
2015
|
|
GOVERNO (aprile ’14)
|
0,8
|
1,3
|
|
CER (febbraio ’14)
|
0,6
|
1,3
|
|
PROMETEIA (marzo ’14)
|
0,8
|
1,4
|
|
REF.IRS (aprile ’14)
|
0,6
|
1,4
|
|
CONFINDUSTRIA (dicembre ’13)
|
0,7
|
1,2
|
|
BANCA D’ITALIA (gennaio ’14)
|
0,7
|
1,0
|
|
CONSENSUS FORECASTS (marzo ’14)
|
0,5
|
1,0
|
|
OCSE – Economic Outlook n. 94 (novembre ‘13)
|
0,6
|
1,4
|
|
FMI (aprile
‘14)
|
0,6
|
1,1
|
Si rilevi, infine, che le previsioni di
crescita indicate nel DEF 2014 per il periodo 2014-2018 non considerano gli effetti positivi attesi, sulle principali
variabili del quadro macroeconomico (nonché sui saldi di bilancio), dalle riforme programmate dal Governo, volte
a rafforzare la sostenibilità finanziaria dei conti pubblici anche attraverso
un aumento della crescita potenziale.
Sul punto, nel paragrafo su “Riforme
strutturali e avvicinamento graduale all’MTO” del Programma di stabilità, il
Governo rimarca l’impatto macroeconomico
delle misure programmatiche 2014, prevedendo un aumento del PIL di 2,2 punti percentuali nel 2018, in
termini cumulati.
Il Governo precisa che la metodologia di
proiezione del prodotto potenziale utilizzata per la costruzione della tabella
che segue è in linea con quella correntemente discussa a livello europeo dal Comitato di Politica economica del
Consiglio europeo e dall’Output Gap
Working Group.
Le misure indicate nella tavella ricevono
peraltro più ampia trattazione nella Sez. III del DEF 2014, dedicata appunto al
Programma Nazionale di Riforma. In quella sede, sono peraltro valutati - rileva
il Governo - l’impatto di altre misure strutturali, quali ad esempio quelle
volte a superare le problematiche derivanti dai ritardi dei pagamenti della
P.A., che qui invece, sulla base della metodologia europea, non è considerato.
Tabella
1.7
Effetto
sul PIL delle misure programmatiche 2014
(variazioni percentuali)
|
Descrizione della misura
|
Effetti cumulati sul PIL rispetto allo scenario di
base
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Aumento delle detrazioni IRPEF
sui redditi da lavoro dipendente
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,6
|
0,6
|
|
Riduzione dell’Irap
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Revisione della tassazione sulle
rendite finanziarie
|
0,0
|
0,0
|
-0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
|
Spending review
|
-0,1
|
-0,2
|
-0,3
|
-0,2
|
-0,1
|
|
Liberalizzazioni
e semplificazioni
(D.L. n. 1/2012, D.L. n. 5/2012, D.L. n. 69/2013 e ddl A.S. 958)
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,6
|
0,9
|
|
Riforma del
mercato del lavoro
(L. n. 92/2012 con le modifiche apportate dal D.L. n. 34/2014, in corso di
conversione)
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,8
|
|
TOTALE
|
0,3
|
0,6
|
1,0
|
1,5
|
2,2
|
Fonte:
DEF 2014, Sezione I – Programma di Stabilità, Tavola III.8.
Elaborazione
MEF-RGS sui dati degli Allegati 3, delle relazioni Tecniche e delle
informazioni fornite dai Ministeri competenti.
Come espressamente sottolineato nel
Documento, le riforme strutturali annunciate ed in parte avviate contribuiranno
a ridurre lo scostamento tra il prodotto interno lordo e il suo valore potenziale
che, continua ad essere superiore rispetto alla soglia considerata rilevante
secondo a metodologia europea in condizioni congiunturali normali, configurando
la presenza di “eventi eccezionali”. In particolare, il DEF evidenzia che per effetto delle
riforme annunciate dal Governo, il tasso di crescita del PIL potenziale aumenta
già nel 2014 passando da un tasso prossimo a zero a un valore dello 0,2 per
cento. Negli anni a seguire, e fino al 2017 la crescita del prodotto potenziale
è più rapida che nello scenario di riferimento.
In merito all’esigenza di introdurre
politiche strutturali finalizzate a migliorare il funzionamento dell'economia
nel lungo periodo si rileva quanto indicato dall’OCSE nell’Interim Assessment di marzo 2014, secondo il quale esse non
sono un sostituto per politiche macroeconomiche appropriate di stimolo alla
domanda, anche se ne possono essere un utile complemento. Le riforme
strutturali finalizzate ad aumentare il prodotto potenziale sono dunque un
complemento sempre più importante per politiche macroeconomiche di sostegno
alla domanda.
Analisi
delle componenti del quadro macroeconomico italiano
La tabella che segue riporta le previsioni
per gli anni 2014-2018 dei principali indicatori del quadro macroeconomico complessivo esposto nel DEF 2014, posti
a raffronto con i dati di consuntivo degli ultimi due anni.
Tabella
1.8
Il quadro
macroeconomico
(variazioni percentuali)
|
|
Consuntivi
|
Previsioni
|
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
PIL
|
-2,4
|
-1,9
|
0,8
|
1,3
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
|
Importazioni
|
-7,7
|
-2,8
|
2,8
|
4,4
|
4,1
|
4,2
|
4,2
|
|
Consumi finali nazionali
|
-3,9
|
-2,2
|
0,3
|
0,8
|
0,9
|
1,2
|
1,3
|
|
- spesa delle famiglie
|
-4,3
|
-2,6
|
0,2
|
0,9
|
1,2
|
1,6
|
1,7
|
|
- spesa delle P.A. e I.S.P.
|
-2,9
|
-0,8
|
0,2
|
0,3
|
0,1
|
0,0
|
0,2
|
|
Investimenti fissi lordi
|
-8,0
|
-4,7
|
2,0
|
3,0
|
3,6
|
3,8
|
3,8
|
|
- macchinari, attrezzature e vari*
|
-9,9
|
-2,4
|
4,2
|
4,3
|
4,7
|
4,9
|
4,9
|
|
- costruzioni
|
-6,2
|
-6,7
|
-0,5
|
1,7
|
2,4
|
2,6
|
2,4
|
|
Esportazioni
|
2,3
|
0,1
|
4,0
|
4,4
|
4,2
|
4,1
|
4,1
|
|
|
|
Occupazione (ULA)
|
-1,1
|
-1,9
|
-0,2
|
0,7
|
0,8
|
1,0
|
1,0
|
|
Tasso di disoccupazione
|
10,7
|
12,2
|
12,8
|
12,5
|
12,2
|
11,6
|
11,0
|
|
|
|
Deflatore PIL
|
1,6
|
1,4
|
1,0
|
1,2
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
Inflazione programmata
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
-
|
-
|
-
|
* Tale voce ricomprende gli investimenti in
macchinari e attrezzature, in trasporti e in beni immateriali.
Fonte: DEF 2014, Sezione II: Analisi e
tendenze di Finanza pubblica, Tab. I.1-1.
Come si evince dalla tabella, tutti i principali indicatori macroeconomici
manifestano nell’anno 2014 un valore positivo rispetto al 2013, salvo l’andamento negativo indicato per
gli investimenti nel settore delle costruzioni
(-0,5 per cento).
Tutte le principali componenti della domanda
interna dovrebbero iniziare a manifestare un contributo positivo alla crescita
del PIL, già a partire dall’anno in corso.
In
particolare, l’andamento dei consumi
privati torna positivo nel 2014 (+0,3 per cento), evidenziando una
progressiva crescita negli anni successivi. In tale ambito, i consumi delle famiglie manifestano un
recupero di quasi 3 punti percentuali nel 2014, anno in cui tornano a crescere
dello 0,2 per cento, ed una crescita via via sempre più sostenuta, fino all’1,7
per cento di fine periodo.
Anche
gli investimenti fissi lordi sono
previsti in sensibile aumento, dopo gli andamenti fortemente negativi degli
ultimi anni (-8,0 per cento nel 2012 e -4,7 per cento nel 2013), evidenziando
nell’anno in corso una crescita del 2,0 percento rispetto al 2013, che prosegue
a ritmi sostenuti anche nel periodo successivo. In particolare nel DEF si
evidenzia l’andamento particolarmente positivo degli investimenti in macchinari, sostenuto dalle favorevoli prospettive
della domanda e dalla maggiore immissione di liquidità nel sistema economico
proveniente dal pagamento dei debiti commerciali della PA.. già programmati.
Mantiene
una dinamica ancora negativa nel 2014
il settore delle costruzioni,
per il quale si prevede ancora un calo
dello 0,5 per cento. Anche tale settore, tuttavia, è previsto in ripresa a
partire dal 2015, e destinato a stabilizzarsi su valori positivi pari in media
al 2,5 per cento nel triennio 2016-2018.
Per
quanto concerne le esportazioni – che hanno costituito l’unico apporto
positivo alla crescita del PIL negli ultimi due anni – continuerebbero a
manifestare un andamento positivo anche nell’anno in corso, raggiungerebbero una crescita del 4 per
cento nel 2014 e mantenendosi al di sopra di tale livello per tutto il periodo
successivo.
Anche
le importazioni, secondo le previsioni del DEF, torneranno ad
evidenziare un andamento positivo per tutto il periodo, trainate dalla ripresa
della domanda interna.
Con riferimento alla bilancia dei pagamenti, il saldo corrente è stimato migliorare nel
2014, mantenendosi in surplus
(intorno a +1,4 per cento) per l’intero arco di previsione, grazie al
contributo dell’avanzo commerciale.
Il
grafico seguente indica l’andamento delle principali variabili del quadro
macroeconomico a partire dal 2008 sino alla fine del periodo di previsione
indicato del DEF 2014.
Grafico
1.1
Conto
economico delle risorse e degli impieghi
(variazioni % a prezzi costanti)


2013-2015
obiettivi Governo
|
|
Quanto all’andamento dei prezzi, il deflatore del PIL è stimato
in riduzione nell’anno in corso, pari all’1,0 per cento (rispetto all’1,4 del
2013).
L’aumento dei prezzi al consumo, secondo le
previsioni del DEF, resterebbe modesto per tutto il periodo.
L’indice armonizzato dei prezzi al consumo
(IPCA), valutato al netto dei prodotti energetici, è stimato attestarsi al 1,4
per cento nel 2014, in
discesa rispetto al 2013,
in cui l’indice ha raggiunto l’1,8 per cento.
Mercato del lavoro
Per quanto concerne il mercato del lavoro, il DEF stima per l’anno 2014 una ulteriore contrazione dell’occupazione, in
termini di ULA, dello 0,2 per cento, rispetto all’anno 2013 anno
in cui l’occupazione si è ridotta dell’1,9 per cento.
La stima per il 2014 fornita nel DEF è
dunque più pessimistica di quella prospettata nel Documento programmatico di
bilancio presentato ad Ottobre scorso, in cui si rappresentava per l’anno in
corso una variazione nulla.
Una ripresa
dell’occupazione è attesa realizzarsi, secondo le nuove previsioni,
soltanto a partire dal 2015, anno in
cui l’occupazione segnerebbe una inversione di tendenza, con una evoluzione
positiva (+0,7 per cento), fino a
crescere dell’1,0 per cento nel 2016 ed anche nel 2017.
Il
grafico seguente mostra l’andamento dell’occupazione in Italia a partire dal
2008, con le previsioni 2014-2018 contenute nel DEF.
Grafico
1.2
Andamento
dell’occupazione
(variazioni %)
Il tasso
di disoccupazione crescerebbe più di quanto registrato nel 2013 (12,2 per
cento) attestandosi all’12,8 per
cento nel 2014 – rispetto al 12,4
percento prospettato dal Governo a settembre nella Nota di aggiornamento al DEF
2013 - per poi progressivamente cominciare a scendere in modo più deciso solo
nella parte finale dell’orizzonte di previsione, quando esso si dovrebbe
portare all’11 per cento.
Per ciò che concerne l’andamento del mercato
del lavoro nei primi mesi del 2014, l’ISTAT,
nel Comunicato del 1 aprile u.s.,
indica che nel mese di Febbraio il tasso di disoccupazione si è attestato
al 13 percento, sostanzialmente
stabile in termini congiunturali, ma in aumenti di 1,1 punti percentuali nei
dodici mesi.
In particolare, il tasso di disoccupazione dei
15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi
(occupati o disoccupati) è pari al 42,3 percento, in calo di 0,1 punti
percentuali rispetto al mese precedente, ma in aumento di 3,6 punti nei dodici
mesi. Dal calcolo sono pertanto esclusi i giovani inattivi, cioè quelli che non
sono occupati e non cercano lavoro, perché ad esempio impegnati negli studi.
Infine, si rileva
che situazione occupazionale italiana è vista in termini lievemente meno
pessimistici rispetto a quelli delineati dal Governo, dalla Commissione europea nel Winter Forecast, che stima per l’Italia
una crescita del tasso di disoccupazione intorno al 12,6 per cento nel 2014 e
al 12,4 per cento nel 2015.
Il
grafico che segue mostra l’andamento del tasso di disoccupazione a partire dal
2004 per i principali paesi della UE e per gli Stati Uniti, tratte dal recente
rapporto del Fondo monetario internazionale (Word Economic Outlook, aprile
2014).
Grafico
1.3
Andamento
del tasso di disoccupazione
(variazione percentuale)
 Fonte: Per i consuntivi 2008-2013 dei paesi della UE, dati
della Commissione Europea, per USA, dati FMI. Per le previsioni 2014-2015, FMI,
Word Economic Outlook (aprile 2014)
Fonte: Per i consuntivi 2008-2013 dei paesi della UE, dati
della Commissione Europea, per USA, dati FMI. Per le previsioni 2014-2015, FMI,
Word Economic Outlook (aprile 2014)
Con riferimento al costo
del lavoro per unità di prodotto (CLUP),
misurato in termini di rapporto sul PIL, la crescita della
produttività, unitamente alla prosecuzione della moderazione salariale sono considerati
nel DEF elementi volti a favorirne un rallentamento. Tale indicatore, cresciuto
dell’1,4 per cento nel 2013, avrebbe nel 2014 una crescita pressoché nulla,
pari allo 0,1 per cento.
Si osservi che le riforme programmate, secondo le stime del Governo, come illustrate
nel paragrafo precedente, avrebbero effetto
anche sull’occupazione soprattutto a
decorrere dall’anno 2015: l’effetto cumulato di esse sarebbe un incremento
dello 0,2 per cento nel 2014, dello 0,4 nel 2015 per poi giungere al termine dell’orizzonte
previsionale, nel 2018, ad un incremento dell’1,2 per cento (cfr. Tavola II.8
della Sez. I - Programma di stabilità del DEF).
Inoltre, il Governo prospetta, dalle riforme
programmate, effetti positivi
sull’offerta di lavoro: l’introduzione delle detrazioni IRPEF sul lavoro
dipendente per le fasce più basse di reddito, oltre a rappresentare una
riduzione del cuneo fiscale, afferma il Governo, produrrebbe effetti indiretti
sul tasso di partecipazione atteso
aumentare in termini cumulati di 0,6 punti percentuali nel triennio 2015-2018
(effetti stimati sulla base del modello di micro simulazione del mercato del
lavoro del dipartimento del Tesoro del MEF ItaxSIM).
1.3 Confronti
internazionali
Nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale (Word
economic outlook – aprile 2014), le previsioni per l’economia dell’Area
dell’euro risultano riviste lievemente al rialzo.
In tale ambito, con riferimento all’Area
dell’euro, le revisioni rispetto alle precedenti stime hanno riguardato la
Germania, stimata crescere intorno all’1,7 percento nel 2014 (rispetto al 1,6
stimato a gennaio), e la Francia, per la quale si prevede una crescita dell’1,0
percento nel 2014 (rispetto al precedente 0,9).
Le previsioni dell’FMI per l’Italia sono invece rimaste invariate
rispetto al precedente Rapporto, stimandosi per il 2014 una crescita per il nostro Paese dello 0,6 per cento, in simmetria con quanto prospettato dalla stessa
Commissione Europea nel Winter Forecast
di febbraio 2014.
Il ritmo sarebbe dunque più modesto di
quanto indicato dal Governo nel DEF, pari allo +0,8 per cento.
Nel complesso, nell’Area euro l’FMI prevede una crescita del prodotto nel 2014 pari
allo 1,2 per cento, e anche tale stima corrisponde a quella elaborata dalla
Commissione europea.
Tabella
1.9
Prodotto
interno lordo – Confronti internazionali
(variazioni %)
|
|
DEF 2014
aprile 2014
|
Commissione Europea
febbraio 2014
|
FMI
WEO
aprile 2014
|
|
|
2014
|
2015
|
2014
|
2015
|
2014
|
2015
|
|
Economie
avanzate
|
|
Italia
|
0,8
|
1,3
|
0,6
|
1,2
|
0,6
|
1,1
|
|
Francia
|
|
|
1,0
|
1,7
|
1,0
|
1,5
|
|
Germania
|
|
|
1,8
|
2,0
|
1,7
|
1,6
|
|
Spagna
|
|
|
1,0
|
1,7
|
0,9
|
1,0
|
|
area
euro
|
|
|
1,2
|
1,8
|
1,2
|
1,5
|
|
Regno Unito
|
|
|
2,5
|
2,4
|
2,9
|
2,5
|
|
Usa
|
|
|
2,9
|
3,2
|
2,8
|
3,0
|
|
Giappone
|
|
|
1,6
|
1,3
|
1,4
|
1,0
|
|
Economie
emergenti
|
|
cina
|
|
|
|
|
7,5
|
7,3
|
|
india
|
|
|
|
|
5,4
|
6,4
|
|
brasile
|
|
|
|
|
1,8
|
2,7
|
|
russia
|
|
|
|
|
1,3
|
2,3
|
Il settore manifatturiero
Il DEF riporta un approfondimento sulla
manifattura italiana: fatturato competitività e strategie anticrisi.
Riprendendo
i dati diffusi dall’ISTAT nel recente Rapporto sulla Competitività dei settori
produttivi diffuso il 26 febbraio 2014, il DEF evidenzia, in un apposito focus come la crisi economica del
periodo 2010-2013 abbia riverberato i suoi effetti in modo differenziato nei
diversi settori della manifattura italiana.
Tra
gennaio-ottobre del 2010 e lo stesso periodo del 2013, il 51 per cento delle
imprese industriali ha aumentato il fatturato totale: il 39 per cento del
totale delle unità ha incrementato le vendite sul mercato interno ed il 61
percento quelle sul mercato esterno. Vi sono comunque, rileva l’ISTAT, marcate
eterogeneità settoriali, le quali sono rilevabili anche dall’analisi della
variazione mediana del loro fatturato totale, che è risultata positiva e
superiore alla dinamica della manifattura nel suo complesso in dieci comparti,
mentre in tredici essa ha registrato un calo.
Tra
i top performer emergono taluni
settori che caratterizzano il modello specializzato italiano: gli articoli in
pelle il cui incremento di fatturato è risultato nel periodo considerato il più
elevato (21,8 percento); nonché l’industria delle bevande (11 percento);
l’industria alimentare (9,4 percento9; i macchinari e le attrezzatura(7,6
percento).
Tra i
bottom performer il settore dei
mobili (-14,6 percento), l’abbigliamento (13,5 percento) e le industrie del
legno (-12,5 percento). Il dettaglio settoriale evidenzia inoltre che
l’andamento della domanda internazionale ha rappresentato un elemento decisivo
per sostenere l’attività produttiva nel triennio 2010-2013. In soli quattro anni
si è verificata una variazione negativa di fatturato estero (produzione di
mobili legno, stampa ed abbigliamento). In un solo comparto (alimentari) si è
registrato un incremento di fatturato sul mercato interno, mentre per bevande e
pelli si è registrata una sostanziale invarianza.
Comunque,
si osservi che in alcuni settori, il marcato crollo della domanda interna non è
stato compensato dall’incremento (in certi casi percentualmente elevato) del
fatturato estero (si pensi alle apparecchiature elettriche (+5,1 percento di
fatturato estero contro il -16,3 percento del fatturato interno).
L’ISTAT
rileva comunque che per la maggior parte delle imprese esportatrici, il mercato
domestico continua a rappresentare la principale destinazione delle proprie
produzioni: il 60 per cento delle imprese manifatturiere esportava non più del
35 percento del proprio fatturato nel 2010 e non oltre il 41,5 percento nel 2013. In particolare, le
imprese dei comparti top performer
mostrano una notevole eterogeneità in termini di apertura all’estero: il
settore alimentare segnano quote modeste di fatturato esportato; al contrario,
le imprese dei comparti delle pelli e dei macchinari sono caratterizzate da
propensioni all’export
particolarmente elevate. Una maggiore propensione all’export si registra anche
per le imprese farmaceutiche.
Anche
tra i bottom performer vi è comunque
propensione all’estero, come ad esempio per il settore dei mobili che ha
risentito della crisi nonostante quasi la metà delle imprese ha presentato nel
2013 una quota di fatturato estero superiore al 50 percento. A sua volta, il
settore dell’abbigliamento ha presentato un grado di apertura pari a quello
medio manifatturiero.
L’ISTAT
ha elaborato un indicatore sintetico di competitività, sulla base del quale ha
identificato un gruppo di settori più performanti – quali la farmaceutica, le
bevande, la chimica e la meccanica, che nel 2011 hanno spiegato circa un quarto
del valore aggiunto manifatturiero (24,8 percento). Nella parte più bassa della
graduatoria, si trovano settori significativi della manifattura italiana, quali
la fabbricazione dei prodotti in metallo e l’alimentare (con il 20 percento del
valore aggiunto totale).
Sulla
base dell’indicatore sintetico di competitività, con riferimento ai primi tre
trimestri del 2013, l’ISTAT conferma la situazione competitiva iniziale
superiore alla media per il solo settore farmaceutico. Il tessile e i
macchinari appaiano invece sostanzialmente in linea con la competitività media
del settore. La metallurgia evidenzia difficoltà, mentre taluni settori
registrano un miglioramento in termini di competitività in corso d’anno, quali
autoveicoli e mezzi di trasporti.
L’Istat
ha suddiviso le imprese in quattro classi: vincenti, crescenti all’esterno,
crescenti all’interno e in ripiegamento, dando indicazione delle strategie ed
elle performance adottate da ciascuno
di tali gruppi

2. La finanza pubblica
2.1 Gli andamenti tendenziali di finanza pubblica
Il
Documento di Economia e Finanza (DEF) riporta l'analisi del conto economico
delle amministrazioni pubbliche (PA) a legislazione vigente, integrato con le
informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2013 (tabella 2.1). I conti
a legislazione vigente, presentati nella sezione II del DEF, vengono
rappresentati nella versione conforme alle regole di Contabilità Nazionale,
differenziandosi rispetto ai quelli contenuti nella sezione I, che sono redatti
ai sensi del Regolamento CE 1500/2000.
2.1.1 Il
consuntivo 2013
L’indebitamento
netto delle Pubbliche amministrazioni
I dati
di consuntivo Istat attestano un indebitamento netto della PA per il 2013 pari
a 47.321 milioni, pari al 3 per cento del PIL.
La
conferma delle stime del saldo di bilancio contenute nella Nota di
aggiornamento del DEF 2013 presentata nel settembre 2013 e nella successiva
Nota tecnico illustrativa della Legge di Stabilità 2014 (NTI) si determina a
fronte di un avanzo primario inferiore alle attese (-2,1 miliardi), in parte
compensato da una minore spesa per interessi (-1,9 miliardi).
L’avanzo
primario, dopo aver raggiunto il 2,5 per cento del PIL nel 2012 (39,1 miliardi)
è sceso al 2,2 per cento nel 2013 (34,7 miliardi). Lo scostamento rispetto al
valore indicato nei precedenti documenti (2,4 per cento del PIL nella NTI) è
dovuto alla dinamica più contenuta delle entrate (circa 0,5 punti percentuali
di PIL in meno rispetto a quanto previsto), compensata solo parzialmente dal
minore rapporto della spesa primaria sul PIL (circa 0,3 punti percentuali)
La
spesa per interessi si è attestata al 5,3 per cento del prodotto (82 miliardi),
in riduzione di oltre 1 decimo di punto rispetto alle precedenti stime (5,4 per
cento nella NTI) e di oltre due decimi di punto rispetto al livello del 2012
(5,5 per cento del PIL, pari a 86,5 miliardi).
Le
entrate
Le
entrate complessive delle Amministrazioni Pubbliche realizzate nel 2013,
valutate in rapporto al PIL, sono risultate superiori a quelle del 2012 di 0,1
punti percentuali.
Analizzando,
tuttavia, l’andamento delle sole entrate tributarie si riscontra una riduzione
di 0,2 punti, determinata da alcune misure adottate, tra le quali il Documento
in esame segnala la soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e su
altre tipologie di immobili.
La pressione
fiscale, a fronte di una sostanziale invarianza dell’incidenza delle
entrate contributive, si è ridotta di 0,2 punti di PIL attestandosi al 43,8 per
cento.
Rispetto
alle stime contenute nella Nota di aggiornamento al DEF 2013 (settembre
2014) nella successiva Nota tecnico-illustrativa della legge di stabilità
2014 (NTI), a fronte di una riduzione complessiva delle entrate tributarie
della PA di 3,89 miliardi, il gettito tributario degli Enti territoriali ha
subito un decremento di circa 5 miliardi di euro.
Le stime
indicate nella Nota di aggiornamento al DEF 2013 includono la riduzione
del gettito IMU dell’abitazione principale ed altri immobili indicati dalla
normativa (decreto legge n. 102/2013) limitatamente alla prima rata 2013 che
era scaduta nel mese di giugno.
Il
decreto legge n. 133 del 2013 è intervenuto sul pagamento della seconda rata
IMU 2013 (scadenza dicembre 2013, poi prorogata a gennaio 2014) disponendo, per
specifiche tipologie di immobili, l’obbligo di versare il 40% della differenza,
se positiva, tra l’aliquota effettiva deliberata da ciascun comune e l’aliquota
standard stabilita a livello nazionale (c.d. mini IMU, introdotta in luogo
della soppressione totale dell’imposta). A fronte di tale disposizione, la
relazione tecnica allegata al richiamato provvedimento ha attribuito effetti di
minor gettito stimati in circa 2,16 miliardi di euro.
In
merito al gettito tributario in favore degli Enti locali, inoltre, si ricordano
anche gli interventi in materia di maggiorazione TARES (stimata in circa 1
miliardo per l’anno 2013) ai sensi dei quali il gettito tributario è stato
riconosciuto in favore dello Stato; contestualmente è stato riconosciuta ai
Comuni un’attribuzione di risorse da parte dell’Erario di pari importo.
In proposito, è opportuno acquisire
chiarimenti in merito alla riduzione delle entrate tributarie degli enti locali
indicata in misura pari a circa 5 miliardi di euro rispetto alla stima
contenuta nella Nota di aggiornamento al DEF 2013. Ciò in considerazione del
fatto che qualora, come è presumibile ritenere, la soppressione della prima
rata IMU fosse stata considerata nelle stime indicate nella predetta Nota, gli
ulteriori interventi in materia di IMU per l’anno 2013 dovrebbero riguardare
esclusivamente la seconda rata d’imposta valutata dalla relazione tecnica in
circa 2,2 miliardi.
Il
Documento in esame afferma che, rispetto alle previsioni della NTI 2014,
il comparto degli enti territoriali registra un gettito inferiore di 5.006
milioni di euro. In particolare, si sono registrate minori entrate IMU per
1.168 mln (abolizione della seconda rata, per la quota di spettanza dei comuni)
nonché una riduzione dell’IRAP di 1.276 mln e delle tasse auto per 488 milioni
di euro.
Appare opportuno acquisire chiarimenti anche
in merito alla riduzione delle entrate tributarie degli enti locali rispetto
alla NTI 2014, tenuto conto che il minor gettito individuato nel DEF risulta
pari a circa 2,9 miliardi rispetto ai 5 miliardi complessivi.
L’analisi
per tipologia di imposta evidenzia, rispetto alle stime dei precedenti
documenti programmatici (Nota di aggiornamento e NTI) una rilevante riduzione
delle imposte indirette (-9,4 miliardi) imputabile in via prevalente ad una
dinamica dei consumi meno favorevole di quella stimata. Contestualmente si
registra un incremento delle imposte dirette (+4,6 miliardi) imputabile in via
prevalente agli interventi in materia di IRES, sia in termini di liquidazione
dell’imposta sia in termini di misura dell’acconto da versare.
Le
spese
Le
spese finali nel 2013 mostrano una riduzione rispetto al precedente
esercizio (-0,2 per cento), passando da 800.873 milioni del 2012 a 798.940 milioni del
2013. Tale risultato si determina a fronte di un aumento della spesa primaria
(+0,3 per cento) e di una riduzione della spesa per interessi (-5,1 per cento).
In
presenza di una contrazione anche in termini nominali del prodotto, le spese
totali aumentano lievemente la loro incidenza sul PIL, passando dal 51,1 per
cento del 2012 al 51,2 del 2013. La variazione complessiva è determinata
dall’aumento per 0,7 punti di PIL della spesa corrente primaria (da 42,5 a 43,2 per cento) a
fronte della riduzione di 0,4 punti di quella di parte capitale (da 3,1 a 2,7 per cento) e di 0,2
punti della spesa per interessi (da 5,5 a 5,3 per cento).
Alla
dinamica mostrata dalla spesa primaria corrente contribuisce una variazione
positiva sia delle prestazioni in denaro (+2,7 per cento rispetto al 2012), che
scontano un aumento significativo della spesa per ammortizzatori sociali (+15,9
per cento) e per le indennità di disoccupazione (+ 19,8 per cento) conseguenti
al protrarsi della recessione, che delle altre spese correnti (+5,6 per cento).
Si riducono, invece, i redditi da lavoro dipendente (-0,7 per cento) per
effetto delle misure limitative delle assunzioni nelle Amministrazioni
pubbliche e della conferma del blocco dei rinnovi contrattuali, e i consumi
intermedi (-1,4 per cento), su cui pesano le misure correttive adottate negli
ultimi anni. Tali andamenti si riflettono sulla spesa sanitaria che, per il
terzo esercizio consecutivo, si riduce in valore assoluto (-0,3 per cento).
Evidenzia
una significativa variazione negativa la spesa in conto capitale (-12,8 per
cento). Parte della riduzione è correlata al calo dei contributi in conto
capitale, diminuiti per la minore richiesta di agevolazioni per crediti di
imposta da parte delle imprese, oltre che per il venir meno del contributo per
la ricostruzione dell’Abruzzo (oltre 1 miliardo). Gli investimenti fissi lordi
si sono ridotti del 9,5 per cento, nonostante il dato relativo al 2013
comprenda i pagamenti in conto capitale dei debiti pregressi della P.A.
autorizzati per lo scorso esercizio.
Rispetto
alla Nota tecnico illustrativa della legge di stabilità, la spesa finale
risulta inferiore di oltre 7 miliardi, per effetto di minori interessi passivi
per 1,9 miliardi e di minori spese in conto capitale per 7,5 miliardi
principalmente, riconducibili principalmente ai minori contributi, a fronte di
spese correnti al netto degli interessi più elevate di 2,4 miliardi.
All’interno
di tale aggregato, si riducono in misura significativa, rispetto alle
precedenti stime, la spesa sanitaria (-1,8 miliardi) e quella per pensioni ed
altre prestazioni (-1 miliardo), a fronte di un aumento delle altre componenti.
2.1.2 Le previsioni tendenziali per il periodo 2014-2018
Rispetto
alle stime relative al triennio 2014-2016 contenuto nella Nota tecnico
illustrativa della legge di stabilità 2014 (quadro programmatico) e a quelle
relative all’esercizio 2017 della Nota di aggiornamento, il DEF presenta le
nuove previsioni sulla base delle informazioni di consuntivo 2013, della
revisione del quadro macroeconomico e dell'impatto dei provvedimenti adottati
entro il mese di marzo, con particolare riferimento al pagamento dei debiti
della P.A. Viene, inoltre, presentata per la prima volta la stima relativa
all’esercizio 2018.
L’indebitamento
netto della PA
Il
conto economico esposto dal DEF evidenzia un indebitamento netto pari a -2,6
per cento del PIL nel 2013, superiore di 0,1 punti rispetto alle previsioni
(-2,5 per cento) della NTI (v. tabella 2.1).
Tale
variazione è ascrivibile ai seguenti fattori:
· -0,3
punti a minori entrate fiscali;
· +0,2
punti a entrate non fiscali
· -0,3
punti a minori spese primarie
· -0,2
punti a minori spese per interessi, in relazione ad un andamento dei tassi più
favorevole rispetto a quello previsto in precedenza.
L’aggiornamento
delle stime per l’esercizio in corso comporta una revisione anche nel
successivo biennio:
· -2
per cento nel 2015 rispetto a -1,6 per cento della NTI
· -1,5
per cento nel 2016 rispetto a -0,8 per cento della NTI.
Per il
2017, le stime contenute nel Documento evidenziano un indebitamento netto pari
a -0,9 per cento rispetto al valore obiettivo di -0,1 per cento indicato nella
Nota di aggiornamento. Per il 2018, il saldo tendenziale è previsto pari a -0,3
per cento.
Le
entrate
Il
Documento in esame chiarisce che le previsioni sono costruite considerando gli
effetti finanziari associati anche ai provvedimenti legislativi approvati a
tutto marzo 2014 con particolare riferimento al tema dei pagamenti dei debiti
pregressi delle pubbliche amministrazioni.
Nel
2014 le entrate totali presentano un incremento rispetto al PIL di 0,1 punti
percentuali rispetto all’esercizio precedente, per effetto principalmente delle
misure previste dal DL n. 133/2013 e n. 4/2014 e della legge di stabilità 2014.
Le
principali misure in materia tributaria contenute nel decreto legge n. 133/2013
sono:
-
abolizione della seconda rata IMU (fatto salvo il
pagamento della c.d. mini-IMU) per le abitazioni principali e gli altri
immobili appositamente individuati. La relazione tecnica stima una perdita di
gettito di circa 2,2 miliardi nel 2013;
-
aumento dell’acconto IRES/IRAP 2013 per banche,
assicurazioni e altre società che operano nel settore finanziario. La relazione
tecnica considera un anticipo delle imposte al 2013 rispetto al 2014 valutato
in circa 15 mld;
-
introduzione di una addizionale IRES 2013 per i
soggetti che operano nel settore finanziario (come banche e assicurazioni). La
relazione tecnica stima una maggiore entrata nel 2014 pari a 1,5 mld;
-
introduzione, a regime, di un acconto dell’imposta
sostitutiva sul risparmio amministrato. La relazione tecnica stima effetti
positivi per l’anno 2013 pari a 670 milioni.
Il
decreto legge n. 4 del 2014 prevede, tra l’altro, la soppressione della
disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 che riduceva la misura
della detrazione IRPEF per oneri dal 19% al 18% per il 2013 e al 17% dal 2014.
Gli effetti finanziari (negativi nel dl 4/2014, al fine di annullare gli
effetti positivi ascritti nella legge di stabilità) sono valutati in circa 490
mln nel 2014, 770 mln nel 2015 e 560 mln dal 2016.
Le
entrate tributarie (che passano dal 30 per cento del PIL del 2013 al 29,9 per
cento del 2018) considerano, oltre alle variazioni del quadro macroeconomico e
agli effetti dei provvedimenti legislativi, anche l’effetto di trascinamento
dei risultati 2013, che hanno fatto registrare una riduzione di 3.890 milioni
rispetto alle stime della NTI 2014.
In
particolare, le previsioni per il 2014 (+13.919 milioni rispetto al 2013)
rappresentano un impatto differenziale netto sul 2014 delle misure fiscali
adottate e del miglioramento del quadro macroeconomico; negli anni successivi,
le misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 e dagli altri provvedimenti
fiscali e le prospettive di miglioramento della congiuntura economica
continuano a produrre effetti positivi.
Per
quanto riguarda la dinamica delle entrate territoriali, le previsioni
riflettono l’effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità per l’anno
2014 relative alla riforma della tassazione immobiliare ed il miglioramento del
quadro congiunturale; il valore rispetto al PIL delle entrate tributarie delle
amministrazioni locali passa dal 6,7 per cento del 2013 al 6,2 per cento del
2018 evidenziando un andamento costante decrescente.
Andrebbero forniti chiarimenti in merito
alla valutazione degli effetti sulle entrate tributarie recati dalle
prospettive di miglioramento del quadro macroeconomico. In particolare, sarebbe
utile individuare l’ammontare e la tempistica in base ai quali gli effetti di
maggior gettito, in relazione alla prevista congiuntura economica, si
manifestano.
In
proposito, si fa presente che i dati relativi al gettito IVA (aggiornati al
mese di febbraio 2014) evidenziano un lieve incremento di gettito che non
sembrerebbe imputabile interamente ad una ripresa economica.
Infatti,
sulla base dei dati contenuti nel Bollettino delle entrate tributarie
pubblicato dal Dipartimento delle finanze, risulta che:
-
la variazione del gettito mensile dell’IVA ha assunto
un valore negativo (se confrontato con il gettito dello stesso mese dell’anno
precedente) per tutto il periodo gennaio-agosto 2013;
-
dal mese di settembre 2013 fino a tutto febbraio 2014
la variazione mensile è tornata positiva, con l’unica eccezione del mese di
gennaio 2014 nel quale, tuttavia, sono effettuati versamenti a conguaglio relativi
all’intero periodo d’imposta precedente.
Contestualmente,
tra gli interventi normativi introdotti in materia, si ricorda che a decorrere
dal 1° ottobre 2013 l’aliquota IVA ordinaria è stata elevata dal 21% al 22%.
Inoltre, nel secondo semestre 2013, il gettito IVA dovrebbe aver risentito
degli effetti positivi recati dalle disposizioni in materia di pagamento dei
debiti pregressi della P.A.
In
base a quanto sopra indicato non è possibile individuare in quale misura
l’inversione di tendenza mensile (dal segno negativo al segno positivo) possa
essere attribuita ad una ripresa dei consumi, seppure moderata, e quanto invece
sia determinato dagli interventi normativi introdotti (incremento dell’aliquota
IVA ordinaria e pagamento dei debiti pregressi).
In via
prudenziale, tuttavia, è presumibile ritenere che i dati indicati, pubblicati
ad aprile 2014 ed aggiornati per competenza al mese di febbraio 2014,
evidenzino una ripresa economica graduale che potrebbe determinare effetti
positivi progressivi nel tempo.
In merito alle entrate tributarie delle
Amministrazioni locali, si segnala che le stime indicate sono effettuate
considerando le aliquote standard stabilite dalla normativa nazionale dei
principali tributi (IMU, addizionali IRPEF, IRAP). Tuttavia, si evidenzia che
le disposizioni vigenti, oltre a stabilire l’aliquota di base di ciascun
tributo, consentono alle predette Amministrazioni la facoltà di variare (in
aumento o in diminuzione) le predette aliquote. I dati a livello nazionale
mostrano, in generale, una tendenza ad un incremento delle aliquote
effettivamente applicate cui corrisponderebbe un valore superiore di gettito
valutato rispetto al PIL.
Con
riferimento all’imposta municipale sugli immobili (IMU) si segnala che il
gettito dell’anno 2012 riferito alle manovre sulle aliquote dei comuni è
indicato in circa 3,8 miliardi (a fronte di un gettito complessivo di circa
23,8 miliardi).
Per l’anno
2013, il gettito della c.d. mini-IMU (40% della differenza, se positiva,
tra aliquota deliberata dagli enti locali ed aliquota standard riferita ai soli
immobili individuati dalla normativa, quali le abitazioni principali ed
assimilati) è stimato in misura pari a circa 400 milioni.
Si fa inoltre presente che le stime indicate
non sembrano includere gli effetti degli interventi – allo stato attuale
solamente annunciati – in materia di riduzione del cuneo fiscale. In
particolare, secondo quanto indicato nel PNR, l’incremento della detrazione
IRPEF per redditi di lavoro dipendente determinerebbe effetti di minor gettito
tributario stimabile, su base annua, in circa 10 miliardi (6 miliardi per il
2014, considerata l’introduzione in corso d’anno): tale intervento troverebbe
la copertura finanziaria nella riduzione della spesa pubblica. Non sembra
essere invece indicata la stima degli effetti finanziari recati dall’annunciata
riduzione del 10 per cento dell’IRAP, per la cui copertura finanziaria sono
previste modifiche al regime di tassazione delle rendite finanziarie.
In
proposito, si evidenzia che il gettito IRAP relativo al 2013 risulta pari,
secondo i dati contenuti nel Bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal
Dipartimento delle Finanze, a 34,7 miliardi, di cui 24,8 miliardi rappresentano
la quota versata dai soggetti privati.
Le
previsioni dei contributi sociali registrano una riduzione rispetto al PIL
passando dal 13,8 per cento del 2013 al 13,4 per cento del 2018.
La pressione
fiscale, pari al 43,8 per cento nel 2013, registra un lieve incremento
negli anni 2014 e 2015 (44 per cento) per poi assumere un andamento decrescente
raggiungendo il valore del 43,3 per cento nel 2018.
Il
valore della pressione fiscale stimato include effetti finanziari di segno
opposto attribuiti ad alcuni interventi normativi già approvati. In
particolare, tra le misure che determinano una riduzione del gettito si
segnalano:
-
la soppressione dell’IMU sull’abitazione principale ed
altre tipologie di immobili individuate;
-
il minor gettito recato dalle norme (introdotte nel
2008, e poi prorogate) che hanno consentito la rivalutazione agevolata dei
valori attivi di bilancio per le società che hanno effettuato operazioni
straordinarie (quali, ad esempio, le fusioni bancarie). Tali misure hanno
determinato, nei primi anni di applicazione, un incremento del gettito di
imposta sostitutiva e determinano, negli anni successivi, una riduzione del
gettito ordinario riferito ai periodi d’imposta nei quali le predette
operazioni straordinarie producono effetti ai fini fiscali.
Tra le
misure che recano, invece, incremento di gettito si segnala la
previsione di riduzioni di agevolazioni fiscali vigenti (comma 430 della legge
di stabilità 2014) da effettuare in modo da assicurare un maggior gettito
tributario pari a 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e a 10 miliardi
annui a decorrere dal 2017.
Sul punto è opportuno acquisire chiarimenti
tenuto conto che, a fronte di interventi specifici che determinano la riduzione
di gettito, non risultano allo stato individuate le misure che si intende
adottare per assicurare gli effetti positivi inclusi nelle stime indicate.
Le
spese
All’andamento
dei saldi nel periodo 2014-2018 contribuisce una dinamica della spesa corrente
al netto degli interessi (+1 per cento nell’anno in corso, +1,3 per cento nel
2015, +1,4 nel 2016 e +1,8 nella media nel successivo biennio), che consente
una riduzione dell’incidenza sul prodotto di 2,4 punti percentuali: il peso sul
PIL passa, infatti, dal 42,9 per cento del 2014 al 40,5 per cento nel 2018.
Per
quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, continua il trend decrescente
osservato negli anni precedenti, in conseguenza del blocco della contrattazione
collettiva, dei trattamenti economici individuali e delle progressioni di
carriera. Le misure limitative del turnover,
che si protraggono su tutto l’orizzonte temporale, fanno sì che solo nel 2018
sarebbe possibile sostituire completamente con nuovi addetti il personale
cessato dal servizio. Lo scenario tendenziale evidenzia, infatti, una riduzione
in valore assoluto della spesa nel 2014 (-0,7 per cento), a fronte di una lieve
variazione positiva (+0,1 per cento) nel 2015. Nel 2018, l’erogazione della
nuova indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2018-2020 comporta
un aumento dello 0,3 per cento. L’aggregato riduce pertanto il suo peso sul
prodotto, passando dal 10,3 per cento del 2014 (10,5 per cento nel 2013) al 9,1
per cento del 2018.
I consumi
intermedi, dopo le accentuate riduzioni registrate negli esercizi
2012-2013, aumentano in misura contenuta nel 2014 (+0,2 per cento) e nel 2015
(+0,6), per poi aumentare più sensibilmente (+2,2 per cento in media annua)
negli anni successivi, mantenendosi comunque al di sotto della dinamica del PIL
nominale: si riduce, infatti, l’incidenza sul prodotto interno lordo, che passa
dall’8,2 per cento dell’esercizio in corso (8,3 per cento nel 2013) al 7,8 per
cento del 2018.
L’andamento della spesa sanitaria
indicato nel quadro tendenziale riflette un valore di preconsuntivo 2013
inferiore alle precedenti stime (-1,8 miliardi rispetto alla NTI): i
tendenziali sono pertanto rideterminati riduzione di circa 1,6 miliardi nel
2014, 1,2 miliardi nel 2015 e 900 milioni nel 2016. Il nuovo profilo della
spesa, che sconta una crescita intorno al 2 per cento annuo in tutto il periodo
di previsione, comporta una lieve riduzione dell’incidenza dell’aggregato sul
PIL, che passa dal 7 per cento del 2014 al 6,8 per cento nel 2018.
Per quanto riguarda la spesa per prestazioni
sociali, dopo una crescita del 2,7 per cento nel 2013 e nel 2014, l’aggregato
si riduce nel biennio successivo (+ 2,1 per cento) per poi aumentare nuovamente
nel 2017 (+2,6 per cento) e 2018 (+2,5 per cento). L’incidenza sul PIL si
attesta a fine periodo sul 20,1 per cento, in riduzione rispetto al dato
relativo al 2014 (20,7 per cento).
Le previsioni tendenziali mostrano un
andamento complessivamente decrescente per la spesa in conto capitale: a
fine periodo l’aggregato si attesta su un valore pari a 41,5 miliardi,
inferiore di circa 4 miliardi rispetto al valore previsto per il 2014 e di
oltre 7 miliardi rispetto a quello registrato nel 2012. L’andamento descritto
viene confermato dalla dinamica della spesa in termini di PIL, che dal 2,9 per
cento del 2014 scende al 2,3 per cento a fine periodo.
Rispetto alle precedenti previsioni
contenute nella NTI, nel 2014 si registrano minori spese per circa 7,6
miliardi, di cui 3,5 miliardi relativi agli interessi passivi e 4 miliardi alla
spesa primaria (-3,2 miliardi la spesa in conto capitale e -767 milioni quella
di parte corrente). La revisione in riduzione delle stime per il biennio
successivo (-7,1 miliardi nel 2015 e -5,8 miliardi nel 2016) è ascrivibile alla
spesa per interessi (-6,7 e -6,5 miliardi nei due anni) a fronte di variazioni
di segno diverso all’interno della spesa primaria.
2.1.3 L'analisi degli
andamenti tendenziali per sottosettori
Il
documento riporta, come di consueto, la disaggregazione dei conti dei
sottosettori della PA, con riferimento sia agli esercizi di consuntivo, sia
alle previsioni tendenziali. Di seguito si analizza in particolare la
componente relativa alle amministrazioni locali. Per tale settore i risultati
conseguiti nel 2013 mostrano una seppur marginale flessione della
dimensione del bilancio pubblico locale espresso in termini di incidenza sul
PIL (l’incidenza sia delle spese che delle entrate sul PIL passa dal 15,1% nel
2012 al 15% nel 2013, con un saldo che resta in sostanziale pareggio[11]), a fronte di un incremento della
dimensione del bilancio pubblico centrale e di quello previdenziale. In
particolare, le componenti della spesa che registrano una flessione
sono, per la parte corrente, quella relative ai redditi da lavoro dipendente e,
per la parte in conto capitale, la spesa per gli investimenti fissi lordi. Sul
lato dell’entrata risulta evidente la riduzione del gettito delle imposte
indirette, dovuta in larga misura al venir meno del gettito IMU sulla prima
casa. E’ inoltre marcata la riduzione dei trasferimenti dalle amministrazioni
pubbliche, per via dei tagli derivanti dalle manovre di finanza pubblica, solo
parzialmente compensati dall’incremento dei trasferimenti a compensazione del
predetto minor gettito IMU sulla prima casa. L’incremento delle entrate non
tributarie, sia di parte corrente che in conto capitale, appare sintomatico del
tentativo delle amministrazioni locali di far fronte, con aumenti tariffari e
valorizzazione dei cespiti patrimoniali, alla riduzione del gettito tributario
e dei trasferimenti.
L’andamento
riscontrato nei dati di consuntivo è previsto accentuarsi nelle previsioni
tendenziali, con una progressiva flessione dell’incidenza del bilancio
locale sul PIL per oltre un punto percentuale nell’arco del quinquennio
(l’incidenza sia delle spese che delle entrate sul PIL passa dal 15% del 2013
al 13,5% del 2018, con un saldo che resta in sostanziale pareggio). Prosegue,
sul lato della spesa, la flessione dei redditi da lavoro dipendente e
degli investimenti, a cui si aggiunge anche una flessione della spesa per
interessi passivi. Prosegue altresì, sul lato dell’entrata, la riduzione
dei trasferimenti pubblici e del gettito tributario, inclusa la componente
diretta, e non è prevista una crescita compensativa delle entrate non
tributarie, che sono a loro volta previste ridursi.
Al
riguardo si segnala che, in ragione del processo di consolidamento dei conti
della PA, la spesa per interessi nel conto economico delle amministrazioni
locali non registra l’incremento della spesa per interessi connesso alle
anticipazioni erogate alle amministrazioni locali a valere sul Fondo per il
pagamento dei debiti della PA.. Tale spesa, originariamente stimato nell’ordine
di un miliardo annuo[12], è presumibilmente registrata nell’ambito
dei trasferimenti verso altre amministrazioni pubbliche che mostrano,
effettivamente, un aumento sensibile nel 2014 (0,1 punti di PIL) e più
contenuto negli esercizi successivi.
In
considerazione del descritto andamento tendenziale dei conti delle
amministrazioni locali, andrebbe valutato se la riduzione della dimensione del
bilancio locale in termini di incidenza sul PIL, ove non accompagnata da
recuperi compensativi di efficienza, possa riflettersi in una parallela
riduzione dei servizi locali.
Di
seguito si riporta l’analisi grafica delle principali componenti della
spesa primaria della PA e dei suoi sottosettori, espressa in valori assoluti:
Grafico 2.1
Spesa
consolidata della PA - Valori assoluti (milioni di euro)

Nota: le scale dei grafici sono tra loro
diverse.
Gli
andamenti raffigurati mostrano che l’evoluzione crescente in valore assoluto
della spesa complessiva è pressoché integralmente spiegato dalla sua componente
previdenziale, con un modesto contributo della spesa corrente delle
amministrazioni locali. La spesa in conto capitale risulta pressoché costante
nel suo complesso, con un contributo variabile tra amministrazioni locali e
centrali.
Di
seguito gli stessi importi sono rappresentati in termini di incidenza sul PIL.
Grafico 2.2
Spesa
consolidata della PA – Incidenza sul PIL (milioni di euro)

Nota: le scale dei grafici sono tra loro diverse.
I grafici evidenziano che l’unica componente della
spesa primaria che mantiene invariata la propria incidenza sul PIL è quella
previdenziale. Le restanti componenti di spesa tendenziale registrano una
dinamica inferiore a quella del PIL.
2.2 Il quadro programmatico
Il Documento di economia e finanza per il
2014 presenta un quadro programmatico che si discosta da quello previsto per
l’Italia dalle regole di bilancio europee e nazionali. La raccomandazione del
Consiglio europeo del luglio 2013 invitava l’Italia a conseguire l’obiettivo di
medio termine (OMT - corrispondente al pareggio di bilancio) nel 2014.
In alternativa, l’Italia dovrebbe conseguire nel 2014 un aggiustamento del
saldo di bilancio strutturale pari ad almeno lo 0,5 per cento del PIL. Gli
stessi obblighi derivano dalla legge 243 del 2012 di attuazione del principio
costituzionale di bilancio in pareggio, la quale recepisce la normativa europea
nella definizione sia dell’equilibrio di bilancio che del percorso di
avvicinamento all’obiettivo stesso.
Il Governo, tuttavia, sostiene nel DEF
l’inopportunità di procedere in questa fase congiunturale dell’economia
italiana ad una correzione del saldo di bilancio che rischierebbe di rallentare
la ripresa avviata nell'ultimo trimestre del 2013. Il Governo si appella,
pertanto, alla possibilità offerta dalle regole di bilancio definite dal Patto
di stabilità e crescita (articolo 5 del regolamento (CE) 1466 del 1997 come
modificato dal regolamento (UE) 1175 del 2011) e dalla normativa nazionale
(articoli 3 e 6 della legge n. 243 del 2012) di allontanarsi temporaneamente
dall'OMT o dal percorso di avvicinamento ad esso in presenza di gravi recessioni
economiche oppure in relazione all'attuazione di riforme strutturali.
Il Patto di stabilità e crescita definisce
"grave recessione economica" un periodo di tasso di crescita negativo
del PIL reale o di perdita di prodotto accumulata durante un periodo in cui il
PIL reale è molto basso rispetto al PIL potenziale che si rifletta nell'output gap. Il Governo rileva che l'output gap del 2014 (-3,4 per cento del
PIL potenziale) è previsto ben al di sotto del valore medio (-2,7 per cento del
PIL potenziale) che dovrebbe prevalere, secondo quanto calcolato dalla
Commissione europea,
in presenza di una fase recessiva di un ciclo economico "normale".
Le variabili
utilizzate per l’analisi della finanza pubblica corretta per il ciclo: alcuni
elementi definitori
Il Patto di stabilità e crescita e l’insieme
di regole che costituiscono la governance
europea definiscono gli obiettivi di finanza pubblica in termini non solo in
termini nominali, ma anche strutturali.
Per ottenere il saldo strutturale
(indebitamento netto o saldo primario), occorre in primo luogo depurare il
saldo nominale dalla sua componente ciclica: se negativa, tale componente
migliora il saldo in termini strutturali; viceversa in caso di componente
ciclica positiva.
La componente ciclica del saldo di
bilancio è data dal prodotto tra l’output gap e la stima della
sensibilità al ciclo del saldo di bilancio. Questo è un parametro, il cui
valore, individuato sulla base degli andamenti registrati nell’arco di un
decennio, viene periodicamente aggiornato in sede europea; esso è attualmente
pari per l’Italia a 0,55, quale somma delle elasticità ponderate delle entrate
e delle spese.
Il saldo corretto per il ciclo va poi
depurato delle misure una tantum, sottraendo sia le entrate che
le spese identificate come straordinarie: in caso di prevalenza delle prime
sulle seconde il saldo strutturale risulterà peggiore del saldo corretto per il
solo ciclo, viceversa in caso di prevalenza delle spese sulle entrate.
Va infine osservato come variazioni nelle
stime del PIL (effettivo e potenziale) e dell’output gap determinano, a parità di parametro
relativo alla sensibilità del bilancio al ciclo e di valore nominale
dell’indebitamento netto o del saldo primario una variazione nel saldo
strutturale. Ciò si verifica con riferimento non solo agli esercizi di
previsione, ma anche per i valori di consuntivo.
PIL potenziale e output
gap
Il PIL potenziale rappresenta il livello
teorico massimo di produzione che un paese può raggiungere senza causare
tensioni inflazionistiche. Esso esprime, pertanto, i fattori fondamentali
dell’economia e la componente strutturale della crescita. La differenza tra il
livello del PIL effettivo e quello del PIL potenziale, espressa in percentuale
del PIL potenziale stesso, viene denominata output
gap.
Il PIL potenziale non è direttamente
osservabile, ma viene stimato secondo la metodologia approvata dall’Ecofin e
utilizzata dagli Stati membri dell’UE per il calcolo degli indicatori
strutturali di finanza pubblica riportati nei Programmi di stabilità.
Tale metodologia è basata sulla funzione di produzione e dipende quindi non
solo dalle ipotesi del quadro macroeconomico, ma anche dei parametri utilizzati
per la stima del tasso di disoccupazione strutturale (NAIRU) e della Total factor productivity (TFP).
Per quanto riguarda il NAIRU, i parametri
sono stati più volte rivisti dalla Commissione, alla luce degli effetti sul mercato
del lavoro della prolungata recessione. Il NAIRU è stato pertanto rideterminato
verso l’alto, determinando una riduzione nel tasso di crescita del PIL
potenziale. Ciò comporta, a sua volta, un più contenuto valore dell’output gap e della componente ciclica,
con effetti sul calcolo dei saldi di bilancio in termini strutturali.
Occorre inoltre rilevare che, a parità di
metodologia, riforme strutturali che incidessero sul costo del lavoro e/o sulla
produttività di tale fattore avrebbero l’effetto di ridurre stabilmente il
tasso di disoccupazione di equilibrio.
E’ da osservare infine che, poiché la
metodologia utilizza sia i valori del PIL effettivamente registrati a
consuntivo negli anni precedenti, sia il valore del PIL atteso nel periodo di
previsione, ne derivano due conseguenze: i) difficilmente il calcolo del PIL
potenziale è in grado di cogliere appieno i punti di inversione del ciclo e gli
effetti di cambiamenti strutturali; ii) la variazione del valore atteso del PIL
per il periodo di previsione o le modifiche riguardanti i dati di consuntivo
(conseguenti anche a revisioni contabili) determinano una revisione del PIL
potenziale, e quindi dell’output gap, anche negli anni in cui non
si è verificata alcuna variazione nella crescita effettiva (o attesa). Tali
revisioni influiscono, a loro volta, sul calcolo degli indicatori strutturali
di finanza pubblica (cfr. infra).
Il Governo motiva, inoltre, il rallentamento
nel percorso di avvicinamento all'OMT in base all'intenzione di approntare delle
riforme strutturali in grado di aumentare il tasso di crescita del PIL
potenziale.
Sulla base di tali considerazioni, il quadro
programmatico pospone il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale di
tre anni - dal 2013 al 2016 - rispetto all'obiettivo contenuto nel DEF 2013, e
di due anni - dal 2014 al 2016 - rispetto alla raccomandazione del Consiglio
europeo del luglio 2013. In
particolare, il DEF 2014 indica per il 2014 un disavanzo strutturale pari a
-0,6 punti percentuali di PIL, in miglioramento di 0,2 punti percentuali
rispetto al saldo del 2013 attestatosi a -0,8 per cento (cfr. la tabella 2.2 e
il grafico 2.3).
Tabella
2.2
Obiettivi
programmatici della PA
(in percentuale del
PIL)

Fonte: DEF 2014, Nota di aggiornamento del
DEF 2013 e DEF 2013.
Il percorso di avvicinamento all’OMT
riprenderà nel 2015, anno in cui il saldo strutturale è programmato al livello
di -0,1 per cento del PIL, quindi in miglioramento di 0,5 punti percentuali
rispetto all’anno precedente come richiesto dalle regole di bilancio europee e
nazionali. Nel 2016 il saldo di bilancio strutturale è previsto raggiungere
l’OMT, che si manterrà per il resto del periodo considerato.
Sulla base della stima aggiornata della
componente ciclica (rivista nel presente documento sulla base delle nuove
previsioni macroeconomiche), gli obiettivi di indebitamento netto nominale del
conto economico della pubblica amministrazione sono pari a -2,6 per cento nel
2014, -1,8 per cento nel 2015, -0,9 per cento nel 2016, -0,3 per cento nel 2017
e 0,3 per cento nel 2018 (cfr. la tabella 2.2 e il grafico 2.4). I valori
programmatici, pur rimanendo negativi, evidenziano una rapida discesa nell'arco
di programmazione, posizionandosi in modo deciso al di sotto della soglia
limite dell'ordinamento europeo, pari al 3 per cento di disavanzo sul PIL.
Rispetto alla Nota di aggiornamento, il peggioramento della posizione economica
del paese implica una correzione ciclica maggiore e quindi un disavanzo ciclico
consentito più ampio (grafico 2.5).
Grafico
2.3
Saldo
strutturale programmatico: confronto tra DEF 2014, Nota di aggiornamento 2013 e
DEF 2013

Fonti: DEF 2014, Nota di aggiornamento del
DEF 2013 e DEF 2013
Grafico
2.4
Indebitamento
netto programmatico: confronto tra DEF 2014, Nota di aggiornamento 2013 e DEF
2013

Fonti: DEF 2014, Nota di aggiornamento del
DEF 2013 e DEF 2013
Il grafico 2.5 mostra l’evoluzione
dell'indebitamento netto programmatico in relazione agli obiettivi strutturali
e all’andamento stimato dell’output gap,
cioè della misura del divario tra andamento economico effettivo e potenziale.
Esso evidenzia che - in presenza di pareggio strutturale - l'entità dell’output gap determina la misura del
disavanzo nominale consentito, cioè la misura della stabilizzazione consentita
per far fronte alla posizione ciclica negativa. Gli obiettivi nominali - dopo
un picco nel 2013 corrispondente all'ampliamento dell'output gap - si riducono di entità, in conseguenza della
progressiva chiusura attesa dell'output
gap.
Grafico
2.5
Andamento
del saldo nominale e strutturale in relazione all'output gap

Nota:
il grafico presenta i valori del saldo nominale, strutturale e output gap
a segni invertiti
Fonte: elaborazione su DEF 2014
L’avanzo primario nominale viene mantenuto
su livelli significativi, crescenti in tutto il periodo di programmazione,
passando dal 2,2 per cento del PIL nel 2013 al 5 nel 2018. Gli interessi sono
nettamente decrescenti, passando da 5,3 nel 2013 a circa 4,7 punti di
PIL nel 2018 (cfr. la tabella 2.2).
La tabella 2.3 espone le stime per gli anni
2013-2018 dei principali saldi programmatici di finanza pubblica in rapporto al
PIL, come rappresentati nel DEF 2014, nella Nota di aggiornamento al DEF 2013 e
nel DEF 2013.
Tabella
2.3
Indicatori
strutturali - Confronto documenti programmatici
|
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Tasso di crescita del PIL a
prezzi costanti
|
DEF-Progr.stabil 14
|
-2,4
|
-1,9
|
0,8
|
1,3
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
|
Nota agg DEF 2013
|
-2,4
|
-1,7
|
1,0
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
-2,4
|
-1,3
|
1,3
|
1,5
|
1,3
|
1,4
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
-2,4
|
-0,2
|
1,1
|
1,3
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
-1,2
|
0,5
|
1,0
|
1,23
|
|
|
|
|
Tasso di crescita del PIL
potenziale
|
DEF-Progr.stabil 14
|
-0,7
|
-0,4
|
-0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,7
|
0,8
|
|
Nota agg DEF 2013
|
-0,6
|
-0,3
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,6
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
-0,5
|
0,0
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,5
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
-0,6
|
-0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
-0,3
|
0,0
|
0,2
|
0,4
|
|
|
|
|
Output gap
|
DEF-Progr.stabil 14
|
-3,1
|
-4,5
|
-3,7
|
-2,7
|
-1,6
|
-0,5
|
0,6
|
|
Nota agg DEF 2013
|
-3,4
|
-4,8
|
-4,0
|
-2,7
|
-1,4
|
-0,2
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
-3,6
|
-4,8
|
-3,8
|
-2,6
|
-1,7
|
-0,8
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
-3,7
|
-3,8
|
-2,7
|
-1,7
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
-3,0
|
-2,6
|
-1,8
|
-1,0
|
|
|
|
|
Componente ciclica del saldo di
bilancio
|
DEF-Progr.stabil 14
|
-1,7
|
-2,5
|
-2,0
|
-1,5
|
-0,9
|
-0,3
|
0,3
|
|
Nota agg DEF 2013
|
-1,9
|
-2,6
|
-2,2
|
-1,5
|
-0,8
|
-0,1
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
-2,0
|
-2,7
|
-2,1
|
-1,5
|
-0,9
|
-0,5
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
-1,9
|
-1,9
|
-1,4
|
-0,8
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
-1,5
|
-1,3
|
-0,9
|
-0,5
|
|
|
|
|
Indebitamento netto
|
DEF-Progr.stabil 14
|
-3,0
|
-3,0
|
-2,6
|
-1,8
|
-0,9
|
-0,3
|
0,3
|
|
Nota agg DEF 2013
|
-3,0
|
-3,0
|
-2,5
|
-1,6
|
-0,8
|
-0,1
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
-3,0
|
-2,9
|
-1,8
|
-1,5
|
-0,9
|
-0,4
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
-2,6
|
-1,6
|
-1,5
|
-1,4
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
-1,7
|
-0,5
|
-0,1
|
0,0
|
|
|
|
|
Nota agg DEF 2011
|
-1,6
|
-0,1
|
0,2
|
|
|
|
|
|
Saldo primario
|
DEF-Progr.stabil 14
|
2,5
|
2,2
|
2,6
|
3,3
|
4,2
|
4,6
|
5,0
|
|
Nota agg DEF 2013
|
2,5
|
2,4
|
2,9
|
3,7
|
5,5
|
5,1
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
2,5
|
2,4
|
3,8
|
4,3
|
5,1
|
5,7
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
2,9
|
3,8
|
4,4
|
4,8
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
3,6
|
4,9
|
5,5
|
5,7
|
|
|
|
|
Misure una tantum
|
DEF-Progr.stabil 14
|
0,1
|
0,2
|
0,0
|
-0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Nota agg DEF 2013
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
-0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
0,1
|
-0,2
|
-0,1
|
-0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
-0,1
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
0,2
|
0,1
|
0,2
|
0,1
|
|
|
|
|
Saldo di bilancio corretto per
il ciclo al netto delle una tantum
|
DEF-Progr.stabil 14
|
-1,4
|
-0,8
|
-0,6
|
-0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Nota agg DEF 2013
|
-1,3
|
-0,4
|
-0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
-1,2
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
-0,9
|
0,2
|
-0,2
|
-0,5
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
-0,4
|
0,6
|
0,6
|
0,4
|
|
|
|
|
Variazione saldo di bilancio
corretto per ciclo al netto delle una tantum
|
DEF-Progr.stabil 14
|
-2,2
|
-0,6
|
-0,2
|
-0,5
|
-0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Nota agg DEF 2013
|
-2,3
|
-0,9
|
-0,1
|
-0,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
-2,3
|
-1,1
|
-0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
-2,7
|
-1,1
|
0,4
|
0,3
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
-3,2
|
-1,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
|
|
Saldo primario corretto per il
ciclo al netto delle una tantum
|
DEF-Progr.stabil 14
|
4,1
|
4,5
|
4,6
|
4,9
|
5,1
|
4,9
|
4,7
|
|
Nota agg DEF 2013
|
4,3
|
5,0
|
5,1
|
5,3
|
5,3
|
5,2
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
4,4
|
5,3
|
6,0
|
5,8
|
6,0
|
6,1
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
4,6
|
5,9
|
5,7
|
5,7
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
4,9
|
6,1
|
6,2
|
6,1
|
|
|
|
|
Variazione saldo primario
corretto per ciclo e al netto delle una tantum
|
DEF-Progr.stabil 14
|
|
0,4
|
0,1
|
0,3
|
0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
|
Nota agg DEF 2013
|
2,9
|
0,7
|
0,1
|
0,2
|
0
|
-0,1
|
|
|
DEF-Progr.stabil 13
|
2,9
|
0,9
|
0,7
|
-0,2
|
0,2
|
0,1
|
|
|
Nota agg DEF 2012
|
3,3
|
1,3
|
-0,2
|
0,0
|
|
|
|
|
DEF-Progr.stabil 12
|
3,6
|
1,2
|
0,1
|
-0,1
|
|
|
|
Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale
possono determinare incongruenze tra i valori in tabella.
N.B.: I valori dell'indebitamento netto e
del saldo primario sono quelli effettivi per gli esercizi passati e quelli
programmatici per il periodo di previsione. Fa eccezione la Nota di
aggiornamento 2012, in
cui il calcolo dei saldi strutturali si basa sui valori tendenziali a
legislazione vigente
La raccomandazione del Consiglio europeo del luglio 2013,
le valutazioni sul Documento programmatico di bilancio 2014 e le previsioni
invernali della Commissione europea
Nel luglio
2013 il Consiglio europeo ha adottato una raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2013
dell'Italia con il relativo parere sul programma di stabilità 2012-2017.
La raccomandazione si basava sulle analisi della politica economica e degli
squilibri macroeconomici compiuta dalla Commissione europea.
Il Consiglio raccomandava all'Italia per il
2014 di conseguire e mantenere l'Obiettivo di medio termine (OMT, cioè il
livello del saldo di bilancio strutturale fissato come obiettivo specifico per
ogni paese)
e di realizzare gli avanzi primari strutturali programmati per instradare il
rapporto debito/PIL su una traiettoria discendente, soprattutto attraverso un
miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'intervento pubblico ottenuto
mediante revisioni periodiche della spesa (spending
review).
Il Consiglio poneva l'attenzione sulla
necessità di attuare rapidamente le riforme per potenziare l'efficacia della
pubblica amministrazione, semplificare il quadro amministrativo e normativo,
rendere più efficiente la giustizia civile, potenziare il quadro giuridico di
repressione della corruzione e migliorare la gestione dei fondi UE nel
mezzogiorno.
Una raccomandazione riguardava il mercato
dei capitali, richiedendo di estendere le buone pratiche di governo societario
all'intero settore bancario, le cui attività devono continuare ad essere
sottoposte a controllo qualitativo anche agevolando la risoluzione dei prestiti
in sofferenza iscritti in bilancio, e di promuovere lo sviluppo del mercato dei
capitali per diversificare e facilitare l'accesso delle imprese ai
finanziamenti.
Prioritari erano il mercato del lavoro e la
disoccupazione giovanile. Il Consiglio incoraggiava il Governo ad adottare
misure idonee a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile e riformare il
mercato del lavoro; rilevava inoltre la necessità di adottare ulteriori
provvedimenti volti a migliorare l'accesso al mercato del lavoro delle donne,
programmando servizi sufficienti per l'infanzia e per l'assistenza agli
anziani.
In relazione al sistema fiscale, il
Consiglio raccomandava di trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a
consumi, beni immobili e ambiente, a parità di gettito complessivo, anche
attraverso la revisione delle agevolazioni fiscali, la riforma del catasto e la
prosecuzione della lotta all'evasione e all'economia sommersa.
Il Consiglio, infine, si soffermava sulla
corretta attuazione delle riforme volte all'apertura del mercato nel settore
dei servizi, in particolare di quelli professionali e di quelli pubblici
locali, al miglioramento dell'accesso al mercato nelle industrie di rete e al
potenziamento della capacità infrastrutturale per i trasporti e le
telecomunicazioni.
Nel novembre
2013 la Commissione europea ha adottato un parere sul Documento programmatico
di bilancio (DPB) predisposto dal Governo per illustrare i principali
aspetti della situazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche per il
2014-.
Il parere esaminava il progetto di bilancio e le proiezioni in esso contenute
in relazione a quelle del Programma di stabilità di aprile 2013 confrontandole
con quelle fornite dalla stessa Commissione nell'autunno del 2013. La
Commissione europea ricordava preliminarmente che l'Italia è soggetta al
braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita (PSC) e
deve pertanto assicurare la realizzazione di progressi sufficienti al
raggiungimento dell'OMT, nonché verso il rispetto della regola del debito
secondo le disposizioni transitorie valevoli nei tre anni successivi all'uscita
dalla procedura per disavanzi eccessivi (che per l'Italia è avvenuta nel 2012).
La Commissione notava il carattere
ottimistico delle previsioni di crescita economica del Governo per il 2014
rispetto a quelle di autunno della stessa Commissione (1,1 contro 0,7 per
cento). La Commissione osservava inoltre che il regolamento (UE) n. 473 del
2013 prescrive che il progetto di bilancio sia basato su previsioni
macroeconomiche elaborate o approvate da un ente indipendente, mentre quelle
contenute nel DPB sono state elaborate dal Governo, senza il coinvolgimento di
altre istituzioni. Il DPB affermava che a partire dal 2014 le previsioni
saranno approvate dal nuovo e indipendente Ufficio parlamentare di bilancio,
che avrà in particolare il compito di valutare le previsioni macroeconomiche e
di bilancio, di verificare il rispetto delle norme di bilancio (e l’attivazione
dei meccanismi di correzione) e di elaborare relazioni sulla sostenibilità di
bilancio a lungo termine.
La Commissione prevedeva nel 2014 un
disavanzo nominale più elevato di quello programmato dal Governo (2,7 contro
2,5 per cento del PIL) principalmente a causa della minore crescita economica.
Il saldo strutturale risultava così in linea con quello ricalcolato nel DPB. La
Commissione associava i rischi di revisione al ribasso delle previsioni di
bilancio alla mancata piena attuazione delle misure già sancite dalla
legislazione e all’indebolimento del DPB in Parlamento. Rispetto al documento
programmatico del Governo, la Commissione prevedeva un rapporto debito/PIL più
elevato nel 2013 (133 contro 132,9 per cento) e nel 2014 (134 contro 132,7 per
cento). Ciò era spiegato dalle peggiori prospettive di crescita e dalla minore
inflazione. Negli anni 2013-2014 il pagamento in corso dei debiti pregressi
aggiungeva circa 3 punti percentuali del PIL al debito quale definito nel
quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, mentre il sostegno ad altri
Stati membri della zona euro aggiungeva un ulteriore punto percentuale del PIL.
Al contrario, i proventi dei piani di privatizzazione del governo (0,5 per
cento sia nel 2013 che nel 2014) non erano presi in considerazione dalla
Commissione in quanto non sufficientemente dettagliati.
Le previsioni della Commissione circa
l'impatto del DPB sulla crescita e l'occupazione erano in linea con quelle del
Governo. Dalla valutazione complessiva del DPB, la Commissione traeva la
conclusione che l’Italia avrebbe compiuto progressi sufficienti verso
l’osservanza della regola del debito nel 2013 ma non nel 2014 a causa di un
aggiustamento strutturale insufficiente secondo le previsioni della Commissione
(0,12 punti percentuali del PIL contro gli 0,66 punti percentuali richiesti).
Per quanto riguarda l'obiettivo di medio termine il Consiglio europeo nella
raccomandazione formulata nei confronti dell’Italia in luglio chiedeva di
raggiungere l’OMT di un pareggio di bilancio strutturale nel 2014.
Il DPB rinviava invece il conseguimento dell’OMT al 2015, e migliorava il saldo
strutturale di soli 0,2 punti percentuali del PIL nel 2014, a causa della
maggiore spesa per investimenti prevista a motivo dell’applicazione della
“clausola sugli investimenti”. Tuttavia, poiché, secondo le previsioni della
Commissione, non rispetta il criterio del debito nel 2014 e di conseguenza non
può beneficiare della clausola sugli investimenti, l'Italia dovrebbe continuare
a compiere progressi sufficienti verso l’obiettivo di medio termine anche nel
2014, garantendo un aggiustamento strutturale, cioè un miglioramento del saldo
di bilancio strutturale, di almeno 0,5 punti percentuali del PIL. Inoltre,
secondo la Commissione, se lo scostamento si ripetesse nel 2015 potrebbe essere
ritenuto significativo e mettere a rischio l’osservanza delle prescrizioni del
braccio preventivo del PSC.
Con riferimento agli aspetti fiscali del
DPB, la Commissione osservava che la lieve riduzione del cuneo fiscale sul
lavoro e la maggiore deduzione per il nuovo capitale societario vanno nella direzione
indicata dalla raccomandazione di luglio sull’efficienza tributaria. Tuttavia
il nuovo tributo per i servizi comunali previsto nel DPB produrrà un gettito
inferiore a quello dell’imposta sugli immobili e del tributo per lo smaltimento
dei rifiuti cui doveva sostituirsi, riducendo ulteriormente la possibilità di
un trasferimento più sostanziale del carico fiscale. Inoltre, l’aumento di un
punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria (salita al 22 per cento)
dall’ottobre 2013 non risolve il problema dell’erosione della base imponibile
derivante dalla frequente applicazione di aliquote ridotte (del 10 o del 4 per
cento).
In conclusione, sulla base del rischio che
il DPB non consentisse una riduzione del rapporto debito/PIL in linea con il
parametro di riferimento, e dei limitati progressi sulla parte strutturale
delle raccomandazioni di bilancio formulate dal Consiglio europeo, la
Commissione invitava le autorità ad adottare, nell’ambito della decisione di
bilancio nazionale, le misure necessarie per assicurare che il bilancio 2014
sia pienamente conforme con il PSC e per affrontare i rischi individuati nella
valutazione del DPB. La Commissione invitava altresì le autorità ad accelerare
i progressi verso l’attuazione delle raccomandazioni di bilancio formulate dal
Consiglio.
Nel marzo
2014 la Commissione europea ha pubblicato le previsioni invernali nelle
quali sono stati evidenziati i seguenti andamenti.
Le ultime previsioni programmatiche del Governo, contenute nella Nota
tecnico-illustrativa indicavano per il 2014 un indebitamento netto pari a -2,5
per cento del PIL, migliore di 0,1 punti percentuali rispetto a quello della
Commissione (-2,6 per cento). La Commissione europea non sconta nelle
previsioni di spesa la riduzione conseguente al programma di spending review annunciato dal Governo,
in quanto il meccanismo di previsione cosiddetto "a politiche
invariate" prevede soltanto la considerazione di misure che siano
sufficientemente dettagliate[29].
Per i medesimi motivi non sono considerate le riduzioni delle agevolazioni
fiscali, di cui 3 miliardi previsti per il 2014[30].
Inoltre, con specifico riferimento alla spesa per i redditi da lavoro
dipendente, la Commissione prevede per il 2014 una riduzione dell’aggregato
rispetto al 2013 dovuta alla sostanziale stabilità delle retribuzioni e ad una
riduzione del numero di occupati nella PA; per il 2015, invece, la spesa è
prevista in lieve aumento quale risultato di una contrazione del numero degli
occupati e di un aumento delle retribuzioni in linea con l’inflazione
programmata.
Per quanto riguarda il saldo di bilancio
strutturale, cioè al netto della componente ciclica e delle misure una tantum, la Commissione europea stima
per il 2014 un valore pari a ‑0,6 per cento, rispetto al -0,7 per cento
previsto in autunno.
Le stime della Commissione confermano valori
del saldo strutturale più elevati rispetto a quelli indicati dal Governo nel
DPB dell'ottobre scorso (-0,3 per cento nel 2014).
Le valutazioni espresse in occasione
dell'esame del DPB sono state sostanzialmente confermate nell’opinione espressa
dalla Commissione a seguito dell’analisi approfondita sull’Italia nell’ambito
della procedura sugli squilibri macroeconomici. Nella comunicazione della
Commissione diffusa il 5 marzo scorso[31],
con riferimento alla finanza pubblica, si afferma, infatti, che “nel 2013
l’Italia ha compiuto progressi verso l’obiettivo di bilancio a medio termine.
Tuttavia l’aggiustamento del saldo strutturale nel 2014 potrebbe risultare
insufficiente, vista la necessità di ridurre l’elevatissimo rapporto debito
pubblico/PIL a un ritmo adeguato”.
Sulla base di quanto sopra, l'indebitamento
netto strutturale del 2014 coerente con la valutazione della Commissione
sarebbe, pertanto, pari a -0,3 per cento del PIL (derivante da un miglioramento
di 0,5 punti percentuali rispetto al livello del 2013, stimato pari a 0,8 per
cento nelle Winter forecast).
2.2.1
La manovra di correzione
Il confronto tra l'indebitamento netto
programmatico e a legislazione vigente (tendenziale) evidenzia che per
l'esercizio 2014 non vi è necessità di operare una correzione netta dei saldi,
coincidendo i saldi programmatici con la dinamica tendenziale dei conti. Il
raggiungimento degli obiettivi programmatici richiederà invece una azione di
correzione a partire dal 2015.
La tabella 2.4 indica che la misura della correzione
dell'indebitamento netto richiesta per raggiungere gli obiettivi
programmatici sarebbe pari a 0,2 per cento del PIL nel 2015 e a 0,6 per cento
in ciascun anno del periodo 2016-2018.
La correzione del saldo primario
tendenziale sarebbe uguale a quella dell'indebitamento netto in ogni anno
del periodo considerato ad eccezione del 2015, anno in cui il saldo primario
verrebbe corretto di 0,3 punti percentuali di PIL per compensare l'aumento di
0,1 punti percentuali (da 5 a
5,1 per cento del PIL) della spesa per interessi programmatica rispetto alla
spesa tendenziale.
Tabella
2.4
Misura
della correzione dell'indebitamento netto e del saldo primario tendenziali
(in percentuale del
PIL)

Fonte: Elaborazione su dati DEF 2014,
Sezione I, Tavola I.1 e Tavola III.2.
Nota: eventuali incongruenze tra le cifre
sono dovute agli arrotondamenti.
Il Governo afferma che parte della
correzione avverrà tramite riduzioni di spesa attuate nell'ambito del processo
di spending review. Le riforme
strutturali annunciate non produrranno effetti negativi sui saldi di bilancio
in quanto saranno reperiti adeguati mezzi di copertura finanziaria.
Si
ricorda che la legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009)
richiede che la sezione I del DEF indichi l'articolazione della manovra
necessaria per il conseguimento degli obiettivi almeno per un triennio, nonché
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere
i predetti obiettivi (art. 10, comma 2, lett. f)).
2.2.2
I saldi per sottosettore
Il DEF 2014 espone l’obiettivo di
indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; viene altresì indicato il
saldo a legislazione vigente dei sottosettori della PA: amministrazioni
centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza (tabella 2.5).
Il DEF evidenzia che nell'intero periodo gli
enti di previdenza registrerebbero un indebitamento netto tendenziale stabile
(pari a 0,1 punti di PIL) mentre le amministrazioni locali registrerebbero
un indebitamento nullo. Il percorso di contenimento dell’indebitamento netto
della PA viene pertanto riflesso nel saldo delle amministrazioni centrali, il
quale passa dal -2,7 per cento del PIL nel 2014 al -0,4 per cento nel 2018.
La tabella 2.5 mostra anche la variazione
cumulata del saldo primario necessaria a ricondurre l'evoluzione
dell'indebitamento netto della PA a legislazione vigente all'obiettivo
programmatico.
Si
rileva che - poiché il DEF 2014 non indica la ripartizione per sottosettore
delle azioni di correzione richieste a partire dal 2015 - non è possibile
desumere i saldi programmatici per sottosettore. Si ricorda che la legge di
contabilità richiede che i saldi programmatici siano articolati per
sottosettore (art. 10, comma 2, lett. e)).
Tabella
2.5
Indebitamento
netto per sottosettore.
(in
percentuale del PIL)

Fonte: DEF 2014, Sezione I, Tavola III.2.
Nota: eventuali incongruenze tra le cifre
sono dovute agli arrotondamenti.
2.2.3
La regola della spesa
Le modifiche del Patto di stabilità e
crescita del 2011 hanno introdotto un vincolo sull'evoluzione della spesa. Esso
è stato recepito anche nell'ordinamento nazionale con l'articolo 5 della legge
n. 243 del 2012 di attuazione del principio di pareggio del bilancio.
Il tasso di crescita dell'aggregato di spesa
di riferimento per la regola è calcolato secondo l'ipotesi di politiche
invariate e non incorpora, pertanto, l'effetto delle misure programmate dal
Governo. Le spese da escludere nel calcolo dell'aggregato di spesa di
riferimento che deve rispettare la regola sono indicate nella tabella 2.6.
Il tasso di crescita limite (benchmark) è fissato dalla Commissione
europea pari a -0,81 per il triennio 2011-2013, è ulteriormente ridotto a -1,07
per il triennio 2014-2016 ed è pari a 0,0 per gli anni 2017 e 2018.
La tabella 2.7, che indica i passaggi e gli
importi necessari per calcolare il tasso di crescita dell'aggregato di spesa di
riferimento nonché il relativo limite massimo consentito dalla regola (benchmark), mostra che la spesa è
diminuita ad un tasso medio del 3 per cento circa nel periodo 2011-2013 (-3,2
nel 2011, -4,38 nel 2012 e -2,35 nel 2013), superiore al benchmark di -0,81 fissato dalla regola, che pertanto risulta
osservata.
Nel triennio successivo, invece, la
proiezione a politiche invariate stima un tasso di variazione della spesa
(-0,64 nel 2014, 0,74 nel 2015 e -0,41 nel 2016) non compatibile con lo sforzo
ulteriore di riduzione imposto dalla regola (-1,07) che pertanto non risulta
osservata.
Il Governo evidenzia che gli scostamenti del
tasso di crescita della spesa dal benchmark
di riferimento non producono sul saldo di bilancio strutturale deviazioni
reputate significative dalle regole di bilancio europee e nazionali (superiori
a 0,5 punti percentuali di PIL in un anno o 0,25 punti percentuali in due
anni). Il Governo precisa inoltre che gli interventi correttivi della spesa
programmati a partire dal 2015 saranno sufficienti a ricondurre l'evoluzione
della spesa entro il limite previsto dalla regola.
Tabella
2.6
Spese da
escludere dalla regola della spesa

1) In milioni di euro.
2) La componente ciclica della spesa per
sussidi di disoccupazione è stata calcolata utilizzando l'elasticità all'output gap riportata nella pubblicazione
‘The cyclically-adjusted budget balance
used in the EU fiscal framework: an update’ di Mourre et al., European Economy
- Economic papers No. 478, marzo 2013.
3) Le entrate discrezionali includono gli
effetti netti sulle entrate derivanti dalle seguenti misure: D.L. n. 98/2011;
D.L. n. 201/2011; D.L. n. 92/2012; Legge di Stabilità 2013; D.L. n. 43/2013;
D.L. n. 102/2013; Legge di Stabilità 2014. Sono comprese le entrate
discrezionali contributive. In particolare, per queste ultime, gli importi
tengono conto degli effetti dei seguenti provvedimenti: D.L. n. 201/2011, D.L.
n. 54/2013, Legge di Stabilità 2014.
Tabella
2.7
Applicazione
della regola della spesa
(milioni di euro)

1) L'aggregato di spesa di riferimento è
coerente con i valori presentati nel conto della P.A (tavola III.2), sottraendo
al totale delle spese a politiche invariate l’ammontare della spesa per
interessi, delle spese finanziate con fondi UE, la componente ciclica delle
indennità di disoccupazione e considerando la spesa media per investimenti
(calcolata sull’anno in corso e i precedenti tre anni). Sono inoltre sottratte
le misure discrezionali sulle entrate e i contributi sociali (tavola III.3). Il
tasso di crescita della spesa di riferimento è stato deflazionato per mezzo dei
tassi forniti dalla Commissione negli anni 2011-2015, mentre negli anni
successivi è stato utilizzato il tasso di crescita del deflatore del PIL
esposto nella tavola II.2b.
2.2.4
La regola del debito
Il quadro programmatico del DEF 2013 evidenzia
una crescita del rapporto debito/PIL, al lordo dei contributi italiani a
sostegno dell'area dell'euro, dal 132,6 per cento del 2013 al 134,9 per cento
del 2014, mentre negli esercizi successivi è prevista una progressiva riduzione
dal 133,3 per cento del 2015 al 120,5 per cento del 2018.
Tale dinamica è realizzata scontando - sin
dal 2014 - introiti da privatizzazioni pari a 0,7 punti percentuali di PIL
all'anno, il pagamento nel 2014 dei debiti pregressi della PA per ulteriori 13
miliardi, nonché il raggiungimento dell'OMT nel 2016 e il suo mantenimento
negli anni successivi (cfr. tabella 2.8).
Tabella
2.8
Andamento
del rapporto debito/PIL della PA a confronto.
(in
percentuale del PIL)

Fonte: Documento di economia e finanza 2014,
Sezione I (DEF 2014), Fiscal Monitor 2014
del Fondo monetario internazionale (FM FMI 2014), Winter Forecast 2014 della Commissione europea (WF CE 2014) e Nota
di aggiornamento al DEF 2013 (Nota agg. DEF 2013).
Rispetto all'andamento programmatico
riportato nella Nota di aggiornamento al DEF 2013, le stime del DEF 2014
risultano mediamente maggiori di circa 4 punti percentuali di PIL nel periodo
2014-2017. Inoltre, l'inizio della riduzione del rapporto debito/PIL è
posticipato dal 2014 (Nota di aggiornamento al DEF 2013) al 2015 (DEF 2014).
Rispetto alle previsioni – a politiche invariate – di inverno della Commissione
europea, invece, il debito previsto dal DEF 2014 risulta in media superiore di
1 punto percentuale di PIL nel biennio 2014-2015.
Anche per la Commissione il debito è previsto ridursi a partire dal 2015.
Il Fondo monetario internazionale stima, a
politiche invariate, un debito inferiore a quello previsto dal DEF sia nel 2014
(134,5 per cento del PIL) che nel 2015 (133,1 per cento) mentre le stime sono
superiori a quelle del DEF in media di 2,5 punti percentuali nel triennio
2016-2018. Il Fondo monetario internazionale prevede una riduzione del rapporto
debito/PIL a partire dal 2015.
La conformità da parte dell'Italia alla
regola del debito - introdotta dalla nuova governance
economica europea - verrà valutata dalla Commissione e dal Consiglio europeo
relativamente al rapporto debito/PIL del 2015, cioè al termine del periodo di
transizione previsto dopo la chiusura della procedura per deficit eccessivo
(2013-2015). Nel periodo di transizione l'Italia deve assicurare un
aggiustamento strutturale minimo del saldo di bilancio (Minimum linear structural adjustment - MLSA) tale da consentire di
colmare gradualmente la differenza tra il debito previsto e quello che
consentirebbe di rispettare la regola al termine del periodo di transizione.
La regola del debito è stata recepita nell'ordinamento nazionale con l'articolo
4 della legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio dell'equilibrio di
bilancio in Costituzione.
Nel DEF 2014 l'aggiustamento lineare
strutturale minimo calcolato dal Governo a legislazione vigente è pari a circa
0,6 punti percentuali di PIL nel 2014 e 1,1 punti percentuali nel 2015 (cfr.
tabella 2.9), da cui discenderebbe la necessità di un aggiustamento ulteriore
nel 2014 pari a 0,5 punti percentuali di PIL rispetto a quello previsto (0,2
per cento del PIL).
Tabella
2.9
Aggiustamento
lineare strutturale minimo nel periodo di transizione verso l'osservanza della
regola del debito nel 2015.
(in percentuale del PIL)

Fonte: DEF 2014, Sezione I, Tavola III.12,
pag. 56.
Il Governo sostiene tuttavia che tenendo
conto dello scenario programmatico delineato nel DEF stesso - implementazione
del piano di rientro dal 2015, raggiungimento dell'OMT nel 2016, piano di
privatizzazioni pari allo 0,7 per cento del PIL annuo nel periodo 2014-2017 -
si modificherebbe il profilo evolutivo del debito pubblico riducendo
l'aggiustamento lineare strutturale minimo richiesto per rispettare la regola
nel 2015. Il valore dell'aggiustamento così ricalcolato è mostrato nella
tabella 2.9. In particolare, le misure descritte nel DEF 2014 permetterebbero
il rispetto della regola del debito nella formulazione forward-looking, cioè per il 2017, senza alcun aggiustamento
ulteriore nel 2014.
Nel parere sul documento programmatico di
bilancio (DPB) dello scorso novembre, la Commissione europea rilevava che in
base alle proprie previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e alle
prospettive di bilancio delineate dal Governo nel DPB, l'Italia non avrebbe
compiuto progressi sufficienti nel 2014 verso l'osservanza della regola del
debito in quanto l'aggiustamento del saldo di bilancio strutturale previsto
dalla Commissione (pari a circa 0,12 punti percentuali di PIL) era
eccessivamente distante da quello richiesto (MSLA) per il 2014 durante il
periodo di transizione (pari a circa 0,66 per cento di PIL).
Ciò ha impedito all'Italia di beneficiare della "clausola sugli
investimenti" invocata dal Governo nel DPB per giustificare uno
scostamento dal percorso di avvicinamento del saldo di bilancio strutturale
verso l'obiettivo di medio termine. A tal proposito, la Commissione ha
specificato che "occorre che le previsioni della Commissione (e non quelle
del Governo) attestino il rispetto di entrambi i criteri di debito e disavanzo
della procedura per i disavanzi eccessivi".
Le stesse considerazioni sono state da ultimo ribadite dalla Commissione
europea nella revisione approfondita sull'Italia compiuta ai sensi del
regolamento (UE) n. 1176 del 2011 dove si evidenzia l'esistenza del rischio che
l'aggiustamento del saldo di bilancio strutturale si riveli insufficiente nel
2014 data la necessità di ridurre l'elevato debito pubblico ad un ritmo
adeguato.
Le
considerazioni del DEF 2014 si basano sull'evoluzione programmatica del debito,
il quale incorpora gli effetti delle misure proposte. La valutazione da parte
della Commissione europea, e le conseguenti raccomandazioni del Consiglio
europeo, terranno conto anche dell’evoluzione dei saldi di finanza pubblica e
del quadro macroeconomico prevista a politiche invariate. Secondo il principio
della previsione a politiche invariate "soltanto le misure che siano state
chiaramente specificate e per cui ci sia un impegno da parte dei governi sono
prese in considerazione". In particolare, le misure di politica di
bilancio che siano state annunciate ma non ancora incluse in proposte normative
possono essere considerate purché siano specificate in sufficiente dettaglio e
il Governo sia impegnato a realizzarle in modo credibile. La plausibilità dello scenario a politiche
invariate viene considerata in modo specifico nella valutazione del Programma
di stabilità da parte della Commissione europea.
Il ruolo dei fattori rilevanti nella
valutazione del debito
Nel caso di mancato rispetto della regola
del debito, prima di aprire una procedura per disavanzo eccessivo la
Commissione europea è tenuta a prendere in considerazione eventuali
"fattori rilevanti" che possano influire sull'evoluzione programmatica
del debito.
Particolare rilevanza assumono i contributi finanziari di sostegno alla
stabilità finanziaria dell'area dell'euro (EFSF, ESM e contributi bilaterali
alla Grecia) nonché la composizione degli aggiustamenti stock-flusso.
Il DEF 2014 evidenzia numerosi fattori
rilevanti aventi effetti sul livello programmatico del debito. Innanzitutto il
generale andamento economico degli anni più recenti (circa -9 punti percentuali
di PIL reale dal 2007 ad oggi) che spiega, secondo il Governo, la maggior parte
dell'evoluzione del rapporto debito/PIL dal 2011 in poi.
Un secondo fattore rilevante è legato agli
aggiustamenti stock-flusso derivanti
dalle operazioni di assistenza finanziaria agli altri paesi europei (contributi
in conto capitale per l'ESM, erogazioni all'ESFS e prestiti bilaterali alla
Grecia) nonché al pagamento dei debiti commerciali arretrati della Pubblica
amministrazione. Il DEF stima un impatto complessivo delle suddette operazioni
di aggiustamento stock-flusso pari al
4,6 per cento del PIL nel 2013, 6,8 per cento nel 2014 e 6,6 per cento nel
2015.
Dal
contenuto del DEF relativo ai fattori rilevanti non risulta chiaro se la stima
dell'impatto delle operazioni di aggiustamento stock-flusso comprenda le misure
aggiuntive di pagamento dei debiti pregressi della PA. Sarebbe opportuno un
chiarimento in merito da parte del Governo.
Infine, nel DEF il Governo sottolinea il
carattere relativamente favorevole, rispetto agli altri paesi sviluppati, della
struttura e della dinamica del debito italiano. Ciò con particolare riguardo
alla struttura per scadenze tra le più lunghe in Europa, alla denominazione in
euro del 100 per cento del debito pubblico italiano, con conseguente assenza di
rischi valutari, alla frazione ridotta di detentori "stranieri", al
basso livello delle passività implicite e al basso livello del debito delle
famiglie rispetto agli altri paesi dell'area euro.
Si
rammenta che l'adozione da parte dei paesi membri dell'Unione europea del nuovo
Sistema europeo dei conti 2010 - Sec 2010 - in sostituzione del Sec 95 a partire dal settembre
2014 produrrà una modifica dei criteri di classificazione delle unità
istituzionali ai fini dell'appartenenza o meno alla pubblica amministrazione.
Ciò potrebbe comportare un ingresso di alcune società partecipate dagli enti
pubblici, attualmente classificate come unità istituzionali private,
all'interno del perimetro della pubblica amministrazione. In base ai risultati
di bilancio delle stesse società il livello di debito pubblico potrebbe
pertanto variare rispetto a quello attuale. Sarebbe opportuno che il Governo
chiarisse se nel computo delle passività implicite della Pubblica
amministrazione si tiene conto di tale eventualità.
2.3
Spesa per interessi, fabbisogno e debito
La spesa per interessi
Nelle nuove stime del Documento di economia
e finanza 2014,
la spesa per interessi nel 2013 risulta pari a 82.043 milioni,
con una riduzione rispetto al dato del 2012 di 4.431 milioni.
Dal confronto con i dati contenuti nella
Nota di aggiornamento 2013 e con la successiva Nota tecnico illustrativa LS
2014, si osserva che la stima attuale per l’anno 2013 registra una netta
diminuzione della spesa. In particolare, la revisione delle stime mostra una
correzione in diminuzione della spesa di circa 1.900 milioni sia rispetto al
valore stimato nel DEF 2013 sia rispetto a quello contenuto nella Nota di
aggiornamento.
Negli anni 2014 e 2015 le
previsioni a legislazione vigente mostrano una spesa per interessi pari rispettivamente
a 82.550 milioni (con un aumento rispetto al 2013 di 507 milioni) e a 82.096
milioni. Rispetto alle precedenti stime, si osserva una netta correzione al
ribasso e una generale stabilizzazione dell’andamento di tale aggregato, il
quale raggiunge nel 2018, ultimo anno considerato dalla serie, il valore
massimo di 85.502 milioni.
In termini di incidenza sul PIL, la spesa
passa dal 5,3 per cento del 2013 al 5,1 per cento del 2016, per attestarsi ad
un valore pari a 4,8 punti percentuali di PIL alla fine del 2018.
Tabella
2.10
Spesa per
interessi, andamento tendenziale a legislazione vigente: confronto tra Nota di
aggiornamento del DEF 2013, Nota tecnico illustrativa LS2014 e Documento di
economia e finanza 2014
(milioni di euro - % PIL)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota agg. DEF 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
Spesa per interessi
|
83.949
|
86.087
|
88.827
|
91.858
|
92.500
|
-
|
|
Variazione assoluta
|
- 2.768
|
2.138
|
2.740
|
3.031
|
642
|
-
|
|
Variazione %
|
-3,2
|
2,5
|
3,2
|
3,4
|
0,7
|
-
|
|
in
percentuale del PIL
|
5,4
|
5,4
|
5,3
|
5,3
|
5,2
|
-
|
|
PIL
nominale
|
1.557,3
|
1.602,9
|
1.660,7
|
1.718,4
|
1.779,6
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NTI LS 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
Spesa per interessi
|
83.949
|
86.099
|
88.832
|
91.858
|
-
|
-
|
|
Variazione assoluta
|
- 2.768
|
2.150
|
2.733
|
3.026
|
-
|
-
|
|
Variazione %
|
-3,2
|
2,6
|
3,2
|
3,4
|
-
|
-
|
|
in
percentuale del PIL
|
5,4
|
5,4
|
5,3
|
5,3
|
-
|
-
|
|
PIL
nominale
|
1.558,3
|
1.604,4
|
1.661,3
|
1.719,6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
Spesa per interessi
|
82.043
|
82.550
|
82.096
|
85.339
|
85.379
|
85.502
|
|
Variazione assoluta
|
-4.431
|
507
|
- 454
|
3.243
|
40
|
123
|
|
Variazione %
|
-5,1
|
0,6
|
-0,5
|
4,0
|
0,0
|
0,1
|
|
in percentuale del PIL
|
5,3
|
5,2
|
5,0
|
5,1
|
4,9
|
4,8
|
|
PIL nominale
|
1.560
|
1.587
|
1.626,8
|
1.676,6
|
1.731
|
1.788,9
|
|
|
Fonte: Elaborazioni su dati MEF
Con riferimento all’anno 2013, il DEF – PdS
precisa che in tale anno la crescita della spesa per interessi ha subito
un’interruzione dovuta alla maggiore credibilità del Paese e al progressivo
dissolversi delle tensioni sul mercato dei titoli del debito sovrano. Le
migliorate condizioni nel costo medio ponderato sulle nuove emissioni, passato
dal 3,11 per cento nel 2012 al 2,08 per cento nel 2013, ha più che
compensato l’aumento rispetto al 2012 nel volume di emissioni nette,
verificatosi nel corso dell’anno per far fronte all’incremento del fabbisogno
delle Amministrazioni centrali, ascrivibile anche alla maggior provvista
necessaria per coprire i prestiti alle Amministrazioni locali finalizzati al
rimborso dei debiti commerciali nei confronti del settore privato.
Per gli anni 2014-2018, la spesa rispetto al
PIL segue un percorso di riduzione progressiva, per arrivare ad un valore pari
a 4,9 per cento nel 2017, inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto a quanto
stimato in sede di Nota di aggiornamento a settembre 2013.
Il Documento sottolinea che tali previsioni
sono state formulate assumendo che il differenziale dei tassi di interesse
sulla Germania sulla scadenza a 10 anni rimanga in linea con quello corrente
per il 2014, per poi scendere progressivamente a 150 punti base nel 2015 e a
100 punti base dalla fine del 2016 (le ipotesi rispecchiano, pertanto, quelle
formulate in sede di Nota di aggiornamento al DEF 2013). Tuttavia il Documento
precisa che a spiegare la riduzione delle stime rispetto a quelle formulate a
settembre scorso sono principalmente il percorso più accelerato di riduzione
dello spread il primo anno e
il livello assoluto dei tassi tedeschi, attualmente inferiore a quello di
settembre 2013.
Tabella 2.11
Ipotesi
utilizzate per i tassi di interesse
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Tasso di
interesse a breve termine
|
0,24
|
0,61
|
0,85
|
1,26
|
1,79
|
2,19
|
|
Tasso di
interesse a lungo termine
|
4,38
|
3,61
|
3,61
|
3,43
|
3,45
|
3,65
|
|
|
Fonte: PdS-DEF 2014
Nota: per tasso di interesse a breve termine
si intende la media dei tassi previsti sui titoli di Stato a 3 mesi in
emissione durante l’anno. Per tasso di interesse a lungo termine si intende la
media dei tassi previsti sui titoli di Stato a 10 anni in emissione durante
l’anno.
Come rilevato dalla Banca d’Italia,
dalla fine di settembre la stabilizzazione del quadro interno e il
consolidamento delle prospettive di crescita nell’area dell’euro hanno
contribuito al miglioramento delle condizioni del mercato dei titoli di Stato
italiani. In novembre, i prezzi di tali titoli sono stati sostenuti anche dal
buon esito di alcune operazioni di concambio effettuate dal Tesoro di titoli a
breve scadenza con titoli a più lungo termine e dalla cancellazione di alcune
aste programmate per la fine dell’anno, in virtù di una minore esigenza di
finanziamenti. Tra la fine di settembre e la metà di gennaio i rendimenti dei
BTP sono sensibilmente diminuiti (di 55 punti base, al 3,9 per cento sulla
scadenza a dieci anni), nonostante un lieve aumento dei tassi di interesse a
lungo termine sui titoli considerati più sicuri; il differenziale di rendimento
tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi si è ridotto di 58 punti
base, a 207. Nel periodo successivo, il differenziale ha confermato una
tendenza alla riduzione (in data 9 aprile 2014 risultava pari a circa 161 punti
base).
Si segnala infine che, con Decisione del 3
aprile 2014, il Consiglio direttivo della BCE ha deliberato di mantenere
invariato, ad un valore dello 0,25 per cento, il tasso minimo sulle operazioni
di rifinanziamento principali.
Grafico
2.6
Differenziale
di rendimento BTP-BUND-BENCHMARK10 anni

Nota: grafico tratto dal Pds-DEF 2014
Il fabbisogno del settore pubblico
I
risultati del 2013
Il fabbisogno, corrispondente alla
differenza (negativa) tra il totale degli incassi e il totale dei pagamenti
(correnti, in conto capitale e finanziari), è un indicatore utilizzato per il
monitoraggio e la gestione della finanza pubblica secondo il profilo di cassa.
Per il calcolo del fabbisogno il MEF
effettua la somma algebrica fra il saldo del conto economico e quello delle
attività finanziarie, al netto dell’accensione e del rimborso di prestiti. Non
incidono sulla determinazione del fabbisogno le garanzie fornite dallo Stato
sulle emissioni di titoli effettuate dallo European
Financial Stability Fund (EFSF); ciò in quanto tali garanzie sono attivate
solo nel caso in cui l’EFSF non adempia i propri obblighi nei confronti dei
creditori. Sono esclusi, inoltre, dalla determinazione del fabbisogno, i
proventi delle dismissioni di azioni e partecipazioni in quanto destinati al
fondo ammortamento del debito pubblico.
Pertanto, il fabbisogno rappresenta
l’ammontare di liquidità necessaria per finanziare l’attività pubblica. Poiché
tale liquidità è reperita sul mercato con l’emissione di titoli del debito
pubblico, il fabbisogno rappresenta la principale componente della variazione
annuale dello stock di debito pubblico.
Nel 2013 il settore pubblico
ha registrato incassi totali per 765.418 milioni e pagamenti totali per 839.420
milioni da cui risulta un fabbisogno pari a – 74.001 milioni di euro.
Considerando i pagamenti al netto della voce interessi passivi (pari, nel 2013, a 83.383 milioni) si
ottiene un saldo primario pari a + 9.381 milioni.
Rispetto al 2012, il fabbisogno registra un
peggioramento (dal 3,2% del PIL al 4,7%) dovuto sia all’incremento dei
pagamenti finali sia, anche se in misura minore, alla riduzione degli incassi
finali.
L’evoluzione del saldo risente, fra l’altro,
degli effetti dei provvedimenti adottati nel 2013 in merito al pagamento
dei debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche nonché della revisione
contabile del bilancio dello Stato operato a seguito dell’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane.
Sono rientrati, infatti, tra i pagamenti correnti, le vincite dei giochi
gestiti dalla ex Amministrazione dei Monopoli di Stato.
La tabella 2.12 consente un confronto del
dato relativo al fabbisogno pubblico del 2013 con quello degli anni precedenti.
Tabella 2.12
|
|
milioni di euro
|
percentuale del PIL
|
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Incassi
correnti
|
737.227
|
754.018
|
755.700
|
46,7
|
48,1
|
48,4
|
|
Incassi in
conto capitale
|
9.380
|
7.325
|
7.102
|
0,6
|
0,5
|
0,5
|
|
Incassi
partite finanziarie
|
2.871
|
10.341
|
2.617
|
0,2
|
0,7
|
0,2
|
|
TOTALE INCASSI
|
749.478
|
771.685
|
765.418
|
47,4
|
49,2
|
49,1
|
|
Pagamenti
correnti
|
746.356
|
754.998
|
777.014
|
47,2
|
48,2
|
49,8
|
|
di cui interessi passivi
|
77.616
|
82.769
|
83.383
|
4,9
|
5,3
|
5,3
|
|
Pagamenti in
conto capitale
|
54.281
|
54.002
|
46.935
|
3,4
|
3,4
|
3,0
|
|
Pagamenti
partite finanziarie
|
12.093
|
12.761
|
15.470
|
0,8
|
0,8
|
1,0
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
812.730
|
821.761
|
839.420
|
51,4
|
52,4
|
53,8
|
|
Saldo di parte corrente
|
-9.129
|
-980
|
-21.314
|
-0,6
|
-0,1
|
-1,4
|
|
Saldo primario
|
14.364
|
32.693
|
9.381
|
0,9
|
2,1
|
0,6
|
|
Fabbisogno
|
-63.252
|
-50.076
|
-74.001
|
-4,0
|
-3,2
|
-4,7
|
I pagamenti di carattere finanziario
(15.470 milioni nel 2013 rispetto a 12.761 nel 2012) comprendono, tra l’altro,
le erogazioni relative alle quote di sottoscrizione dell’aumento di capitale
della Banca Europea per gli Investimenti, del Meccanismo Europeo di Stabilità e
di strumenti finanziari a favore del Monte Paschi di Siena.
Il saldo degli incassi finali evidenzia
una riduzione di 6.266 milioni rispetto al 2012 dovuta all’effetto combinato
di:
-
una riduzione degli incassi relativi alle partite
finanziarie -7.725 milioni) che, nel 2012, avevano registrato un forte
incremento per effetto del versamento in tesoreria statale delle disponibilità
detenute dalla Amministrazioni locali sui propri conti correnti bancari in
seguito alla sospensione del regime di tesoreria mista;
-
un incremento degli incassi correnti (+1.682 milioni)
determinato, da un lato, dall’incremento dei trasferimenti alle famiglie
(+10.760 milioni) e, dall’altro lato, dalla riduzione degli incassi tributari
(-7.169 milioni) e contributivi (-1.233 milioni);
-
una riduzione degli incassi in conto capitale di 223
milioni.
Analizzando, in particolare, gli incassi
correnti si segnala che:
-
l’incremento dei trasferimenti alle famiglie è
imputabile, in analogia alle variazioni intervenute nei trasferimenti dalle
famiglie inclusi nelle spese correnti, ad una revisione contabile del bilancio
dello Stato operato a seguito dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato nell’agenzia delle dogane;
-
la riduzione degli incassi tributari e contributivi
riflettono sia i maggiori rimborsi e/o compensazioni ammessi dal provvedimento
che ha disposto il pagamento dei debiti pregressi della P.A. (decreto legge n.
35/2013) sia la riduzione del gettito IVA, dovuto alla contrazione dei consumi.
Le imposte dirette sono cresciute grazie, soprattutto, all’andamento dell’IRES,
in connessione con le misure adottate a copertura dell’abolizione della seconda
rata IMU.
La tabella 2.13 riporta l’analisi distinta
del fabbisogno pubblico riferito ai settori delle Amministrazioni centrali e
delle Amministrazioni locali.
I dati evidenziano un’evoluzione sfavorevole nel comparto delle Amministrazioni
centrali, che ha registrato un peggioramento pari a 30.848 milioni (passando da
40.015 milioni del 2012 a
79.863 milioni nel 2013) e un miglioramento di quasi 7 miliardi nel comparto
delle Amministrazioni locali il cui saldo passa da -1.061 milioni nel 2012 ad
un valore positivo pari a 5.861 milioni nel 2013.
Tabella 2.13
(milioni di euro)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Amministrazioni centrali
|
|
Incassi
correnti
|
410.081
|
417.220
|
421.236
|
|
Incassi in
conto capitale
|
4.060
|
1.833
|
3.066
|
|
Incassi
partite finanziarie
|
3.810
|
3.784
|
3.558
|
|
TOTALE INCASSI
|
417.951
|
422.837
|
427.860
|
|
Pagamenti
correnti
|
439.958
|
430.777
|
454.316
|
|
Pagamenti in
conto capitale
|
32.297
|
32.612
|
27.753
|
|
Pagamenti
partite finanziarie
|
8.378
|
8.463
|
25.654
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
480.634
|
471.852
|
507.723
|
|
Fabbisogno Amministrazioni centrali
|
-62.682
|
-49.015
|
-79.863
|
|
in
percentuale del PIL
|
-4,0
|
-3,1
|
-5,1
|
|
Amministrazioni locali
|
|
Incassi
correnti
|
228.154
|
222.143
|
227.457
|
|
Incassi in
conto capitale
|
13.467
|
13.618
|
13.871
|
|
Incassi
partite finanziarie
|
2.792
|
9.318
|
15.383
|
|
TOTALE INCASSI
|
244.413
|
245.079
|
256.710
|
|
Pagamenti
correnti
|
211.496
|
213.236
|
218.387
|
|
Pagamenti in
conto capitale
|
29.965
|
29.483
|
28.923
|
|
Pagamenti
partite finanziarie
|
3.520
|
3.422
|
3.539
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
244.982
|
246.140
|
250.849
|
|
Fabbisogno Amministrazioni locali
|
-569
|
-1.061
|
+5.861
|
|
in
percentuale del PIL
|
0,0
|
-0,1
|
+0,4
|
Il comparto delle Amministrazioni
centrali registra un incremento del fabbisogno di 30.848 milioni rispetto
al 2012. Tale incremento è determinato dal peggioramento del saldo corrente
(-19.523 milioni) e del saldo finanziario (-17.417 milioni) mentre il saldo in
conto capitale registra una riduzione del saldo (+6.092 milioni).
Il peggioramento del fabbisogno è da
ricondurre, in via prevalente:
-
all’incremento dei pagamenti correnti (+23.539 milioni)
che risente della sospensione, prevista per il triennio 2012-2014, del sistema
di “tesoreria mista”. Il ripristino della tesoreria unica ha comportato,
infatti, l’afflusso sui conti della tesoreria statale delle disponibilità
bancarie degli enti territoriali, delle università e suoi dipartimenti nonché
di altri enti pubblici con conseguenti minori trasferimenti;
-
all’incremento dei pagamenti per partite finanziarie
(+17.191 milioni) che include la sottoscrizione dell’aumento del capitale
sociale della Banca Europea per gli Investimenti (circa 1.600 milioni), la
sottoscrizione di strumenti finanziari a favore del Monte dei Paschi di Siena
(circa 2.000 milioni), il pagamento di 5.737 milioni relativo alla quota di
sottoscrizione del capitale del Meccanismo Europeo di Stabilità (legge n. 116
del 2012) e le anticipazioni fornite agli enti territoriali per il pagamento
dei debiti pregressi.
L’incremento degli incassi delle
Amministrazioni centrali (+5.023 rispetto al 2012) è imputabile sia agli
incassi correnti che a quelli in conto capitale. Tuttavia, analizzando gli
incassi correnti risulta che questi incorporano effetti opposti determinati, da
un lato, dalla riduzione di alcuni introiti tributari (maggiori rimborsi e/o
compensazioni consentite dal provvedimento che prevede il pagamento di debiti
pregressi della PA e andamento negativo del gettito IVA) e, dall’altro lato, dall’incremento
delle imposte dirette determinato anche dai provvedimenti in materia di IRES.
Il comparto delle Amministrazioni locali
evidenzia un miglioramento rispetto al 2012, registrando nel 2013 un saldo
positivo (+5.861 milioni rispetto al fabbisogno del 2012 pari a -1.061)
determinato da un incremento degli incassi finali (+11.632 milioni) superiore a
quello dei pagamenti finali (+4.709 milioni).
Il miglioramento dell’entrate è dovuto
all’aumento dei trasferimenti provenienti dalle altre Amministrazioni pubbliche
(+ 5.004 milioni rispetto al 2012) e all’aumento degli incassi per partite
finanziarie (+6.065 milioni rispetto al 2012).
Dal lato dei pagamenti, si assiste ad una
crescita più contenuta, riferita principalmente all’acquisto di beni e servizi
(+6.601 milioni rispetto al 2012) e ai trasferimenti alle imprese (+1.535
milioni). All’opposto, le spese per il personale e le spese per investimenti
fissi lordi mostrano una contrazione.
Più in dettaglio, per quanto concerne le Regioni:
-
il finanziamento del settore statale è diminuito
di 148 milioni passando da 87,1 mld del 2012 a 87,0 mld del 2013. A tali risorse si
sono aggiunte le anticipazioni erogate per consentire il pagamento di debiti
pregressi (decreto legge n. 35/2013) pari a 6.708 milioni per il pagamento dei
debiti sanitari e a 4.153 milioni per il pagamento degli altri debiti delle
Regioni;
-
le giacenze dei conti correnti intestati a tutte
le Regioni presso la Tesoreria Statale, relativi all’IRAP e all’addizionale
regionale IRPEF, hanno registrato un aumento complessivo, rispetto al 1°
gennaio 2013, pari a 1.210 milioni;
-
i depositi bancari sono diminuiti di circa 599
milioni;
-
sono stati assunti nuovi prestiti (per esigenze
legate al fabbisogno e al rimborso dei prestiti in corso) per un totale di
7.478 milioni di cui 5.456 milioni rappresentati da anticipazioni di tesoreria;
-
i pagamenti, al netto di quelli relativi alla
spesa sanitaria e alle partite finanziarie, registrano un incremento di 1.826
milioni;
-
le disponibilità presso le contabilità speciali
di tesoreria unica intestate a tutte le regioni presentano un aumento di 3.227
milioni passando da 11.902 milioni a 15.129 milioni;
-
i pagamenti per rimborso di prestiti alle banche
sono stati pari a 12.551 milioni (rispetto a 6.472 milioni del 2012) di cui
8.832 milioni per restituzione di anticipazioni di tesoreria. Per far fronte
alle maggiori esigenze finanziarie, sono stati assunti nuovi prestiti verso le
banche per 8.328 milioni (rispetto a 6.725 milioni del 2012) di cui 7.216
milioni per anticipazioni di tesoreria.
Per quanto concerne, invece, i Comuni e le Province:
-
i pagamenti per rimborso di prestiti agli
istituti di credito sono stati pari a 13.926 milioni, di cui 7.926 milioni per
restituzione di anticipazioni di tesoreria;
-
sono stati assunti nuovi prestiti dal sistema
bancario per 12.139 milioni (di cui 3.553 milioni dalla Cassa Depositi e
Prestiti), dal collocamento sul mercato di prestiti obbligazionari per 14
milioni e 6.404 milioni per anticipazioni di tesoreria;
-
i rapporti di mutuo con il settore statale
registrano nel 2013 un’acquisizione netta di 2.654 milioni, contro un rimborso
netto di 388 milioni nel 2012.
In particolare, le partite finanziarie dal settore
statale includono i mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per un
importo pari a 2.985 milioni in attuazione delle disposizioni in materia di
pagamento di debiti pregressi della P.A. (decreto legge n. 35/2013)
-
gli incassi finali registrano un incremento
rispetto al 2012 (da 76.488
a 80.946 milioni) dovuta in via prevalente agli incassi
correnti pari a 5.728 milioni (+9,6%);
-
gli incassi relativi alle partite finanziarie
registrano una riduzione di 1.559 milioni, parzialmente imputabile al minore
ammontare dei depositi bancari conseguente all’obbligo del versamento in
tesoreria statale (temporanea sospensione del sistema di tesoreria mista,
disposta dal decreto legge n. 35/2013).
Fabbisogno di cassa del settore pubblico: previsioni tendenziali 2014‑2018
Le previsioni del fabbisogno del settore
pubblico, e della sua analisi per comparti, è riportata nella seguente tabella
2.14.
Tabella 2.14
(milioni di euro)
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Fabbisogno settore pubblico
|
|
Incassi
correnti
|
772.662
|
791.144
|
810.399
|
832.251
|
855.738
|
|
Incassi in
conto capitale
|
39.106
|
39.436
|
39.646
|
39.959
|
40.297
|
|
Incassi
partite finanziarie
|
1.364
|
920
|
586
|
840
|
676
|
|
TOTALE INCASSI
|
781.252
|
799.254
|
818.322
|
840.037
|
863.375
|
|
Pagamenti
correnti
|
789.105
|
781.254
|
788.996
|
796.707
|
808.889
|
|
Pagamenti in
conto capitale
|
34.773
|
34.795
|
36.877
|
33.301
|
33.272
|
|
Pagamenti
partite finanziarie
|
8.805
|
10.741
|
7.901
|
5.647
|
5.842
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
851.742
|
845.134
|
846.593
|
849.427
|
860.716
|
|
Fabbisogno
|
-70.490
|
-45.880
|
-28.271
|
-9.389
|
2.660
|
|
in
percentuale del PIL
|
-4,8%
|
-2,9%
|
-1,8%
|
-0,6%
|
0,1%
|
|
Comparto amministrazioni centrali
|
|
Incassi
correnti
|
434.320
|
447.689
|
459.512
|
473.720
|
487.814
|
|
Incassi in
conto capitale
|
2.845
|
2.829
|
2.930
|
2.473
|
2.423
|
|
Incassi
partite finanziarie
|
2.141
|
2.149
|
1.839
|
2.109
|
1.990
|
|
TOTALE INCASSI
|
439.307
|
452.668
|
464.282
|
478.302
|
492.227
|
|
Pagamenti
correnti
|
461.528
|
465.332
|
462.940
|
461.017
|
463.937
|
|
Pagamenti in
conto capitale
|
33.450
|
33.121
|
29.487
|
26.785
|
25.772
|
|
Pagamenti
partite finanziarie
|
20.457
|
1.144
|
1.155
|
948
|
938
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
515.434
|
499.597
|
493.582
|
488.750
|
490.647
|
|
Fabbisogno
|
-76.128
|
-46.929
|
-29.300
|
-10.448
|
1580
|
|
in
percentuale del PIL
|
-4,8%
|
-2,9%
|
-1,7%
|
-0,6%
|
0,1%
|
|
Comparto amministrazioni locali
|
|
Incassi
correnti
|
229.516
|
238.021
|
232.129
|
231.320
|
232.556
|
|
Incassi in
conto capitale
|
12.260
|
11.960
|
11.482
|
11.384
|
11.344
|
|
Incassi
partite finanziarie
|
17.251
|
899
|
813
|
820
|
824
|
|
TOTALE INCASSI
|
259.026
|
250.880
|
244.425
|
243.523
|
244.724
|
|
Pagamenti
correnti
|
222.157
|
214.345
|
211.095
|
212.005
|
213.166
|
|
Pagamenti in
conto capitale
|
27.964
|
27.249
|
26.868
|
26.772
|
26.662
|
|
Pagamenti
partite finanziarie
|
3.268
|
8.237
|
5.433
|
3.687
|
3.817
|
|
TOTALE PAGAMENTI
|
253.389
|
249.831
|
243.396
|
242.464
|
243.644
|
|
Fabbisogno
|
5.637
|
1.049
|
1.029
|
1.059
|
1.079
|
|
in
percentuale del PIL
|
0,4%
|
0,4%
|
0,1%
|
0,1%
|
0,1%
|
Negli anni dal 2014 al 2018 è stimato nel
Documento in esame un fabbisogno del settore pubblico in costante miglioramento
fino a raggiungere, nel 2017, il valore minimo di – 9.389 milioni (-0,5 per
cento rispetto al PIL) e a risultare di segno positivo nel 2018 (+ 2.660
milioni).
Le previsioni indicate considerano gli
effetti dei provvedimenti sui pagamenti dei debiti commerciali pregressi
(decreto legge n. 35 del 2013 e decreto legge n. 102/2013). In particolare,
precisa il Documento, le stime tengono conto degli esborsi per 20.000 euro nel
2014 e dello slittamento al 2014 di alcuni pagamenti inizialmente previsti per
l’anno 2013.
Il fabbisogno del 2014 registra una
riduzione rispetto a quello registrato nel 2013 (da -74.001 milioni a -70.490
milioni) e, anche per effetto del deterioramento del quadro macroeconomico, più
elevato di quasi 14 miliardi rispetto al valore della Nota tecnico illustrativa
al disegno di legge di stabilità 2014.
Rispetto al 2013, il miglioramento
del saldo è in larga parte riconducibile alla positiva evoluzione degli incassi
tributari e dei contributi sociali, in conseguenza del miglioramento del quadro
macroeconomico, nonché dei maggiori incassi IVA determinati dal pagamento dei
debiti pregressi della PA..
Il Documento in esame evidenzia inoltre, tra
i fattori che influiscono sulla determinazione del fabbisogno 2014, il
pagamento dell’ultima tranche di versamenti relativi alla quota di
sottoscrizione del capitale del Meccanismo Europeo di Stabilità,
i pagamenti dei debiti della PA e il mantenimento del regime di tesoreria unica
(è previsto, dal 2015, un progressivo ritorno alla tesoreria mista).
In
merito alle stime riferite alle annualità successive al 2015 andrebbero forniti
dei chiarimenti sulla valutazione “progressiva” del ritorno al regime di
tesoreria mista.
Rispetto alle stime della NTI 2014,
la nuova previsione mostra un profilo di sviluppo delle entrate più moderato,
in coerenza con i risultati riscontrati a consuntivo.
Nel 2015 il fabbisogno registra una
importante contrazione (oltre 24 miliardi di euro) conseguente al significativo
aumento del gettito tributario e dei contributi sociali, legato alla prevista
ripresa economica.
Per quanto concerne gli anni 2016 e 2017
viene precisato che il miglioramento del saldo è attribuibile all’evoluzione
favorevole del quadro macroeconomico, che influenza positivamente il gettito
tributario e contributivo determinando, a fronte di una crescita contenuta dei
pagamenti totali, un miglioramento del fabbisogno pari a, rispettivamente,
28.287 milioni e a 9.389 milioni.
L’andamento della stima degli incassi
tributari presenta, nel periodo considerato, un andamento crescente (da 490
mld del 2014 a
549 mld del 2018) che risulta, in termini di PIL, lievemente decrescente
passando dal 30,9 per cento del 2014 al 30,7 per cento del 2018.
Anche l’andamento della stima degli incassi
dei contributi sociali presenta una crescita costante anche se più
contenuta rispetto al PIL: in rapporto al PIL si passa dal 13,4 per cento del
2014 al 13,1 per cento del 2018. Tale circostanza è dovuta a previsioni di
moderata crescita nel 2014 (+0,8 percento) e ad una graduale ripresa negli anni
successivi che riflette la dinamica dell’attività economica e dell’occupazione
nel periodo considerato.
La spesa per il personale presenta una flessione nel 2014 dello
0,5%, per effetto delle misure contenitive dei trattamenti economici
individuali, del blocco della contrattazione collettiva nazionale e delle
progressioni di carriera e delle disposizioni limitative delle assunzioni. Nel
triennio 2015-2017 la spesa rimarrebbe circa costante, salvo mostrare un lieve
aumento (+0,2%) nel 2018, a
riflesso degli oneri connessi all’indennità di vacanza contrattuale relativa al
triennio 2018-2020.
La spesa per l’acquisto di beni e servizi
evidenzia un incremento nel 2014 (+3,1%) per gli effetti del decreto legge n.
35 del 2013, per poi assumere un andamento tendenzialmente decrescente o
costante fino al 2018.
I trasferimenti correnti presentano un andamento crescente in
tutto il periodo considerato, imputabile in buona parte ai trasferimenti alle
famiglie che includono principalmente le prestazioni di natura previdenziale e
assistenziale.
Il debito pubblico
Il Documento in esame colloca il rapporto
debito/PIL per l’anno 2013 ad un valore pari a 132,6 punti percentuali,
un valore inferiore di 0,3 punti a quello programmatico indicato nella Nota
di aggiornamento al DEF 2013. Il Documento precisa che tale correzione è da
attribuire interamente ad un valore di consuntivo del deflatore del PIL
superiore rispetto alla stima effettuata a settembre (1,2 contro un dato finale
di 1,4 per cento).
Per l’anno 2014, il rapporto è
previsto aumentare ulteriormente, fino a raggiungere il 134,9 per cento, con un
incremento di 2,1 punti percentuali rispetto all’analogo dato della Nota di
aggiornamento al DEF 2013. Il Documento precisa che tale incremento è da
attribuire in gran parte al ridimensionamento della crescita del PIL nominale
(che passa dal 2,9 per cento all’1,7 per cento), ma anche ad una previsione
dello stock di debito maggiore per circa 0,8 punti percentuali. Quest’ultima
revisione è dovuta principalmente alla nuova stima del fabbisogno del Settore
pubblico (dal 3,7 per cento al 5,3 per cento del PIL) imputabile, secondo il
DEF, in misura equivalente sia ad un peggioramento del saldo a legislazione
vigente, sia al pagamento di ulteriori 13 miliardi di debiti commerciali della
P.A. che si prevede di erogare in aggiunta a quanto già previsto per il 2014
dal combinato disposto dei due decreti legge adottati nel 2013.
Questa tendenza è in parte compensata da un valore più contenuto, per circa lo
0,3 per cento del PIL, degli effetti di valutazione del debito, rappresentati
dagli scarti di emissione e dalla rivalutazione per l’inflazione dovuta sui
titoli indicizzati, nonché da una stima delle entrate da privatizzazione
superiore per circa lo 0,2 per cento (0,7 punti percentuali l’anno contro 0,5
punti considerati in sede di Nota di aggiornamento).
Con riferimento al piano di privatizzazioni,
il DEF – PNR afferma che il Governo ha pianificato la cessione di quote di
aziende pubbliche. Le società coinvolte nell’operazione di valorizzazione degli
asset includono società a
partecipazione diretta quali ENI, STMicroelectronics, ENAV, nonché società in
cui lo Stato detiene partecipazioni indirettamente tramite Cassa Depositi e
Prestiti, quali SACE, FINCANTIERI, CDP Reti, TAG (Trans Austria Gastleitung Gmbh)
e, tramite Ferrovie dello Stato, in Grandi Stazioni – Cento Stazioni. I
proventi di tali privatizzazioni sono previsti ammontare a circa 0,7 punti
percentuali di PIL all’anno nel periodo 2014-2017. Il Documento ricorda,
infine, che un primo passo nella vendita delle partecipazioni statali è stato
fatto già a gennaio 2014, attraverso l’approvazione di due decreti
che regolamentano l’alienazione del 40 per cento delle quote di capitale di
Poste Italiane e il 49 per cento delle quote di capitale di ENAV.
In proposito si rileva che i due schemi di
DPCM, relativi alla privatizzazione di ENAV e di Poste italiane, presentati
alle Camera per l’approvazione del parere non indicavano la misura della
riduzione del debito che si riteneva attuabile mediante la loro approvazione.
Dopo aver raggiunto il valore massimo nel
2014, il rapporto diminuisce negli anni successivi, passando dal 133,3 del PIL
nel 2015 al 120,5 del 2018. Esso mantiene, tuttavia, un profilo più elevato di
4 punti percentuali, rispetto alle stime contenute nella Nota, nel 2015 e
rispettivamente di 4,8 e 5 punti percentuali nel 2016 e 2017. Il Documento, con
riferimento all’anno 2015, attribuisce tale differenza sia ad una minore
crescita nel biennio 2014-2015 (2,7 punti percentuali cumulati), sia ad un
incremento dello stock di debito (che incide per circa 1,2 punti percentuali).
Si precisa, inoltre, che oltre all’effetto di trascinamento dall’anno
precedente, incide sul debito il peggioramento del fabbisogno del settore
pubblico dall’1,5 al 2,5 per cento di PIL, il cui effetto è tuttavia attenuato
dalle maggiori privatizzazioni per uno 0,2 per cento di PIL rispetto alla Nota
e da altri due fattori: l’impatto nel 2015 del rimborso dei bond finanziati dal
Tesoro (cosiddetti Monti bond),
che dovrebbero prendere avvio nel 2014, e i piani di ammortamento dei prestiti
erogati dal MEF alle Amministrazioni locali per il rimborso dei debiti
commerciali (per un valore complessivo pari quasi allo 0,3 per cento del PIL).
Per gli anni successivi, gli incrementi rispetto alle precedenti stime sono
riconducibili ai medesimi fattori con una più forte incidenza dell’effetto di
trascinamento degli anni precedenti.
Nella tabella che segue è riportato il
confronto tra le previsioni contenute nel quadro programmatico della Nota di
aggiornamento e del DEF del rapporto debito/PIL per il periodo 2013-2018. I
dati sono, rispettivamente, al netto ed al lordo degli effetti delle misure di
sostegno adottate nell’area euro ai fini della stabilizzazione finanziaria.
Negli anni 2012 e 2013, il valore del debito
al lordo delle misure di sostegno tiene conto della quota di pertinenza
dell’Italia dei prestiti EFSF diretti alla Grecia e del programma ESM, per un
valore pari rispettivamente a 36.932 e a 55.620 milioni di euro.
Tabella 2.15
Debito delle
Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL: confronto tra Nota di
Aggiornamento al DEF 2013 e DEF 2014
(in percentuale del PIL)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF 2014:
|
|
|
|
|
|
|
|
quadro
programmatico
|
|
|
|
|
|
|
|
al lordo
dei sostegni
|
132,6
|
134,9
|
133,3
|
129,8
|
125,1
|
120,5
|
|
al netto
dei sostegni
|
129,1
|
131,1
|
129,5
|
126,1
|
121,5
|
116,9
|
|
Nota agg. DEF 2013:
|
|
|
|
|
|
|
|
quadro programmatico
|
|
|
|
|
|
|
|
al lordo
dei sostegni
|
132,9
|
132,8
|
129,4
|
125,0
|
120,1
|
|
|
al netto
dei sostegni
|
129,3
|
129,0
|
125,7
|
121,4
|
116,6
|
|
|
Fonte: DEF
2014
|
|
Nota:
- il quadro programmatico indicato nel DEF 2014 sconta
per gli anni 2014-2017 un ammontare di proventi da privatizzazioni e
dismissioni immobiliari pari a circa 0,7 punti percentuali di PIL all’anno.
Nella Nota di aggiornamento al DEF 2013, tali effetti sono, invece, presi in
considerazione in misura pari a 0,5 punti percentuali di PIL all’anno;
- le stime tendenziali sottostanti allo scenario
programmatico includono i proventi attesi dal rimborso dei bond finanziati
dal Tesoro a favore del Monte dei Paschi di Siena pari a circa 4 miliardi con
tranches nel periodo 2014-2017.
|
Si
rileva che il Documento non espone i dati di debito relativi al quadro
tendenziale. In proposito si osserva che la disponibilità degli stessi
risulterebbe utili al fine di verificare gli effetti delle misure che si
intendono adottare per la riduzione del rapporto debito/PIL.
Nella tabella che segue è riportata la
ripartizione del debito al lordo e al netto dei sostegni finanziari all’area
dell’euro per sottosettori, con la precisazione che la quota relativa a
tali sostegni è posta interamente a carico delle Amministrazioni centrali.
Tabella 2.16
Debito
programmatico delle Amministrazioni pubbliche per sottosettori
(milioni di euro-
in percentuale del PIL)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Debito netto sostegni
|
|
P.A.
|
2.013.373
|
2.079.871
|
2.107.043
|
2.113.578
|
2.102.670
|
2.091.945
|
|
%PIL
|
129,1
|
131,1
|
129,5
|
126,1
|
121,5
|
116,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amm.C.
|
1.915.825
|
1.994.960
|
2.023.181
|
2.030.745
|
2.020.895
|
2.011.250
|
|
%PIL
|
122,8
|
125,7
|
124,4
|
121,1
|
116,7
|
112,4
|
|
variazione %
|
5,4
|
2,9
|
-1,3
|
-3,2
|
-4,4
|
-4,3
|
|
Amm.L.
|
136.837
|
124.200
|
123.152
|
122.123
|
121.064
|
119.984
|
|
%PIL
|
8,8
|
7,8
|
7,6
|
7,3
|
7,0
|
6,7
|
|
variazione %
|
0,4
|
-0,9
|
-0,3
|
-0,3
|
-0,3
|
-0,3
|
|
Enti prev.
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Debito lordo sostegni
|
|
P.A.
|
2.068.993
|
2.141.454
|
2.169.068
|
2.176.064
|
2.165.654
|
2.155.428
|
|
%PIL
|
132,6
|
134,9
|
133,3
|
129,8
|
125,1
|
120,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amm.C.
|
1.971.445
|
2.056.543
|
2.085.205
|
2.093.230
|
2.083.879
|
2.074.733
|
|
%PIL
|
126,4
|
129,6
|
128,2
|
124,9
|
120,4
|
116,0
|
|
variazione %
|
6,2
|
3,2
|
-1,4
|
-3,3
|
-4,5
|
-4,4
|
|
Amm.L.
|
136.837
|
124.200
|
123.152
|
122.123
|
121.064
|
119.984
|
|
%PIL
|
8,8
|
7,8
|
7,6
|
7,3
|
7,0
|
6,7
|
|
variazione %
|
0,4
|
-0,9
|
-0,3
|
-0,3
|
-0,3
|
-0,3
|
|
Enti prev.
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: DEF 2014
|
|
Nota: il debito delle amministrazioni centrali,
locali e degli enti di previdenza è da considerarsi al lordo degli interessi
non consolidati.
|
Come evidenziato nella tabella 2.16,
l’andamento complessivo del debito della PA risulta determinato pressoché integralmente
dalla componente delle amministrazioni centrali. Quest’ultima registra una
crescita annua in termini assoluti fino al 2016; dal 2017 subentra, invece, una
lieve flessione. In termini di incidenza sul PIL, tale flessione si registra
già dal 2016.
La componente delle amministrazioni locali
inizia invece a ridursi già nel 2014 per portarsi, nell’ultimo anno di
previsione, ad un livello pari al 6,7 per cento del PIL.
Rispetto ai dati contenuti nel DEF non si
rilevano variazioni sostanziali della composizione del debito per sottosettori.
Nella tabella che segue è riportata,
un’analisi delle componenti che determinano la variazione del rapporto
debito/PIL: il segno algebrico delle singole componenti indica l’effetto, ad
incremento o a riduzione del rapporto, esercitato dalle medesime.
Tabella 2.17
Determinanti
della variazione del rapporto debito /PIL programmatico, anni 2013-2018
(in percentuale del PIL)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Rapporto
debito/PIL
|
132,6
|
134,9
|
133,3
|
129,8
|
125,1
|
120,5
|
|
Variazione rapporto debito/PIL
|
5,7
|
2,3
|
-1,6
|
-3,5
|
-4,7
|
-4,6
|
|
Di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo primario (segno “-“ indica l’avanzo)
|
-2,2
|
-2,6
|
-3,3
|
-4,2
|
-4,6
|
-5,0
|
|
|
Snow ball
effect
|
5,8
|
3,0
|
1,8
|
1,1
|
0,8
|
0,6
|
|
|
|
di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
interessi
|
5,3
|
5,2
|
5,1
|
5,1
|
4,9
|
4,7
|
|
|
Stock flow
adjustment
|
2,1
|
1,9
|
-0,1
|
-0,5
|
-0,9
|
-0,2
|
|
|
|
di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
differenza
tra cassa e competenza
|
0,8
|
2,2
|
0,1
|
-0,3
|
-0,6
|
-0,8
|
|
|
|
accumulazione
netta di asset finanziari (*)
|
0,3
|
-0,2
|
-0,4
|
-0,4
|
-0,5
|
0,2
|
|
|
|
effetti di
valutazione del debito
|
-0,5
|
-0,7
|
-0,7
|
-0,7
|
-0,7
|
0,0
|
|
|
|
altro (**)
|
0,9
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Fonte: DEF
|
|
(*) include
gli effetti dei contributi per GLF e programma ESM
(**)la voce
altro residuale rispetto alle precedenti comprende: variazioni delle
disponibilità liquide del MEF; discrepanze statistiche; riclassificazione
Eurostat, contributi a sostegno dell’area Euro previsti dal programma EFSF
|
Dall’analisi dei dati sopraesposti è
possibile osservare che la riduzione del rapporto debito/PIL dal 2014 è quasi
interamente attribuibile ad un miglioramento del saldo primario, che
contribuisce in misura pari a circa 3,9 punti percentuali nella media del
periodo 2014-2018.
L’effetto snowball riduce la sua incidenza sulla dinamica del rapporto già a
decorrere dal 2014, ma in maniera molto più evidente dall’anno 2015, in considerazione di
una più elevata crescita del PIL nominale; il suo contributo all’incremento del
rapporto debito PIL risulta pari a circa 1,1 per cento nella media del periodo
2015-2018.
Con riferimento all’aggiustamento stock-flow, il Documento sottolinea che
esso registra un sostanziale annullamento nel corso del periodo considerato,
beneficiando dell’esaurimento del programma di rimborso dei debiti commerciali
e dell’impatto delle privatizzazioni.
Infine, con riferimento alla durata del
debito, il Documento afferma che il debito italiano presenta una struttura per
scadenze tra le più lunghe in Europa (la terza più lunga nel 2011). Inoltre il
100 per cento del debito pubblico in Italia è denominato in euro, cosa che determina
la completa assenza di rischi valutari. Al 31 marzo 2014, la vita residua media
del debito è pari a 6,32 anni.
Gli
“altri fattori rilevanti”
La nuova regola per la riduzione del debito
pubblico (v. Approfondimento sulla regola
del debito) prevede che, nel caso in cui il rapporto debito/PIL risulti più
elevato del benchmark, si tengano
comunque in considerazione un certo insieme di “altri fattori rilevanti”.
L’analisi di tali fattori rappresenta, quindi, un passo importante nell'ambito
delle procedure europee.
Il sistema bancario
Con riferimento alla situazione del sistema
bancario, il DEF sottolinea che gli interventi monetari non convenzionali,
ossia l’introduzione delle due operazioni di rifinanziamento a tre anni (Long Term Refinancing Operations LTRO) e
delle operazioni definitive monetarie (Outright
Monetary Transactions OMT), hanno contribuito a sostenere la liquidità
delle banche. In Italia, l’indagine sul credito bancario relativo al quarto
trimestre del 2013 ha
segnalato una stabilizzazione della domanda di prestiti a breve termine; i
criteri per la concessione dei prestiti sono diventati meno restrittivi, in
particolare per le piccole imprese e nel segmento a breve termine. Il tasso di
copertura medio dei crediti deteriorati è risultato pari al 44 per cento in
dicembre (da 39,7 per cento in settembre). Il livello di capitalizzazione dei
principali gruppi bancari risulta in linea con quello delle banche dell’area
euro, ma le banche italiane sono quelle che hanno ricevuto il minor sostegno da
parte del bilancio pubblico (0,3 per cento del PIL) nel confronto
internazionale.
Il Documento sottolinea, pertanto, la
solidità complessiva del sistema bancario italiano, dovuta ad un’esposizione
contenuta verso attività rischiose e a un valore ridotto della leva finanziaria
rispetto alla media europea.
Al riguardo, la Banca d’Italia
sottolinea come la raccolta al dettaglio del sistema bancario si conferma
solida; si registra qualche segnale di ritorno della fiducia degli investitori
internazionali verso gli intermediari italiani. Le banche italiane hanno
migliorato ulteriormente la propria posizione patrimoniale, nonostante la
redditività resti contenuta. È proseguita, tuttavia, la flessione dei prestiti
bancari al settore privato non finanziario: nei tre mesi terminanti in novembre
sono diminuiti del 5,6 per cento (in ragione d’anno). Si sono contratti
dell’8,4 per cento i prestiti alle imprese, del 2,1 quelli alle famiglie.
Il debito privato
Con riferimento all’indebitamento del
settore privato, il DEF afferma che nel 2012, il livello dell’indebitamento del
settore privato è risultato in diminuzione rispetto al 2011 e considerando
anche altre variabili, il settore privato in Italia mantiene un elevato grado
di solidità finanziaria.
Il debito complessivo delle famiglie
italiane e delle società non finanziarie è pari nel 2012 al 126 per cento del
PIL, al di sotto della soglia di rischio fissata dalla Commissione Europea per
questo indicatore (133 per cento). La struttura del portafoglio delle famiglie
rimane caratterizzata da un elevato livello di attività (rispetto al reddito
disponibile), con una riduzione di quelle ad alto rischio.
Il DEF precisa che nei primi nove mesi del
2013, rispetto alla fine del 2012, le attività finanziarie delle famiglie hanno
registrato un aumento dei depositi per 14,2 miliardi, mentre si sono ridotte di
37,5 miliardi le obbligazioni bancarie.
Secondo i dati diffusi da Banca d’Italia,
nel terzo trimestre del 2013 il debito delle famiglie in rapporto al
loro reddito disponibile è rimasto pressoché invariato (al 65 per cento),
sensibilmente al di sotto di quello medio dell’area dell’euro (pari a circa il
100 per cento). Gli oneri sostenuti dalle famiglie italiane per il servizio del
debito (spesa per interessi e restituzione del capitale) sono scesi al 9,2 per
cento del reddito disponibile, dal 9,4.
Con riferimento alle imprese non finanziarie, il DEF afferma
che i dati di contabilità nazionale segnalano un certo deterioramento della
loro situazione finanziaria. Nel periodo 2003-2012, il debito delle imprese
italiane ha registrato un valore medio del 68,8 per cento del PIL, superiore di
1,8 punti percentuali a quello dell’area euro. Alla fine del 2012 tale valore
si colloca intorno all’80 per cento del PIL. Il Documento aggiunge che le
imprese nel corso degli ultimi anni hanno aumentato il risparmio e ridotto il
tasso d’investimento. La ripresa economica attesa nei prossimi mesi, potrebbe
favorire il miglioramento della situazione finanziaria, della redditività e
delle decisioni di investimento delle imprese.
Peraltro la Banca d’Italia
rileva un’ulteriore contrazione dei prestiti bancari alle imprese non finanziarie
(-5,8 per cento nei dodici mesi terminanti in novembre). L’Istituto indica che
lo stock di debito complessivo delle imprese è rimasto al di sotto dell’80 per
cento del PIL.

(1) I dati si
riferiscono ai 12 mesi terminati nel trimestre di riferimento.
Il debito, al
netto delle esposizioni intra settore, include i prestiti cartolarizzati.
Fonte: Banca
d’Italia – Bollettino economico, gennaio 2014
Garanzie concesse dallo Stato
Con particolare riferimento alle garanzie
concesse dallo Stato sia su attività finanziarie che non finanziarie (grandi
opere, imprenditoria, etc.), il DEF indica che, al 31 dicembre 2013, esse sono
ammontate a circa 98,7 miliardi, pari al 6,3 per cento del PIL, di cui quelle
concesse ad istituti di credito in seguito alla recente crisi finanziaria hanno
raggiunto 81,7 miliardi, pari al 5,2 per cento del PIL.
|
Garanzie
pubbliche (in milioni di euro) - 2013
|
|
|
Livello
|
in % di PIL
|
|
Stock garanzie
|
98.651
|
6,3
|
|
di cui:
settore finanziario
|
81.679
|
5,2
|
All’ammontare complessivo hanno contribuito
le seguenti componenti:
-
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese. E’ uno strumento di politica industriale del Ministero dello
Sviluppo Economico che opera attraverso tre distinte modalità di intervento:
garanzia diretta, concessa alle banche e agli intermediari finanziari;
controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi e altri fondi di
garanzia; cogaranzia concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e
congiuntamente ai Confidi e altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia
istituiti nell’ambito dell’UE o da essa cofinanziati. Al 31 dicembre 2013, il
debito residuo complessivo garantito risulta pari a 11.050 milioni.
-
TAV S.p.A.. Il Ministero del Tesoro garantisce
l’adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei
confronti della TAV S.p.a., in relazione alla concessione, realizzazione e
gestione del sistema Alta Velocità. Si tratta di una garanzia fideiussoria di
diritto finalizzata a rendere possibile il reperimento sul mercato delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della rete ad alta velocità.
Al 31 dicembre 2013, il debito residuo garantito risulta pari a circa 2.134
milioni.
-
Aiuti al salvataggio delle imprese. Tali aiuti
comprendono le garanzie concesse dallo Stato alle imprese a fronte di debiti
contratti con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione
corrente e per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili ed
attrezzature industriali. Nel corso del 2013 sono state concesse garanzie per
23 milioni, che sono scadute in corso d’anno, sicché il debito residuo
garantito alla data del 31 dicembre 2013 risulta pari a zero.
-
Garanzie assunte dalle amministrazioni locali. I
dati relativi alle garanzie prestate dagli Enti Locali sono forniti dalla Banca
d’Italia, che li rileva attraverso le informazioni trasmesse, per mezzo delle
segnalazioni di vigilanza, direttamente dagli istituti finanziari che ne
beneficiano. Al 31 dicembre 2013, il debito residuo garantito risulta pari a
3.788 milioni.
-
Banche italiane. Tali garanzie sono
concesse dallo Stato sulle passività delle banche italiane relativamente ai
titoli obbligazionari emessi dagli istituti di credito. Al 31 dicembre 2013, il
debito residuo garantito risulta pari a 81.679 milioni.
3. Analisi speciali
3.1 Analisi di
sensitività della finanza pubblica
Il Documento di economia e finanza 2014
fornisce un'analisi di sensitività delle previsioni programmatiche dei
principali indicatori di finanza pubblica (scenario di base) rispetto ad
ipotesi alternative sulla dinamica della crescita economica e dei tassi di
interesse, fattori assunti esogeni rispetto al quadro di finanza pubblica.
3.1.1 Analisi di
sensitività alla crescita
Per analizzare la sensitività della finanza
pubblica alla crescita economica nel periodo 2014-2018, il DEF considera due
scenari macroeconomici alternativi, uno ottimistico - di alta crescita - e
l'altro pessimistico - di bassa crescita. In entrambi i casi lo scostamento del
tasso di crescita del PIL reale rispetto a quello dello scenario di base è di
0,5 punti percentuali all'anno a partire dal 2014.
Le alternative ipotesi di crescita
influenzano la dinamica del PIL potenziale e dell'output gap. Conseguentemente ne risulta modificato l’avanzo
primario sia nella parte strutturale che nella componente ciclica. A sua volta
il diverso andamento degli avanzi primari si riflette sull'andamento del debito
e, conseguentemente, della spesa per interessi. Nella derivazione del rapporto
debito/PIL, si assume che il tasso di interesse implicito e lo stock-flow adjustment non cambino negli
scenari alternativi rispetto allo scenario base.
La tabella 3.1 riporta l'andamento del tasso
di crescita reale nei tre scenari (base, ottimistico e pessimistico).
Tabella
3.1
Ipotesi
alternative di crescita del PIL reale.
(in percentuale del PIL)

Fonte: DEF 2014, Sezione I, Tavola IV.1.
La tabella 3.2 mostra la simulazione della
dinamica dell'indebitamento netto negli scenari di crescita alternativi, mentre
la tabella 3.3 riporta per ogni anno la differenza tra i valori simulati e
quelli di base.
Tabella
3.2
Sensitività
dell'indebitamento netto alla crescita.
(in percentuale del PIL)

Fonte: DEF 2014, Sezione I, Tavola IV.1.
Tabella
3.3
Variazioni
dell'indebitamento netto tra gli scenari alternativi e quello di base
(in percentuale del PIL)

Fonte: elaborazioni su DEF 2014.
Nota: il segno positivo indica un
miglioramento (riduzione) dell'indebitamento netto rispetto allo scenario di
base.
Nello scenario di maggiore crescita si
avrebbe una riduzione dell'indebitamento netto compresa tra 0,2 punti
percentuali di PIL nel 2014 e 1,1 punti nel 2018. Simmetricamente, nello
scenario di minore crescita la simulazione mostra un aumento dell'indebitamento
compresa tra 0,2 punti percentuali di PIL nel 2014 e 1 punto percentuale nel
2018. Nello scenario di maggiore crescita si raggiungerebbe un saldo positivo -
accreditamento netto - a partire dal 2017, un anno prima rispetto allo scenario
di base.
La
corrispondenza - in valore assoluto ma con segno opposto - della variazione
media dell'indebitamento netto nei due scenari alternativi rispetto a quello di
base è spiegabile con la simmetria della variazione del tasso di crescita del
PIL reale ipotizzata nei due scenari e con le caratteristiche di calcolo dei
valori simulati (invariato rispetto alle condizioni del ciclo economico). Un
meccanismo di simulazione più realistico, ma indubbiamente più complicato da
applicare, potrebbe utilmente differenziarsi in fasi di espansione
dell'economia rispetto alle fasi di contrazione.
La tabella 3.4 mostra i risultati delle
simulazioni per il rapporto debito/PIL, mentre la tabella 3.5 riporta le
differenze dei valori di debito simulati rispetto a quelli dello scenario base.
Nello scenario di maggiore crescita la diminuzione del rapporto oscilla tra 0,8
punti percentuali nel 2014 e 6,5 punti nel 2018. La simulazione nel caso di
crescita ridotta mostra una dinamica del debito quasi identica per le stesse
motivazioni rappresentate sopra in riferimento all'indebitamento netto.
Tabella
3.4
Sensitività
del rapporto debito/PIL alla crescita.
(in percentuale del PIL)

Fonte: DEF 2014, Sezione I, Tavola IV.1.
Tabella
3.5
Variazioni
del rapporto debito/PIL tra gli scenari alternativi e quello di base.
(in percentuale del PIL)

Fonte: elaborazioni su DEF 2014.
Nota: il segno negativo indica un
miglioramento (riduzione) del rapporto debito/PIL rispetto allo scenario di
base.
E'
bene ricordare che tali esercizi di simulazione mostrano una serie di
limitazioni che inducono cautela nella valutazione dei risultati. L'elemento più problematico, in
particolare, riguarda l'ipotesi di invarianza dei tassi di interesse impliciti,
la quale risulta poco realistica in presenza di variazioni del tasso di
crescita del PIL reale che possono influenzare i tassi di interesse attraverso
una diversa percezione del rischio legato ai titoli del debito pubblico da
parte dei mercati finanziari.
Sarebbe,
inoltre, utile ottenere dal Governo una valutazione circa il rispetto delle
regole della spesa e del debito nei due scenari macroeconomici alternativi.
3.1.2
Analisi di sensitività ai tassi di interesse
L'analisi di sensitività del debito pubblico
all'andamento dei tassi di interesse viene condotta nel DEF stimando l’impatto
di potenziali variazioni della curva dei rendimenti che influenzino il costo
all’emissione dei titoli del debito pubblico sul mercato primario.
I risultati si basano sull'attuale e futura
composizione dello stock dei titoli
di Stato negoziabili che, a fine dicembre 2013, si componeva di titoli
domestici, ossia emessi sul mercato interno, per il 96,70 per cento, e di
titoli esteri, sia in euro che in valuta, per il 3,30 per cento.
L'analisi indica che a un aumento istantaneo
e permanente di un punto percentuale della curva dei rendimenti sui titoli di
Stato comporta un aumento dell'onere del debito di 0,17 punti percentuali di
PIL nel primo anno, 0,34 nel secondo, 0,44 nel terzo e 0,53 nel quarto. La
trasmissione di questa variazione sul costo del debito avviene interamente dopo
5,51 anni. Tali valori sono lievemente superiori per i primi due anni rispetto
a quelli stimati nel DEF del 2013
a causa, da un lato, della composizione del debito, che
vede infatti una modesta riduzione della vita media, e, dall’altro, del suo
maggiore livello assoluto, che tende di per sé a dilatare quantitativamente gli
effetti di un medesimo shock.
3.2
L’analisi di sostenibilità di lungo periodo
L’aggiornamento del DEF- Programma di
stabilità 2014 reca l’analisi di sostenibilità delle finanze pubbliche
nel lungo periodo. Essa tiene conto degli effetti sulla spesa e sulla dinamica
del debito del progressivo invecchiamento della popolazione, alla luce di
diverse ipotesi circa il quadro macroeconomico e di finanza pubblica di
riferimento.
Il PdS presenta, quindi, una proiezione
della spesa pubblica in Italia, per pensioni, sanità, assistenza agli anziani,
istruzione e indennità di disoccupazione, nonché il dettaglio delle ipotesi
demografiche e macroeconomiche di riferimento.
Da
tali analisi emerge come, grazie alle riforme implementate negli ultimi venti
anni, le spese legate all’invecchiamento risultino essere sotto controllo.
Sulla base delle ipotesi relative
all’evoluzione di tali variabili viene costruito lo scenario base che
evidenzia, nel periodo 2018-2060, una costante riduzione del rapporto
debito/PIL. Sono poi presentate delle simulazioni sulla dinamica del debito,
basate su ipotesi alternative, rispetto allo scenario di riferimento,
riguardanti sia le principali variabili macroeconomiche, che il livello di
avanzo primario strutturale.
Con riguardo a tale saldo, i risultati delle
simulazioni evidenziano come la dinamica del debito si modifichi
significativamente a seguito della variazione dell’avanzo primario rispetto al
valore programmatico inglobato nello scenario di base (+4,7 nel 2018 in termini
strutturali). Per un livello inferiore, pari al 3,7 per cento, il debito
continua a diminuire, ma varca la soglia del 60 per cento del PIL solo nel
2040. Un avanzo primario inferiore al 3 per cento nel 2018 non stabilizzerebbe
il debito al 60 per cento nel lungo periodo.
L’analisi è completata dagli indicatori
sintetici di sostenibilità previsti dalla metodologia europea (i sustainability gaps indicati con S1
e S2 ed il required primary
bilance indicato con RPB), che confermano gli andamenti descritti. Essi
evidenziano, tuttavia, la necessità di uno sforzo fiscale aggiuntivo, peraltro
di dimensione contenuta (0,3 punti di PIL per l’indicatore S1), per
raggiungere la soglia del 60 per cento del rapporto/PIL entro il 2030.
L’impatto dell’invecchiamento della
popolazione sulla spesa pubblica
Le proiezioni della spesa pubblica contenute
nella Tabella IV.3 del Programma di stabilità (PdS), recepiscono – secondo
quanto specificato dal documento - le ipotesi dello scenario baseline concordato in sede europea, con
alcune modifiche.
Queste sono dirette ad aggiornare i dati iniziali per tener conto dei risultati
2012-2013 e del quadro normativo in vigore ad aprile 2014.
Per il periodo 2014-2018 le previsioni recepiscono il quadro di finanza
pubblica a legislazione vigente e le ipotesi di crescita, occupazione, tassi di
attività, ecc. previste nel DEF.
Come evidenziato dalla Tabella IV.3 del PdS,
negli anni successivi al 2015 le spese legate all’invecchiamento della
popolazione in rapporto al PIL si riducono, per poi aumentare nuovamente a
partire dal 2035 fino al 2050, riflettendo l’andamento della spesa
previdenziale in corrispondenza del pensionamento della generazione del c.d. baby boom. Alla fine dell’orizzonte di
previsione, la spesa age-related tende
a ridursi e a convergere (in termini di rapporto con il PIL) sui livelli del
2010 (28,3 per cento).
La
sostenibilità del debito
Sulla base delle ipotesi relative
all’evoluzione delle variabili demografiche e macroeconomiche e
delle proiezioni delle spese legate all’invecchiamento, l’analisi di
sostenibilità della finanza pubblica è condotta nel documento attraverso la
proiezione del rapporto debito/PIL nel periodo compreso tra il 2018 ed il
2060 ed attraverso il calcolo di indicatori sintetici di sostenibilità (i sustainability gaps indicati con S1
e S2 ed il required primary
balance indicato con RPB).
La simulazione si basa, inoltre, sui
seguenti parametri:
- livelli
del rapporto debito/PIL e dell’avanzo primario strutturale corrispondenti a
quelli indicati dal Governo per l’anno 2018 pari, rispettivamente, al 120,5 ed
al 4,7 per cento del PIL;
- tasso
di interesse reale costante per tutto il periodo di riferimento e pari al 3 per
cento. Ipotizzando che il deflatore PIL converga al 2 per cento dal 2019, il
tasso di interesse nominale si colloca al 5 per cento;
- variazione
dell’avanzo primario strutturale per effetto delle (sole) variazioni delle
spese correlate all’invecchiamento della popolazione e dei redditi proprietari,
mentre le entrate fiscali in rapporto al PIL si mantengono per tutto il periodo
di previsione al livello programmato per il 2018.
I risultati della simulazione mostrano un
andamento del rapporto debito/PIL costantemente decrescente nel periodo di
riferimento, che si colloca sulla soglia del 60 per cento nel 2031 (2027 nella
precedente simulazione che partiva da un livello iniziale del rapporto
debito/PIL più contenuto e da un avanzo primario più elevato).
Come si è detto, una indicazione della
dimensione degli squilibri eventualmente presenti nei conti pubblici, è fornita
dagli indicatori S1 e S2, i quali misurano l'ampiezza dell'aggiustamento
fiscale permanente, in termini di saldo primario strutturale, necessario per
raggiungere:
1.
l'obiettivo debito/PIL del 60 per cento nel 2030 (S1);
2.
l'obiettivo del vincolo intertemporale su un orizzonte
infinito (S2).
La metodologia di calcolo dell’indicatore S1
è stata recentemente modificata dalla Commissione europea:
l’obiettivo del debito al 60 per cento del PIL è stato anticipato al 2030
(rispetto al precedente termine del 2060); dato il maggiore sforzo richiesto
per conseguire prima il raggiungimento di tale soglia, si prevede la
possibilità di non compiere l’intero aggiustamento fiscale immediatamente, ma
di procedere gradualmente (in modo lineare) tra il 2018 e il 2020, per poi
mantenere il livello di avanzo primario raggiunto nei successivi 10 anni.
E' possibile scomporre gli indicatori S1
ed S2 nelle loro rispettive componenti, al fine di valutare se i
rischi alla sostenibilità provengono dalla posizione fiscale corrente (saldo
primario strutturale e stock di
debito) e/o anche dal progressivo invecchiamento della popolazione.
La posizione fiscale iniziale (initial budget position) misura la
distanza tra l'avanzo primario strutturale alla fine del periodo coperto dal
Programma di stabilità (4,7 per cento del PIL) e quello in grado di mantenere
costante il rapporto debito/PIL al livello iniziale, coeteris paribus. Esso indica, quindi, se le finanze
sono sostenibili, considerando esclusivamente la posizione fiscale corrente.
Questa componente, per quanto riguarda S1,
include il “costo” del ritardo dell’aggiustamento, in quanto si ipotizza che
l’avanzo primario aumenti in modo graduale fino al 2020, per poi stabilizzarsi
al livello raggiunto.
La seconda componente, la condizione sul
debito (debt requirement) al 2030, è
specifica dell'indicatore S1 ed evidenzia l'aggiustamento necessario
per portare il debito dal livello iniziale al 60 per cento nel PIL entro tale
anno.
La terza componente (long-term changes in the primary balance), quantifica l'impatto
dell'invecchiamento della popolazione sul bilancio, prevedendo un ulteriore
aggiustamento per fare fronte all'aumento delle spese connesse con tale
fenomeno. Nel caso di S1, l’aggiustamento è anticipato al 2030.
S1 e S2 sono dati
dalla somma algebrica delle rispettive componenti. Valori positivi di S1
e S2 indicano la necessità di uno sforzo di aggiustamento permanente
per soddisfare l’una o l'altra delle condizioni, tanto maggiore quanto maggiore
è la grandezza assunta dagli indicatori. Valori negativi indicano, invece, che
la sostenibilità di lungo periodo non richiede sforzi addizionali permanenti
(ulteriori, cioè, rispetto a quelli richiesti dal raggiungimento degli
obiettivi programmatici contenuti nel documento presentato dal Governo).
Un terzo indicatore utilizzato in tali
analisi è l'avanzo primario necessario (required
primary balance, RPB), che indica l'avanzo primario strutturale medio nei
primi 5 anni del periodo di proiezione
coerente con l'aggiustamento suggerito da S2.
Come si evince dalla tabella 3.6, tratta
dall'aggiornamento 2014 del Programma di Stabilità, il consolidamento previsto
è sufficiente ad assicurare finanze pubbliche sostenibili nel lungo periodo,
tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione. Per rientrare, tuttavia, al
di sotto della soglia del 60 per cento entro il 2030, è richiesto uno sforzo
aggiuntivo di 0,3 decimi di punto di PIL come evidenziato dal valore positivo
di S1.
L’indicatore S2 invece assume un
valore negativo, confermato da un RPB pari a 2,5 per cento, inferiore di 2,2
punti all’avanzo primario di fine periodo indicato nel quadro programmatico.
Tabella
3.6
Indicatori
di sostenibilità di lungo periodo
|
|
S1
|
S2
|
RPB
|
|
Valore, di cui
|
0,3
|
-2,7
|
2,5
|
|
Posizione
fiscale iniziale
|
-3,6
|
-2,9
|
|
|
Ritardo
nell’aggiustamento
|
0,0
|
-
|
|
|
Condizione
sul debito nel 2030
|
4,4
|
-
|
|
|
Costi di
invecchiamento
|
-0,6
|
0,2
|
|
|
.
|
Fonte: Tavola IV.4, PdS – DEF 2014
La sensitività della dinamica del debito nel lungo periodo rispetto
alle ipotesi demografiche, macroeconomiche e di finanza pubblica
I risultati ottenuti dall’analisi di
sostenibilità delle finanze pubbliche in termini di dinamica di lungo periodo
del rapporto debito/PIL e di indicatori sintetici mostrano come la tenuta degli
obiettivi programmatici indicati a tutto il 2018 sia in grado di garantire,
nello scenario macroeconomico ipotizzato, la copertura delle spese connesse
all’invecchiamento della popolazione e la sostenibilità del rapporto debito/PIL
nel medio-lungo periodo.
Nel documento in esame tali esiti sono
sottoposti ad un test di sensitività, che consiste nell’introdurre modifiche
permanenti delle ipotesi assunte nello scenario di base, riguardanti la
variazione di parametri legati a variabili demografiche (dinamica dei flussi
migratori), macroeconomiche (andamento della produttività del lavoro,
dell’occupazione e del tasso attività degli anziani e delle donne) e di finanza
pubblica (saldo primario e spesa per sanità e assistenza agli anziani e ai
disabili a lungo termine -LTC).
In linea con la metodologia utilizzata dalla
Commissione Europea, lo scenario di base assume per la proiezione del rapporto
debito/PIL fino al 2060 che le entrate fiscali si mantengano costanti in
rapporto al PIL al livello programmato per il 2018 lungo tutto l’orizzonte di
previsione. La spesa pubblica, invece, varia in funzione della dinamica delle
spese connesse con l’invecchiamento della popolazione. Il deflatore del PIL
converge al 2,0 per cento dal 2021 e il tasso di interesse nominale si assume
costante e pari al 5,0 per cento.
Tali analisi hanno la finalità di verificare
l’affidabilità dei risultati dello scenario di riferimento a fronte
dell’incertezza che caratterizza proiezioni macroeconomiche e demografiche di
lungo periodo e di indicare in quale misura eventuali interventi di riforma,
ovvero l’adozione di misure strutturali di bilancio, possano agire sulla
sostenibilità del debito.
Con riferimento al primo gruppo di
variabili, si sono valutati gli effetti di una diminuzione e di un aumento del
20 per cento medio annuo dei flussi migratori (‑62.000 unità
rispetto al flusso scontato nello scenario di base), mantenendo tuttavia la
stessa composizione per età e genere dello scenario di riferimento. Le
conseguenze sul debito di tali variazioni appaiono non trascurabili: una
riduzione dei flussi comporterebbe un allungamento del periodo necessario a
scendere sotto la soglia del 60 per cento.
Riguardo alla produttività del lavoro (v. grafico IV.9 tratto dal PdS), la
simulazione prevede uno scenario alternativo nel quale, a partire dal 2025,
tale variabile sia permanentemente superiore (o inferiore), rispetto allo
scenario di base, di 0,5 punti percentuali: gli effetti sulla dinamica del
debito appaiono trascurabili sia nel breve e medio, mentre incidono
significativamente nel lungo periodo.
Un graduale aumento del tasso di
occupazione della popolazione 15-64 anni, fino a raggiungere 1 punto più
elevato al 2060, ha
effetti marginali nei primi anni, ma si amplificherebbe successivamente.
Determina, invece, effetti più significativi sulle proiezioni del rapporto
debito/PIL, già a partire dal 2025, un aumento del tasso di attività dei
lavoratori anziani tale da raggiungere nel 2060 un incremento di 5 punti
rispetto allo scenario di base. Effetti solo nel medio-lungo periodo derivano
da un aumento della partecipazione femminile di 5 punti rispetto
all’ipotesi base (v. grafico IV.10 tratto
dal PdS).
|
Figura iV.9: sensitivita’ alle ipotesi
macroeconomiche. maggiore e minore crescita della produttivita’ (in percentuale del PIL)
|
|
|

|
|
Fonte: Elaborazioni MEF tramite il Modello di Previsione di Lungo
Periodo della Ragioneria Generale dello Stato.
|
|
FIGURA iV.10: SENSITIVITA’ ALLE IPOTESI
MACROECONOMICHE. TASSI DI OCCUPAZIONE E TASSI DI ATTIVITA DEGLI ANZIANI E
DELLE DONNE (in percentuale del PIL)
|
|

|
|
Fonte: Elaborazioni MEF tramite il Modello di Previsione di Lungo
Periodo della Ragioneria Generale dello Stato
|
Tali risultati mostrano come l’adozione di
riforme strutturali suscettibili di determinare nel medio periodo aumenti del
tasso di partecipazione al mercato del lavoro di soggetti attualmente esclusi,
potrebbero migliorare, a parità di altre condizioni, la sostenibilità di lungo
periodo delle finanze pubbliche.
Per quanto riguarda l’analisi di sensitività
relativa alle spese sanitarie legate all’invecchiamento della
popolazione, in cui si testano gli effetti sull’evoluzione del debito di una
dinamica della spesa sanitaria e per assistenza agli anziani e disabili di
lungo periodo (LTC), derivanti da ipotesi (relative a fattori non
demografici) più stringenti rispetto allo scenario di base. Anche in questo
caso gli scostamenti (che peggiorano l’evoluzione del rapporto debito/PIL)
hanno una rilevanza limitata: il rapporto scende al di sotto della soglia del
60 per cento dopo 2030.
Per quanto riguarda le variabili di finanza
pubblica, si ipotizzano variazioni del livello dell’avanzo primario
strutturale in termini di PIL rispetto al valore assunto nello scenario
base nel 2018 e mantenuto per tutto il periodo di previsione, coincidente con
il 4,7 per cento indicato dal Governo. I valori del saldo sono ridotti via via
di 1 punto percentuale scendendo fino ad un saldo pari +2,7 per cento.
I risultati mostrano (v. grafico IV.2 tratto dal PdS) che per un livello iniziale pari al
3,7 per cento il rapporto debito/PIL decresce, ma raggiunge la soglia obiettivo
solo nel 2039 (rispetto al 2031 dello scenario base). Per valori dell’avanzo
primario pari al 2,7 per cento, nel lungo periodo il debito si stabilizzerebbe
intorno all’ 80 per cento del PIL.
I valori obiettivo dei saldi indicati nel
Documento sono quindi sufficienti a garantire la sostenibilità del debito nel
lungo periodo. Più in generale, ciò richiede il mantenimento nel tempo di
elevati avanzi primari.
|
FIGURA iV.12: SENSITIVITA’ DEL DEBITO
PUBBLICO ALL’AVANZO PRIMARIO strutturale (in percentuale del PIL)
|
|

|
|
Fonte: Elaborazioni MEF tramite il Modello di Previsione di Lungo
Periodo della Ragioneria Generale dello Stato
|
Il Documento reca, infine, una specifica
analisi riguardo l’impatto delle riforme pensionistiche sulla
sostenibilità del debito. Come evidenziato grafico
IV.13, tratto dal PdS, la serie
di riforme previdenziali che si sono susseguite dal 2004 ad oggi hanno reso
compatibile la dinamica di lungo periodo delle spese age-related con la sostenibilità del debito pubblico italiano.
Tale grafico descrive le implicazioni sul
rapporto debito/PIL degli interventi normativi adottati tra il 2004 al 2011,
sulla base di un esercizio contro fattuale che ridetermina il livello iniziale
del debito e dell’avanzo primario nell’ipotesi di assenza di interventi
normativi di riforma. Tutti gli interventi in esame hanno comportato effetti
strutturali e determinato, complessivamente, una riduzione dell’incidenza della
spesa pensionistica in rapporto al PIL rispetto alle previsioni a legislazione
previgente, avendo effetto, pertanto, sul valore attuale dei flussi di spesa
attesi.
I risultati mostrano che nello scenario che
sconta l’assenza delle riforme adottate dal 2004, il rapporto debito/PIL
continuerebbe a ridursi, ma si attesterebbe su livelli permanentemente più alti
rispetto a quelli dello scenario di riferimento (linea verde scuro), che invece
incorpora gli effetti finanziari della riforma adottata con la legge 214/2011.
|
FIGURA iV.13: l’IMPATTO DELLE RIFORME
SUL RAPPORTO DEBITO/PIL (in percentuale del PIL)
|
|

|
|
Fonte: Elaborazioni MEF tramite il Modello di Previsione di Lungo
Periodo della Ragioneria Generale dello Stato
|
3.2.1 Tendenze di
medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano
Il DEF dedica un apposito approfondimento
all’illustrazione dell’andamento della spesa pubblica per pensioni in rapporto
al PIL fino al 2060, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n.
335/1995.
Per quanto riguarda il quadro demografico,
le previsioni recepiscono le ipotesi di fecondità, mortalità e flusso
migratorio netto sottostanti lo scenario centrale elaborato dall’ISTAT con base
2011[72].
Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, il tasso di crescita del PIL è
stimato intorno all’1,5 per cento medio annuo, mentre il tasso di occupazione
aumenta di 9-10 punti percentuali nella fascia di età 15-64 anni, rispetto al
valore del 2010. Per quanto riguarda la cornice normativa, le previsioni
incorporano gli effetti delle misure recate dagli interventi di riforma
adottati nel corso del 2011,
nonché l’adeguamento su base triennale (biennale dal 2021) dei coefficienti di
trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento in base alla
speranza di vita..
Sulla base di tali premesse, il rapporto fra
spesa pensionistica e PIL, cresciuto nel triennio 2008-2010 a causa della
recessione, continua a risentire negativamente dell’ulteriore fase di
recessione (in particolare, della contrazione del 2012 e del 2013),
sostanzialmente stabilizzato, negli anni 2014-2015, anche dagli effetti di
contenimento conseguenti all’elevazione dei requisiti di accesso al
pensionamento.
A partire dal biennio 2015-2016 e per circa
quindici anni, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL decresce in modo
significativo, attestandosi intorno al 15 per cento intorno al 2030, per
l’effetto di contenimento dovuto all’innalzamento dei requisiti di accesso al
pensionamento e all’introduzione del sistema di calcolo contributivo. Tali
effetti compensano significativamente quelli negativi indotti dalla transizione
demografica.
Nel periodo successivo, tali ultimi effetti
della transizione demografica uniti a quelli, altrettanto negativi, dei
maggiori importi di pensione conseguenti al posticipo del pensionamento
comportano la crescita del rapporto fra spesa pensionistica e PIL che si
protrae fino al 2044, quando raggiunge il picco massimo del 15,7 per cento.
Nella parte finale del periodo di
previsione, il rapporto decresce significativamente, fino ad attestarsi al 13,9
per cento nel 2060. Tale andamento è da ascriversi essenzialmente al
completamento del passaggio dal sistema di calcolo misto a quello interamente
contributivo, che determina un’attenuazione della dinamica degli importi di
pensione di nuova liquidazione (anche per effetto della revisione dei
coefficienti di trasformazione), ed alla progressiva eliminazione dei
pensionati nati negli anni del baby boom.
In sintesi, a seguito delle modifiche
normative introdotte nel sistema a partire dal 2004, l’Italia presenta una
variazione della spesa pensionistica in rapporto al PIL migliore rispetto alla
media dei paesi UE, nonostante una dinamica demografica meno favorevole.
In particolare, mentre per l’insieme dei
paesi dell’area UE la spesa pensionistica in rapporto al PIL cresce in media di
1,6 punti percentuali nel periodo 2010-2060, nel caso dell’Italia, il rapporto
scende di 0,9 punti percentuali[74].
|
spesa
pubblica per pensioni in rapporto al PIL sotto differenti ipotesi normative
|
|

Note: Scenario EPC-WGA Baseline - Programma di Stabilità 2014
Fonte: Modello di Previsione di
Lungo Periodo della RGS
|
4. Approfondimenti
4.1 Esame di alcune voci di spesa
I redditi da lavoro dipendente
Il DEF fornisce una nuova previsione dei
dati di consuntivo 2013 e tendenziali per quinquennio 2014-2018 relativi alla
spesa per redditi da lavoro dipendente. Tali dati sono raffrontati,
limitatamente al quadriennio 2013-2016 con quelli recati, da ultimo, nella Nota
tecnico-illustrativa della legge di stabilità 2014.
Tabella
4.1
Spesa per redditi da lavoro dipendente (milioni di euro)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
tecnico-illustrativa L.S.
|
164.258
|
162.496
|
162.780
|
162.663
|
n.d.
|
n.d.
|
|
DEF 2014
|
164.062
|
162.884
|
163.015
|
162.945
|
162.800
|
163.291
|
|
Differenze
tra le due previsioni
|
-196
|
388
|
235
|
282
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Variazione
annua degli importi prevista in:
|
|
|
|
|
|
|
|
-Nota
|
|
-1.762
|
284
|
-117
|
n.d.
|
n.d.
|
|
-DEF
|
|
-1.178
|
131
|
-70
|
-145
|
491
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: DEF 2014
|
|
|
|
|
|
|
Rispetto a quanto rilevato nello scorso mese
di settembre si assume che il dato di consuntivo 2013 possa evidenziare un
miglioramento di 196 milioni, viene, pertanto, sostanzialmente confermato il
dato previsionale fornito dalla Nota tecnico illustrativa (NTI). Dato questo
miglioramento di partenza, la diminuzione che si presume di riscontrare per il
2014 passa da 1.762 a
1.178 milioni mentre il dato 2015 passa da un peggioramento di 284 milioni ad
uno di 131. La differenza cumulata tra le due previsioni comporta un incremento
della spesa complessiva pari a 235 milioni nel 2015. Nel 2016 entrambi i
documenti ipotizzano una riduzione della spesa, di 117 milioni secondo la NTI
mentre è di 70 milioni nel DEF. La maggior parte dello scarto tra le due
previsioni scaturisce dal più ampio differenziale del dato 2013 rispetto a
quello del 2014: i risparmi che si ipotizzano di conseguire nel 2014 si
riducono di quasi 600 milioni di euro. Il trascinamento parziale di tale
peggioramento spiega la divergenza del dato 2016 proposto dal DEF rispetto a
quello stimato nella Nota.
Il DEF non indica esplicitamente la causa
della maggior spesa stimata per il 2014. Sono, invece, elencati gli interventi
normativi che hanno contribuito a determinare l’importo della spesa registrata
a consuntivo nel 2013. Nello specifico hanno inciso sull’ammontare della spesa
i seguenti interventi:
1.
la razionalizzazione del comparto scuola;
2.
il blocco dei rinnovi contrattuali per il periodo
2010-2015;
3.
l’introduzione di un limite di spesa individuale
rapportato alla retribuzione percepita nell’anno 2010;
4.
il riconoscimento solo ai fini giuridici delle progressioni
di carriera disposte nel quadriennio 2011-2014;
5.
la riduzione in base al numero del personale cessato
dell’ammontare delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;
6.
la rimodulazione delle limitazioni all’assunzione di
personale con modalità diversificate in base alla tipologia di comparto
interessato (ad esclusione dei soli comparti Scuola/AFAM e Forze armate).
La riduzione attesa nel 2014 è dovuta,
secondo il DEF, al consolidarsi delle misure di contenimento della spesa per
redditi per il pubblico impiego sopra indicate.
Il modesto incremento dello 0,1 per cento
stimato per l’anno 2015 è determinato, principalmente, dal venir meno di alcune
delle predette misure di contenimento della spesa in vigore nel periodo 2011-2014, in particolare il
limite di spesa individuale riferito alla retribuzione percepita nell’anno 2010
ed il riconoscimento ai soli fini giuridici delle progressioni di carriera.
Tali effetti di spesa sono in gran parte compensati dalla decurtazione
permanente, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2015 dalla Legge di Stabilità
2014, delle risorse destinate al trattamento accessorio in relazione ai
risparmi di spesa determinati ai sensi del D.L. 78/2010 ed inizialmente
previsti per il solo triennio 2011-2013 (successivamente prorogati dal DPR
122/2013 sino al 31 dicembre 2014). Inoltre, la previsione per l’anno 2015 non
sconta più l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al
triennio 2015-2017, a
seguito della disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 che ha
individuato, quale indennità di vacanza contrattuale di riferimento per il
predetto triennio, quella in godimento dall’anno 2010.
Negli anni 2016 e 2017 la spesa per redditi
si manterrebbe circa costante, per poi aumentare dello 0,3% nel 2018 in ragione della nuova
indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2018-2020.
Appare
opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio circa le cause che hanno
determinato la revisione del dato di preconsuntivo 2013 e di stima del 2014 dal
momento che la loro variazione spiega per la maggior parte le variazioni ai
dati di previsione proposti nel DEF.
Il DEF evidenzia che gli effetti di
slittamento salariale sono stimati prudenzialmente sulla base delle risultanze
nell’ultimo quinquennio.
Con slittamento salariale si indica la
differenza tra i salari effettivamente percepiti dai lavoratori e quelli
stabiliti dalla contrattazione collettiva; può derivare da pagamenti di lavoro
straordinario, da premi di operosità o da altro tipo di elargizioni.
Prestazioni sociali in denaro
Il DEF espone i dati relativi alla spesa per
prestazioni sociali in denaro 2013 e aggiorna
le previsioni relative al quadriennio al 2014-2017. Sono esposte per la prima
volte le previsioni relative al 2018.
Tabella
4.2
Spesa per
prestazioni sociali
(milioni
di euro)
|
DEF 2014
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Valore
assoluto
|
319.525
|
328.260
|
335.280
|
342.260
|
351.150
|
359.840
|
|
Var % anno
precedente
|
2,7
|
2,7
|
2,1
|
2,6
|
2,6
|
2,5
|
|
incidenza
% su PIL
|
20,5
|
20,7
|
20,6
|
20,4
|
20,3
|
20,1
|
|
Nota tecnico illustrativa LS 2014
|
|
Valore
assoluto
|
320.549
|
330.067
|
337.391
|
344.757
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Var % anno
precedente
|
2,9
|
3,0
|
2,2
|
2,2
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Incidenza %
su PIL
|
20,6
|
20,6
|
20,3
|
20,1
|
n.d.
|
n.d.
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: DEF 2014 e NTI LS 2014
Il consuntivo
2013
Con riferimento all’anno 2013 la spesa per
prestazioni sociali in denaro è risultata, nella stima di Contabilità
Nazionale, pari a 319.525 milioni registrando un’incidenza sul PIL pari al 20,5
per cento. La complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha presentato
un tasso di incremento, rispetto all'anno 2012, pari al 2,7 per cento.
Detto incremento risulta più contenuto
rispetto a quanto indicato nella Nota tecnico-illustrativa (NTI) della legge di
Stabilità 2014 e inferiore di circa 1 miliardo di euro. Il rallentamento della
dinamica di spesa in esame risulta evidente confrontando il quadriennio
2010-2013 (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,3%, prendendo a
base l’anno 2009) con il decennio 2000-2009 (tasso di variazione medio annuo
pari a circa 4,4%, prendendo a base l’anno 1999) e a maggior ragione con il
quadriennio precedente 2006-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa
4,7%, prendendo a base l’anno 2005).
In particolare, per quanto concerne la spesa
pensionistica (+2,3%), l’indicizzazione ai prezzi applicata al 1°gennaio 2013 è
stata pari a 3,1 per cento con deindicizzazione totale, come per l’anno 2012, in relazione ai
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento
minimo INPS. I residuali fattori di incremento sono riconducibili al saldo tra
le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici
che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere
e ad arretrati liquidati;
L’incremento relativo alla spesa per le
altre prestazioni sociali in denaro (+4,5%), risente tra l’altro,
dall’incremento della spesa per ammortizzatori sociali, da ascrivere, in
particolare, all’incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità
di mobilità per effetto sia del maggior ricorso agli istituti, sia degli
interventi normativi relativi al potenziamento degli stessi attraverso
l’introduzione di ASPI e Mini ASPI.
Previsioni
per l’anno 2014
Per l’anno 2014, la stima della spesa per prestazioni
sociali in denaro, a legislazione vigente, è prevista in aumento, rispetto
all’anno 2013, di circa il 2,7 per cento.
La spesa pensionistica è prevista in aumento
del 2,3%; tale previsione incorpora, tra l’altro, la liquidazione di nuove
pensioni,
i tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, la
rivalutazione delle pensioni in essere (pari, per l’anno 2014, a 1,2%), la
ricostituzione degli importi delle pensioni in essere, nonché gli effetti conseguenti
alle disposizioni contenute nella L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
In particolare, si fa riferimento alla
rivalutazione delle pensioni ai prezzi per l’anno 2014 secondo il meccanismo
delineato per le pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS, di cui all’articolo 1, comma 483, della L. 147/2013. Si tiene
altresì conto degli interventi diretti ad incrementare il numero di lavoratori
salvaguardati dall’innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento, come
definiti dall’articolo 24 del DL 201/2011.
La previsione considera infine gli elementi emersi nell’ambito dell’attività di
monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l’anno 2013 e dei primi
elementi disponibili per l’anno 2014.
Per quanto concerne la spesa per altre
prestazioni sociali in denaro (+4,3%), la previsione tiene anche conto delle
misure di potenziamento degli strumenti di ammortizzatori sociali previste
dalle disposizioni relative alla legge di riforma del lavoro cosiddetta Fornero
(L. 92/2012) e degli interventi introdotti dalla legge n. 147/2013 (legge di
Stabilità 2014), tra i quali il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga, l’incremento delle risorse destinate alla sperimentazione di misure di
contrasto alla povertà e per l’inclusione attiva, la revisione della disciplina
di riconoscimento dell’indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici che
maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento dal 2014 (di cui
all’articolo 1, commi 484 e 485, della L. 147/2013, con effetti, in
particolare, negli anni successivi), nonché degli elementi emersi nell’ambito
dell’attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l’anno 2013
e dei primi elementi disponibili per l’anno in corso.
Previsioni per gli anni 2015-2018
Per il periodo 2015-2018, la complessiva
spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di variazione medio
del 2,3 per cento annuo. Il tasso di variazione medio del periodo per la spesa
pensionistica risulta pari al 2,5 per cento annuo, mentre quello della spesa
per altre prestazioni sociali in denaro pari all’1,7 per cento annuo.
Per quanto riguarda la spesa pensionistica,
gli specifici tassi di variazione sono condizionati dalla rivalutazione delle
pensioni, dal numero di pensioni di nuova liquidazione, dai tassi di cessazione
e dalla ricostituzione delle pensioni in essere, tenendo altresì conto degli
interventi normativi successivi alla DL 201/2011, diretti ad incrementare il
numero di lavoratori salvaguardati dall’innalzamento dei requisiti di accesso
al pensionamento, di cui all’articolo 24 del suddetto DL 201/2011.
Per quanto concerne la spesa per altre
prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di variazione risentono delle
specifiche basi tecniche riferite alle diverse tipologie di prestazione e degli
aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano. Dal 2014 si tiene conto
anche degli effetti relativi sia al finanziamento degli ammortizzatori sociali
in deroga, come previsti a legislazione vigente, sia al potenziamento degli
strumenti di tutela del reddito.
La spesa sanitaria
Il DEF espone i dati relativi alla spesa
sanitaria 2013 e aggiorna le previsioni per il periodo 2014-2017. Per la prima
volta sono presentate le previsioni relative al 2018.
I risultati 2013 e le previsioni per il 2014.
Tabella
4.3
La spesa sanitaria nel conto della P.A.
(milioni di euro - %)
|
DEF 2014
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
valore
assoluto
|
111.094
|
109.611
|
109.254
|
111.474
|
|
var % su
anno precedente
|
-1,3
|
-1,3
|
-0,3
|
2,0
|
|
incidenza %
su spesa netto interessi
|
15,5
|
15,3
|
15,2
|
15,3
|
|
incidenza %
su PIL
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
|
Nota
illustrativa L.S. 2014
|
|
|
|
|
|
valore
assoluto
|
111.593
|
110.842
|
111.108
|
113.116
|
|
var % su
anno precedente
|
-0,8
|
-0,7
|
0,2
|
1,8
|
|
incidenza %
su spesa netto interessi
|
15,5
|
15,5
|
15,4
|
15,5
|
|
incidenza %
su PIL
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
|
Fonte:
DEF 2014 e Nota tecnico illustrativa LS 2014
|
Sulla base dei dati acquisiti al IV
trimestre, nel 2013 la spesa è risultata pari a 109.254 milioni, segnando una riduzione dello 0,3 per cento
rispetto all’anno precedente. Si conferma al 7 per cento l’incidenza sul PIL,
mentre si riduce di un decimo di punto il peso sulla spesa al netto degli
interessi (15,2 per cento).
Tale risultato é inferiore di oltre 1,8
miliardi rispetto al pre-consuntivo indicato nella Nota tecnico-illustrativa
della Legge di stabilità 2014: la revisione incorpora anche la variazione delle
stime relative agli anni precedenti, riviste in riduzione per circa 500 milioni
nel 2011 e 1,2 miliardi nel 2012.
Tabella
4.4
Spesa
sanitaria - composizione: risultato 2013 e previsioni 2014
(milioni di euro - %)
|
|
2013
|
2014
|
2013
|
2014
|
|
|
(milioni)
|
(var % annua)
|
|
Spesa
sanitaria
|
109.254
|
111.474
|
-0,3
|
2,0
|
|
Beni e
servizi da produttori non market
|
65.294
|
66.432
|
n.d.
|
1,7
|
|
di cui
|
|
|
|
|
|
Redditi da
lavoro dipendente
|
36.024
|
36.054
|
-1,1
|
0,1
|
|
Consumi
intermedi
|
29.270
|
30.378
|
0,3
|
3,8
|
|
Beni e
servizi da produttori market
|
39.246
|
40.014
|
n.d.
|
2,0
|
|
Farmaci
|
8.637
|
8.766
|
-3,0
|
1,5
|
|
medicina di
base
|
6.669
|
6.676
|
-0,7
|
0,1
|
|
altre
prestazioni (ospedaliera, specialistica, riabilitative, integrative, altra
assistenza)
|
23.940
|
24.752
|
1,4
|
3,4
|
|
Altre
componenti di spesa
|
4.714
|
5.029
|
-1,1
|
6,7
|
|
Fonte: DEF
2014
|
|
|
|
|
All’interno delle prestazioni relative a produttori
non market (assistenza
ospedaliera e altri servizi sanitari offerti direttamente dagli operatori
pubblici), la spesa per il personale dipendente è diminuita dell’1,1 per cento.
Su tale evoluzione incide il blocco del turnover nelle regioni in piano di
rientro e le politiche di contenimento delle assunzioni per le regioni non in
piano. Incidono inoltre favorevolmente gli effetti di contenimento della spesa
conseguenti all’obbligo per le regioni di garantire con appositi accantonamenti
la copertura integrale degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. Ciò ha
comportato una maggiore congruità nella valutazione dei relativi costi e una
riduzione delle sopravvenienze passive di rilevante entità negli esercizi
finanziari successivi a quello della sottoscrizione del contratto.
Aumentano dello 0,3 per cento i consumi
intermedi. Tale dinamica sconta le misure di contenimento adottate negli ultimi
anni, che comportano:
- una riduzione del 10 per cento dei
corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi e dei corrispondenti volumi di
acquisto per tutta la durata residua dei contratti in essere, con la
possibilità per le regioni di adottare misure alternative di contenimento della
spesa, nel rispetto degli obiettivi programmati e dell’equilibrio finanziario,
nonché l’obbligo per le aziende sanitarie di rinegoziare i contratti (ed
eventualmente recedere) qualora i prezzi unitari siano superiori del 20 per
cento rispetto ai prezzi di riferimento;
- la fissazione di un tetto alla spesa per
dispositivi medici, pari al 4,8 per cento del livello di finanziamento del SSN
cui concorre in via ordinaria lo Stato (4,4 per cento dal 2014);
- la rideterminazione del tetto sulla spesa
farmaceutica ospedaliera dal 2,4 al 3,5 per cento, con fissazione al 50 per
cento della quota di ripiano dello sfondamento del tetto a carico delle aziende
farmaceutiche, mentre il restante 50 per cento del disavanzo resta a carico
delle regioni nelle quali è superato il tetto di spesa, in proporzione dei
rispettivi disavanzi.
Per quanto riguarda la spesa dei
produttori market, al risultato
complessivo (una spesa sostanzialmente stazionaria rispetto all’esercizio
precedente) contribuisce, in primo luogo la riduzione della farmaceutica (-3
per cento), sulla quale influiscono l’aumento della compartecipazione a carico
dei cittadini(+2 per cento rispetto al 2012), sia nelle regioni in piano di
rientro che nelle restanti realtà territoriali,
la riduzione del prezzo medio dei farmaci (-5 per cento) il potenziamento del
monitoraggio delle prescrizioni attraverso il sistema Tessera sanitaria, nonché
le misure di contenimento varate negli anni precedenti.
Tra queste vi é la rideterminazione del
tetto della spesa farmaceutica territoriale (voce in cui confluisce la spesa
farmaceutica convenzionale) dal 13,1 per cento del finanziamento cui concorre
lo Stato del 2012 all’11,35 per cento dal 2013 e la modifica del meccanismo di
ripiano dell’eventuale sforamento della spesa.
Si rileva, inoltre, una riduzione della
spesa per l’assistenza medico-generica (-0,7 per cento) a fronte di un aumento
della spesa per altre prestazioni (che comprendono la specialistica,
l’ospedaliera convenzionata, la riabilitativa ed altra assistenza) (+1,4 per
cento).
Al risultato di queste ultime contribuisce
la riduzione in misura percentuale fissa (1 per cento rispetto al valore
registrato consuntivo nel 2011) degli importi e dei volumi degli acquisti da
erogatori privati prevista dal D.L. 95/2012
e, più in generale, la migliore regolazione, anche nelle regioni in disavanzo,
dell’accreditamento degli operatori privati con l’assegnazione di tetti di
spesa e l’attribuzione di budget, e la tendenza a trasferire gli oneri di
carattere socio-sanitario al di fuori della sanità. Per quanto riguarda la
specialistica, un effetto di contenimento della spesa è ascrivibile anche alla
reintroduzione dei ticket.
Le altre componenti di spesa evidenziano,
infine, una riduzione dell’1,1 per cento.
Con riferimento al 2014, come
precisato dal DEF, le previsioni sono elaborate sulla base del quadro
macroeconomico e dei dati ufficiali Istat concernenti il conto consolidato
della Sanità 2011-2013 aggiornato al IV trimestre 2013, delle rettifiche
operate sul 2011 e dell’acquisizione dei dati di consuntivo 2012.
La spesa prevista, pari a 111.474 milioni
(+2 per cento rispetto al precedente esercizio) evidenzia una riduzione di
oltre 1,6 miliardi rispetto alle stime contenute nella Nota illustrativa della
legge di stabilità 2014, che sconta l’effetto di trascinamento della revisione
degli esercizi precedenti.
All’interno della spesa dei produttori non market, il complesso dei redditi
da lavoro dipendente aumenta dello 0,1 per cento. Tale variazione sconta i dati
sul costo del personale rilevati al IV trimestre del 2013 e il limite al
riconoscimento di incrementi retributivi stabilito dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda i consumi intermedi,
sono previsti aumentare del 3,8 per cento rispetto al 2013. Su tale andamento
incidono in riduzione le misure di contenimento della spesa già ricordate e
in aumento l’incremento dell’aliquota IVA al 22 per cento.
All’interno della spesa dei produttori market, che aumenta complessivamente del 2 per cento, la farmaceutica
è attesa aumentare dell’1,5 per cento. La previsione sconta le misure prima
ricordate e l’abbassamento del tetto stabilito per la farmaceutica territoriale
all’11,35 per cento.
La medicina di base presenta un aumento
dello 0,1 per cento che sconta gli effetti dei limiti agli incrementi
retributivi al personale convenzionato con il SSN.
Le altre prestazioni in convenzione
presentano una variazione positiva del 3,4 per cento. Tale stima sconta, da un
lato, gli effetti delle misure di contenimento della spesa ed, in particolare,
della riduzione del 2 per cento rispetto al valore 2011 degli importi e dei
volumi degli acquisti da erogatori privati;
dall’altro, gli effetti della non applicabilità - a seguito della sentenza n.
187/2012 della Corte costituzionale - di quanto disposto dall’articolo 17,
comma 1, lett. d, del D.L. 98/2011 che prevedeva, attraverso un regolamento ai
sensi della legge 400/1988, l’introduzione di misure di compartecipazione alla
spesa per un importo pari a 2 miliardi a decorrere dal 2014 (i ticket sono
portati in riduzione del livello di spesa). Sono infine inclusi i maggiori
costi (pari a 82 milioni per l’anno in corso) connessi al finanziamento a
carico dello Stato delle attività dei Policlinici universitari e degli ospedali
non statali[87].
Le altre componenti di spesa (pari a 5
miliardi nel 2014) sono previste in aumento del 6,7 per cento.
Le previsioni per gli anni 2015-2018
Tabella
4.5
La spesa
sanitaria nel conto della P.A.
(milioni di euro - %)
|
DEF
2014
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
valore
assoluto
|
111.474
|
113.703
|
116.149
|
118.680
|
121.316
|
|
var % su
anno precedente
|
2,0
|
2,0
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
|
incidenza %
su spesa netto interessi
|
15,3
|
15,5
|
15,6
|
15,8
|
15,8
|
|
incidenza %
su PIL
|
7,0
|
7,0
|
6,9
|
6,9
|
6,8
|
|
Nota
illustrativa L.S. 2014
|
|
|
|
|
|
|
valore
assoluto
|
113.116
|
114.926
|
117.048
|
n.d.
|
n.d.
|
|
var % su
anno precedente
|
1,8
|
1,6
|
1,8
|
n.d.
|
n.d.
|
|
incidenza %
su spesa netto interessi
|
15,5
|
15,6
|
15,8
|
n.d.
|
n.d.
|
|
incidenza %
su PIL
|
7,1
|
6,9
|
6,8
|
n.d.
|
n.d.
|
|
Fonte: DEF 2014 e Nota tecnico
illustrativa LS 2014
|
Nel
periodo 2015-2018, la spesa sanitaria cresce ad un ritmo del 2,1 per cento
medio annuo, inferiore alla variazione attesa del PIL nominale (+3 per cento
annuo): l’incidenza della spesa sul prodotto si riduce pertanto lievemente,
passando dal 7 per cento del 2014 al 6,8 per cento del 2018. Aumenta invece di
0,5 punti l’incidenza sulla spesa corrente al netto degli interessi per la
quale si prevede una variazione più contenuta.
Le
previsioni scontano il quadro macroeconomico previsto per il periodo di riferimento,
un profilo di spesa per le diverse componenti coerente con la dinamica
registrata negli ultimi anni, l’efficacia delle misure di contenimento della
spesa adottate. Sono inoltre inclusi i maggiori costi pari
a 35 milioni annui relativi al finanziamento dei Policlinici universitari non
statali.
4.2 L’impatto macroeconomico delle riforme
Il DEF evidenzia che sia la normativa
nazionale che quella comunitaria
prevedono una forma di flessibilità sul calendario di convergenza verso
l’Obiettivo di Medio Periodo (MTO)
in presenza di riforme strutturali di impatto macroeconomico significativo.
Presupposto per l’ottenimento di una maggiore flessibilità di bilancio in
concomitanza con l’adozione di riforme strutturali è che queste ultime siano in
grado di generare effetti positivi sulla sostenibilità di medio-lungo periodo
delle finanze pubbliche, anche attraverso un aumento della crescita potenziale.
Il documento presta quindi particolare
attenzione alla illustrazione degli effetti macroeconomici degli interventi
programmati dal Governo e ai relativi riflessi in termini di miglioramento
strutturale delle finanze pubbliche del Paese, anche al fine di evidenziare la
sussistenza delle condizioni richieste per l’ammissibilità della deviazione
temporanea dal percorso di convergenza verso l’MTO proposta dal Governo nello
stesso documento.
Si ricorda infatti che nel DEF, anche in
considerazione all’esigenza di far fronte agli ‘eventi eccezionali’ costituiti
dalla forte recessione del 2012 e del 2013, viene dichiarata l’intenzione di
operare una deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all’ MTO,
fissato dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale. L’intenzione
dichiarata e sottoposta ad autorizzazione parlamentare è quella di ridurre il
disavanzo strutturale nel 2014 di soli 0,2 punti percentuali di PIL rispetto al
2013, contro l’ammontare minimo di 0,5 punti richiesto dal percorso di
convergenza all’MTO.
Ove tale deviazione fosse autorizzata, gli
andamenti tendenziali risulterebbero sufficienti al raggiungimento dei più
contenuti obiettivi di miglioramento dei saldi strutturali, senza la necessità
di adottare nell’esercizio in corso, ulteriori misure correttive (che si
renderebbero invece necessarie nel 2014, in misura pari a 0,3 punti di PIL, in
caso contrario). Non emergerebbero comunque spazi finanziari utilizzabili per
il finanziamento delle riforme proposte, che dovrebbero pertanto, in ogni caso,
essere finanziate con apposite coperture.
Nel presentare le principali riforme di
prossima attuazione, il documento fornisce un’indicazione preliminare anche
delle corrispondenti coperture. In particolare il documento preannuncia:
§
la riduzione del carico fiscale per le famiglie
a basso reddito, mediante un aumento selettivo delle detrazioni per lavoro
dipendente. La corrispondente perdita di gettito, indicata in 6 miliardi nel
2014 e 10 miliardi negli anni successivi, sarà integralmente coperta con
interventi di contenimento della spesa pubblica che ne modifichino il livello e
la composizione;
§
la riduzione del carico fiscale a beneficio
delle imprese, mediante una diminuzione del 10 per cento dell’IRAP. Le minori
entrate derivanti da tale provvedimento, non indicate nel loro importo, saranno
coperte interamente con il maggior gettito derivante dalla revisione dell’imposizione
fiscale sulle rendite finanziarie.
Sono inoltre menzionate riforme già
adottate e in corso di implementazione, tra cui il pagamento dei debiti
commerciali della P.A. per un ammontare di 13 miliardi nel 2014 (aggiuntivi
rispetto a quelli previsti a legislazione vigente) e
una serie di interventi in materia di liberalizzazioni e semplificazioni e sul
mercato del lavoro, rispetto alle quali il documento sottolinea l’esigenza di
ulteriori interventi volti alla loro prosecuzione e perfezionamento.
Oltre a fornire l’impatto di queste riforme
sui principali aggregati macroeconomici è considerata anche la loro retroazione
sul saldo primario e sul debito, entrambi in rapporto al PIL.
Di seguito si riportano i dati relativi
all’impatto macroeconomico sul PIL delle misure considerate nel DEF.
Tabella 4.6
Impatto macroeconomico delle misure programmatiche
2014
(effetti cumulati sul PIL e sul saldo primario(*)
rispetto alla simulazione base)
|
Descrizione misura
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Aumento delle detrazioni IRPEF sui
redditi da lavoro dipendente
|
PIL
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,6
|
0,6
|
|
Saldo
prim.
|
0,4
|
0,6
|
0,5
|
0,5
|
0,4
|
|
Riduzione dell’IRAP
|
PIL
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Saldo
prim.
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Revisione della tassazione sulle rendite
finanziarie
|
PIL
|
0,0
|
0,0
|
-0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
|
Saldo
prim.
|
0,0
|
-0,2
|
-0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
|
Spending
review
|
PIL
|
-0,1
|
-0,2
|
-0,3
|
-0,2
|
-0,1
|
|
Saldo
prim.
|
-0,3
|
-0,4
|
-0,4
|
-0,3
|
-0,4
|
|
Liberalizzazione e semplificazione (L.
n. 27/12, L. n. 35/12, L. n. 98/13, DDL A.S. n. 958)
|
PIL
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,6
|
0,9
|
|
Saldo
prim.
|
-0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
0,0
|
|
Riforma del mercato del lavoro (L. n.
95/2012, come modificata dal D.L. n. 34/2014)
|
PIL
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,8
|
|
Saldo
prim.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-0,1
|
|
Totale
|
PIL
|
0,3
|
0,6
|
1,0
|
1,5
|
2,2
|
|
Saldo prim.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-0,1
|
|
Effetti
delle riforme sul rapporto debito/PIL
|
-0,2
|
-0,8
|
-1,3
|
-2,1
|
-3,5
|
(*) Con riferimento al saldo primario, il
segno positivo indica un peggioramento rispetto allo scenario di base.
Fonte: DEF 2014 - Estratto dalla tavola
III.8 del programma di stabilità.
Si
osserva in proposito che la massima parte dell’impatto macroeconomico sul PIL (dal 100% nel primo esercizio al 77%
nell’ultimo esercizio considerato nella tabella) è ascritto a riforme già
adottate dai precedenti governi, rispetto alle quali il documento in esame
evidenzia l’esigenza di interventi di perfezionamento. Il mancato scorporo
degli effetti macroeconomici derivanti da misure pregresse, rispetto agli
effetti derivanti dagli interventi di perfezionamento delle misure stesse, non
consente di individuare puntualmente il contributo complessivo alla crescita e
alla sostenibilità delle finanze pubbliche delle sole riforme di nuova
attuazione. Andrebbe quindi acquisita conferma che anche le riforme pregresse
possano essere considerate nella valutazione dei presupposti per
l’ammissibilità di un rallentamento nel percorso di convergenza verso l’MTO. In
caso affermativo, andrebbe altresì chiarito su base di quali criteri vadano
selezionate le misure da includere o escludere dalla valutazione.
Nel caso in esame, ad esempio, il documento
evidenzia che non sono considerati gli effetti derivanti dalla soluzione a
regime della questione dei ritardi nei pagamenti della PA, che può avere
effetti positivi strutturali sul PIL.
Ove
tale riforma fosse stata inclusa, peraltro, si sarebbero presumibilmente dovuti
computare anche i relativi effetti negativi sul debito.
Si evidenzia, inoltre, che le riforme di
nuova attuazione presentano un impatto macroeconomico più limitato rispetto
alle precedenti; inoltre, il loro effetto sul PIL viene in larga misura
compensato da quello derivante dalle relative forme di copertura. Le riforme
pregresse non risentono di un’analoga compensazione, presumibilmente in ragione
della loro natura prevalentemente ordinamentale. Su tale aspetto appare
opportuno acquisire una conferma.
In merito all’impatto macroeconomico delle
misure di copertura, si segnala in particolare che alla spending review è ascritto inizialmente un impatto negativo sul PIL
di un decimo di punto annuo (che in termini cumulati raggiunge i 3 decimi di
punto nel 2016), mentre negli esercizi successivi alle stesse misure è ascritto
un effetto di impatto sul PIL positivo di un decimo di punto annuo (che, in
termini cumulati riduce nel 2018 l’impatto negativo degli esercizi precedenti a
un solo decimo di punto).
Andrebbe
chiarito in proposito se l’attribuzione di un effetto positivo sul PIL alla
riduzione della spesa pubblica negli esercizi 2017 e 2018, pari a un decimo di
punto all’anno, sia ascritto al venir meno di effetti di spiazzamento, e quindi
all’incremento della spesa privata a fronte del diminuire di quella pubblica..
Si
evidenzia infine che il documento non fornisce gli effetti macroeconomici di
lungo periodo ascritti alle riforme di nuova attuazione (detrazioni IRPEF,
taglio dell’IRAP e relative coperture), mentre conferma quelli, estremamente
ingenti (7,1 punti di PIL ), attribuiti alle riforme già adottate in precedenza
(cfr. infra). Risulterebbe pertanto opportuno un chiarimento sugli effetti
macroeconomici di lungo periodo attesi dalle nuove riforme.
In
merito all’impatto macroeconomico delle
riforme sul saldo primario in
rapporto al PIL andrebbe preliminarmente confermato che gli importi
indicati in tabella considerino le variazioni sia del numeratore che del
denominatore del rapporto, derivanti dalle riforme stesse.
Il dubbio è generato dalla circostanza che a
riforme a cui è ascritto un considerevole effetto positivo sul PIL, quali la
riforma del mercato del lavoro e quella in materia di semplificazione e
liberalizzazione, non è attribuito un analogo vantaggio in termini di rapporto
tra saldo primario e PIL.
Anche nel caso in cui le menzionate riforme
fossero prevalentemente ordinamentali e non determinassero rilevanti effetti
diretti sul saldo primario, gli effetti prodotti sul denominatore (ove inclusi
nelle stime) dovrebbero determinare un miglioramento del rapporto. Ove tale
miglioramento non si determini, in quanto le menzionate riforme sono in realtà
suscettibili di produrre effetti onerosi anche sul numeratore, compensativi di
quelli positivi recati sul denominatore, resterebbe non chiaro perché le
risorse poste a copertura delle riforme in questione non siano considerate
nella valutazione dei relativi effetti macroeconomici sul PIL.
Si
rileva in ogni caso che i dati riportati non evidenziano un contributo significativo
delle riforme al miglioramento del saldo primario in rapporto al PIL
nell’ambito dell’orizzonte di riferimento del DEF.
In merito all’impatto finanziario delle
principali riforme, il programma di stabilità presenta una tavola (tavola
III.6) riferita all’impatto sul bilancio dello Stato (non quindi sul conto
economico della PA) delle “nuove misure del PNR 2014”. Si tratta delle misure
adottate dall’aprile 2013 al marzo 2014, analizzate con maggior dettaglio in
una delle griglie allegate dell’Appendice al PNR. Tali misure non sembrano
quindi sovrapponibili con quelle sopra considerate nell’ambito della
valutazione degli effetti macroeconomici delle riforme, che considerano anche
riforme ancora da intraprendere.
Con riferimento agli effetti delle riforme sul prodotto potenziale, il DEF evidenzia
effetti positivi, non inclusi nel quadro macroeconomico e in quello
programmatico di finanza pubblica, pari ad un maggior tasso di crescita
potenziale compreso tra i 2 e i 3 decimi di punto annui. Tali effetti sono
calcolati applicando al quadro macroeconomico, inclusivo degli effetti delle
riforme, la metodologia concordata a livello europeo di calcolo della funzione
di produzione, separando l’impatto ciclico da quello strutturale.
Il documento descrive sinteticamente la
metodologia adottata, evidenziando in particolare che si stima che le riforme
riducano il livello “ancora” del NAIRU
di 0,6 punti percentuali (dal 9,4 all’8,8) e anticipino di tre anni (al 2028)
il processo di convergenza della crescita dello stock di capitale al proprio
valore di equilibrio, in linea con la Total
factor productivity.
In merito agli effetti delle riforme sul rapporto debito/ PIL, il documento
evidenzia che tale rapporto registra un’immediata flessione in conseguenza della
più alta crescita potenziale. Tale riduzione rispetto allo scenario di base è
indicata nella tabella sopra riportata per l’orizzonte temporale di riferimento
del documento. Nel lungo periodo (2026) la riduzione del rapporto debito/PIL
dovuta alle riforme è stimata in 9 punti percentuali.
Si
ricorda in proposito, come sopra segnalato, che tra le riforme oggetto di
analisi non è considerata quella relativa rimborso dei debiti pregressi della
PA e alla riduzione a regime dei tempi di pagamento, che avrebbe,
presumibilmente, un effetto negativo sul debito, parzialmente riduttivo di
quello sopra stimato.
Revisione
delle stime degli effetti macroeconomici delle riforme strutturali del 2012 e
del 2013
La tavola degli effetti macroeconomici delle
riforme programmatiche include l’impatto ascritto alle riforme pregresse
relative al 2012, frutto di una revisione al ribasso delle precedenti stime e
al 2013.
Di seguito si riportano gli effetti
aggiornati attribuiti alle predette riforme:
Tabella
4.7
Impatto
macroeconomico delle riforme 2012 e 2013
(PIL – scostamenti percentuali rispetto alla
simulazione base)
|
Descrizione misura
|
2015
|
2020
|
Lungo periodo
|
|
Riforme 2012: stime riviste
|
0,7
|
2,5
|
6,9
|
|
Riforme 2013
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|
Totale
|
0,8
|
2,7
|
7,1
|
Fonte: DEF 2014 - Tavola III.3.2 del
Programma nazionale di riforma.
Il documento esplicita i fattori alla base
delle revisioni degli effetti relativi alle riforme 2012 e il relativo importo.
In particolare viene chiarito che le revisioni sono dovute:
-
a ritardi nella attuazione delle riforme ;
-
al protrarsi della fase recessiva che
rallenterebbe l’impatto delle riforme.
Di seguito è riportato l’effetto delle
revisioni dovute ai predetti fattori:
Tabella
4.8
Revisione
degli effetti macroeconomici delle riforme del 2012
(PIL – scostamenti percentuali rispetto alla
simulazione base)
|
Descrizione misura
|
2015
|
2020
|
Lungo periodo
|
|
Riforme 2012: stime precedenti
|
1,6
|
3,9
|
6,9
|
|
Revisione
per ritardi di attuazione
|
0,3
|
0,6
|
0
|
|
Revisione
per fase recessiva
|
0,6
|
0,8
|
0
|
|
Riforme 2012: Stime aggiornate
|
0,7
|
2,5
|
6,9
|
Fonte: DEF 2014 – Elaborazione su Tavola
III.3.1 del Programma nazionale di riforma.
Si osserva che entrambi i fattori alla base
delle revisioni operate sono di carattere temporaneo, legati a ritardi di
implementazione o al protrarsi di una fase congiunturale. Pertanto restano non
rivisti gli ingenti effetti di lungo periodo attribuiti alle riforme del 2012.
Appare pertanto opportuno un chiarimento sui profili di prudenzialità delle
stime di lungo periodo degli effetti macroeconomici delle riforme 2012.
Si segnala in proposito che il documento
evidenzia che, utilizzando la metodologia CE, parzialmente difforme in materia
di stima del costo di creazione di nuove imprese, si otterrebbe una stima
leggermente inferiore anche a regime. In particolare, adottando le elasticità
stimate dalla Commissione europea (CE) alla riduzione delle barriere all’entrata
connesse ai costi amministrativi per la creazione di nuove imprese, si
otterrebbero stime dell’impatto macroeconomico positivo leggermente inferiori
con effetti anche a regime (di 0,1 punti di PIL nel 2015, 0,2 nel 2020 e 0,3
nel lungo periodo).
4.3 L’OMT nella governance
europea e il pareggio di bilancio ex
Legge n. 243 del 2012
L’obiettivo
di medio termine
Gli obiettivi di finanza pubblica, indicati
nei documenti presentati in corso d’anno dal Governo, si inquadrano nel
contesto delle regole che costituiscono la governance
europea e cioè del complesso di strumenti normativi, trattati e regolamenti
europei, tesi a rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa
politica di bilancio e garantire la solidità finanziaria dei Paesi aderenti
all’ Unione europea.
L’impianto normativo richiamato è costituito
da tre regolamenti approvati dalle Istituzioni europee nel novembre 2011
nell’ambito di un insieme complessivo di sei atti legislativi (il c.d. Six pack),
dal Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'unione economica e monetaria (cd. Fiscal Compact
), ratificato dall’Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114, e da due ulteriori
regolamenti del 21 maggio 2013, n. 472 e
n. 473
(c.d. Two pack).
Gli Stati membri, nell’ambito dell’aggiornamento
dei rispettivi programmi di stabilità, presentano un obiettivo di medio termine
(OMT), concordato in sede europea e definito sulla base del potenziale di
crescita dell’economia e del rapporto debito/PIL. Esso consiste in un livello
di indebitamento netto strutturale (corretto, cioè, per il ciclo e al netto
delle misure temporanee e una tantum) che può divergere dal requisito di un
saldo prossimo al pareggio o in attivo, ma che deve essere tale da garantire,
in presenza di normali fluttuazioni cicliche, un adeguato margine di sicurezza
rispetto alla soglia del 3 per cento dell’indebitamento ed un ritmo di
avvicinamento certo ad una situazione di sostenibilità delle finanze pubbliche.
In particolare l’obiettivo di medio termine è calcolato in termini di saldo del
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e si attesta in una forcella
stabilita tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo del saldo strutturale di
bilancio, in termini corretti per il ciclo. Il Fiscal Compact fissa l’obbligo per i Paesi il cui debito supera il
60% del PIL di convergere verso l’obiettivo del pareggio di bilancio con un
miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno lo 0,5% e di ridurre il debito
nella misura di almeno 1/20 della eccedenza rispetto alla soglia del 60%,
calcolata nel corso degli ultimi tre anni. I documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di
programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per
sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell’obiettivo di
medio termine, ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale
obiettivo nei casi di scostamento dall’obiettivo previsti per eventi
eccezionali e per scostamenti negativi del saldo strutturale emersi a
consuntivo che prevedono un meccanismo di correzione. Insieme agli obiettivi
del saldo del conto consolidato i medesimi documenti indicano anche le misure
da adottare per conseguirli.
Nella definizione degli obiettivi
programmatici è comunque possibile
tenere conto, in conformità con quanto disposto in sede europea, dei riflessi
finanziari delle riforme strutturali
con un impatto positivo
significativo sulla sostenibilità
delle finanze pubbliche.
La legge di
attuazione del principio del pareggio di bilancio
In ottemperanza alla previsione del Trattato
sulla stabilità che prevede l’inserimento della regola del bilancio in pareggio
strutturale all’interno dell’ordinamento interno con norme di carattere
vincolante e permanente, preferibilmente a livello costituzionale, ed il
recepimento di specifici meccanismi di correzione da attivare nel caso di
scostamenti tra i risultati di consuntivo e l’OMT, la legge costituzionale
20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l’ articolo 81
della Costituzione, introducendo il principio del "pareggio
di bilancio" in termini strutturali, in base al quale lo
Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle diverse fasi - avverse o favorevoli - del ciclo economico.
La definizione del contenuto della legge di
bilancio, delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare
l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stati demandati dalla
legge
costituzionale alla legge 24 dicembre 2012, n. 243,
la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2014.
Tale legge viene definita "rinforzata",
in quanto approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Essa ribadisce l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche, di assicurare l’equilibrio dei bilanci, specificando
che tale equilibrio corrisponde all' obiettivo di
medio termine ossia al valore del saldo individuato sulla
base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea, che per
l’Italia attualmente coincide con il pareggio di bilancio calcolato in termini
strutturali, quindi corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico
e al netto delle misure una tantum.
Ai sensi della legge n. 243 del 2012 l’equilibrio dei bilanci si considera
conseguito quando il saldo strutturale, calcolato in sede di consuntivo nel primo semestre
dell’esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a)
risulta almeno pari all’obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo
obiettivo di medio termine inferiore
a quello considerato significativo
ai sensi dell’ordinamento dell’Unione europea ossia non superiore allo 0,5 per
cento del PIL;
b) assicura
il rispetto del percorso di
avvicinamento all’obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali e di scostamenti dall’obiettivo
programmatico che danno luogo a meccanismi di correzione, ovvero evidenzia uno
scostamento dal medesimo percorso di avvicinamento inferiore a quello
considerato significativo in sede comunitaria (ossia fino a -0,5 per cento
rispetto all'obiettivo).
La legge dà altresì attuazione al secondo
comma del nuovo articolo 81
della Costituzione, che consente il ricorso all’indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti.
In tale ambito viene specificato che per
eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche all’area dell’euro o
all’intera Unione europea e gli
eventi straordinari, al di fuori del
controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla
situazione finanziaria generale del Paese.
Quanto alla procedura di autorizzazione, si
prevede che il Governo,
qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall’obiettivo
programmatico per fronteggiare i suddetti eventi eccezionali, sentita la
Commissione europea, presenti alle Camere una relazione di aggiornamento degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione che
indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilendo
le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello
stesso e definendo al contempo il piano di rientro verso l’obiettivo
programmatico.
La durata del piano di rientro deve essere commisurata alla gravità degli eventi
straordinari e lo stesso deve essere attuato a decorrere dall'esercizio
successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto
dell'andamento del ciclo economico. In conformità al disposto costituzionale,
la deliberazione con la quale ciascuna Camera
autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti.
Il piano
di rientro può essere aggiornato
con le medesime modalità al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali, ovvero qualora, in relazione
all’andamento del ciclo economico,
il Governo intenda apportarvi modifiche.
Per quanto riguarda invece il debito, la legge rinforzata (art. 4, co. 2) prevede che i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscano obiettivi
relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con
quanto disposto dall’ordinamento dell’Unione europea. Qualora tale rapporto
superi il valore di riferimento definito dall’ordinamento della UE, in sede di
definizione dell’obiettivo in termini di indebitamento netto nominale, occorre
tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell’eccedenza del
debito pubblico rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la
disciplina in materia di fattori
rilevanti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea. In altri termini, i
documenti di programmazione devono indicare obiettivi in termini di rapporto
tra debito pubblico e PIL idonei a ridurre il livello del debito stesso nella
misura e nei tempi previsti dalle normative UE (un ventesimo all’anno di
riduzione della differenza tra il livello del debito nazionale (134,9 per cento
del PIL nel 2014) e la soglia europea (60 per cento del PIL). Tale vincolo comporta la necessità di
realizzare ogni anno avanzi primari (differenza tra le spese e le entrate del
bilancio statale al netto della spesa per interessi). A tale principio è
possibile derogare solo in presenza dei c.d. fattori rilevanti previsti dalle
medesime normative UE. Tali fattori rilevanti (richiamati dall’art. 4 della legge n. 243 del 2012) devono
considerarsi nella misura in cui essi influenzino in modo significativo la
valutazione dell’osservanza dei criteri riferiti
al debito In altri termini, il percorso discendente del debito pubblico va
realizzato nei tempi e nei modi definiti dalla disciplina europea, tuttavia, in
presenza di fattori rilevanti, da considerarsi preliminarmente all’apertura di
una procedura per debito eccessivo, il percorso di riduzione può risultare più
graduale.
I fattori rilevanti sono, in sintesi, i
seguenti:
· l’evoluzione
della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita
potenziale;
· la
posizione in termini di risparmi netti del settore privato;
· l’evoluzione
della posizione di bilancio a medio termine, lo stato di avvicinamento
all’obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e
l’evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l’attuazione di
politiche relative agli squilibri economici eccessivi e di politiche nel
contesto di una strategia di crescita comune della UE;
· gli
sviluppi della posizione del debito pubblico a medio termine, la sua dinamica e
sostenibilità e, in particolare, i fattori di rischio;
· dovranno,
in particolare, essere tenuti in considerazione i contributi finanziari a
sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi
delle politiche UE, nonché al debito assunto in forma di sostegno bilaterale e
multilaterale agli Stati membri e l’attuazione di riforme delle pensioni volte
a promuovere la sostenibilità a lungo termine.
Si
segnala che nella valutazione del Documento programmatico di bilancio del 2014
la Commissione ha sostenuto che l'Italia, in base al quadro programmatico di
finanza pubblica prospettato dal Governo in tale documento, non rispetta il
criterio del debito nel 2014 e di conseguenza non può beneficiare della
clausola sugli investimenti. Pertanto, dovrebbe continuare a compiere progressi
sufficienti verso l’obiettivo di medio termine anche nel 2014 garantendo un
miglioramento del saldo di bilancio strutturale di almeno 0,5 punti percentuali
del PIL. Inoltre, secondo la Commissione, se lo scostamento si ripetesse l’anno
successivo potrebbe essere ritenuto significativo e mettere a rischio
l’osservanza delle prescrizioni del braccio preventivo del PSC.
Tali
valutazioni sono sostanzialmente confermate nell’opinione espressa dalla
Commissione a seguito dell’analisi approfondita sull’Italia nell’ambito della
procedura sugli squilibri macroeconomici. Nella comunicazione della Commissione
diffusa il 5 marzo scorso, con riferimento alla finanza pubblica, si
afferma, infatti, che “nel 2013 l’Italia ha compiuto progressi verso l’obiettivo
di bilancio a medio termine. Tuttavia l’aggiustamento del saldo strutturale nel
2014 potrebbe risultare insufficiente, vista la necessità di ridurre
l’elevatissimo rapporto debito pubblico/PIL a un ritmo adeguato”.
4.4 La regola della spesa
I regolamenti europei che costituiscono il
c.d. six pack[98] hanno introdotto nell'ambito del
braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) un vincolo alla
crescita della spesa (expenditure
benchmark), diretto a rafforzare il raggiungimento dell’obiettivo di medio
termine, parametrato al tasso di crescita di medio periodo del PIL
potenziale.
Il Codice di condotta stabilisce in
proposito che questo è calcolato come media delle stime dei precedenti 5
esercizi, della stima per l'esercizio corrente e delle proiezioni per i 4
esercizi successivi. Ai fini del calcolo del benchmark, esso viene aggiornato periodicamente e comunicato agli
Stati membri: per quanto riguarda l’Italia, il valore relativo al 2012 e al
2013 é pari +0,3 per cento, mentre per il triennio 2014-2016 il valore è pari a
zero.
L'aggregato di spesa pubblica
sottoposto a valutazione è individuato nel totale della spesa delle
Amministrazioni Pubbliche[100]
diminuito della spesa per interessi, della spesa nei programmi europei per la
quota coperta da fondi comunitari e della componente legata al ciclo delle
spese non discrezionali per indennità di disoccupazione.
L'aggregato deve essere poi depurato dalla volatilità intrinseca della spesa
per investimenti, prevedendo che il valore iscritto in ciascun esercizio sia
sostituito da un valore medio calcolato sulla base della spesa per l'esercizio
in corso e quella relativa ai tre esercizi precedenti. Deve inoltre essere
aggiunta la stima delle maggiori spese, rispetto a quelle iscritte nel
tendenziale a legislazione vigente, secondo lo scenario a politiche invariate.
Al valore della spesa così ottenuto devono
essere sottratte le entrate derivanti da misure discrezionali, considerando
l’incremento rilevato (o atteso) nell’anno t
rispetto all’esercizio precedente (t-1).
A queste si aggiungono (purché non ricomprese nella precedente voce o già
scontate nei tendenziali) le eventuali maggiori entrate derivanti da innalzamenti
automatici di imposte e/o tasse previsti dalla legislazione a copertura di
poste specifiche di spesa.
Poiché il PIL potenziale è stimato in
termini reali, la spesa così determinata è deflazionata con il deflatore del
PIL quale risulta dalle previsioni della Commissione: per l’Italia, per la
valutazione del rispetto della regola nel 2012 e nel 2013, tale valore è pari,
rispettivamente, all’1,87 nel 2012 all’1,88 per cento.
Per il 2014 e il 2015, si utilizza la media dei valori del deflatore del PIL
indicati per tale anno dalle previsioni della Commissione pubblicate nell’anno
precedente (media previsioni Spring e
Autumn del 2013). Per gli anni
successivi a quelli per i quali si dispongono le previsioni della Commissione,
si utilizzano i valori del deflatore indicati dai Governi nell’aggiornamento annuale
dei Programmi di stabilità.
Il limite massimo per la variazione della
spesa è diverso a seconda della posizione di ciascuno Stato rispetto
all'OMT, in quanto è diretto a garantire la coerenza con il percorso di
convergenza concordato. Per gli Stati membri che hanno già raggiunto l'OMT, la
crescita della spesa pubblica non deve essere più elevata del parametro medio
relativo al PIL potenziale. Eventuali dinamiche di crescita superiori possono
essere consentite soltanto se compensate da misure discrezionali dal lato delle
entrate di pari ammontare. Per gli Stati che non hanno ancora raggiunto l'OMT
il tasso di crescita della spesa deve essere inferiore a quello del PIL
potenziale e coerente con un miglioramento del saldo strutturale di almeno 0,5
punti in termini di PIL.
Per l’Italia, secondo le stime della
Commissione, il c.d. shortfall risulta
pari a -1,1 punti:
per il 2012-2013, a
fronte di una crescita del potenziale pari +0,3 per cento, il benchmark prevede una variazione
negativa dell’aggregato di spesa pari a -0,8. Per il triennio 2014-2016
(esercizio in cui, secondo le stime contenute nel DEF, dovrebbe essere
raggiunto l’OMT), a fronte di una crescita economica nulla, il benchmark è pari a -1,1 per cento. A
partire dal 2017 il benchmark
dovrebbe essere allineato alla variazione del PIL potenziale.
Il rispetto del benchmark viene valutato ex post nell’ambito del giudizio
sull’avvicinamento o raggiungimento dell’OMT. Uno scostamento nella dinamica
della spesa dal valore di riferimento non ha conseguenze se il Paese ha già
raggiunto l’OMT e questo non sia pregiudicato.
Per un Paese che non abbia raggiunto
l’OMT e che presenti una deviazione del saldo di bilancio rispetto al percorso
di avvicinamento pari o superiore allo 0,5 per cento del PIL in un anno (o
cumulativamente in due anni), lo scostamento viene considerato significativo se
la spesa al netto delle misure discrezionali sulle entrate ha un impatto sul
saldo pari ad almeno allo 0,5 per cento del PIL in un anno (o cumulativamente
in due anni).
4.5 La regola del debito
Il quadro di riforma della governance
economica dell'UE, adottato nel novembre 2011(six pack) e richiamato nel
fiscal compact, rafforza il controllo della disciplina di bilancio
attraverso l'introduzione di una regola numerica che specifica il ritmo di
avvicinamento del debito al valore soglia del 60 per cento del PIL[105].
In particolare, il nuovo articolo 2 del
regolamento 1467/97 stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in
eccesso rispetto al valore del 60%, il tasso di riduzione debba essere pari ad
1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi[106].
Nel caso in cui il valore del rapporto
debito/PIL nell’esercizio di riferimento sia superiore al benchmark, la
Commissione deve verificare se il mancato rispetto della regola possa essere
attribuibile a effetti ciclici o se, sulla base delle previsioni a politiche
invariate, è prevista una correzione entro i due anni successivi al primo anno
di valutazione (t+2)[107].
Per quanto riguarda il primo aspetto,
occorre considerare che una regola sul debito che non tenga in considerazione
gli andamenti ciclici potrebbe portare a risultati incoerenti con la fissazione
di obiettivi di saldo in termini strutturali, depurato cioè dagli effetti degli
stabilizzatori automatici. Essa, inoltre, rischierebbe di essere fortemente
pro-ciclica, penalizzando un deterioramento delle finanze pubbliche non
imputabile a fattori strutturali. Per tale ragione la regola di benchmark
del debito é affiancata da un'altra formula che misura il debito aggiustato per
l'andamento ciclico[108].
In fasi negative del ciclo, il rapporto debito/PIL aggiustato risulterà
inferiore rispetto a quello effettivo, in quanto il debito verrà depurato per
l'effetto degli stabilizzatori automatici e il PIL nei tre anni precedenti
viene fatto variare al tasso di crescita del PIL potenziale. E' da notare che
tale formula non viene utilizzata dalla Commissione nelle fasi positive del
ciclo, nelle quali il debito aggiustato risulterebbe superiore rispetto a
quello effettivo (una componente ciclica positiva farebbe aumentare il
numeratore e quindi il valore del rapporto). In altre parole, ai paesi non é
chiesto, in relazione al debito, uno sforzo aggiuntivo nei "tempi
buoni".
In conclusione, la prima formula fornisce il
livello di debito in percentuale sul PIL da perseguire che, qualora raggiunto,
esime il paese da ulteriori sforzi; la seconda formula serve, invece, a
valutare - qualora l'applicazione del primo algoritmo evidenziasse un mancato
rispetto del benchmark - se la regola possa essere considerata comunque
effettivamente rispettata, tenuto conto della possibilità di scontare gli
andamenti ciclici.
Qualora il rapporto debito/PIL fosse più
alto del benchmark anche dopo l’aggiustamento per il ciclo e rimanesse
più elevato anche in prospettiva (nei due anni successivi all’anno di
riferimento), la Commissione sarà chiamata a redigere un rapporto ex art.
126(3) TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), nel quale al benchmark
numerico si aggiungono valutazioni “qualitative” relative a un certo insieme di
“altri fattori rilevanti”. L’analisi di tali fattori rappresenta, quindi, un
passo obbligato nelle valutazioni che inducono ad avviare una procedura per
disavanzi eccessivi a causa di una mancata riduzione del debito ad un “ritmo
adeguato”.
Nella relazione si prende in considerazione
l’evoluzione di medio periodo del quadro macroeconomico e di finanza pubblica,
ed in particolare:
· l'evoluzione
della posizione economica a medio termine;
· gli
sviluppi nella posizione del debito a medio termine, la sua dinamica e
sostenibilità, anche alla luce di fattori di rischio legati alla struttura per
scadenze e alla denominazione in valuta;
· le
operazioni di aggiustamento stock-flow;
· le
riserve accantonate e le altre voci dell’attivo del bilancio pubblico;
· le
garanzie, specie quelle legate al settore finanziario;
· le
passività, sia esplicite che implicite, connesse all’invecchiamento della
popolazione e al debito privato, nella misura in cui questo rappresenti una
passività implicita potenziale per il settore pubblico.
Particolare attenzione meritano, inoltre,
gli interventi di sostegno tra Stati membri o nei confronti dell’EFSF/MES nel
contesto della salvaguardia della stabilità finanziaria: qualora la regola non
fosse rispettata, la Commissione dovrà valutare in quale misura tali interventi
incidano sul debito e verificare se, al netto di essi, la regola risulti
rispettata.
La Commissione tiene infine in debita
considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro
interessato, sono significativi per valutare gli osservanza dei criteri
relativi al disavanzo e al debito.
Nel
caso di Stati membri che siano stati sottoposti alla procedura di deficit
eccessivo, è previsto un periodo di transizione di tre anni (dall’uscita
della PDE) per l’applicazione della regola. In tale periodo, gli Stati devono
prevedere un aggiustamento fiscale strutturale “minimo”, cioè una correzione
del saldo di bilancio che garantisca un progresso continuo e realistico verso
il benchmark del debito, considerando la regola meno stringente.
L’aggiustamento deve essere tale da rispettare le seguenti condizioni:
§
l’aggiustamento strutturale annuo del saldo di
bilancio non deve scostarsi più dello 0,25 per cento del PIL dell’aggiustamento
richiesto per assicurare la regola del debito a fine periodo;
§
in qualsiasi momento del periodo di transizione,
il restante aggiustamento strutturale annuo non deve superare lo 0,75 per cento
del PIL.
Tale percorso di aggiustamento è evidenziato
dalle seguenti figure (tratte dalla Nota Ecofin/ C1-C4 (2011):

E’ da rilevare che il sentiero di
aggiustamento lineare viene rivisto alla fine del primo e del secondo anno del
periodo transitorio, al momento dell’invio della notifica alla Commissione
europea e dell’aggiornamento annuale dei programmi di stabilità, per tener
conto dei risultati conseguiti e dell’aggiornamento del quadro macroeconomico e
delle previsioni del debito. A chiusura del terzo anno viene valutato ex post
il rispetto della regola.
A conclusione della valutazione ex post
di ogni “step”, l’eventuale mancato rispetto dell’aggiustamento
richiesto attiva la preparazione di un rapporto da parte della Commissione ai
sensi dell’articolo 126(3) del Trattato, diretto a valutare se debba essere
aperta o meno la procedura per deficit eccessivi. Anche in questo caso, la
Commissione prende in debita considerazione i “fattori rilevanti”.
4.6 L’analisi della fiscal stance
Il confronto tra l’andamento dell’avanzo
primario strutturale (cioè il saldo primario corretto per il ciclo e al netto
delle una tantum) e l’output gap, che evidenzia la
distanza tra il PIL effettivo e il PIL potenziale, consente un’analisi della fiscal
stance, la quale misura
l’indirizzo espansivo o restrittivo della politica di bilancio a fronte
dell’andamento macroeconomico.
Le variabili utilizzate nell’analisi grafica
sono riportate nella Tabella 1.
Tabella
4.9
Output
gap e avanzo
primario strutturale programmatico
(% PIL)
|
|
2013
|
2104
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Output gap
|
-4,5
|
-3,7
|
-2,7
|
-1,6
|
-0,5
|
0,6
|
|
variazioni output
gap
|
-1,4
|
0,8
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avanzo primario strutturale
|
4,5
|
4,6
|
4,9
|
5,1
|
4,9
|
4,7
|
|
Variazioni avanzo primario strutturale
|
0,4
|
0,1
|
0,3
|
0,2
|
-0,2
|
-0,2
|
|
|
Fonte: DEF 2014, La finanza pubblica
corretta per i ciclo, Tavola III.9
Il grafico 4.1 confronta la variazione
dell’avanzo primario strutturale con l’output gap nel periodo 2013-2018.
Esso si compone di quattro quadranti. Quello in alto a sinistra contiene i
punti che rappresentano situazioni di restrizione di bilancio e di ciclo
economico negativo. In basso a sinistra, si posizionano le combinazioni di
manovre espansive e ciclo economico negativo. I due quadranti a destra,
corrispondenti a situazioni economiche favorevoli, illustrano, quello in alto,
una politica di bilancio restrittiva, quello in basso, una politica di bilancio
espansiva.
Secondo la teoria economica, la politica di
bilancio dovrebbe svolgere una funzione di stabilizzazione e avere pertanto un
carattere anticiclico, attraverso l’adozione di misure di consolidamento
fiscale nella fasi positive del ciclo e viceversa nelle fasi recessive. La
crisi economica e finanziaria, e in particolare l'aumentato livello di rischio
sui titoli di debito sovrano, hanno tuttavia comportato per alcuni paesi tra
cui l’Italia la necessità per la politica di bilancio di mantenere un
compromesso tra l'esigenza di incidere sulla domanda aggregata a fini di
stabilizzazione anticiclica dell'economia e quella di garantire, al contempo,
la sostenibilità di medio e lungo termine della finanza pubblica.
In questa ottica, le regole europee
prevedono che solo gli Stati membri che abbiano già raggiunto l’obiettivo di
medio termine (OMT) e che presentino pertanto un bilancio pubblico in pareggio
strutturale possono lasciare
operare liberamente gli stabilizzatori automatici (in termini del grafico 4.1,
ciò implica che tali Paesi si trovino sull’asse orizzontale che rappresenta una
stance neutrale), o eventualmente adottare misure discrezionali per
contenere le fluttuazioni cicliche, nei limiti del rispetto del loro OMT.
Ai Paesi che non abbiano raggiunto il
pareggio di bilancio sono richiesti, invece, aggiustamenti annui in termini di
aumento dell’avanzo primario strutturale pari o superiori allo 0,5 per cento.
Essi dovrebbero pertanto trovarsi in punti situati nei due quadranti superiori
del grafico, corrispondenti a politiche di bilancio restrittive.
Per l’Italia, l’OMT è fissato nel pareggio
di bilancio strutturale da raggiungersi, secondo le raccomandazioni del
Consiglio del luglio 2013,
entro il 2014. Nel Documento in esame, l’obiettivo del pareggio di bilancio
viene indicato per il 2016.
Grafico
4.1
Variazione
dell'avanzo primario strutturale e output
gap, DEF 2014

Fonte: Elaborazioni su dati DEF 2014
Il grafico 4.1 evidenzia l’impronta
restrittiva della politica di bilancio fino al 2016. In particolare, nel 2013 in presenza di un output
gap di elevato valore negativo (-4,5 per cento), l’avanzo primario è
aumentato di 0,4 punti di PIL. Nel 2014, pur in assenza di ulteriori manovre
correttive, l’avanzo strutturale aumenta di 0,1 punti a fronte di output gap pari a -3,7 per cento.
Negli anni 2014-2015, l’avanzo tende ad
aumentare superando il 5 per cento del prodotto (con variazioni annue comprese
tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento), consentendo di raggiungere il pareggio di
bilancio strutturale nel 2016,
a fronte di un output
gap che si riduce, passando da -2,7 per cento nell’anno in corso a -1,6 per
cento alla fine del triennio. E’ da notare che tali variazioni del saldo
programmatico si determinano a fronte di misure correttive pari a 0,3 punti nel
2015 e 0,6 punti (cumulati) a decorrere dal 2016.
Negli anni 2017 e 2018, a fronte di un output gap che cambia di segno e passa
in territorio positivo, l’avanzo si riduce lievemente (- 0,2 punti annui).
Un secondo metodo per valutare la fiscal
stance mette in relazione le variazioni dell'avanzo primario strutturale
con le variazioni dell'output gap
anziché con il suo livello. Un simile approccio permette di porre maggiore
enfasi sulla dinamica del ciclo economico e di cogliere in modo più puntuale i
cambiamenti della politica di bilancio.
Grafico
4.2
Variazione
dell'avanzo primario strutturale e variazione dell’output gap, DEF 2014

Fonte: Elaborazioni su DEF 2014
Nel grafico 4.2 si nota come la stretta
fiscale attuata nel 2013 in
una fase di forte peggioramento del ciclo (l’output gap aumenta il proprio valore negativo di 1,4 punti di PIL),
si attenua nel 2014. Nell’esercizio in corso, infatti, il consolidamento di
bilancio rallenta in presenza di un output
gap che comincia a chiudersi. La politica di bilancio torna ad essere
moderatamente restrittiva nel biennio successivo in corrispondenza delle misure
correttive necessarie a raggiungere l’OMT nel 2016. Negli anni 2017-2018, in presenza di un
pareggio di bilancio in termini strutturali, la politica fiscale diventa
pro-ciclica: è prevista infatti una riduzione dell’avanzo primario (-0,2 punti
di PIL annui) a fronte di un output gap
che a fine periodo diventa di segno positivo.
4.7
Le misure una tantum
Il DEF 2014 riporta il quadro delle misure una tantum
con riferimento, per la parte di consuntivo, agli esercizi 2011-2013 e, per la
parte di previsione, al periodo 2014-2018.
Tabella
4.10
Le misure
una tantum nel DEF 2014
(milioni di euro)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Totale One-Offs
|
10.738
|
1.469
|
3817
|
445
|
-2.181
|
-64
|
140
|
160
|
|
In percentuale del PIL
|
0,7
|
0,1
|
0,2
|
0,0
|
-0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
a ) Entrate
|
6.755
|
2.122
|
3.111
|
1.325
|
729
|
469
|
10
|
10
|
|
In percentuale del PIL
|
0,4
|
0,1
|
0,2
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Imposte
sostitutive varie
|
1.595
|
770
|
541
|
641
|
250
|
0
|
0
|
0
|
|
Rientro
dei capitali/scudo fiscale-ter
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Condono
edilizio
|
41
|
39
|
32
|
30
|
25
|
15
|
10
|
10
|
|
Allineamento
bilancio ai principi IAS
|
5.115
|
643
|
2.538
|
654
|
454
|
454
|
0
|
0
|
|
Contributo
U.E. per sisma Emilia
|
0
|
670
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
b) Spese
|
3.678
|
-236
|
-87
|
-70
|
-50
|
-30
|
-20
|
0
|
|
In percentuale del PIL
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
IVA
auto aziendali
|
-37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Interventi
per calamità naturali
|
-855
|
-1.585
|
-187
|
-1.960
|
-3.860
|
-1.503
|
-350
|
-350
|
|
Dividendi
in uscita
|
-149
|
-133
|
-87
|
-70
|
-50
|
-30
|
-20
|
0
|
|
Asta
licenze
|
3.827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Compensazioni
emittenti
|
|
-103
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
c ) Dismissioni immobiliari
|
1.197
|
1.168
|
980
|
1.150
|
1.000
|
1.000
|
500
|
500
|
|
In percentuale del PIL
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Ripartizione per Sottosettori
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Amministrazioni Centrali
|
9.486
|
250
|
2.859
|
-155
|
-2.641
|
-534
|
-330
|
-310
|
|
- Enti di previdenza
|
1.008
|
792
|
617
|
350
|
240
|
260
|
250
|
240
|
|
- Amministrazione Locali
|
244
|
427
|
341
|
250
|
220
|
210
|
220
|
230
|
|
PIL[1] (x 1.000)
|
1.580
|
1.567
|
1.560
|
1.587
|
1.627
|
1.677
|
1.731
|
1.789
|
Fonte: DEF 2014 - Tavola II.2.9
Si segnala che, come di consueto, il DEF,
nel presentare la tabella ricognitiva delle misure una tantum, di seguito
riprodotta, non correda la stessa di alcun commento.
Rispetto all’analisi contenuta nella Nota di
aggiornamento al DEF 2013, l’incidenza complessiva sul PIL delle
misure una tantum registra variazioni particolarmente significative per
l’esercizio di consuntivo. Le predette misure sono infatti riviste al rialzo
nel 2013 per circa 3,4 mld (da 0,4 mld previsti dalla Nota a 3,8 mld previsti
dal DEF 14), corrispondenti ad un incidenza di due decimi di punto sul PIL.
Tale incremento spiega la metà del peggioramento del saldo strutturale
complessivamente rilevato per l’esercizio 2013.
La revisione delle una tantum è dovuta in
massima parte a tre fattori principali, uno sul lato delle entrate, uno sul
lato delle spese e uno inerente le dismissioni immobiliari:
Sul lato delle entrate incide in modo
particolarmente significativo sull’esercizio 2013 il maggior gettito
conseguito dall’imposta sostitutiva applicabile in caso di allineamento dei
valori di bilancio ai principi IAS (+ 2.538 milioni), cui si aggiunge una più
contenuta revisione al rialzo delle altre imposte sostitutive (+ 181 mln).
Si
segnala, con riferimento ai risultati dell’esercizio 2013, che in occasione
della Nota di aggiornamento al DEF 2013 si era rilevata la presenza di un
disallineamento tra la sensibile revisione al rialzo del gettito per il 2013 delle imposte in
conto capitale nel conto economico della Pubblica amministrazione e l’assenza
di riflessi di tale revisione sul quadro complessivo delle una tantum. Si era
in proposito domandato se nessuna delle imposte in conto capitale alla base del
rialzo della previsione di entrata del conto economico evidenziata dalla Nota
di aggiornamento fosse annoverabile tra quelle considerate una tantum. Sembra
quindi doversi desumere, in questa sede, che parte della attuale revisione al
rialzo delle entrate una tantum operata dal DEF fosse stata in precedenza
classificata tra le entrate ordinarie, con una conseguente sottostima del deficit
strutturale di bilancio indicato nella Nota di aggiornamento al DEF13.
A fronte dei risultati migliori riscontrati
nell’esercizio di consuntivo, il documento opera una revisione al rialzo delle
medesime voci per gli esercizi di previsione, il cui ammontare, più
contenuto,
non raggiunge il decimo di punto sul PIL e non determina quindi riflessi
percepibili in termini di variazione delle previsioni del saldo strutturale in
rapporto al PIL.
Con
riferimento agli esercizi di previsione, andrebbe chiarito se le modifiche
introdotte siano in parte da attribuirsi a fattori legislativi intervenuti
successivamente all’approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2013.
Si
segnala, in particolare, che la legge di stabilità per il 2014, ha introdotto
modifiche in tema di imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni di
impresa e sull’affrancamento maggiori valori
contabili conseguenti a operazioni straordinarie ai cui effetti di gettito non sembrano
riconducibili le variazioni apportate alle previsioni di gettito delle imposte
sostitutive. Andrebbe pertanto acquisita conferma che le menzionate fattispecie
impositive modificate dalla legge di stabilità non rientrino tra quelle
considerate quali misure una tantum.
La
legge di stabilità per il 2014
ha inoltre modificato la disciplina fiscale del
trasferimento delle quote di partecipazione al capitale di Banca d’Italia
disciplinato dall’articolo 6 del DL n. 133/2013, senza ascrivere a tali
modifiche effetti di maggiore gettito. Tali effetti, non inclusi negli
andamenti tendenziali del conto della PA, sono coerentemente non considerati
nella tavola tendenziale delle una tantum in esame (cfr. infra con riferimento
agli andamenti programmatici).
Appare
opportuno acquisire dal Governo:
§
nell’ambito delle imposte in conto capitale
considerate nel conto economico della PA, il dettaglio di quelle incluse tra le
una tantum e l’esplicita indicazione dei fattori sottostanti l’aggiornamento
delle previsioni del relativo gettito;
§
di un coordinamento tra l’aggiornamento delle
previsioni di gettito delle imposte sostitutive e quello delle imposte
ordinarie, alla cui riduzione è finalizzato il versamento delle imposte
sostitutive da parte dei contribuenti.
Sul lato delle spese, si evidenzia
che nel 2013 gli interventi per calamità naturali sono risultati a consuntivo
pari a circa un settimo di quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al DEF13
(187 mln erogati contro i 1.282 previsti, con una riduzione di 1,1 mld). Tale
riduzione risulta ancor più significativa se si ricorda che essa si aggiunge
alla revisione al ribasso di 3,2 mld già operata dalla Nota di aggiornamento al
DEF13 rispetto allo stesso DEF13, che prevedeva una spesa di 4,5 mld per il 2013. A fronte dei
risultati di spesa inferiori alle attese per il 2013, il DEF stima un recupero
solo parziale di spesa diluito nel triennio successivo, per complessivi 387
mln.
Appare
in proposito opportuno acquisire informazioni sulle determinanti che hanno
causato la cospicua riduzione degli interventi nei territori terremotati. In
particolare, in relazione alle tipologie di intervento che riscontrano minori
margini di implementazione, andrebbe chiarito se l’ostacolo risieda nella
scarsa domanda da parte dei potenziali beneficiari, poco interessati al tipo di
intervento adottato (come sembrerebbe indicare lo scarso tiraggio dei
finanziamenti riconosciuti a favore dei soggetti danneggiati dal sisma
dell’Emilia) ovvero in una tempistica di attuazione degli interventi più lunga
del previsto (in particolare nel caso di ricostruzione degli edifici di
pubblica utilità).
Con riferimento alle dismissioni
immobiliari, il DEF evidenzia il conseguimento nel 2013 di entrate
inferiori di un terzo rispetto alle attese (980 mln incassati rispetto ai 1.500
previsti), con un effetto di trascinamento sulle previsioni di incasso per i
prossimi esercizi, ridotte complessivamente di 1,2 mld su un arco di 4 anni
rispetto a quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al DEF 2013.
Al
riguardo si evidenzia che la tavola in esame, al pari di quella analoga
contenuta nella Nota di aggiornamento al DEF 2013, sembra fare riferimento
all’importo delle entrate “ordinarie” da dismissione immobiliare, senza
considerare quelle derivanti dalle preannunciate operazioni di carattere
straordinario (quali quelle da realizzare mediante operazioni di conferimento
di immobili pubblici a fondi immobiliari, tramite InvImit SGR[122], già menzionate dalla Nota di aggiornamento
al DEF13). Si osserva però che la revisione al ribasso delle previsioni di
entrata non sembra tenere conto degli effetti espressamente ascritti all’articolo
1, comma 391 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014): tale
disposizione delega il Governo a definire un programma straordinario di
cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo
2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui. La relazione tecnica alla
citata disposizione, discostandosi dai criteri di prudenzialità precedentemente
seguiti dalle relazioni tecniche con riferimento a disposizioni di analogo
contenuto, ha optato per l’iscrizione anticipata nei saldi degli effetti attesi
dalla norma. Tali effetti, iscritti negli andamenti tendenziali, dovrebbero
quindi necessariamente trovare una corrispondente quantificazione nell’ambito
delle misure una tantum poiché, in caso contrario, risulterebbe corrispondentemente
sottostimata la previsione del deficit strutturale.
Appare
quindi necessario che sia chiarito se le previsioni di incassi da dismissione,
benché riviste al ribasso, includano l’incremento di 500 mln annui per il
periodo 2014-2016 ascritto alla citata disposizione della legge di stabilità.
In caso affermativo, andrebbe altresì chiarito a cosa sia dovuta una così
cospicua revisione al ribasso delle previsioni di entrata quantificabile, al
lordo del citato incremento, in 800 mln per il 2014, 950 mln per il 2015 e 550
mln per il 2016.
La tavola in esame considera unicamente gli
effetti di misure incluse negli andamenti tendenziali, mentre non sono
considerati i possibili effetti una tantum sul saldo di indebitamento netto di
alcune misure cui prudenzialmente non sono stati ascritti effetti (quali la
tassazione delle riserve della Banca d’Italia) o di altre misure preannunciate
nel DEF14, quali, ad esempio l’incremento delle entrate da dismissione
immobiliare che dovrebbe concorrere, assieme ad altri interventi di
valorizzazione patrimoniale, alla riduzione del debito di 0,7 punti percentuali
di PIL annui (contro i 0,5 punti precedentemente previsti).
Si
segnala in proposito che il quadro degli andamenti programmatici e il quadro
degli andamenti della finanza pubblica corretta per il ciclo stimano le previsioni di indebitamento netto strutturale (aventi carattere programmatico)
sulla base delle misure una tantum tendenziali, sottraendo queste ultime
ai valori dell’indebitamento netto programmatico. Ne consegue che il
saldo dell’indebitamento netto strutturale previsto dal documento in esame
risulta coerente con il quadro delineato unicamente nell’ipotesi di coincidenza
tra le misure una tantum programmatiche e quelle tendenziali. Tale saldo potrà
quindi subire variazioni nel caso di effettiva implementazione di misure, quali
quelle sopra menzionate, suscettibili di produrre effetti una tantum non
inclusi nei tendenziali.

![]()
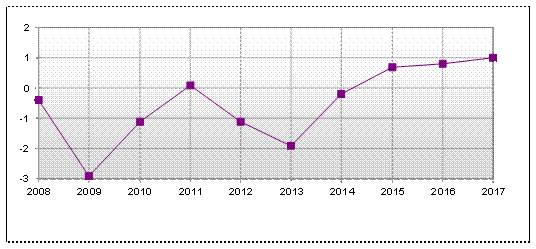
 Fonte: Per i consuntivi 2008-2013 dei paesi della UE, dati
della Commissione Europea, per USA, dati FMI. Per le previsioni 2014-2015, FMI,
Word Economic Outlook (aprile 2014)
Fonte: Per i consuntivi 2008-2013 dei paesi della UE, dati
della Commissione Europea, per USA, dati FMI. Per le previsioni 2014-2015, FMI,
Word Economic Outlook (aprile 2014)